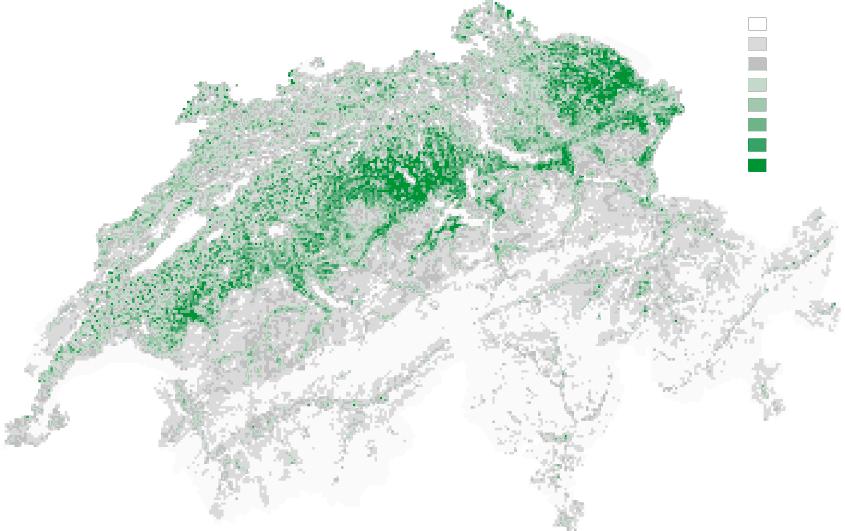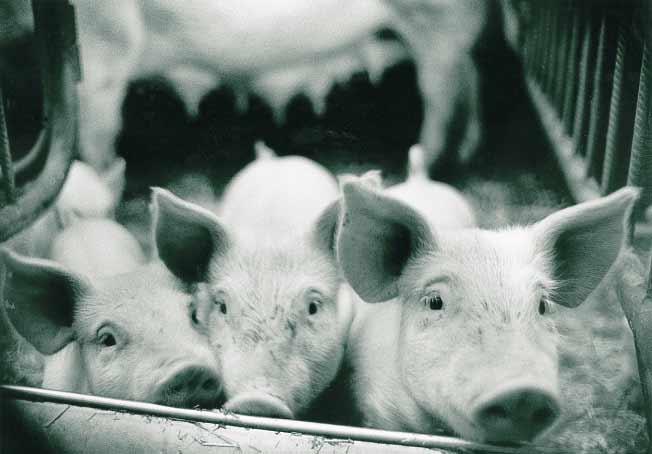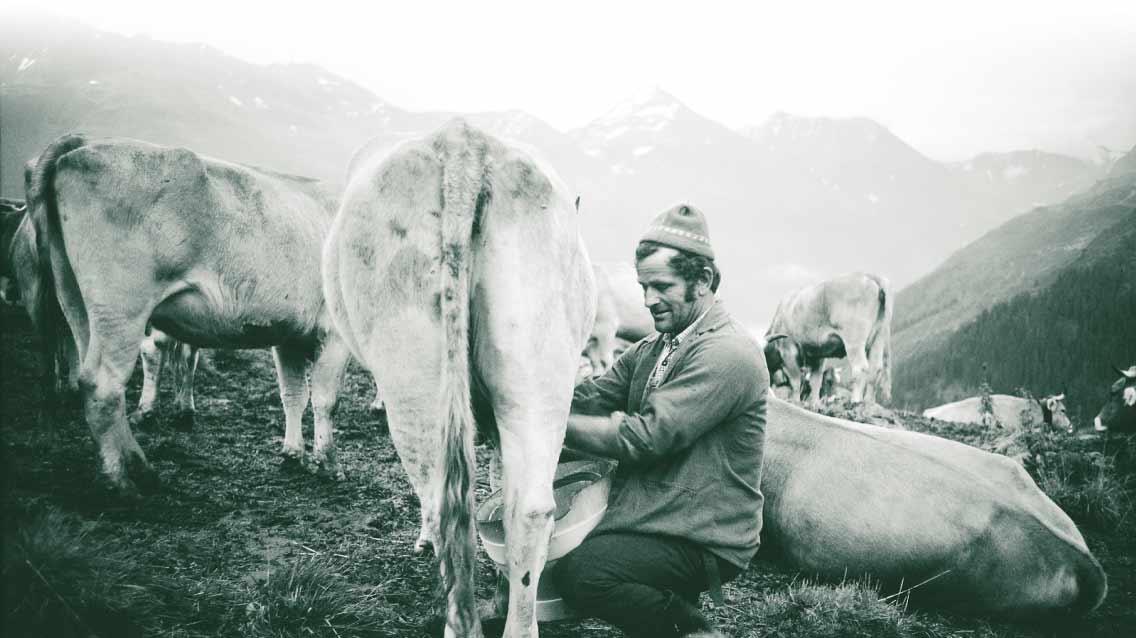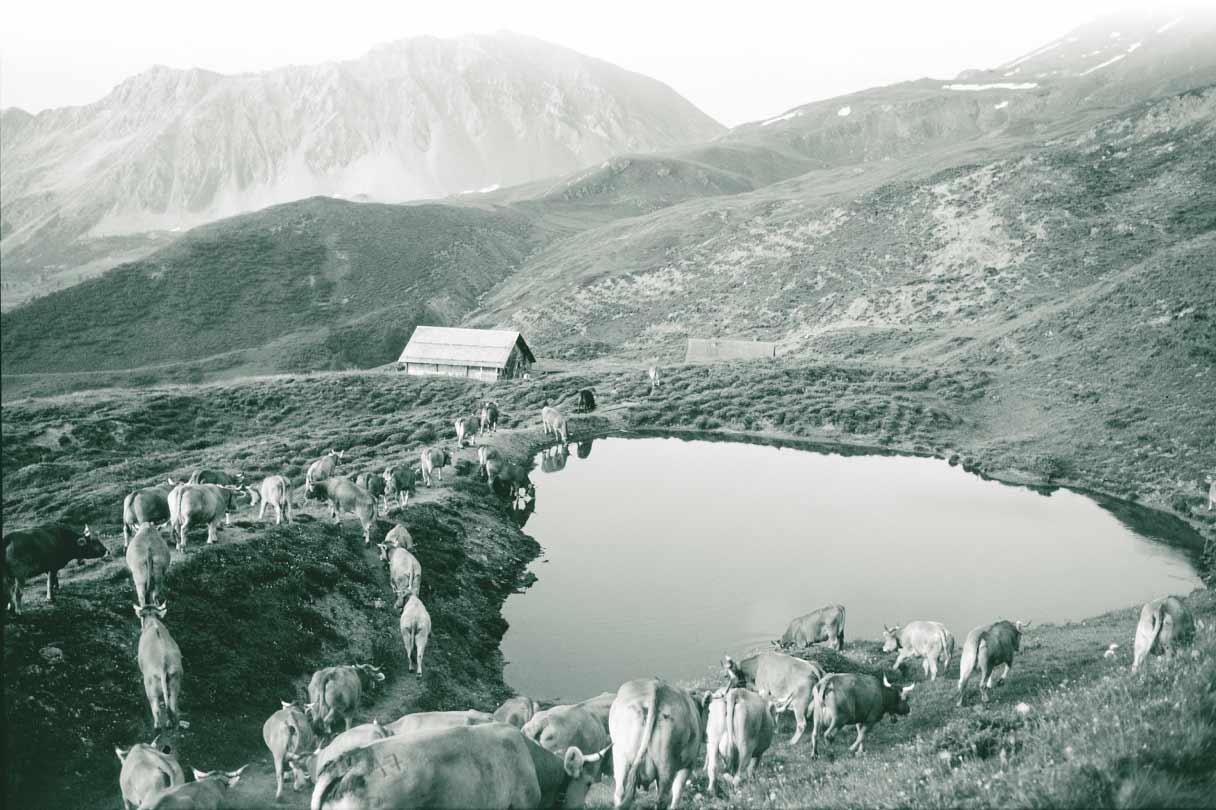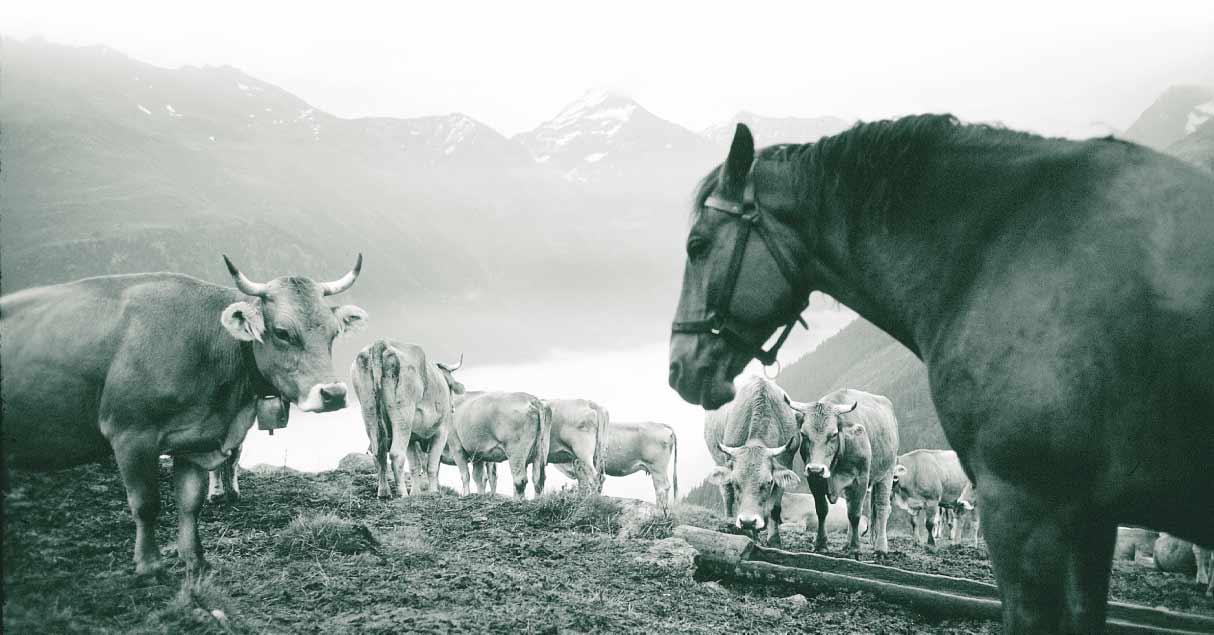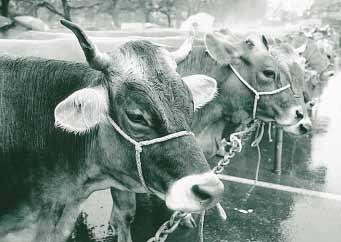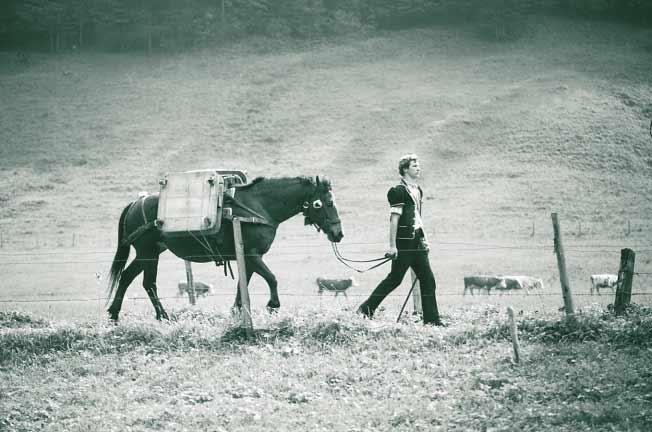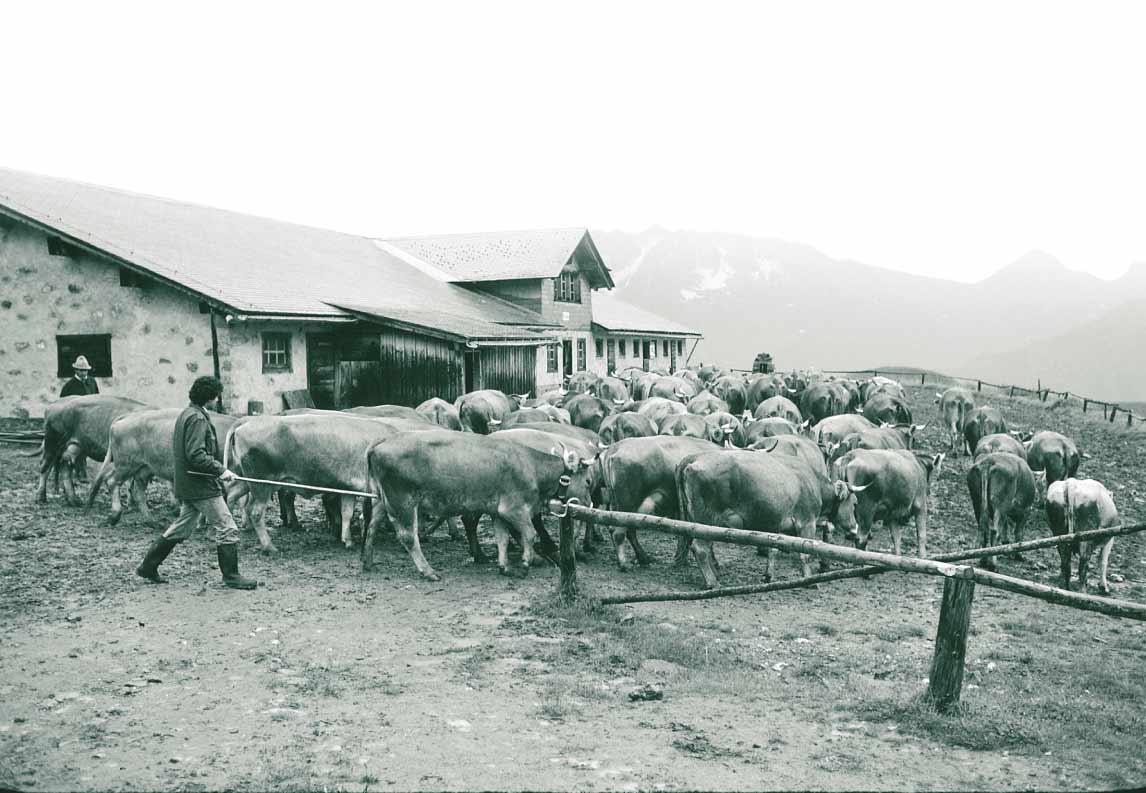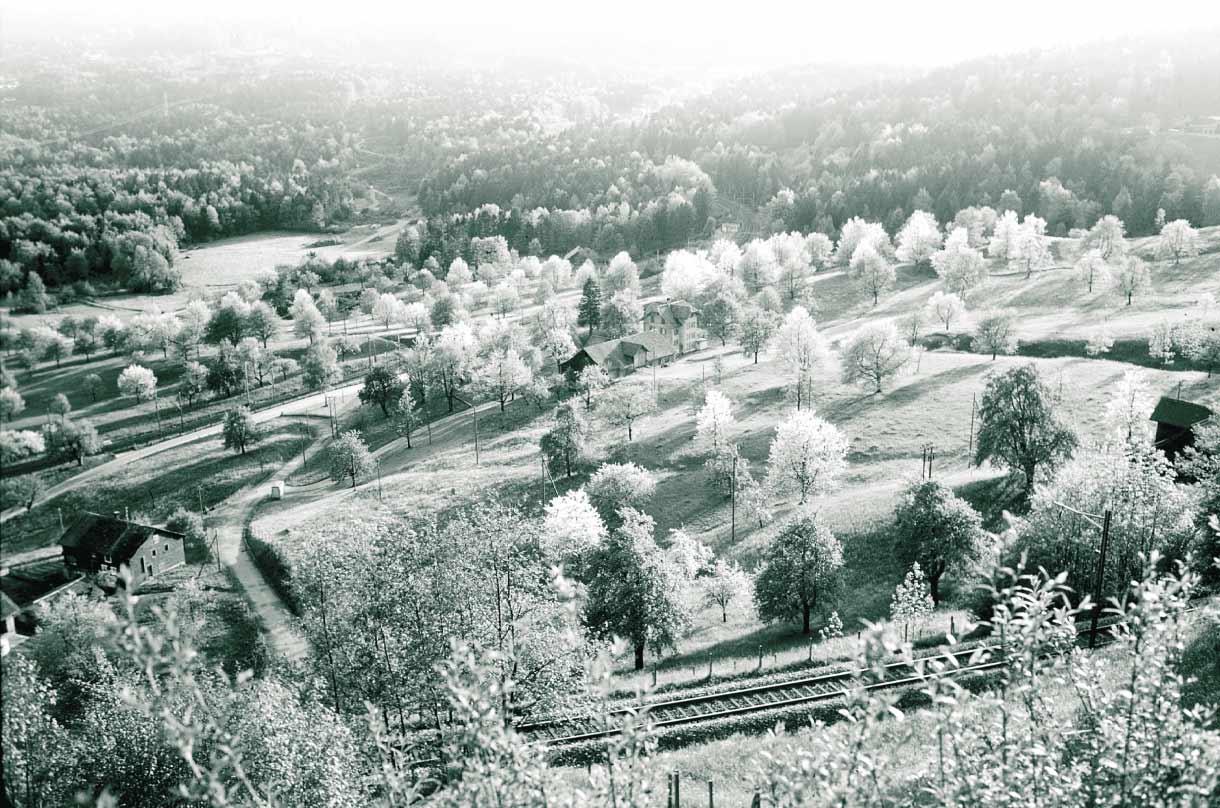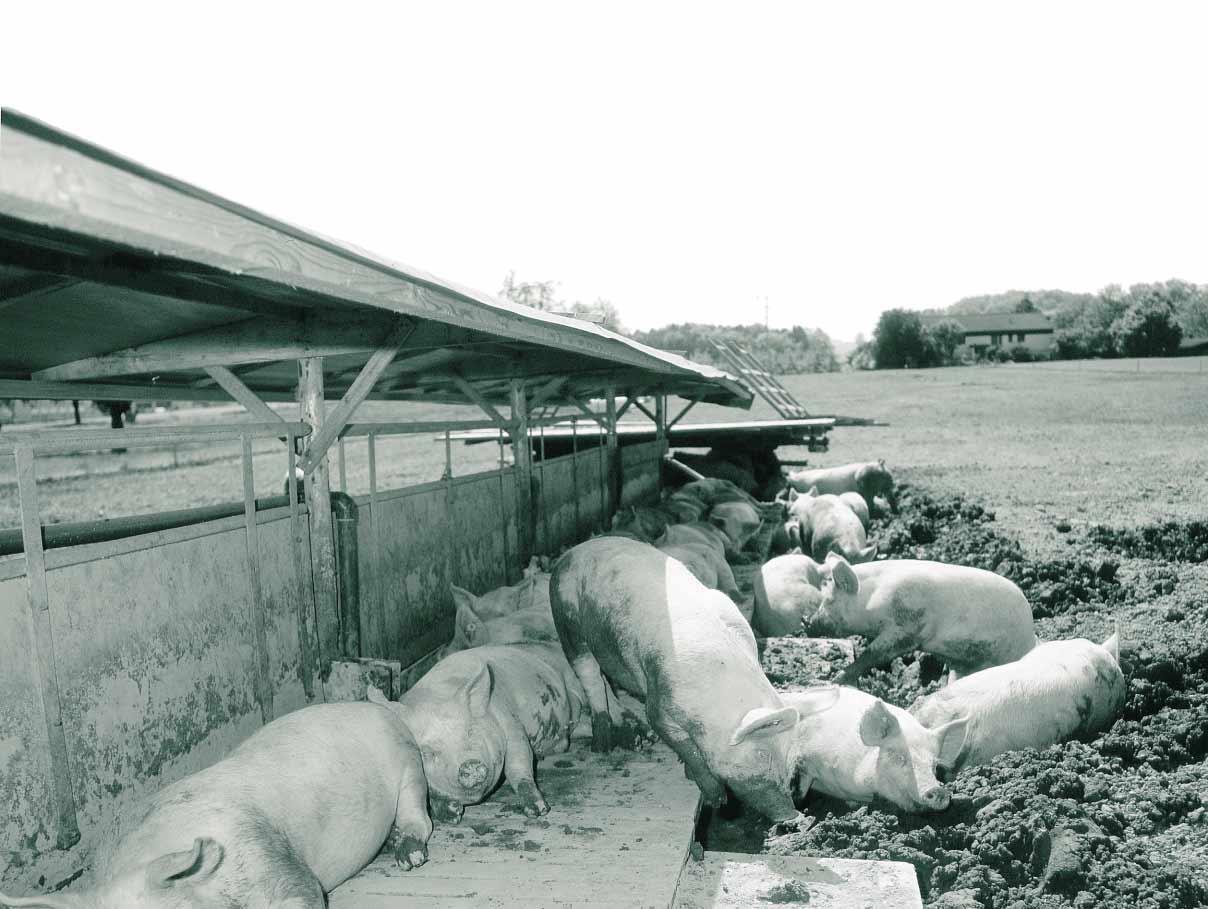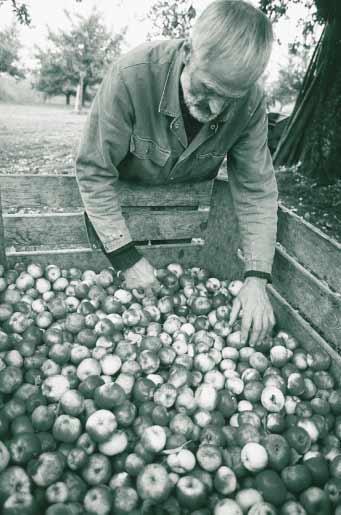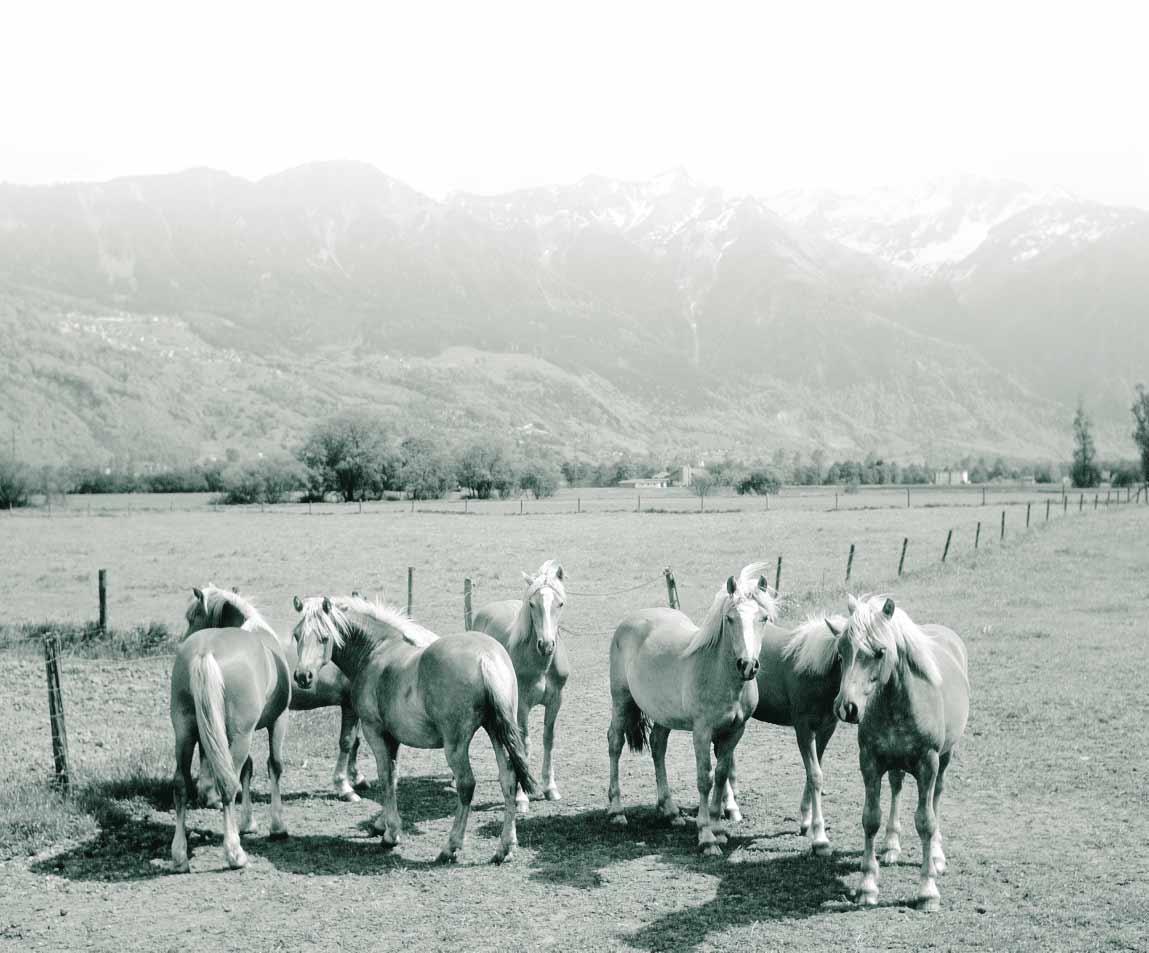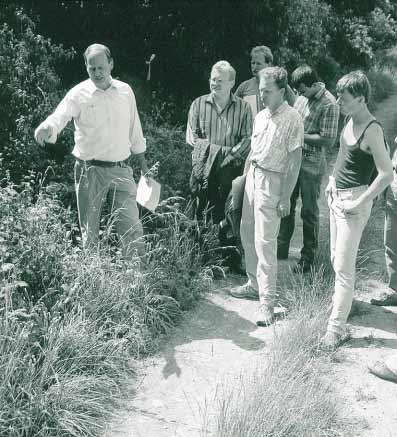Reddito e indicatori economico-aziendali
Evoluzione del reddito delle aziende agricole: media di tutte le regioni
Nel 2003 i risultati economici sono stati lievemente migliori rispetto al 2002.Al contrario,se paragonato con i dati del 2000/02,il reddito agricolo ha registrato una diminuzione del 2 per cento.Rispetto al 2000/02 il reddito lordo derivante dalla produzione agricola è calato del 4 per cento.Le perdite sono state particolarmente significative nel settore della produzione vegetale (–20%) e ciò è riconducibile al perdurare della siccità come pure al calo dei prezzi dei cereali.Il reddito lordo derivante dalla detenzione di animali si è mosso in controtendenza,segnando una leggera progressione (+2%).Nel settore lattiero si sono registrate delle perdite legate ai prezzi (–5%) mentre l’evoluzione relativa al bestiame da macello è stata positiva (+15%).Dato l’andamento del mercato,la valutazione del bilancio è stata adeguata rispetto agli animali,il che ha influenzato in maniera favorevole i risultati inerenti alla detenzione di bovini.Anche i risultati relativi all’avicoltura hanno registrato un notevole miglioramento (+19%).Rispetto al triennio precedente e alla media delle aziende i pagamenti diretti sono aumentati (+10%).La crescita nella regione collinare e di montagna è stata leggermente superiore alla media.Ciò è riconducibile agli adeguamenti attuati nel 2002 in relazione ai contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione e ai contributi per la detenzione di animali che consumano foraggio grezzo.L’aumento dei pagamenti diretti per azienda è stato dato anche dalla crescente partecipazione ai programmi ecologici ed etologici quali SSRA (sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali),URA (uscita regolare all’aperto),agricoltura biologica o promozione regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica.Nel 2003 i costi di terzi si sono situati del 6 per cento circa al disopra del valore del triennio 2000/02.A ciò hanno contribuito essenzialmente le maggiori uscite per edifici,affitto e ammortamento di contingenti lattieri nonché la cosiddetta para-agricoltura.In quest’ultimo caso le maggiori uscite sono direttamente collegate all’aumento del reddito in tale settore.In particolare sono diminuiti gli interessi passivi in seguito al calo del livello degli interessi.
1.1 ECONOMIA 1 50
1990/922000200120022003 Fr. per azienda Reddito accessorio Reddito agricolo
0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 ULAFUnità di
19 208 64 675 1,30 18 633 52 434 1,29 18 577 51 500 1,28 21 210 55 029 1,24
Fonte: Agroscope FAT Tänikon
lavoro annuale della famiglia
Tabelle 17–26,pagine A16–A26
■ Reddito 2003: lieve miglioramento rispetto al 2002
Il reddito agricolo è il risultato della differenza fra reddito lordo e costi di terzi.Nel 2003 è stato segnato un aumento rispetto al 2002 (+7%),benché non si siano raggiunti i livelli del 2000/02 (–2%).Il reddito agricolo indennizza il lavoro della manodopera familiare pari mediamente a 1,24 unità e il capitale proprio investito nell’azienda pari mediamente a 400'000 franchi circa.
Rispetto al periodo 2000/02,nel 2003 il reddito agricolo è diminuito del 6 per cento nella regione di pianura mentre nella regione collinare e in quella di montagna è aumentato dell'1 rispettivamente del 5 per cento.Il reddito accessorio è aumentato in tutte le regioni:in quella di pianura del 20 per cento,in quella collinare del 5 per cento e in quella di montagna del 10 per cento.Il reddito globale registrato nel 2003 non ha subito variazioni per quanto concerne la regione di pianura mentre è aumentato nella regione collinare e di montagna (2 risp.7%).
Reddito delle aziende agricole secondo le regioni
Nel 2003 la quota di pagamenti diretti rispetto al reddito lordo era del 16 per cento nella regione di pianura,del 25 per cento in quella collinare e del 39 per cento in quella di montagna.Rispetto al 2000/02 la quota nella regione di pianura e in quella di montagna è rimasta stabile,mentre è leggermente aumentata nella regione collinare.
1.1 ECONOMIA 1 51 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA
Reddito per regioneUnità 1990/9220002001200220032000/02–2003 % Regione di pianura Superficie agricola utileha16,6619,4119,9320,6819,79 –1,1 Unità di lavoro della famigliaULAF1,361,261,261,251,19 –4,8 Reddito agricolofr.73 79477 73862 45363 40264 129 –5,5 Reddito accessoriofr.16 42917 80517 04316 74320 64220,0 Reddito globalefr.90 22395 54379 49680 14584 771 –0,3 Regione collinare Superficie agricola utileha15,3017,8317,9518,0918,482,9 Unità di lavoro della famigliaULAF1,401,291,261,241,260 Reddito agricolofr.59 83858 72547 49646 25751 4421,2 Reddito accessoriofr.14 54421 81420 55719 36921 6715,3 Reddito globalefr.74 38280 53968 05365 62673 1142,4 Regione di montagna Superficie agricola utileha15,7618,6318,8518,5518,60 –0,4 Unità di lavoro della famigliaULAF1,421,391,381,351,31 –4,4 Reddito agricolofr.45 54147 72140 13537 51243 9215,1 Reddito accessoriofr.17 85319 01119 41420 74821 6629,8 Reddito globalefr.63 39466 73259 54958 26065 5836,6 Fonte:Agroscope FAT Tänikon
Tabelle 17–20,pagine A16–A19
La situazione reddituale negli undici tipi di azienda (indirizzi di produzione) è indicatrice di differenze ragguardevoli.
Reddito delle aziende agricole secondo i tipi di azienda – 2001/03
Tipo di aziendaSuperficie Unità di lavoro RedditoRedditoReddito agricola utiledella famigliaagricoloaccessorioglobale haULAFfr.fr.fr.
Nella media degli anni 2001/03 le aziende attive nei settori della trasformazione, campicoltura nonché determinate aziende combinate (trasformazione combinata,latte commerciale/campicoltura) hanno realizzato il reddito agricolo più elevato.Queste stesse aziende (escluse le aziende combinate del settore latte commerciale/campicoltura) hanno registrato anche il maggior reddito globale.Il reddito agricolo e il reddito globale più bassi sono stati rilevati nelle aziende dei tipi «Equini/ovini/caprini» e «Altro bestiame bovino»
Media di tutte le aziende19,191,2752 98819 47372 461 Campicoltura23,891,0966 51121 97488 485 Colture speciali12,721,2963 89818 87482 773 Latte commerciale18,861,3348 46618 22466 690 Vacche madri17,621,0938 74031 45570 194 Altro bestiame bovino16,171,2532 29021 88654 176 Equini/ovini/caprini12,611,2222 25632 67154 926 Trasformazione11,741,1866 94917 10684 055 Aziende combinate, latte commerciale/campicoltura25,391,3165 35114 39879 749 Aziende combinate,vacche madri21,811,1351 14629 09580 241 Aziende combinate,trasformazione19,431,2867 13516 41183 546 Aziende combinate,altre20,501,2552 75919 99572 754 Fonte:Agroscope FAT Tänikon
52 1.1 ECONOMIA 1
Tabelle 21a–21b,pagine A20–A21
Il profitto del lavoro conseguito dalle aziende agricole (reddito agricolo meno interessi per il capitale proprio investito nell’azienda) remunera il lavoro della manodopera familiare non salariata.Il profitto del lavoro registrato nel 2003 per unità di lavoro della famiglia (valore mediano) è cresciuto del 12 per cento rispetto alla media del triennio 2000/02.Rispetto al 2002 si è registrato addirittura un incremento del 22 per cento.Questo aumento è riconducibile in primo luogo al calo del livello degli interessi e alla conseguente notevole diminuzione degli interessi per il capitale proprio.
Il profitto del lavoro per unità di lavoro della famiglia evolve in modo molto diverso a dipendenza della regione.Mediamente esso è decisamente più elevato nella regione di pianura che in quella di montagna.Divari notevoli si registrano anche per quanto concerne i quartili.Nel periodo 2001/03 nella regione di pianura,il profitto medio del lavoro nel primo quartile ammonta al 20 per cento e nel quarto quartile al 200 per cento del valore medio di tutte le aziende della regione.Nella regione collinare la varianza è stata simile mentre è risultata più marcata nella regione di montagna.
Profitto del lavoro delle aziende agricole – 2001/03, per regioni e quartili

Profitto del lavoro 1 in fr.per ULAF 2
1L’interesse del capitale proprio corrisponde al tasso d’interesse medio delle obbligazioni della Confederazione. 2001:3,36%;2002:3,22%;2003:2,63%
2Unità di lavoro annuale della famiglia:base 280 giorni di lavoro Fonte:Agroscope FAT Tänikon
Valore Valori medi mediano RegioneI quartileII quartileIII quartileIV quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Regione di pianura37 7077 92930 37445 57579 836 Regione collinare27 7474 26821 67334 22959 828 Regione di montagna20 55689716 01026 41948 099
Tabelle 22–25,pagine A22–A25
53 1.1 ECONOMIA 1
■ Profitto del lavoro –2003
■ Stabilità finanziaria
Nel 2001/03 nelle regioni di pianura e collinare il quarto quartile delle aziende agricole ha superato il livello di salario lordo annuale della rimanente popolazione.Nella regione collinare,invece,il quarto quartile ha raggiunto a malapena il salario comparabile,mentre nella regione di montagna il valore è rimasto di circa 8'000 franchi al disotto del valore di paragone.Rispetto al periodo 2000/02 vi è stato un miglioramento della situazione nella regione di montagna,che si contrappone al peggioramento della situazione in quella di pianura e collinare.
Salario comparabile 2001/03,per regioni
RegioneSalario comparabile 1 fr.per anno
Regione di pianura66 832
Regione collinare61 758
Regione di montagna56 053
1Valore mediano dei salari lordi annui di tutte le persone impiegate nel secondario e nel terziario
Fonti:UST,Agroscope FAT Tänikon
Va tenuto in considerazione che le economie domestiche agricole non dispongono soltanto del profitto del lavoro per il proprio sostentamento.Il loro reddito globale, compreso quello accessorio, è notevolmente maggiore del profitto del lavoro.
La quota di capitale di terzi rispetto al capitale globale indica il grado d’indebitamento dell’impresa.Se questo dato viene combinato con l’entità della formazione del capitale proprio, è possibile esprimere considerazioni in merito alla sopportabilità di un debito. Dal profilo finanziario un’azienda permanentemente confrontata con una quota elevata di capitale di terzi e una formazione del capitale proprio negativa non è in grado di sopravvivere.
Sulla base di queste considerazioni,le aziende sono state classificate in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa.
Classificazione delle aziende in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa
Aziende con …
Quota di capitale di terzi
Bassa (<50%)Elevata (>50%)
Formazione di Positiva...una situazione...un’autonomia financapitale proprio preoccupanteziaria limitata
Negativa...un reddito ...una situazione finaninsufficienteziaria preoccupante
54 1.1 ECONOMIA 1
Fonte:De Rosa
Dalla valutazione della stabilità finanziaria delle aziende scaturisce un quadro analogo per tutte le regioni.Il 42 per cento delle aziende si trova in condizioni finanziarie buone.Nel 38 per cento circa dei casi la situazione è considerata problematica (aziende con formazione del capitale proprio negativa).La media del triennio 2001/03 segna un peggioramento generalizzato in tutte le regioni rispetto al 2000/02.
Rispetto al 2000/02 gli investimenti effettuati nel 2003 dalle aziende di riferimento della FAT sono aumentati del 5 per cento.Si è registrata una crescita anche per quanto riguarda il cash flow (+7%).Il rapporto fra cash flow e investimenti è variato soltanto lievemente (+2%).La situazione relativa alla formazione di capitale proprio (reddito globale meno consumo privato) è migliorata rispetto a quella osservata nel periodo di riferimento (+13%),mentre è peggiorata la quota di capitale di terzi (+5%).Il motivo di tali aumenti è l’incremento segnato sia dai crediti d’investimento che dai crediti ipotecari,cui si contrappone il lieve calo dell’impiego di capitale proprio.
Evoluzione della formazione del capitale proprio,degli investimenti e della quota di capitali di terzi
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 55 1.1 ECONOMIA 1
Caratteristica1990/9220002001200220032000/02–2003 % Formazione di capitale propriofr.19 51321 2337 2886 84013 34313,2 Investimenti 1 fr.46 91444 96547 46943 69547 5804,9 Rapporto cash flow – investimenti 2 %951028394952,2 Quota di capitale di terzi%43414141434,9 1 Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti sovvenzioni e disinvestimenti 2 Rapporto fra cash flow (formazione del capitale proprio più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell’inventario vivo) e investimenti
FAT Tänikon Valutazione della stabilità finanziaria 2001/03, per regioni Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna Quota di aziende in % Situazione finanziaria preoccupante Reddito insufficiente Autonomia finanziaria limitata Situazione finanziaria buona Fonte: Agroscope FAT Tänikon 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 18 21 18 42 18 18 22 41 17 21 18 44
Formazione di capitale proprio,investimenti e quota di capitali di terzi
Fonte:Agroscope
■
■ Analisi delle aziende a titolo principale,complementare e accessorio
Analisi delle forme d’attività
Di seguito vengono presentate alcune analisi che consentono un’osservazione più dettagliata in merito ai risultati delle aziende a titolo principale,complementare e accessorio.La base per l’analisi è rappresentata dai dati contabili 2000/02 della Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon.La struttura secondo la forma di attività si basa sulla quota di reddito agricolo rispetto al reddito globale.Tale quota è superiore al 90 per cento nelle aziende a titolo principale,in quelle a titolo complementare si situa tra il 50 ed il 90 per cento,mentre è inferiore al 50 per cento nelle aziende a titolo accessorio.
Regione
CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio
2000/02
Pianura%57423546
Collina%24283227
Montagna%19303327
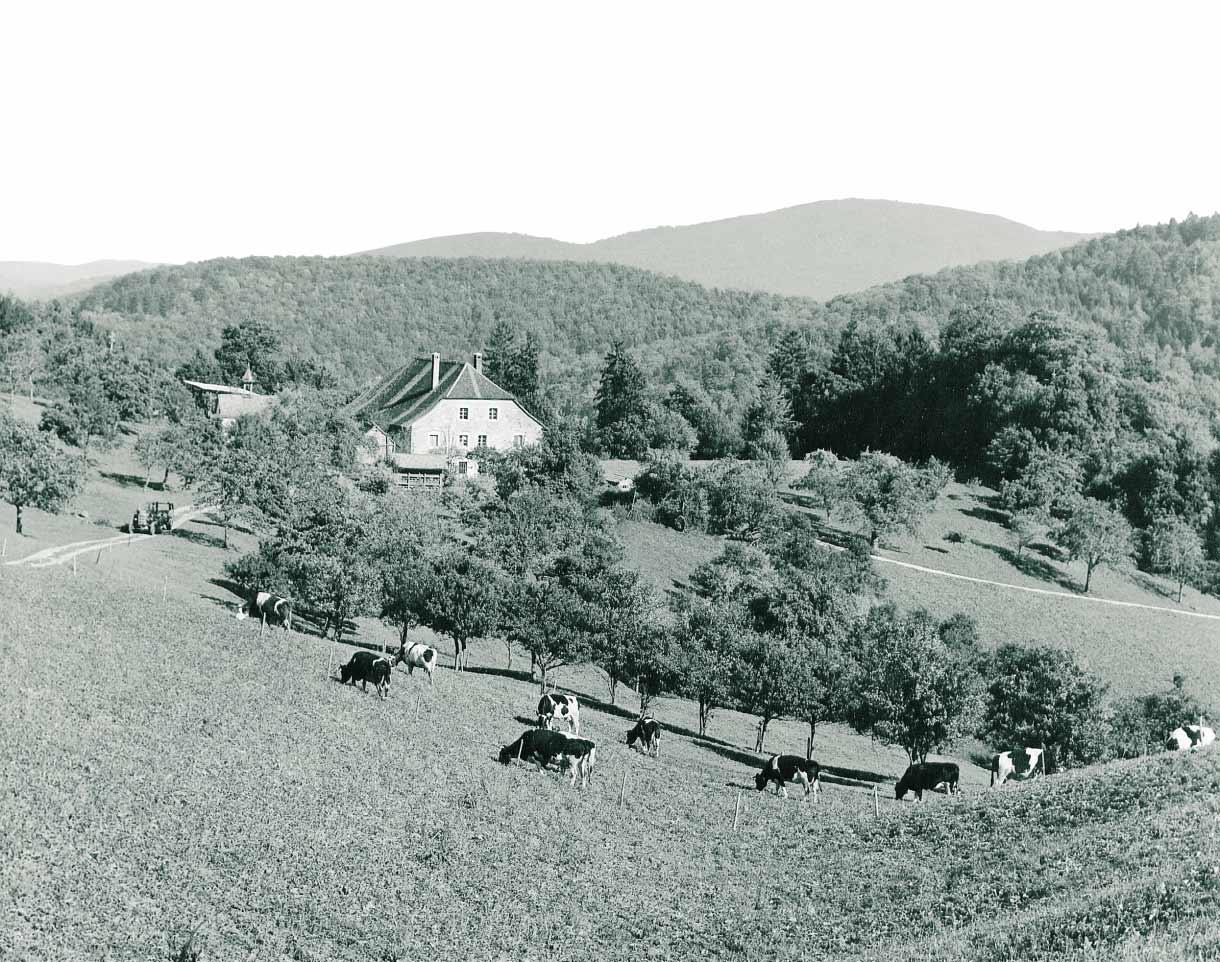
Totale%100100100100
Tutte le aziende per forma di guadagno%334819
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
56 1.1 ECONOMIA 1
Nel complesso un terzo delle aziende (17'357) è rappresentato da aziende a titolo principale secondo la definizione precedentemente citata,il 48 per cento (25'246) rientra nella categoria delle aziende a titolo complementare ed il 19 per cento (9'993) in quella delle aziende a titolo accessorio.Nella regione di pianura le aziende a titolo principale sono la maggioranza,contrariamente alla regione di montagna dove restano una minoranza.Le aziende a titolo accessorio sono ripartite in maniera abbastanza omogenea in tutte le tre regioni.
Strutture
CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio 2000/02
SAU/ULA12,2611,1710,1011,40
Come prevedibile,le aziende a titolo principale sono più grandi di quelle a titolo complementare e accessorio.Le aziende a titolo principale,per unità di manodopera, gestiscono circa il 21 rispettivamente il 10 per cento di superficie in più rispetto alle aziende a titolo accessorio e alle aziende a titolo complementare.Con una quota del 35 per cento sulla SAU,le superfici campicole aperte delle aziende a titolo principale sono del 22 per cento circa superiori a quelle delle aziende a titolo complementare e accessorio.Ciò dipende dalla ripartizione delle aziende nelle regioni.
Tipo di azienda
CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio
2000/02
Campicoltura% 9486
Latte commerciale%29413536
Altro bestiame bovino%38127
Aziende combinate, latte commerciale/campicoltura%159510
Trasformazione combinata%1412611
Aziende combinate,altre%14141314
Altro%16122116
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
Risulta sorprendentemente alta la quota (35%) delle aziende specializzate nella produzione di latte commerciale gestite a titolo accessorio:3'500 aziende sulle 19'000 complessive.
Manodopera aziendaULA1,861,671,351,68 Unità di lavoro della famigliaULAF1,371,321,041,29 ImpiegatiULAI0,490,350,310,39 Superficie agricola utileha22,8218,6413,6719,09 Di cui:superficie campicola apertaha7,914,213,015,20 Superficie per unità di manodoperaha
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 57 1.1 ECONOMIA 1
Quartili (per profitto del lavoro)
CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio
2000/02
I quartile%10187025
II quartile%18331925
III quartile%2929725
IV quartile%4320425
Tutte le aziende%100100100100
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
Una caratteristica in base alla definizione delle aziende a titolo accessorio è il basso reddito proveniente dall’attività agricola.Non è dunque sorprendente che il 70 per cento delle aziende a titolo accessorio si trovi nel primo quartile.Al contrario il 43 per cento delle aziende a titolo principale è situato nel quarto quartile.
princi-comple-acces-
Tra aziende a titolo principale e aziende a titolo accessorio sussistono notevoli differenze sia in termini di reddito lordo dell’agricoltura che di costi di terzi.Nelle aziende a titolo accessorio il reddito lordo dell’agricoltura per ettaro di SAU è minore mentre sono maggiori i costi di terzi,tra cui spiccano essenzialmente i costi strutturali per ettaro.Ciò potrebbe essere determinato dal fatto che nelle aziende a titolo accessorio i costi strutturali derivanti dall’edificio d’abitazione si ripartiscono su meno ettari rispetto a quanto succede nelle aziende a titolo principale e complementare.Per le aziende a titolo accessorio l’importo per ettaro dei pagamenti diretti erogati supera quello delle aziende a titolo principale,tuttavia non in termini assoluti.A fare la differenza per ettaro di SAU sono i pagamenti diretti generali.Ciò si spiega tenendo conto che due terzi delle aziende a titolo accessorio sono ubicati nella regione collinare e di montagna.
2000/02 Reddito lordo per ULAfr./ULA91 80673 25455 19677 019 Reddito lordo per hafr./ha10 67110 1059 48110 245 Reddito lordo agricoltura per hafr./ha7 4836 5635 4516 778 Pagamenti diretti per ha di SAUfr./ha2 0792 2842 5212 236 PD generalifr./ha1 6481 8472 0921 802 Contributi ecologicifr./ha175176191177 Contributi etologicifr./ha162167154184 Totale costi di terzi per hafr./ha7 2447 1028 1467 296 Costi specificifr./ha4 4784 3274 6964 436 Costi strutturalifr./ha2 7662 7753 4502 860 Investimenti per hafr./ha2 2752 3542 7992 377 Fonte:Agroscope FAT Tänikon
Reddito lordo,costi ed investimenti CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale
palementaresorio
58 1.1 ECONOMIA 1
Economia domestica
CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio
2000/02
Età del capoaziendaAnni46464646 Bambini di età <16 anniNumero0,91,51,21,2 Unità di consumatori (UC)Numero3,13,73,63,5
Fonte:Agroscope FAT Tänikon

L’età media del capoazienda è 46 anni,indipendentemente dal tipo di attività.Nelle aziende a titolo complementare e accessorio il numero di bambini di età inferiore a 16 anni è maggiore,come pure le dimensioni del nucleo familiare,rispetto alle aziende a titolo principale.
Reddito e consumo
CaratteristicaUnità TitoloTitoloTitoloTotale princi-comple-accespalementaresorio 2000/02
È opportuno sottolineare come sia ridotta la differenza tra aziende a titolo principale e a titolo accessorio per quanto concerne il reddito globale medio (80'000 risp. 67'000 fr.).Il consumo privato del nucleo familiare è praticamente sugli stessi livelli in tutte e tre le forme di attività (ca.63'000 fr.).Nel caso delle aziende a titolo accessorio, il volume delle uscite per imposte e AVS è minore.
Reddito agricolofr.78 13355 85318 13956 203 Reddito accessoriofr.1 93018 67749 03718 806 Reddito globalefr.80 06374 53167 17675 009 Consumo privato per famigliafr.63 51963 06663 09363 222 Impostefr.7 8985 8855 5616 483 Contributi AVS,AI,IPGfr.4 9563 5721 9943 731 Fonte:Agroscope FAT Tänikon
59 1.1 ECONOMIA 1
■ Conclusioni
Per definizione,le aziende a titolo principale,complementare ed accessorio si distinguono per la struttura del reddito.Il reddito agricolo delle aziende a titolo accessorio è particolarmente basso perché il reddito lordo per ettaro proveniente dall’agricoltura è il più basso,mentre i costi di terzi per ettaro sono i più elevati.Queste differenze per ettaro sono intensificate in termini assoluti,in quanto le aziende a titolo accessorio hanno la quota di SAU più esigua.I pagamenti diretti per ettaro sono più alti,tuttavia ciò contribuisce soltanto marginalmente a ridurre le differenze relative al reddito rispetto alle altre forme di attività.Dai dati emerge che i pagamenti diretti generali sono il motivo per cui l’importo dei pagamenti diretti per ettaro è maggiore nelle aziende a titolo accessorio.Ciò dipende dal fatto che due terzi delle aziende a titolo accessorio sono ubicate nella regione collinare e di montagna.Dall’analisi non emerge alcuna indicazione secondo cui le aziende a titolo accessorio siano essenzialmente aziende che massimizzano i pagamenti diretti.
È interessante constatare come il reddito globale delle tre forme di attività non si discosti molto come invece farebbero supporre le differenze in materia di reddito agricolo.Le aziende a titolo principale occupano il primo posto per quanto concerne il reddito globale (80'000 franchi),seguono le aziende a titolo complementare con 74'000 franchi e quelle a titolo accessorio con 67'000 franchi.Le aziende a titolo principale segnano mediamente anche risultati economici soddisfacenti.Dedicarsi completamente all’attività agricola resta tuttora una scelta vantaggiosa.Le aziende a titolo accessorio,con la loro attività non agricola,riescono a compensare in maniera considerevole il deficit legato al reddito agricolo.Nonostante il reddito globale mediamente più basso,esse costituiscono unità economicamente stabili.Il consumo privato medio è praticamente uguale per tutte e tre le forme di attività,come pure l’età media del capoazienda.Anche questo indica che tutte le forme di attività possiedono la loro attrattiva.
60 1.1 ECONOMIA 1
1.2 Aspetti sociali
Quella sociale è una delle tre dimensioni del concetto di sostenibilità.Nel rapporto sulle conseguenze della politica agricola,gli aspetti sociali ricoprono dunque una posizione a sé stante.Il resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura,ossia il capitolo «Aspetti sociali»,si suddivide in tre parti:reddito e consumo,rilevamento periodico di cinque componenti determinanti per fotografare la situazione sociale,studi di casi collegati a componenti sociali.
Nel capitolo «Aspetti sociali» vengono presi in esame il reddito e il consumo delle economie domestiche agricole in base all’analisi centralizzata dei dati contabili dell’Agroscope FAT.Vengono inoltre presentate un’analisi della rilevazione nell’ambito del reddito e del consumo ed una ricapitolazione delle offerte di consulenza per le famiglie contadine in difficoltà.

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 61
■ Reddito globale e consumo privato
Reddito e consumo
Reddito e consumo sono due indicatori importanti per valutare la situazione delle famiglie contadine sul piano sociale.Nella dimensione economica della sostenibilità, l’aspetto del reddito è interessante soprattutto per appurare la produttività delle aziende.Nella dimensione sociale l’accento è posto sulla situazione reddituale delle economie domestiche agricole.Per tale motivo nell’analisi viene preso in considerazione anche il loro reddito accessorio.Accanto al reddito globale,viene anche seguita l’evoluzione del consumo privato.
Nel 2001/03,il reddito globale,formato dal reddito agricolo e dal reddito accessorio, ha registrato valori medi tra i 61'100 circa e gli 81'500 franchi per azienda a seconda della regione.Il reddito globale delle aziende della regione di montagna corrispondeva al 75 per cento circa di quello delle aziende della regione di pianura.Con un reddito accessorio che variava dai 18'100 ai 20'600 franchi,le aziende hanno avuto una fonte di reddito importante,che per le aziende nella regione di pianura rappresentava il 22 per cento del reddito globale,mentre costituiva rispettivamente il 30 per cento e il 34 per cento del reddito globale per le aziende della regione collinare e per quelle della regione di montagna.Le aziende della regione di montagna hanno anche registrato il reddito accessorio in assoluto più elevato pari a 20'600 franchi.
Reddito globale e consumo privato per azienda e per regione – 2001/03
In tutte le regioni il consumo privato rappresentava mediamente l’87 per cento del reddito globale,segnando valori sempre al disopra di quelli del reddito agricolo. Rispetto al volume del reddito globale,il consumo privato ha registrato i valori più elevati nelle aziende della regione di pianura e i valori più bassi in quelle della regione di montagna.
Nel 2003,con 76'200 franchi circa il reddito globale medio per azienda è stato superiore a quello della media degli anni 2000/02 che ammontava a 75'000 franchi.Il consumo privato per azienda è invece diminuito di circa 330 franchi,fissandosi a 62'900 franchi.
Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna In fr. Consumo privato Reddito accessorio Reddito agricolo
Tänikon 0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 62
Fonte: Centrale analisi, Agroscope FAT
2
Reddito globale e consumo privato per unità di consumo
1 –
Fonte:Centrale analisi,Agroscope FAT Tänikon

Nel 2001/03,nelle aziende del primo quartile il reddito globale per unità di consumo non ha coperto il consumo delle famiglie.A tal fine esse hanno dovuto utilizzare una parte dei mezzi finanziari che invece avrebbero potuto essere destinati a nuovi investimenti o a investimenti sostitutivi nonché alla previdenza per la vecchiaia.La formazione del capitale proprio di queste aziende è stata negativa.Nelle aziende degli altri quartili il consumo privato è stato inferiore al reddito globale.Il reddito globale per unità di consumo delle aziende del primo quartile corrispondeva al 44 per cento di quello delle aziende del quarto quartile.
Nel primo e nel quarto quartile,il consumo privato per unità di consumo rappresentava rispettivamente il 116 e il 71 per cento circa del reddito globale.Per quanto concerne il consumo privato la differenza fra il primo e il quarto quartile è decisamente più contenuta rispetto a quella rilevata per il reddito globale.Il consumo privato delle aziende del primo quartile,infatti,corrispondeva al 71 per cento del consumo delle aziende del quarto quartile.
Rispetto agli anni 2000/02,nel 2003 il reddito globale per unità di consumo è stato leggermente inferiore solo nel terzo quartile,negli altri tre quartili è stato lievemente superiore.I dati sul consumo privato del 2003 hanno messo in evidenza un leggero incremento dei valori soltanto relativamente al quarto quartile rispetto alla media del periodo 2000/02.
quartile
PrimoSecondoTerzoQuarto Tutte le quartilequartilequartilequartileaziende Reddito globale per UC 2 (fr.)13 44416 95321 55930 73620 661 Consumo privato per UC (fr.)15 58316 15018 60821 90518 054
per
2001/03
1 Quartile in base al profitto del lavoro per unità di manodopera familiare
Unità di consumo = membro della famiglia d’età superiore a 16 anni che partecipa al consumo annuo della famiglia
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 63
Rilevazione del reddito e del consumo
In riferimento alle principali tematiche sociali sulle quali viene effettuato un rilevamento quinquennale,nel presente rapporto vengono presentati i risultati della rilevazione del reddito e del consumo 2002 attuata dall'Ufficio federale di statistica (UST). In particolare vengono confrontati i dati in ambito agricolo con quelli del resto della popolazione residente in comuni rurali.
Nel 1990 e nel 1998 l’UST ha effettuato due rilevazioni su larga scala.Dal 2000 attua queste rilevazioni annualmente.La rilevazione del reddito e del consumo dà un’immagine precisa delle entrate delle economie domestiche private e consente di analizzare l’aspetto del consumo a dipendenza delle diverse caratteristiche sociali e demografiche.Nel 2002,sull'arco di dodici mesi sono state interpellate complessivamente 3'726 economie domestiche scelte a caso dall’elenco telefonico.
Le rilevazioni mensili avvengono in tre tappe:
nel quadro di un colloquio iniziale sulla disponibilità a prendere parte al sondaggio vengono rilevate informazioni generali;
– per un mese viene tenuto un registro per l'intera economia domestica ed eventualmente per ogni singolo membro della famiglia nel quale vengono riportate tutte le entrate e le uscite;
nel quadro di un colloquio conclusivo vengono poste domande supplementari relative all’organizzazione dell’economia domestica,all'abitazione,all’ambiente circostante,eccetera.
Nell’insieme rientra la popolazione residente stabilmente entro i confini svizzeri.La persona che contribuisce maggiormente al reddito domestico viene scelta come riferimento per rilevare le caratteristiche dell’economia domestica.
Nel quadro della rilevazione del reddito e del consumo 2002,la base di dati più recente,sono state interpellate 56 economie domestiche contadine residenti in comuni rurali,nelle quali la persona di riferimento era un agricoltore o un’agricoltrice.Per garantire il confronto tra queste economie domestiche e quelle non agricole,oltre alla suddivisione in base alle dimensioni (economie domestiche con 1–2,3–4 o con più di 5 persone),sono stati creati gruppi di confronto strutturati analogamente e formati dal resto della popolazione residente in comuni rurali: «Lavoratori dipendenti in comuni rurali» e «Lavoratori indipendenti in comuni rurali».Unitamente agli «Agricoltori in comuni rurali»,questi gruppi confluiscono nella categoria «Economie domestiche attive in comuni rurali»
Data l’esigua portata del campione delle economie domestiche analizzate si eviterà di entrare nei dettagli,in quanto non è possibile garantire la completa attendibilità di alcuni dati sul piano statistico.
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 64
–
–
■ Rilevazione del reddito e del consumo in Svizzera quale base
Reddito delle economie domestiche in franchi
1 Per ragioni di arrotondamento i singoli valori addizionati possono scostarsi leggermente dal totale
2 Ponderazione speciale UFAG:uguale ripartizione in base alle classi di dimensione dell’economia domestica per le economie domestiche attive in comuni rurali
( )Il risultato non può essere pubblicato siccome il numero delle registrazioni è insufficiente (28)Valore con varianza marcata:coefficiente di variazione > 10%
I risultati mostrano che,considerando le dimensioni dell’economia domestica,il reddito delle economie domestiche rurali è notevolmente inferiore a quello dei gruppi di confronto.Il reddito delle economie domestiche rurali interpellate ammonta in media a 6'200 franchi al mese,mentre quello dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori indipendenti è rispettivamente di 10'200 e 10'900 franchi.La quota del reddito proveniente da un'attività professionale rappresenta l’81 per cento per le economie domestiche rurali,mentre sale rispettivamente all’87 e all’85 per cento per i lavoratori dipendenti e indipendenti.Nelle economie domestiche rurali si riscontrano percentuali lievemente più alte rispetto a quelle di confronto per quanto riguarda i dati «reddito proveniente da locazione e reddito patrimoniale» e «reddito da trasferimento».Vista la casistica ridotta nel contesto delle economie domestiche rurali è impossibile determinare la composizione del reddito proveniente da locazione,di quello patrimoniale e del reddito da trasferimento (ossia prestazioni sociali,alimenti,ecc.).
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 65
Distribuzione percentuale delle economie domestiche24,0 18,1 4,1 1,8 Persone per economia domestica3,72 3,67 3,90 3,81 Reddito mensile mediano in fr.9 126 9 471 8 967 5 470 Reddito mensile per economia domestica in fr.(media)10 000 10 170 10 912 6 239 Struttura del redditoImporto in fr.al mese Reddito proveniente da attività quale dipendente6 901 8 738 (1 266) ( ) Reddito proveniente da attività indipendente(1 719) (101) (7 952) ( ) Reddito proveniente da attività professionale8 620 8 840 9 218 5 070 Reddito proveniente da locazione(108) (77) ( ) ( ) Reddito patrimoniale(146)(107) ( ) ( ) Reddito proveniente da locazione e reddito patrimoniale(253) (184) (591)( ) Prestazioni sociali615 619 (541) ( ) Altre fonti di reddito da trasferimento512 528 (562) ( ) Reddito da trasferimento1 127 1 147 1 103 ( )
Fonte:UST
■
… Struttura 1 Comuni rurali – econ.dom.attive 2 Comuni rurali – lavor.dipendenti 2 Comuni rurali – lavor.indipendenti 2 Comuni rurali –agricoltori 2
Reddito basso
1 Per ragioni di arrotondamento i singoli valori addizionati possono scostarsi leggermente dal totale
2 Ponderazione speciale UFAG:uguale ripartizione in base alle classi di dimensione dell’economia domestica per le economie domestiche attive in comuni rurali
( )Il risultato non può essere pubblicato siccome il numero delle registrazioni è insufficiente
(28) Valore con varianza marcata:coefficiente di variazione > 10%
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 66
Distribuzione percentuale delle economie domestiche24,0 18,1 4,1 1,8 Persone per economia domestica3,72 3,67 3,90 3,81 Uscite mensili per economia domestica in franchi (media)8 690 8 557 10 674 5 562 Struttura delle usciteImporto in fr.al mese Derrate alimentari e bevande analcoliche867 855 929 849 Prestazioni in natura sotto forma di derrate alimentari e bevande analcoliche(34) (21) ( ) 187 Bevande alcoliche e tabacchi96 91 ( ) ( ) Abbigliamento e scarpe282 294 287 ( ) Abitazione ed energia1 439 1 466 1 682 614 Arredamento e corrente gestione della casa (296) (289) (346)(259) Cure mediche272 282 (255)( ) Trasporti637 609 (908)(312) Telecomunicazioni 153 155 156 (132) Divertimento,svaghi e cultura541 553 616 (260) Tasse scolastiche e per la formazione prof.(28)(25) ( ) ( ) Ristorazione ed alloggio503 498 (623) (286) Altre merci e prestazioni192 203 177 (113) Uscite per il consumo5 307 5 320 6 178 3 230 Assicurazioni2 133 2 163 2 291 1 479 Contributi alle assicurazioni sociali da parte delle persone attive992 1 049 997 (410) Cassa malati:assicurazione di base457 455 448 495 Assicurazione privata infortuni e malattia: assicurazione complementare138 132 162 (141) Altri contributi assicurativi personali e dell’economia domestica546 526 685 (433) Imposte e tasse(1 091) 932 (1 962)736 Contributi,donazioni e trasferimenti158 143 (242)(116) Uscite da trasferimento3 382 3 238 (4 496) 2 332
Uscite delle economie domestiche in franchi
■ ...e consumo scarso Struttura 1 Comuni rurali – econ.dom.attive 2 Comuni rurali – lavor.dipendenti 2 Comuni rurali – lavor.indipendenti 2 Comuni rurali –agricoltori 2
Fonte:UST
■ Conclusioni
Visto il livello basso di reddito e considerate le dimensioni dell’economia domestica,le uscite delle economie domestiche rurali sono più esigue rispetto a quelle dei gruppi di confronto.In parte la differenza è riconducibile alle particolarità delle economie domestiche rurali.Una notevole differenza è osservabile per quanto riguarda le uscite nell’ambito dell'alloggio e dell’energia.Nel caso delle economie domestiche rurali questi costi scendono di 800–1'000 franchi al mese.Ciò è dovuto al fatto che l’abitazione fa parte dell’azienda e quindi,generalmente,ha potuto essere ripresa al valore di reddito.Ne consegue che anche il valore locativo è più basso.Per quanto riguarda le uscite legate alle derrate alimentari e alle bevande analcoliche va osservato che sono prese in considerazione pure le prestazioni in natura ossia l’autoapprovvigionamento con prodotti della stalla e dell’orto.Questi prodotti vengono valutati in base ai prezzi dei negozi.Per queste voci le uscite effettive di una famiglia contadina si riducono di 187 franchi ovvero del 22 per cento.Nelle economie domestiche di confronto le prestazioni in natura sono notevolmente più esigue.Un’altra peculiarità delle economie domestiche rurali è che l’abitazione e il luogo di lavoro sono vicini o addirittura coincidono.Di conseguenza i costi del tragitto casa-lavoro e per i pasti fuori casa non incidono sul bilancio.Le uscite più basse per trasporti,ristorazione e alloggio potrebbero essere dovute proprio a suddette circostanze.Il livello basso del reddito delle economie domestiche rurali comporta una significativa riduzione delle uscite da trasferimento – da 900 a 2'100 franchi al mese rispetto alle economie domestiche di confronto – segnatamente delle imposte e dei contributi alle assicurazioni sociali (scala contributiva regressiva).
I dati scaturiti dalla rilevazione del reddito e del consumo 2002 mostrano che,considerando le dimensioni dell’economia domestica,il reddito delle economie domestiche rurali interpellate è notevolmente inferiore a quello delle economie domestiche di confronto residenti in comuni rurali.

Se il livello di reddito delle economie domestiche rurali è basso,anche le uscite sono più contenute.Circa due terzi di questa differenza rispetto alle economie domestiche di confronto possono essere ricondotti da un canto alle peculiarità delle economie domestiche rurali – alloggio meno costoso,autoapprovvigionamento con prodotti della stalla e dell’orto,breve tragitto casa-lavoro,nessun costo per pasti fuori casa
e dall'altro alle minori spese da trasferimento (imposte e contributi alle assicurazioni sociali) determinate dal fatto che i redditi delle economie domestiche rurali sono più modesti.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 67
–
Offerte cantonali per le famiglie contadine in difficoltà
Tra i principali elementi dell’identità contadina rientra la volontà di essere e di rimanere autonomi e indipendenti.Per molte famiglie contadine è molto difficile parlare apertamente dei problemi e delle preoccupazioni che li affliggono.Spesso i contadini come pure l’ambiente circostante associano l'ammissione delle difficoltà al fallimento professionale.
Nella Svizzera tedesca è attivo dal 1996 un servizio di assistenza telefonica anonima al quale i contadini e i loro familiari possono rivolgersi per parlare liberamente dei propri problemi e timori.Dal 2001,nel Cantone Ticino,alla rubrica «Telefono amico per contadine,contadini e i loro famigliari» del programma annuale di perfezionamento professionale in ambito agricolo viene pubblicato il numero telefonico del servizio di consulenza agricola.Nella Svizzera francese una linea telefonica speciale per le famiglie contadine sarà introdotta a breve.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 68
Offerte cantonali esistenti
Breve descrizione
Dal 1997.Programma di pronto intervento di Prométerre per le famiglie contadine in difficoltà finanziarie.Gli interlocutori sono tre consulenti. È disponibile una rete di rappresentanti di banche.
Dal 1998.Gruppo di lavoro (consulenza,camera dell’agricoltura,cassa di credito,Ufficio delle opere sociali) finalizzato alla consulenza e al sostegno alle famiglie contadine in difficoltà finanziarie.
Dal 1999.Triplo concetto di assistenza e aiuto:individuazione del problema,analisi e proposte,assistenza.Gli interlocutori sono consulenti. È disponibile una rete di esperti.
Offeni
Dal 2000.Il servizio di consulenza sostiene le famiglie contadine in gravi difficoltà.L'antenna passa il caso al membro del team di consulenza specializzato nella rispettiva problematica (agronomo,contadina,teologo,medico,giurista).
Dal 2001.Le famiglie contadine vengono sostenute nella difficile fase del mutamento strutturale.Ogni consulente di una sede di Inforama si occupa dell'antenna. È disponibile una rete di esperti.
Dal 2002.Gli interlocutori sono due consulenti che aiutano le aziende contadine nella difficile fase del mutamento strutturale.L’offerta comprende anche un servizio di consulenza familiare.
Dal 2003.Una rete di 17 interlocutori offre assistenza ed aiuto.La Commissione Aspetti sociali dell’Associazione dei contadini turgoviesi coordina le offerte nel settore della prevenzione dei problemi sociali.
Dal 2003.Esiste un'antenna e gli interlocutori sono sei consulenti: consulenza specifica e stretta collaborazione con associazioni contadine,istituti di credito,enti assistenziali,ecc.
Dal 2003.L'antenna analizza la situazione e garantisce,laddove necessario,il contatto con un membro del team di consulenti (psicologo,agronomo,parroco,consulente,giurista,contadina).
Dall’autunno 2003.Gli interlocutori sono quattro consulenti.In gruppi di due,i consulenti assistono e coadiuvano le famiglie contadine.
Nel Cantone Neuchâtel,dall’autunno 2004 è attivo un gruppo pilota denominato «politique sociale agricole».Nel Cantone Argovia verrà introdotto prossimamente un servizio di consulenza per famiglie contadine in difficoltà.Nel Cantone Svitto si stanno mettendo a punto nuove offerte ed è già stato istituito un gruppo di progetto con rappresentati di diverse istituzioni.In altri Cantoni,alle famiglie contadine che ricevono aiuti per la conduzione aziendale viene fornita assistenza sull'arco di diversi anni.Nel Canton Giura i compiti del capoazienda e del consulente sono fissati in un contratto.
Interlocutore Ph.Rossy 021 614 24 33 A.Alter 027 606 75 85 B.Kull 026 305 58 16 R.Angst 01 869 21 68 R.Heiniger 031 720 12 18 M.Vuilleumier 071 353 67 56 H.Hascher 071 622 44 22 S.Hohl 071 886 70 27 U.Stutz 079 675 59 66 J.Muri 041 618 40 08 Nome Cellule de crise Gruppo di lavoro «conseil financier» AED – Aide aux Exploitations en Difficulté
Wegweiser für Bauernfamilien in Notlagen Offeni Tür Offeni Türe Kompass – Neue Wege in der Landwirtschaft Cantone VD VS FR ZH BE AR TG SG LU NW
Tür Inforama – AufWind: Hürden überwinden Weitblick – Bauernfamilien orientieren sich im Zeitwandel
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 69
Numerosi consulenti aziendali possono attingere a un'esperienza professionale pluriennale e sono particolarmente competenti in ambito sociale.Per tale motivo svolgono spesso compiti che vanno ben oltre la mera attività di consulenti,benché non vi sia un'offerta istituzionalizzata.Le centrali di formazione e consulenza agricola offrono corsi specifici come ad esempio «ARC – Ponti per il futuro».Grazie a questi corsi di perfezionamento professionale i contadini e le contadine acquisiscono strumenti e basi decisionali utili per strutturare attivamente e durevolmente lo sviluppo dell'azienda prima che sorgano delle difficoltà
I servizi cantonali di consulenza agricola dispongono raramente delle competenze necessarie per analizzare e trattare questioni sociali,familiari e interpersonali.La consulenza tradizionale non è generalmente in grado di affrontare e risolvere da sola questo genere di problemi.Nella maggior parte dei casi i singoli servizi specializzati, pur essendo disposti ad assistere le famiglie contadine,non possiedono le conoscenze specifiche sulla situazione e sulle peculiarità dell’ambiente rurale.Per tale motivo sono state create delle reti che nel frattempo sono diventate il carattere distintivo di queste offerte.
Oltre al suddetto elemento vi sono determinati principi che caratterizzano tutte le offerte a favore delle famiglie contadine in situazioni difficili:
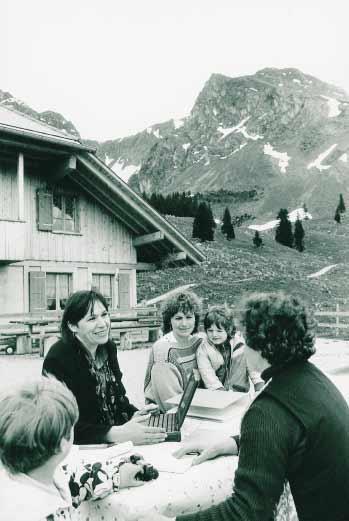
– la famiglia contadina deve svolgere un ruolo attivo,ossia deve rivolgersi alle antenne ed in seguito contattare ulteriori servizi specializzati;
– la consulenza non è per principio gratuita;prestazioni speciali,come alcune terapie, devono essere pagate dalle persone che richiedono assistenza.Il finanziamento della consulenza da parte degli interessati è uno degli elementi che dovrebbe portare alla soluzione del problema in quanto i contadini non hanno l’impressione di essere dei semplici questuanti;
– le persone che svolgono una funzione nell’ambito di queste offerte si impegnano a contribuirvi al massimo.
Emergono tre tipi di offerte,destinate alle famiglie contadine in situazioni difficili,per la soluzione di problemi prettamente finanziari,prettamente sociali e sociofinanziari. Siccome non è possibile operare una chiara distinzione tra le offerte,la classificazione è effettuata in base al principale campo d'intervento.
Di seguito vengono esaminate più dettagliatamente le offerte istituzionalizzate esistenti.Le informazioni sono state raccolte in collaborazione con i rappresentanti e gli interlocutori delle offerte cantonali.Viene inoltre tracciato il profilo della famiglia contadina tipo,che ricorre a queste offerte.
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 70
■ Consolidamento di tre tipi di offerte
■ Offerte per problemi prettamente finanziari
Le offerte che vertono essenzialmente sulla consulenza finanziaria mirano da un lato ad attuare misure immediate per far fronte ai problemi di liquidità e dall’altro a trovare una soluzione accettabile che permetta alla famiglia contadina di vivere e svolgere la propria attività senza l’aiuto di terzi.
L’offerta «Cellule de crise» di Prométerre,nel Canton Vaud,si è specializzata nella consulenza in caso di difficoltà finanziarie.L’idea di creare questo servizio è nata dall’istituto di credito agricolo dopo aver scoperto che alcuni dei suoi clienti dovevano far fronte a ristrettezze economiche.Prométerre,in seno a cui sono riuniti la Camera dell’agricoltura,il servizio di consulenza e l'associazione agricola (Fédération rurale vaudoise),ha raccolto questa sfida e ha creato un’offerta di consulenza con i mezzi a sua disposizione.La stessa Prométerre è una rete che dispone delle competenze economico-aziendali e giuridiche necessarie alla consulenza.I tre interlocutori della «Cellule de crise»,impiegati complessivamente al 150 per cento circa,hanno anche contatti informali con diverse banche.La procedura di consulenza è disciplinata in maniera chiara.L’azienda che richiede un aiuto finanziario viene innanzitutto analizzata dettagliatamente.In seguito vengono elaborate soluzioni sostenibili.Il personale della «Cellule de crise» collabora strettamente con il capoazienda.Laddove necessario, l’azienda viene seguita per diversi anni,in modo da evitare ricadute.In circa un quarto dei casi finora trattati non è stato possibile trovare una soluzione e l’azienda ha dovuto essere chiusa.Ogni anno vengono trattate un centinaio di pratiche.Dall’inizio dell'attività ne sono state evase 735 (stato marzo 2004).
Nel Cantone Vallese alla fine del 1998 è stato istituito il gruppo di lavoro «conseil financier».Le finalità previste sono la consulenza ed il sostegno alle famiglie contadine in difficoltà finanziarie.Il gruppo è composto da rappresentanti del servizio di consulenza agricola,della camera dell’agricoltura,della cassa di credito agricola nonché dell’Ufficio delle opere sociali (Service de l’action sociale) e si avvale di buoni contatti con le banche.In caso di richiesta d’aiuto finanziario da parte di una famiglia contadina – di norma per indebitamento eccessivo – viene svolta un’ispezione presso l’azienda,che prevede l’analisi dei dati d’esercizio e contabili.Infine,in seno al gruppo di lavoro vengono discusse le eventuali soluzioni e viene stabilita l’ulteriore procedura (ristrutturazioni,ammontare del credito,ecc.).L’aiuto finanziario viene concordato sotto forma di credito d’investimento nel quadro di un preventivo speciale per le famiglie contadine in difficoltà finanziarie.Dal canto suo,il capoazienda si impegna a tenere la contabilità in maniera dettagliata e a presentarla regolarmente.Ogni anno vengono aperte una decina di pratiche.Nel 2000 e nel 2001 sono stati trattati una quarantina di casi l’anno.
Nel quadro dell’attuazione della riforma agraria è emerso che in futuro una parte dei contadini del Cantone Friburgo potrebbe richiedere una consulenza altamente specifica e tecnica mentre gli altri potrebbero necessitare di consulenza per poter affrontare le sfide della nuova politica agricola.Per questo è stata concepita l’offerta «AED – Aide aux Exploitations en Difficulté»,che in linea di principio opera nella maniera seguente: i due interlocutori del servizio di consulenza ricevono le richieste e coordinano l’ulteriore procedura,attorno alla famiglia che richiede aiuto viene posto uno schermo di protezione,si cerca di trovare una soluzione per i problemi più urgenti e infine,laddove necessario,vengono elaborate strategie per la riorganizzazione dell'azienda a medio e lungo termine.Inizialmente si voleva creare un sistema di allerta precoce sulla base dei dati contabili.Questo progetto è però naufragato per questioni legate alla protezione
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 71
dei dati e perché spesso le famiglie contadine non vogliono prendere coscienza dello stato di salute della propria azienda.Una volta all’anno si organizza un incontro cantonale al quale partecipano rappresentanti di servizi sociali,enti per la protezione degli animali e delle acque,istituti di credito,banche e altri servizi specializzati.In quell’occasione si discutono i problemi e le tendenze future.Una parte dei fondi iscritti nel preventivo della consulenza è riservata all’offerta «AED – Aide aux Exploitations en Difficulté».Le famiglie contadine devono partecipare ai costi della consulenza in funzione delle loro possibilità finanziarie.Ogni anno vengono trattate circa 30 pratiche.
Stress,esclusione dalla vita sociale,sviluppo di dipendenze,paura del fallimento e perdita di fiducia in se stessi,ostinazione e mancanza di flessibilità nonché paura del futuro sono fenomeni sociali che si riscontrano con sempre maggiore frequenza nell’ambiente agricolo.In tre Cantoni viene offerta assistenza specifica per problemi sociali.
Nel Cantone Zurigo,dal 2000 è attiva l’offerta «Offeni Tür» di cui sono responsabili le associazioni cantonali dei contadini e delle contadine. «Offeni Tür» è quindi un’iniziativa cui partecipano enti privati,nella speranza di poter abbattere il muro dell’inibizione e spingere le famiglie contadine a rivolgersi a questa struttura.L’obiettivo è sostenere le famiglie contadine in gravi difficoltà.Il team di consulenti,composto attualmente da due medici in pensione di estrazione agricola,due padri spirituali,due agronomi – di cui uno anche giurista –,due collaboratori della centrale di consulenza agricola di Lindau,una contadina e dal responsabile del team di consulenti,sostiene i contadini bisognosi direttamente in loco e senza troppe formalità oppure in un luogo d’incontro discreto.Il gruppo di consulenti costituisce una vera e propria rete i cui membri si incontrano ogni quattro mesi o a seconda delle necessità.Nelle riunioni vengono discussi i casi e fatto il punto sullo stato della consulenza.I problemi vertono soprattutto sui conflitti tra generazioni e tra partner.Appare chiaro che nella sfera interpersonale,ed in particolare per quanto concerne i conflitti tra partner,spesso si attende troppo a lungo prima di ricorrere ad un aiuto esterno.Ogni anno vengono trattate circa 35 pratiche.Dal 2000 ne sono state evase 142 (stato marzo 2004).
L’offerta «Weitblick»,nel Cantone Appenzello Esterno, è gestita dal servizio di consulenza agricola,che ha pure lanciato questa iniziativa.Le organizzazioni agricole non sono coinvolte.Il fattore che ha determinato l'istituzione di questa offerta è stato il moltiplicarsi dei casi problematici.In sede di consulenza talvolta emergevano forti tensioni all’interno della famiglia.In risposta all’interrogativo su come affrontare queste problematiche che esulano dalla mera consulenza aziendale è stata ideata l’offerta «Weitblick – Bauernfamilien orientieren sich im Zeitwandel».L’obiettivo è mettere in risalto le risorse e le possibilità dei singoli membri della famiglia.Ciò dovrebbe agevolare anche la presa di decisioni.Le famiglie che richiedono una consulenza possono contattare uno dei due interlocutori – entrambi consulenti con formazione in terapia della famiglia – per concordare un primo colloquio volto ad approfondire la conoscenza reciproca e a chiarire la situazione aziendale e familiare.In un secondo colloquio vengono valutate le possibili soluzioni,con la partecipazione attiva della famiglia,la quale deve formulare i propri obiettivi che dovrà anche realizzare.Le capacità dei singoli membri della famiglia vengono tenute in considerazione nel processo di adeguamento.Insieme si scoprono aspetti nuovi e si rafforza la fiducia nel proprio futuro personale.Ogni anno vengono trattate circa 4 pratiche.
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 72
■ Offerte per problemi prettamente sociali
Per circa quarant'anni,ossia fino alla fine degli Anni ’90,nel Cantone Lucerna due frati cappuccini hanno fornito assistenza spirituale ai contadini.Da allora la creazione di un centro di assistenza spirituale per i contadini è diventata un tema d'attualità in questo Cantone.Dal 2003 è attivo il servizio «Offeni Türe» di cui è responsabile l'associazione dei contadini di Lucerna.Con esso collabora il dipartimento delle opere sociali,il dipartimento dell’economia e alcune fondazioni d’interesse pubblico.L’offerta del Cantone Lucerna si rifà al modello zurighese. «Offeni Türe» è un'antenna privata per le famiglie contadine che vivono tensioni interpersonali,conflitti nella convivenza o difficoltà economiche.Di comune accordo con la famiglia interessata viene richiesto l’aiuto di un esperto del team di consulenti.Questo team è composto da un padre spirituale,uno psicologo,un giurista,una contadina e un rappresentante del servizio di consulenza aziendale.Nella maggior parte dei casi i problemi riguardano i conflitti tra generazioni e tra partner.I problemi relazionali sono talvolta riconducibili a dipendenze. «Offeni Türe» offre un valido sostegno anche per affrontare le proprie ansie e paure.La consulenza è,per principio,gratuita.Le terapie,invece,sono a pagamento. Nel 2003 sono stati trattati una trentina di casi,di cui sei complicati e onerosi.
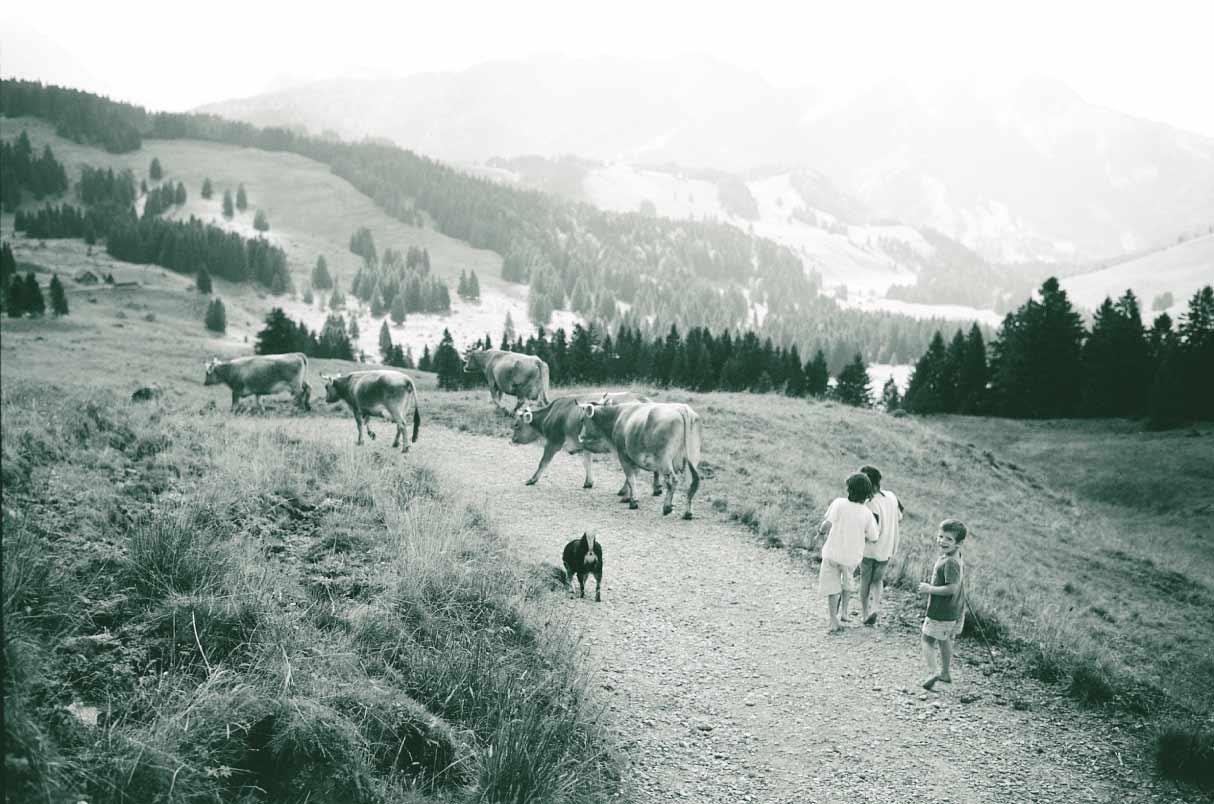
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 73
■ Offerte per problemi sociofinanziari
In una situazione difficile spesso non è a rischio soltanto l’esistenza dell’azienda,bensì anche il matrimonio e la famiglia.A lungo andare i problemi finanziari esercitano una forte pressione sulla famiglia.Alcuni Cantoni,a questo proposito,offrono un servizio ampio e strettamente interconnesso.
Nel Cantone Berna ogni consulente agricolo dei sei centri Inforama dislocati in varie aree cantonali è responsabile della consulenza a famiglie contadine in difficoltà. Attualmente «AufWind»,l’offerta originaria,viene rielaborata e standardizzata per tutto il territorio cantonale,ampliata e meglio coordinata.Nal 1997 la fiduciaria agricola AgroTreuhand ha elaborato le linee guida per la diagnosi precoce di difficoltà finanziarie.Questo sistema di allerta precoce non è tuttavia offerto e utilizzato in tutto il Cantone.I consulenti fungono da interlocutori.A seconda dei casi indirizzano le famiglie contadine verso altri specialisti come ad esempio medici,psichiatri,servizi sociali o Comuni.Molto spesso le aziende alla ricerca d’aiuto sono confrontate con tutta una serie di situazioni difficili.Di norma le famiglie contadine non vogliono avere nulla a che fare con i servizi sociali,anche se avrebbero diritto a un sostegno.Per la consulenza e l’assistenza le famiglie contadine versano un contributo simbolico. Alcune famiglie,dopo un certo periodo,si rivolgono nuovamente al servizio di consulenza.Complessivamente nel Cantone Berna (escluso il Giura bernese) vengono trattati circa 100 casi all’anno.
Nel Cantone Turgovia esiste una rete di 17 interlocutori ed esperti che forniscono assistenza in casi d’emergenza.La Commissione Aspetti sociali dell’associazione dei contadini turgoviesi coordina le offerte in materia di prevenzione dei problemi sociali. Il servizio «Wegweiser»,per le famiglie contadine in situazioni difficili,illustra le offerte esistenti e motiva le famiglie a cercare una soluzione alle proprie difficoltà.L'offerta di servizi comprende la consulenza generica,quella finanziaria,assicurativa e giuridica nonché la consulenza familiare,spirituale ed aziendale.L’eventuale accesso a ulteriori aiuti,come i servizi sociali del Comune, è garantito dagli interlocutori o da un esperto. Spesso un semplice scambio di idee fra colleghi consente di trovare una soluzione al problema.Siccome non si chiede se chi si rivolge ad un'antenna lo ha fatto dopo aver letto gli opuscoli informativi,non è dato di sapere quanti casi possono essere attribuiti al servizio «Wegweiser»
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 74
Dal 2003 la consulenza agricola del Cantone San Gallo offre un nuovo servizio nel quadro del proprio mandato di consulenza. «Offni Tür» è un’iniziativa a favore dei contadini che,a causa di una situazione particolare caratterizzata da un onere insopportabile,ricorrono alla consulenza e al sostegno specifici.Questa offerta è promossa in collaborazione con organizzazioni quali l’associazione dei contadini di San Gallo, l’istituto di credito agricolo e l’associazione di consulenza e contabilità dei Cantoni San Gallo e Appenzello. «Offni Tür» fornisce assistenza per far fronte ai problemi personali e finanziari che toccano le famiglie contadine.Un'antenna agevola i contatti.Il team di sei consulenti assicura una stretta collaborazione con autorità e istituzioni competenti in materia o che possono contribuire alla soluzione del problema.In linea di massima, le prestazioni vengono fatturate secondo le tariffe applicate normalmente per servizi di consulenza.Per i casi sociali vengono comunque fatte delle eccezioni.
Aspetti trattati da «Offni Tür – San Gallo» da marzo a dicembre 2003
Problemi coniugali,separazioni,divorzi19 Chiarimenti in materia di rendita AI e aiuti36 Adeguamenti e disdette di contratti d'affitto6 Chiarimenti sull’assistenza sociale6
1 Il servizio di consulenza e l'istituto di credito agricolo hanno fornito un sostegno rispettivamente per almeno 30 e 20 casi circa 2Non sono comprese numerose richieste di informazioni telefoniche
Fonte:Servizio di consulenza agricola del Cantone San Gallo
Nel Cantone di Untervaldo Sottoselva dall'autunno 2003 esiste l'offerta di consulenza individuale «Kompass – Neue Wege in der Landwirtschaft».Il progetto,di cui è responsabile il servizio cantonale d’agricoltura, è promosso dall'associazione cantonale delle contadine e dei contadini nonché dal Forum Untervaldo Sottoselva.Gli interlocutori sono quattro consulenti.L'offerta «Kompass» è destinata a un ampio gruppo: famiglie contadine che intendono strutturare la propria azienda in funzione delle esigenze future o con formazione di capitale proprio insufficiente,ma anche famiglie contadine con problemi di salute o famigliari oppure confrontate con gravi difficoltà sul piano economico e sociale.La consulenza viene fornita da due persone (un uomo e una donna) coinvolgendo l'intera famiglia contadina.Nel caso di aziende in gravi difficoltà finanziarie vi è una stretta collaborazione con i sevizi sociali del Comune e con enti assistenziali.Durante la fase iniziale,che si protrarrà fino al 2005, «Kompass» offrirà i suoi servizi al prezzo forfettario di 200 franchi.Per i casi sociali,la consulenza è gratuita.Nel primo semestre sono stati trattati sei casi,uno dei quali riguardava una famiglia contadina in gravi difficoltà
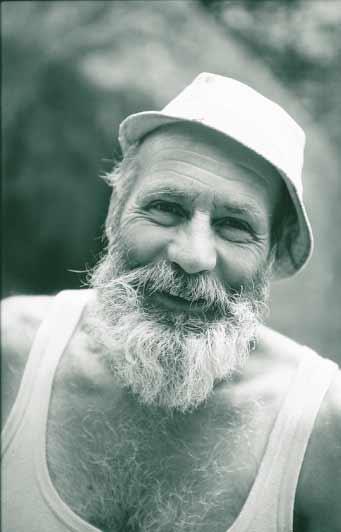
Timori per il futuro5 Riconversione aziendale per malattia2 Difficoltà finanziarie 1 2 Totale 2 76
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 75
■ Chi usufruisce delle offerte di consulenza?
Chi sono le famiglie contadine che ricorrono a queste offerte di consulenza? È possibile individuarne le caratteristiche tipiche? Perché usufruiscono delle offerte cantonali? Sebbene non sia possibile fare una tipologia delle famiglie contadine in difficoltà,si può tuttavia tracciare a grandi linee le principali caratteristiche familiari e aziendali.
Concomitanza di problemi: In parte il problema delle aziende alla ricerca d’aiuto nasce dall’accumularsi di situazioni difficili:difficoltà e ristrettezze finanziarie,alcolismo e altri problemi di salute,depressione,cattiva formazione scolastica e isolamento.Chi ne è colpito è spesso incapace di reagire e teme il fallimento personale o il giudizio di fratelli o vicini.Molto spesso non è facile distinguere la causa dall’effetto.Se le famiglie contadine decidono troppo tardi di ricorrere ai servizi offerti,la consulenza e l’assistenza risultano particolarmente difficili.
Pressione eccessiva dovuta alla riforma agraria: Alcuni contadini non riescono ad adeguarsi alla nuova politica agricola.La gestione dell'azienda diventa sempre più impegnativa,visto che ci sono sempre più aspetti di cui occuparsi.Pur essendo sicuramente dei lavoratori instancabili,questi contadini non sono né contabili né esperti in economia aziendale.Si sentono con le spalle al muro e trattati ingiustamente.La loro identità contadina è minata.Se in passato un contadino conosceva bene il proprio mestiere ed era senza pretese poteva gestire con successo la propria azienda.Ora ciò non basta più.Nelle regioni di montagna le famiglie contadine sono da sempre confrontate con un ambiente statico e isolato. È quindi difficile cambiare atteggiamento dall’oggi al domani.
Ristrutturazioni: Confrontati con difficoltà finanziarie,molti agricoltori tendono a lanciarsi in imprese avventate:aumentano la produzione,riducono i costi licenziando personale,avviano un’attività a titolo accessorio,si danno alla vendita diretta o si dedicano all'agriturismo.Nella maggior parte dei casi le famiglie contadine sottovalutano le conseguenze di queste ristrutturazioni.Una tra le tante è l’eccessivo carico di lavoro.Nel caso della riconversione dalla produzione lattiera alla detenzione di vacche madri,ad esempio,alcune aziende possono incontrare problemi di liquidità dovuti al fatto che il denaro proveniente dalla produzione lattiera viene repentinamente a mancare,mentre per il ricavo proveniente dalla detenzione di vacche madri occorre aspettare qualche tempo.Altre aziende sottovalutano l'onere dell'investimento,non controbilanciato da entrate sufficienti.
Divorzi e conflitti generazionali: Un divorzio – in particolare nell’agricoltura –comporta spesso il rischio di scivolare nella povertà.Oltre a determinare obblighi finanziari a lungo termine,in alcuni casi la fine del matrimonio coincide con il declino dell’azienda.In caso di conflitti tra generazioni e problemi di coppia le donne si rivolgono ai centri di consulenza più spesso degli uomini,che mostrano una certa ritrosia nel parlare dei propri problemi.
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 76
Aziende sull’orlo della chiusura: I responsabili di aziende sull’orlo della chiusura che si rivolgono ai servizi di consulenza in cerca di aiuto sono spesso celibi e di età compresa tra i 50 ed i 60 anni.Di norma reagiscono quando il problema è già in fase avanzata e,colti dal panico,vogliono sapere se possono continuare a lavorare fino all’età del pensionamento.Sono consapevoli di non avere più alcuna possibilità sul mercato del lavoro e che l’azienda resta il loro unico punto fermo.

1.2 ASPETTI SOCIALI 1 77
Le offerte destinate alle famiglie contadine in situazioni difficili si sono dimostrate valide alternative per far fronte ai problemi sociali nell’agricoltura in maniera efficace e concreta.Si basano su competenze specifiche e nella maggior parte dei casi fanno capo a strutture organizzative già esistenti.Un elemento importante è l’interconnessione delle competenze e/o delle organizzazioni.In tal modo la consulenza agricola beneficia delle competenze specifiche di uno psichiatra e viceversa i responsabili dei servizi sociali possono far affidamento sulle conoscenze del consulente agricolo per quanto riguarda le peculiarità della realtà familiare e lavorativa contadina.
Alcuni casi trattati dai servizi di consulenza sono particolarmente onerosi in quanto la loro soluzione richiede molto tempo.Inoltre possono comportare anche un forte stress psicologico per la natura dei problemi trattati.La consulenza aziendale viene di norma affidata a consulenti esperti,che peraltro dovrebbero avere sempre anche una formazione specifica sui metodi più adatti per avviare e moderare un colloquio nonché per affrontare le situazioni conflittuali.I colloqui con i responsabili delle offerte di consulenza hanno mostrato che esse sono un valido sostegno in un periodo in cui il primario deve far fronte a profondi mutamenti.In vista di uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura è opportuno impiegare le risorse disponibili anche per seguire i casi problematici e non concentrarsi soltanto sulle aziende il cui futuro è garantito.
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 78
Conclusioni
■
La protezione dell'ambiente e della natura è uno dei capisaldi della politica agricola svizzera.Nel presente capitolo vengono trattati i temi «azoto» e «acqua».

Il monitoraggio agroecologico è la risposta a quanto sancito dall'ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118) in materia ambientale.Gli indicatori agroambientali alla base di tale monitoraggio possono essere classificati in sei ambiti (azoto,fosforo,energia-clima,acqua,suolo,biodiversità-paesaggio) e sono di tre tipi (pratica agricola,ripercussioni dell'agricoltura sull'ambiente,stato dell'ambiente in relazione all'agricoltura).
Considerati i probabili sviluppi in relazione alla metodologia e i dati statistici,attualmente il monitoraggio contempla indicatori operazionali e indicatori sostitutivi.
Come ogni anno,anche in questo rapporto viene illustrata l'evoluzione dello sfruttamento del suolo e dell'utilizzo dei mezzi di produzione.
■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3
Ecologia ed etologia ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3.1 Ecologia
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 79
Evoluzione della quota di superficie gestita in modo rispettoso dell'ambiente In % della SAU Gestione rispettosa dell'ambiente 1 Di cui bio Fonte: UFAG 1 1993–1998: PI + Bio; dal 1999: SCE 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 2003 Evoluzione delle superfici di compensazione ecologica 1 19931994199519961997199819992000200120022003 In 1 000 ha ZM III – ZM IV ZM I – ZM II ZCamp – ZC Fonte: UFAG 1 Esclusi gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Evoluzione dell'effettivo di animali 199019961997199819992000200120022003 In 1 000 UBG 1 Altri Suini Bovini Fonte: UST 1 UBG: unità di bestiame grosso 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 80
Sfruttamento del suolo e utilizzo dei mezzi di produzione

Evoluzione del consumo di concimi minerali In 1 000 t Azoto (N)Fosfato (P205) Fonte: USC 1990/9219941996199820002002 19931995199719992001 0 80 70 60 50 30 40 20 10 2003 Evoluzione del consumo di alimenti concentrati per animali 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003 (provv.) In 1 000 t Sottoprodotti dell'industria agroalimentare svizzera Cereali da foraggio CH Sottoprodotti dell'industria agroalimentare estera Alimenti importati per animali Fonte: USC 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 81

Evoluzione delle vendite di prodotti fitosanitari 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003 In t di principio attivo Fungicidi, battericidi, prodotti per la concia delle sementi Erbicidi Insetticidi, acaricidi Regolatori della crescita Rodenticidi Fonte: Società svizzera dell'industria chimica 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500
delle importazioni di antibiotici ad uso veterinario 19951996199719981999200020012002 In t di principio attivo Sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali Singolo animale Alimenti medicamentosi Fonte: Statistica sulle importazioni per l'approvvigionamento economico del Paese 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 82
Evoluzione
■ L'azoto è il «carburante» della produzione agricola
L'azoto (N)
Per prosperare piante e rispettivi ecosistemi necessitano di luce,acqua,calore e nutrienti di diversi tipi.Tra questi,l'azoto riveste un significato determinante.Quasi ovunque sul territorio nazionale l'azoto è il nutriente all'origine di rese esigue perché è disponibile in quantità molto limitate.L'apporto di azoto determina quindi la resa delle colture vegetali.Di conseguenza esso rappresenta un importante fattore di produzione per il settore primario.
L'azoto è un abile trasformista e può essere un carico inquinante per l'ambiente
Forme di N, flussi di N ed effetti
Fonti
Traffico, economie domestiche, industria, artigianato Agricoltura
Forme di NEffettiRipercussioni
Crescita Resa
Eutrofizzazione
Acidificazione
Danni alla salute
Colture agricole
Fonti naturali
NH3 : ammoniaca
NO2 : ossido d'azoto
NH4 : ammonio
NO3 : nitrato
N2O : gas esilarante
N2 : azoto elementare
Effetto serra Assottigliamento dello strato d'ozono
Nessun effetto
Falda freatica
Ecosistemi terrestri (boschi, suolo)
Fonte: UFAG
Laghi
Aria
Uomo
N2 NH3 NO2 N2O NH4 NO3
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 83
■ L'agricoltura è la principale fonte d'emissione di ammoniaca,nitrati e gas esilarante
L'azoto ha un ciclo complesso ed è un vero e proprio trasformista.Una parte dell'azoto impiegato nell'agricoltura si fissa nei prodotti vegetali ed animali oppure si deposita nella sostanza organica del suolo,mentre il resto è improduttivo e si disperde.Se ciò avviene sotto forma di azoto elementare (N2) vi è una perdita per il primario,ma nessuna ricaduta sull'ambiente.L'azoto che si disperde sotto forma di ammoniaca (NH3),nitrato (NO3) o gas esilarante (N2O),invece,può rappresentare un carico inquinante per aria,acqua,suolo,biocenosi ed ecosistemi particolarmente sensibili quali boschi,torbiere alte e prati magri.Le conseguenze sono:acidificazione e sovraconcimazione del suolo,eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiali,inquinamento della falda freatica,assottigliamento dello strato d'ozono nella stratosfera (buco dell'ozono) e aggravamento dell'effetto serra.L'ammoniaca concorre pure alla formazione di aerosol secondari nell'atmosfera.Queste polveri fini (PM10) costituiscono un pericolo per la salute umana (cfr.Rapporto agricolo 2003).Inoltre,durante i processi di combustione viene emesso ossido d'azoto (NO2) che contribuisce all'accumulo di azoto e alla formazione di ozono alla superficie del suolo.L'ozono è un gas irritante che può nuocere alla salute di piante,animali ed esseri umani.
Nelle pagine seguenti i principali composti azotati rilevanti per l'ambiente vengono classificati quantitativamente in funzione delle fonti d'emissione.Successivamente vengono presentati gli accordi internazionali e illustrati gli obiettivi fissati per l'agricoltura svizzera in vista della riduzione delle emissioni.Vengono pure riportati alcuni risultati sulle emissioni di azoto di origine agricola in base al bilancio azotato e illustrate le perdite di azoto cosiddette rilevanti per l'ambiente.Le due principali frazioni d'azoto prodotte dall'agricoltura e che si ripercuotono sull'ambiente,ossia ammoniaca e nitrato,vengono trattate esaurientemente in due capitoli speciali.Il resoconto termina con le conclusioni sul tema.
Su incarico del Dipartimento federale dell'economia (DFE) e del Dipartimento federale dell'interno (DFI),il gruppo di progetto «Bilancio dell'azoto in Svizzera» ha redatto un rapporto (serie di articoli sull'ambiente n.273,UFAFP 1996) che illustra le emissioni totali dei principali gruppi di composti azotati.L'agricoltura è la fonte primaria d'emissione di ammoniaca,nitrato e gas esilarante,ossia di composti rilevanti dal profilo ambientale.Sul piano ecologico rivestono un significato notevole anche l’ossido di azoto e l'ammonio,quest'ultimo perché può depositarsi nelle acque superficiali.Questi composti azotati sono emessi prevalentemente dal traffico,dalle economie domestiche,dall'industria e dall'artigianato.La metà circa delle perdite di azoto riscontrabili nel settore agroalimentare si presenta sotto forma di azoto elementare (dato non riportato nel grafico seguente).
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 84
Emissioni di azoto per settori – 1994
■ Gli obiettivi di riduzione dettati da motivazioni ecologiche possono essere raggiunti soltanto a lungo termine
Per proteggere esseri umani ed ecosistemi dagli effetti nocivi,deve essere ridotto il carico rappresentato dai principali composti azotati.Nel rapporto del 23 giugno 1999 sui provvedimenti di igiene dell'aria adottati da Confederazione e Cantoni,redatto all'attenzione del Parlamento,il Consiglio federale ha fissato quale obiettivo l'intervento a lungo termine.Per raggiungere gli obiettivi ecologici,le emissioni di ammoniaca vanno ridotte del 40–50 per cento rispetto allo stato del 1995.Come indicato nel rapporto,anche per l’ossido d'azoto la riduzione dovrebbe essere del 50 per cento circa.Gli obiettivi posti dal Consiglio federale per migliorare l'igiene dell'aria si riferiscono a tutte le emissioni di azoto.Le principali fonti d'emissione sono l'agricoltura per quanto concerne l'ammoniaca e le economie domestiche,l'artigianato e il traffico per quanto riguarda l’ossido d'azoto.Visti i sintomi di sovraconcimazione palesatisi nel corso degli Anni '80,gli Stati che si affacciano sul Mare del Nord e la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (CIPR) hanno deciso di ridurre al più presto (scadenza 2002/05) il carico di azoto nel Mare del Nord del 50 per cento rispetto al livello del 1985.Tale obiettivo si riferisce a tutte le emissioni di azoto, quindi non soltanto a quelle di cui è responsabile il settore primario.Nel 1985 il 52 per cento del carico di azoto era riconducibile a fonti puntuali (impianti di depurazione, industria),mentre il 48 per cento a fonti diffuse (tra cui agricoltura nella misura del 60–70%).Nel 2001 i valori ammontavano rispettivamente al 46 e al 54 per cento.Nel complesso il calo è stato del 22 per cento,quello in ambito agricolo del 18 per cento.
Per quanto riguarda le altre emissioni di azoto,il Consiglio federale non ha posto obiettivi di riduzione a lungo termine dettati da motivazioni ecologiche.Nel rapporto «Strategie per la riduzione delle emissioni di azoto» (serie di articoli sull'ambiente n.273,UFAFP 1996),la commissione istituita dal DFE e dal DFI indica la necessità di ridurre,a lungo termine,anche il carico di nitrato,segnatamente del 50 per cento (14'000–19'000 t di azoto) rispetto al 1994.Tale obiettivo è stato formulato in base alla valutazione del quantitativo di acqua d'infiltrazione nei suoli agricoli. È possibile raggiungere l'obiettivo posto dall'ordinanza sulla protezione delle acque pari a 25 mg di nitrato il litro soltanto se il quantitativo di azoto dilavato diminuisce in misura corrispondente.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 85
In 1 000 t N
Traffico, economie domestiche, industria e artigianato 43 4 2 37 51 3 8 3 34 1 6 12 AgricolturaFonti naturali 0 60 50 40 30 20 10 Ossido
Fonte: UFAFP
d'azoto Azoto nelle acque superficiali Ammoniaca Nitrato nella
falda freatica
Gas esilarante
Secondo le conoscenze attuali,se in Svizzera venissero raggiunti gli obiettivi ecologici, gli ecosistemi – e di riflesso persone ed animali – sarebbero protetti in modo durevole. Purtroppo questi obiettivi sono raggiungibili soltanto a lungo termine.Per tale motivo il Consiglio federale ha fissato obiettivi agroecologici parziali (messaggio concernente l'ulteriore sviluppo della Politica agricola 2002),che l'agricoltura è tenuta ad adempiere entro termini prestabiliti.
Tre dei sette obiettivi agroecologici fissati per il 2005 riguardano l'azoto.Concretamente vengono citati:
– il bilancio dell'azoto (riduzione di 22'000 t a 74'000 t d'azoto l'anno delle perdite d'azoto rilevanti per l'ambiente);
– le emissioni di ammoniaca (riduzione del 9% delle emissioni di ammoniaca,ossia circa 4'800 t d'azoto l'anno,rispetto al 1990);
il nitrato (nel 90% delle captazioni di acqua potabile,il cui settore d'alimentazione è sfruttato dall'agricoltura,il tenore di nitrato della falda freatica è inferiore a 40 mg/l).
I composti azotati rilevanti dal profilo ambientale prodotti dall'agricoltura svizzera comprendono tutte le emissioni di azoto del settore primario ecologicamente rilevanti (ammoniaca,nitrato,gas esilarante).Benché per i due principali composti,ossia ammoniaca e nitrato,siano stati formulati ulteriori obiettivi specifici,soltanto per l'ammoniaca vi è un obiettivo che prevede la riduzione effettiva del carico.Per il nitrato non è quindi possibile indicare un obiettivo di natura quantitativa per il 2005.
Per quanto riguarda l'ammoniaca,esiste una convenzione internazionale che impone alla Svizzera l'adozione di misure concrete.Un ulteriore obiettivo parziale consiste nella riduzione del 13 per cento entro il 2010 delle emissioni di ammoniaca giusta il Protocollo UN/ECE sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (base 1990).
–
■
In 1 000 t N Fonte: UFAFP Emissioni 1990 Emissioni 1994 Obiettivo agroecologico 2005 0 120 100 80 60 40 20
Obiettivi agroecologici quali obiettivi parziali Emissioni di azoto dell'agricoltura, obiettivi agroecologici parziali
Perdite di N dell'agricoltura rilevanti per l'ambiente
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 86
Ammoniaca Nitrato nella falda freatica
■ La produzione agricola è inscindibile dalle emissioni di azoto

Le emissioni nocive di azoto non potranno essere azzerate nemmeno a lungo termine. Nella produzione agricola vi sono processi biologici che comportano inevitabilmente delle perdite di azoto.Ogni vacca espelle sterco e urina.Una parte di queste deiezioni va persa sotto forma di ammoniaca.Qualsiasi tecnica di lavorazione del suolo comporta la riduzione del quantitativo di humus e la liberazione di nitrato.A dipendenza delle condizioni climatiche e pedologiche,una parte del nitrato finisce inevitabilmente nella falda freatica.Vi è quindi un legame inscindibile tra produzione agricola e perdite di azoto.
Mediante semplici accorgimenti tecnici (p.es.foraggiamento ottimale degli animali da reddito,spandimento del liquame mediante tubi flessibili,concimazione più conforme alle esigenze delle piante utili,ecc.) si potrebbero ridurre le emissioni di azoto al livello fissato nell'obiettivo agroecologico parziale.Qualora si volesse ridurre ulteriormente le emissioni,andrebbe prospettata l'adozione di misure tecniche più incisive (p.es.altre forme di trattamento dei concimi aziendali mediante separazione,fermentazione, desalinazione e osmosi nonché produzione di concimi che possono essere utilizzati come i concimi commerciali).Quale ultima ratio andrebbe considerata la riduzione dell'effettivo di animali.Tuttavia,misure di questo genere sono efficaci soltanto se diminuisce pure il consumo di prodotti di origine animale.In caso contrario il problema delle emissioni di azoto verrebbe soltanto spostato dalla Svizzera all'estero.Nei Paesi con bassa densità di animali l'aumento,entro determinati limiti,dell'effettivo di animali da reddito non è considerato ecologicamente pericoloso.
■ Le emissioni di azoto riconducibili all'agricoltura vengono rilevate in diversi modi
L'azoto è una sostanza estremamente complessa.Può presentarsi in diverse forme a tutti i livelli ambientali e muta costantemente.Non sorprende pertanto che si cerchi in diversi modi di rilevare il carico di azoto nell'agricoltura e di stabilirne l'impatto sull'ambiente.Ognuno di questi metodi presenta punti forti e punti deboli.Nei capitoli seguenti vengono descritti e commentati quelli principali.Non è possibile effettuare un confronto diretto fra i dati in quanto ogni metodo si fonda su basi diverse.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 87
Mediante il bilancio dell'azoto s'intende acquisire,nel modo più semplice possibile, una visione d'insieme sull'evoluzione delle emissioni e delle immissioni di azoto.Nel metodo utilizzato dall'OCSE «Bilancio dell'azoto sulla superficie del suolo» viene misurata la differenza fra il quantitativo totale di azoto apportato al suolo sull’arco di un anno (concimi aziendali,concimi a base di scarti riciclati,concimi minerali,fissazione biologica dell’azoto e depositi provenienti dall’aria) e quello sottrattovi da prodotti della campicoltura e della foraggicoltura.La principale fonte d'apporto è costituita dai concimi aziendali che rappresentano il 50 per cento dell'input totale.Il 25 per cento circa è dato dai concimi minerali e da quelli a base di scarti riciclati.Il rimanente 25 per cento proviene da altre fonti (soprattutto apporto attraverso l'aria e fissazione biologica dell'azoto).Il metodo dell'OCSE consente di evidenziare le fluttuazioni annue dei quantitativi di azoto sottratti al suolo.Tali fluttuazioni sono riconducibili alle variazioni della resa dei raccolti a seconda delle condizioni meteorologiche.Negli anni in cui il quantitativo di azoto sottratto al suolo è esiguo vi è un rischio elevato di emissioni di azoto consistenti.
Le immissioni agricole di azoto sono diminuite costantemente fino al 2000,successivamente hanno subito un'evoluzione discontinua.Nel 2001–2002 si è registrato un incremento delle immissioni di azoto,mentre nel 2003 vi è stato un tonfo a un nuovo livello minimo.Per quanto riguarda le emissioni agricole di azoto,le notevoli fluttuazioni che si riscontrano di anno in anno sono dovute alle condizioni atmosferiche. Analogamente a quanto è il caso per l'effettivo di animali,nel complesso si registra un calo della produzione di foraggio.Nel settore campicolo la produzione non ha subito variazioni di rilievo.Soltanto nel 2003,anno estremamente siccitoso,si è avuto un notevole calo delle rese.Quale conseguenza di queste evoluzioni inverse,dal 1990 ad oggi le eccedenze nel quadro del bilancio dell'azoto sono rimaste praticamente stabili, fissandosi a un livello di 70–80 chilogrammi per ettaro.
■
Bilancio di N per ha di superficie gestita Evoluzione dell'input e output di
del bilancio azotato secondo il metodo dell'OCSE 199019911992 19931994199519961997199819992000200120022003 Input di N Fonte: UST Output di N 0 300 250 200 150 100 50 Input e output di N in 1000 t Bilancio azotato in kg/ha 0 120 80 100 60 40 20 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 88
Bilancio dell'azoto secondo il metodo dell'OCSE
azoto nonché
Se si considera l'intero settore primario svizzero come un'azienda, è possibile analizzare l'evoluzione del quantitativo di azoto apportato al suolo e sul quale i contadini possono esercitare un influsso.Nel metodo OSPAR sono considerate immissioni soltanto quelle che giungono nel primario dall'esterno,come ad esempio gli alimenti importati per animali.In questa categoria non rientrano i concimi aziendali.Per quanto concerne i quantitativi di azoto sottratti al suolo viene considerato soltanto l'azoto utilizzato dall'agricoltura per la produzione di derrate alimentari di origine vegetale ed animale nonché di altri prodotti reperibili sul mercato.Non sono invece tenuti in considerazione il rendimento in foraggicoltura e gli altri alimenti per animali prodotti dall'agricoltore stesso.
del
Bilancio dell'azoto
Fissazione dell'azoto, depositi di azoto (precipitazioni)
Concimi minerali (agricoltura)
Importazioni di alimenti per animali e sementi Concimi a base di scarti riciclati, altri concimi
Tra il 1990 e il 1997 l'eccedenza del bilancio dell’azoto è diminuita considerevolmente. Da allora si registra tuttavia un lieve incremento riconducibile soprattutto alle crescenti importazioni di alimenti per animali.Ciò è in parte dovuto all'introduzione di alimenti proteici per animali in sostituzione delle farine di carne per le quali è stato sancito il divieto di valorizzazione (1996:5'000 t N circa). È aumentato nuovamente anche il consumo di concimi minerali azotati.Ciò potrebbe essere dovuto alla sostituzione dell'azoto proveniente dai fanghi di depurazione (1999:4'000 t N circa) il cui tasso di valorizzazione è diminuito considerevolmente in questi ultimi anni (per il momento non vi sono tuttavia dati affidabili al riguardo).
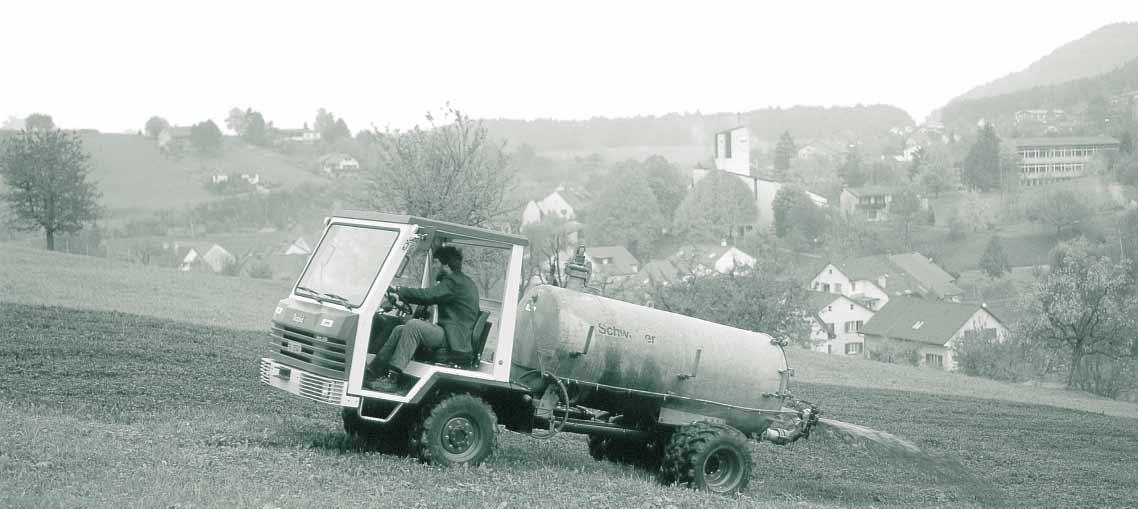 ■ Bilancio dell'azoto secondo il metodo dell'OSPAR
■ Bilancio dell'azoto secondo il metodo dell'OSPAR
In 1 000 t
Evoluzione
bilancio dell'azoto secondo il metodo dell'OSPAR
Fonte: Agroscope FAL Reckenholz 140 120 100 80 60 40 20 0 199019911992199319941995199619971998199920002001 2002 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 89
■ Evoluzione dell'efficienza dell'azoto
L'efficienza dell'azoto è calcolata sulla base del rapporto tra quantitativo sottratto e quantitativo apportato secondo il rispettivo bilancio.Il quantitativo sottratto è espresso in percentuale rispetto all’apporto.Un rapporto pari a 1 sarebbe sinonimo di un'efficienza del 100 per cento,ossia senza alcuna perdita,presupposto che durante il periodo considerato il tasso di azoto presente nel suolo rimanga invariato.Come già indicato precedentemente,in ambito agricolo un'efficienza del 100 per cento non può essere raggiunta.
Evoluzione degli input e output di azoto nonché dell'efficienza dell'azoto secondo il metodo OSPAR
■ Calcolo delle perdite di azoto rilevanti per l'ambiente
Tra il 1990 e il 1999 il grado d'efficienza ha registrato un incremento del 4 per cento. Da allora vi è stata una flessione dell'1 per cento.
Il calcolo delle perdite di azoto rilevanti per l'ambiente viene effettuato con il metodo di Häfliger e collaboratori (IEA,1995),avvalendosi di due metodi di calcolo diversi. L'estrapolazione si basa sui risultati di 240 chiusure contabili circa.Considerando i coefficienti d'emissione viene calcolato il potenziale di perdita di azoto per tutto il settore.Mediante la modellizzazione può essere desunto il carico di azoto rilevante per l'ambiente distinguendo tra ammoniaca,nitrato e gas esilarante.Tale sistema consente di esprimere considerazioni sui diversi tipi di azienda e sulle varie zone.Il conto globale, invece,mette a confronto il fabbisogno di azoto di tutte le colture con la disponibilità totale di concimi aziendali,minerali e a base di scarti riciclati dell'agricoltura svizzera nonché permette di individuare le perdite di azoto rilevanti per l'ambiente.I dati del conto globale vengono utilizzati per verificare la plausibilità dei risultati dell'estrapolazione.I risultati ottenuti con questi due metodi non possono essere confrontati con quelli degli altri tipi di calcolo descritti nel presente capitolo.
È la terza volta che viene effettuato un calcolo delle perdite di azoto rilevanti per l'ambiente.I dati disponibili si riferiscono agli anni 1994,1998 e 2002.Possono venir tenuti in considerazione anche i risultati di un calcolo semplificato effettuato nel 1990. La classificazione delle perdite di azoto nelle diverse categorie e l'analisi delle emissioni specifiche di un'azienda non hanno comunque potuto essere effettuate in modo affidabile nel 2002.Per tale motivo,attualmente è possibile esprimere soltanto considerazioni di natura qualitativa in merito al raggiungimento degli obiettivi in materia di emissioni globali.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 90
Efficienza dell'azoto
199019911992 1993199419951996199719981999200020012002 Input Fonte: Agroscope FAL Reckenholz Output 0 200 160 120 80 40 In 1 000 t N In % 20 30 28 26 24 22
Dopo l'evoluzione positiva registrata nel periodo dal 1990 al 1998,nel 2002 si è avuto nuovamente un incremento delle emissioni di azoto.Indipendentemente da questo dato,l'obiettivo agroecologico parziale fissato per il 2005 non sarà probabilmente raggiunto.All'origine di tale evoluzione vi è,tra l’altro,l'intensificazione della concimazione a partire dal 1997/98. È tuttavia probabile che siano entrati in gioco anche altri fattori come la crescita del numero di stalle a stabulazione libera,la modifica delle direttive sul foraggiamento,le variazioni delle emissioni di azoto ridotto in azoto molecolare (denitrificazione) oppure – aspetto puramente teorico – l'accumulo temporaneo di azoto organico nel suolo.Questa situazione potrebbe esser dovuta anche al fatto che il margine d'errore di questo calcolo è relativamente grande e di conseguenza non possono venir espresse considerazioni affidabili.Sono in atto accertamenti volti ad appurare le cause precise.
In relazione alle perdite di azoto rilevanti per l'ambiente vengono determinati altri due dati importanti:uno è il cosiddetto scarto dalla norma,il quale evidenzia in quale misura l'apporto effettivo di concimi supera quello stabilito dalle norme di concimazione;l'altro è il potenziale di perdita di azoto che comprende le perdite di azoto rilevanti e non per l'ambiente.Ciò consente di evitare errori nella suddivisione delle perdite di azoto tra perdite rilevanti per l'ambiente e non.Nel presente rapporto vengono presentati i risultati del conteggio globale in quanto le constatazioni espresse sulla base di un campione decisamente più grande sono più affidabili.I dati del conteggio globale si riferiscono agli anni 1993,1997 e 2001.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 91
1990199419982002Obiettivo agroecologico parziale 2005 In 1 000 t N Fonte: IEA 0 120 100 60 20 80 40
Evoluzione delle perdite di azoto rilevanti per l'ambiente
Nel 2001 il potenziale di perdita di azoto e lo scarto dalla norma sono risultati decisamente inferiori ai valori del 1993 anche se dal 1998 si registra nuovamente un incremento.
Nei processi biologici che hanno luogo in ambito agricolo una parte dell'azoto si disperde in modo improduttivo,tra l'altro anche sotto forma di ammoniaca (NH3).Nel 2000 le emissioni di ammoniaca riconducibili al settore primario sono state pari a 43'500 tonnellate di azoto.Ciò corrisponde al 92 per cento circa delle emissioni totali di ammoniaca a livello svizzero.La metà circa di tali emissioni viene depositata nel raggio di pochi chilometri.Il quantitativo rimanente si trasforma in ammonio che può venir trasportato nell'atmosfera anche per centinaia di chilometri prima di ricadere sulla superficie terrestre con le precipitazioni o sotto forma di polveri.L'ammoniaca che si deposita sui prati o sulle superfici campicole è irrilevante dal profilo ambientale.Se tale sostanza si accumula in ecosistemi particolarmente sensibili è invece possibile che vi sia un sovraccarico.
Distribuzione
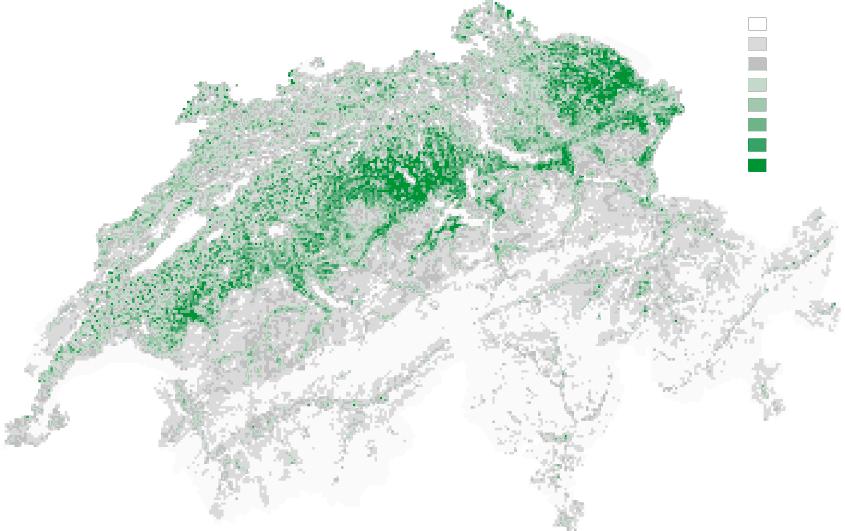
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 92
In 1 000 t N Fonte: IEA 199319972001 0 140 120 100 80 60 40 20 Potenziale
■
è la principale fonte d'emissione
Evoluzione dello scarto rispetto alla concimazione normale
di perdita Scarto dalla norma
Ammoniaca:l'agricoltura
kg N ha/anno ≤ 1 1 – 5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 >50
regionale delle emissioni agricole di NH3 Fonte: GG25 © 2003 swisstopo (UFAFP)
Il confronto dei dati regionali evidenzia il nesso diretto tra emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura e distribuzione sul territorio degli animali da reddito.Nelle regioni con un'elevata densità di animali si registrano emissioni di ammoniaca maggiori rispetto a quelle rilevate in aree a bassa densità di animali o nelle zone a vocazione campicola.

Origine di tutte le perdite di ammoniaca – 2000
Fonti non agricole 9%
Produzione vegetale 11%
Detenzione di animali 80%
Fonte: SHL
Nel 2000,le emissioni di ammoniaca riconducibili al settore della detenzione di animali da reddito sono state dell'89 per cento (di cui 75% per i bovini,17% per i suini,4% per il pollame e un ulteriore 4% per animali di diverse categorie).Il rimanente 11 per cento delle emissioni è determinato dall'utilizzo di concimi minerali e di concimi a base di scarti riciclati.
Fonti d'emissione di NH3 nel settore della detenzione di animali – 2000 Stalla compr. la corte 34%
di concimi aziendali
Impiego di concimi aziendali 53% Pascolo 2%
Fonte: SHL
I dati concernenti le emissioni variano notevolmente a dipendenza di fattori quali l'impiego di concimi aziendali sulle superfici,la detenzione di animali in stalla (compresa la stabulazione libera),l'immagazzinamento dei concimi aziendali o l'uscita al pascolo.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 93
Stoccaggio
11%
■ Diminuiscono le emissioni di ammoniaca di origine agricola
■ Emissioni di ammoniaca: notevoli differenze regionali
In Svizzera nel periodo dal 1990 al 2000 le emissioni di ammoniaca di origine agricola, espresse in azoto,sono scese da 53'500 a 43'500 tonnellate.A questa riduzione del 19 per cento hanno contribuito diversi fattori.Due terzi circa del calo è riconducibile alla flessione del numero di animali,mentre un terzo a cambiamenti intervenuti in relazione alle tecniche di produzione.A tal riguardo vanno annoverati i moderni sistemi applicati per lo spandimento dei concimi aziendali e il minore utilizzo di concimi minerali.Dal 2000 si è registrato un lieve incremento delle emissioni.
Detenzione di animali ed emissioni di ammoniaca sono inscindibili.La concentrazione del numero di animali in determinate regioni della Svizzera centrale e nordorientale rappresenta un vero e proprio problema.
Eccezion fatta per le alte vallate delle Alpi centrali,la soglia di carico critica per gli ecosistemi sensibili viene superata praticamente in tutta la Svizzera.Sulla base delle conoscenze attuali,al disotto di tale soglia l'apporto a lungo termine di azoto non dovrebbe nuocere alla funzionalità e alla struttura dell'ecosistema.La soglia critica, espressa in chilogrammi d'azoto per ettaro l'anno, è di 10–20 per gli ecosistemi forestali,5–10 per le torbiere alte e 10–25 per i siti secchi con molte specie vegetali. In alcune regioni ad elevata densità di animali si registrano valori superiori a 60 chilogrammi di azoto per ettaro l'anno.Localmente è già stata superata la soglia di 120 chilogrammi di azoto per ettaro l'anno.L'azoto ridotto (ammoniaca e ammonio) e l’ossido d'azoto contribuiscono nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo al carico totale.
Sulla base di due esempi (Cantone Soletta e Cantone Lucerna),nei capitoli seguenti vengono illustrate le differenze riscontrabili a livello regionale per quanto riguarda le emissioni di azoto.
Evoluzione delle
In 1 000 t N Fonte: SHL 70 60 50 40 30 20 10 0 199019911992199319941995199619971998199920002001 2002 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 94
emissioni di NH3 dell'agricoltura
Nel Cantone Soletta,nel 2003 le emissioni di ammoniaca di origine agricola,espresse in azoto,sono state di circa 1'100 tonnellate (calcolo secondo il Metodo Dinamo della SHL).Il 90 per cento circa è stato prodotto dalle 1'800 aziende contadine attive sul territorio cantonale.Le aziende agricole del Cantone Soletta gestiscono il 3,1 per cento circa della SAU svizzera e detengono il 2,6 per cento circa dell'effettivo di unità di bestiame grosso nazionale.Il 42 per cento della superficie cantonale totale è utilizzato a scopo agricolo;la densità media di animali ammonta a 1 UBGF per ettaro di SAU. Questa densità di animali rientra nella media svizzera.Le emissioni medie di ammoniaca, espresse in azoto,ammontano a 14 chilogrammi circa e pertanto sono relativamente basse.Il 22 per cento delle superfici parziali di 1 km2 presenta un carico di ammoniaca (ossido d'azoto escluso) di oltre 20 chilogrammi di azoto per ettaro,ossia superiore alla soglia critica degli ecosistemi forestali.Il fatto che nel Cantone Soletta venga superata la soglia critica per gli ecosistemi sensibili è riconducibile al quantitativo di azoto trasportato per lunghe distanze.

■ Emissioni di ammoniaca nel Cantone Soletta Distribuzione delle emissioni di ammoniaca nel Cantone Soletta ≤11–1011–2021–30 Emissioni di NH3 (kg N/ha e anno) 31–4041–50>50 km 2
Meteotest 0 350 300 200 50 250 100 150 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 95
Fonte:
■ Emissioni di ammoniaca nel Cantone Lucerna
Distribuzione delle emissioni di ammoniaca nel Cantone Lucerna
≤11–1011–2021–30
Emissioni di NH3 (kg N/ha e anno) 31–4041–50>50
Fonte: Meteotest
Nel Cantone Lucerna la situazione è più grave.Nel 2002 le emissioni di ammoniaca sono state pari a 5'300 tonnellate di azoto.Il 97 per cento delle emissioni proviene dall'agricoltura.Le 5'800 aziende agricole lucernesi gestiscono il 7,4 per cento circa della SAU svizzera e detengono l'11,5 per cento dell'effettivo svizzero di unità di bestiame grosso.Il 54 per cento della superficie cantonale è gestito a scopo agricolo. La densità di animali ammonta mediamente a 1,9 UBGF per ettaro di SAU.Questo valore è uno dei più elevati di tutta la Svizzera.Vaste aree del Cantone Lucerna rientrano tra le regioni con le maggiori emissioni.Le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie totale ammontano mediamente a 35,5 chilogrammi di azoto per ettaro.Il 63 per cento delle superfici parziali di 1 km2 presenta un carico di ammoniaca di oltre 20 chilogrammi di azoto per ettaro,ossia superiore alla soglia critica degli ecosistemi forestali.
Confronto tra la struttura di un'azienda media svizzera e le strutture di aziende medie dei Cantoni Lucerna e Soletta (2000)
CHLUSO
Superficie totale (ha)4 129 300149 20079 100
Superficie agricola utile – SAU (ha)1 072 49278 84632 868
% SAU rispetto alla superficie totale265342
Totale aziende agricole70 5375 7791 806
Ø Dimensioni delle aziende (ha)15,213,618,2
Unità di bestiame grosso (UBG)1 299 512148 99933 837
% UBG rispetto all'effettivo totale svizzero10011,52,6
Ø UBG/ha1,21,91,0
Fonte:UST
km 2
0 350 300 200 50 250 100 150 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 96
■ Nitrato:tenori elevati nelle regioni campicole
Il nitrato è idrosolubile e può filtrare,con le precipitazioni,fino alla falda freatica. Il tenore di nitrati è particolarmente elevato in alcune regioni dell'Altipiano svizzero. In alcune zone viene addirittura superato il limite di 25 mg/l fissato dall'ordinanza sulla protezione delle acque.
Tenore massimo di nitrato della falda freatica in funzione delle principali forme di gestione – 2002
Conformemente all'obiettivo agroecologico fissato in relazione al nitrato,nel 2005 il 90 per cento delle captazioni di acqua potabile,il cui settore d'alimentazione è utilizzato dall'agricoltura,dovranno presentare un tenore di nitrato inferiore a 40 mg/l. I tenori elevati di nitrato nella falda freatica si riscontrano prevalentemente in aree nelle quali domina la campicoltura.In queste regioni il valore soglia viene talvolta addirittura superato.Gli erbai presentano raramente problemi dovuti al nitrato.Se di tutte le stazioni di misurazione rappresentative della rete nazionale d'osservazione della qualità delle acque sotterranee (NAQUA) ne vengono considerate 298 collocate in un comprensorio a vocazione prevalentemente agricola,tale obiettivo è già stato raggiunto.

In %
Fonte: UFAFP
Campicoltura (n=83) Insediamenti e traffico (n=82)
Colture perenni (campicoltura esclusa) (n=189)
Pascoli
0 –25 mg/l 25 – 40 mg/l >40 mg/l 0 100 80 60 40 20 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 97
Boschi e superfici improduttive (n=65)
alpestri (n=26)
Evoluzione del tenore di nitrato in 158 stazioni di rilevazione dello stato della falda freatica
Anche il tenore medio di nitrato rilevato per un lungo periodo da 158 stazioni di rilevazione è diminuito.I comprensori nei quali sono state collocate queste stazioni di rilevazione non subiscono soltanto gli influssi dell'agricoltura.
Evoluzione del tenore di nitrato nella captazione della falda freatica di Torfmoos nei Comuni di Stetten e Niederrohrdorf / Argovia
Un esempio dell'evoluzione dei tenori di nitrati è dato dall'andamento della curva che si riferisce alla captazione della falda freatica di Torfmoos nei Comuni di Stetten e Niederrohrdorf,nel Cantone Argovia.La presa sfrutta una falda di notevoli dimensioni nella Valle della Reuss,nel Cantone Argovia a cui si aggiunge l'afflusso della Rohrdorferberg.La captazione si trova nel bosco e il comprensorio viene utilizzato prevalentemente a scopo agricolo (campicoltura e pastorizia).Dall'inizio degli Anni '90 viene condotta annualmente una campagna sull'azoto volta a sensibilizzare gli agricoltori. Inoltre,vengono concessi contributi comunali e cantonali per promuovere la semina diretta e a bande fresate nonché l'inerbimento di superfici invece del maggese invernale.La diminuzione del carico di nitrati verificatasi dal 1999 viene prevalentemente ricondotta all'applicazione della PA 2002.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 98
In mg/l
25 20 15 10 5 0 19901991199219931994199519961997199819992000200120022003 2004
Fonte: UFAFP
In mg/l
50 45 40 35 30 25 20 15 5 10 0 1991199219931994199519961997199819992000200120022004 2003
Fonte: Servizio specializzato sulla concimazione e l'ambiente, Liebegg
Evoluzione del tenore di nitrato nella sorgente Frohberg,
■ Conclusioni concernenti l'evoluzione delle emissioni di azoto di origine
In alcune regioni le misure generali di riduzione dell'apporto di nitrato non bastano.In queste aree possono venir realizzati i programmi regionali giusta l'articolo 62a della legge sulla protezione delle acque.A questo proposito va citato l'esempio del progetto sul nitrato di Wohlenschwil,nel Cantone Argovia.Misure quali la conversione delle superfici campicole in erbai,le restrizioni nell'utilizzo di concimi azotati,le limitazioni poste alla lavorazione del suolo,l'avvicendamento delle colture e la limitazione della detenzione di suini all'aperto hanno consentito di ridurre il tenore di nitrato al livello auspicato.
I dati sull'evoluzione delle diverse emissioni di azoto di origine agricola rilevanti dal profilo ambientale nel periodo 1990–2002 non offrono un'immagine ben definita.
Tra il 1990 e il 2002 le emissioni di ammoniaca sono notevolmente diminuite.Gli obiettivi agroecologici sono stati raggiunti più rapidamente di quanto previsto.In alcune regioni vi sono tuttavia ancora molti problemi.Anche per quanto concerne il nitrato i provvedimenti si sono rivelati efficaci.I risultati non sono tuttavia quantificabili.L'impegno profuso applicando l'articolo 62a della legge sulla protezione delle acque è stato fruttuoso.Anche in questo campo gli obiettivi verranno probabilmente raggiunti.
È invece stato mancato l'obiettivo agroecologico parziale che entro il 2005 prevedeva la riduzione,rispetto al 1994,di 22'000 tonnellate di azoto l'anno delle perdite di azoto rilevanti dal profilo ambientale.Conformemente al rapporto del Consiglio federale sulla riduzione dei rischi ambientali dei concimi e dei prodotti fitosanitari,tale obiettivo potrà essere raggiunto soltanto con uno sforzo supplementare.I provvedimenti previsti dalla legislazione ambientale ed agricola vigente sono:
a)la concimazione e la gestione del suolo in funzione del potenziale di gestione delle superfici ubicate in regioni sensibili;
b)l'applicazione di limitazioni preventive delle emissioni giusta l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) onde ridurre le emissioni di ammoniaca di origine agricola nonché la realizzazione di piani cantonali in virtù dell'OIAt per ridurre i carichi eccessivi di azoto.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 99
In mg/l
Wohlenswil, AG1
Fonte: Azione N
60 50 40 30 20 10 0 198591 90 89 88 868792939495969798990001022004 03
1 In questo caso la Sorgente è un ambito di progetto giusta l'art. 62a della legge sulla protezione delle acque
agricola
È possibile fare ulteriori progressi
– riducendo l'utilizzo di azoto nel sistema «agricoltura».Ciò migliorerebbe la situazione per quanto riguarda tutte le emissioni di azoto.Tale obiettivo può essere raggiunto riducendo l'acquisto da terzi di alimenti per animali e concimi oppure utilizzando foraggi a tenore ridotto di sostanze nutritive;
– presupposta una produzione invariata ciò comporta:l’impiego dell'azoto in modo più efficiente.L'efficienza può essere aumentata riducendo le perdite di azoto (p.es.con tecniche migliori per lo spandimento dei concimi),in quanto in tal modo è disponibile un quantitativo maggiore di azoto per la produzione,senza dover ricorrere ad acquisti da terzi.L'efficienza può essere accresciuta anche mediante il trattamento dei concimi aziendali finalizzato all'ottenimento di prodotti da impiegare in modo mirato;
presupposta la riduzione della produzione di prodotti animali:la situazione migliorerebbe soltanto se venisse ridotto anche il consumo di tali prodotti.In caso contrario aumenterebbero le importazioni e il problema delle emissioni verrebbe soltanto spostato all'estero;
– ripartendo in modo più uniforme i concimi aziendali sulla superficie.Ciò contribuirebbe a ridurre i problemi in determinate regioni,ma non vi sarebbero miglioramenti per quanto riguarda il volume totale delle emissioni.Una ripartizione più uniforme dei concimi aziendali può essere realizzata attraverso una migliore distribuzione degli animali sulla superficie e con il trattamento dei concimi aziendali.Le eccedenze di azoto e fosforo potrebbero venir sottratte dalle aree ad elevata densità di animali e impiegate nelle regioni campicole in sostituzione dei concimi minerali;
Il quantitativo futuro delle emissioni d'azoto dipenderà dalle possibilità di smercio per formaggio,carne e prodotti vegetali.Questo criterio – in via suppletiva agli incentivi sotto forma di pagamenti diretti – determinerà il numero di animali allevati nonché la superficie destinata alla campicoltura e influirà sul quantitativo di emissioni di ammoniaca come pure sull'entità del dilavamento di nitrato.
–
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 100
■ Acqua virtuale
Acqua
Il concetto di acqua virtuale consente di illustrare l'importanza dell'acqua in qualità di fattore politico ed economico. È infatti possibile stabilire in quale misura i deficit idrici locali sono dovuti a processi economici globali.

Per acqua virtuale si intende il quantitativo d'acqua utilizzato per ottenere un prodotto agricolo.Per produrre 1 chilogrammo di frumento o di riso sono necessari rispettivamente 1'000 o 2'500 litri d'acqua.Per la produzione di derrate alimentari di origine animale (carne,latte,uova) viene utilizzato un quantitativo d'acqua di gran lunga maggiore rispetto a quello usato per produrre alimenti di origine vegetale.Il quantitativo d'acqua necessario dipende considerevolmente dalla regione nonché dal sistema di coltivazione o di allevamento.
Fabbisogno
ProdottoFabbisogno d'acqua in m3/kg Carne bovina
d'acqua per la produzione di derrate alimentari
fresca15
fresca10
fresca6 Riso2,5 Frumento1 Granturco0,7 Miglio0,5
Carne ovina
Carne di pollame
Fonti:FAO e Barthelemy et al.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 101
Nel mondo vi sono notevoli differenze per quanto concerne la disponibilità di acqua. L'Asia deve far fronte a non pochi problemi in quanto in questo continente vive oltre la metà della popolazione mondiale e la disponibilità d'acqua è pari al 36 per cento delle risorse idriche mondiali.Attraverso l'importazione di derrate alimentari l'Asia importa anche un notevole quantitativo di acqua virtuale.Continenti come l'America e l'Oceania,che dispongono di notevoli risorse idriche rispetto alla popolazione,sono invece esportatori di acqua virtuale.
Disponibilità d'acqua e bilancio idrico virtuale rispetto alla popolazione
ContinenteQuota rispetto alle Quota rispetto allaBilancio idrico virtuale risorse idriche popolazione(import-export)
Fonti:UNESCO-WWAP e Chapagain & Hoekstra
L'acqua è una risorsa vieppiù scarsa.Mezzo miliardo di persone circa vive in Paesi nei quali vi è già scarsità d'acqua.Entro il 2050 almeno un quarto della popolazione mondiale dovrà convivere con una penuria cronica o ricorrente.
Se un Paese con poche risorse idriche importa derrate alimentari anziché produrle, diminuisce la pressione esercitata sulle riserve d'acqua disponibili.Da alcuni calcoli è emerso che la Giordania,ad esempio,importa acqua virtuale per coprire l'80–90 per cento del suo fabbisogno idrico.I Paesi con cospicue risorse idriche sono invece in grado di esportare acqua virtuale.Un grande problema si pone nel momento in cui un Paese con scarse risorse idriche esporta prodotti agricoli che possono essere ottenuti soltanto con l'irrigazione artificiale.
Il problema della carenza d'acqua potrebbe essere meno grave se nelle politiche nazionali ed internazionali venisse tenuto in considerazione il concetto di acqua virtuale.Le considerazioni in merito all'acqua virtuale consentono di giungere alla conclusione che l'agricoltura praticata in Svizzera,un Paese dove l'acqua non manca,coprirà anche in futuro gran parte del fabbisogno indigeno di derrate alimentari.Ciò presuppone tuttavia che la superficie agricola utile,in particolare quella per l'avvicendamento delle colture,non venga ridotta.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 102
mondialimondiale % %mio.m3/anno America settentrionale e centrale158 –44 226 America del Sud266 –21 354 Europa8134 806 Africa11137 795 Asia3660100
–57 942
612 Oceania5<1
Partecipazione ai programmi URA e SSRA
Mediante i programmi «uscita regolare degli animali da reddito all’aperto» (URA) e «sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali» (SSRA) s’intende promuovere la detenzione degli animali da reddito agricoli rispettosa delle loro esigenze.Il programma URA disciplina soprattutto l’uscita degli animali al pascolo, nella corte o nell’area con clima esterno per quanto concerne il pollame.Il programma SSRA prevede in primo luogo condizioni di natura qualitativa per le aree di riposo.La partecipazione a questi programmi è facoltativa.
Dall’introduzione dell’URA (1993) e dei SSRA (1996),la partecipazione ad entrambi i programmi è in costante aumento.Infatti dal 1993 al 2003 il numero di aziende che partecipano ai programmi URA è più che ottuplicato (da circa 4'500 a 36'600) mentre quello delle aziende partecipanti ai programmi SSRA è più che quadruplicato (da quasi 4'500 a circa 18'500).

■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3.2Etologia
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 103
Tabelle 38–39,pagine A43–A44
La quota di UBG,commisurata all’intero effettivo svizzero di animali da reddito,che nel 1996 adempiva le esigenze URA e SSRA,era rispettivamente del 19 e del 9 per cento. Nel 2003 è stata del 65 per cento per l’URA e del 34 per cento per i SSRA;tali valori sono una media delle quattro categorie di animali (bovini,altri animali che consumano foraggio grezzo,suini e pollame).
La partecipazione al programma URA per categoria di animali e per azienda indica che per ciò che concerne le aziende che detengono bovini la percentuale di animali è leggermente inferiore rispetto a quella delle aziende stesse.Per le altre categorie di animali hanno invece partecipato al programma URA le aziende con un effettivo di animali superiore alla media.

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 104 Evoluzione della partecipazione ai programmi URA e SSRA Quota di UBG in % SSRAURA Fonte: UFAG 1996199719981999 0 60 70 50 40 30 20 10 2000 2001 20022003
Partecipazione al programma URA – 2003 In % Quota di animali (in UBG)Quota di aziende Fonte: UFAG BoviniAltri animali che consumano foraggio grezzo SuiniPollame 0 70 80 60 50 40 30 20 10
Partecipazione al programma SSRA – 2003
Rispetto a ciò che accade per i programmi URA,gli effettivi di animali delle aziende che detengono pollame,altri animali che consumano foraggio grezzo nonché suini,che hanno preso parte ai programmi SSRA,sono risultati significativamente al disopra della media svizzera.Nel 2003 il 16 per cento delle aziende deteneva il 78 per cento degli animali conformemente alle prescrizioni SSRA.Per i bovini,invece,la quota di aziende è stata leggermente superiore a quella di animali.
Per quanto concerne la partecipazione al programma URA,nel periodo 1996-2003 si è registrato un notevole aumento che ha interessato tutte le categorie di animali,ad eccezione del pollame.Tale diminuzione si spiega con il fatto che dal 1999 i polli da ingrasso con un ciclo inferiore a 56 giorni di ingrasso sono stati esclusi dal programma URA.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 105
In %
BoviniAltri animali che consumano foraggio grezzo SuiniPollame 0 80 70 60 50 40 30 20 10
Quota di animali (in UBG)Quota di aziende
Fonte: UFAG
Quota di UBG in % Fonte: UFAG Bovini
animali che consumano foraggio grezzo SuiniPollame 199619971998199920012002 2000 0 70 80 50 60 40 30 20 10 2003 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA
Evoluzione della partecipazione al programma URA
Altri
Evoluzione della partecipazione al programma SSRA
Per quanto concerne il programma SSRA si nota soprattutto l’elevata partecipazione nel settore avicolo.Il motivo principale di ciò è che per molte label le esigenze SSRA prescritte dall’ordinanza sui pagamenti diretti sono un presupposto basilare.Il programma SSRA per i suini è stato introdotto soltanto nel 1997;tuttavia l’evoluzione è stata molto soddisfacente:infatti,rispetto all’anno d’introduzione,il numero di suini tenuti in porcili conformi alle esigenze SSRA è più che settuplicato.
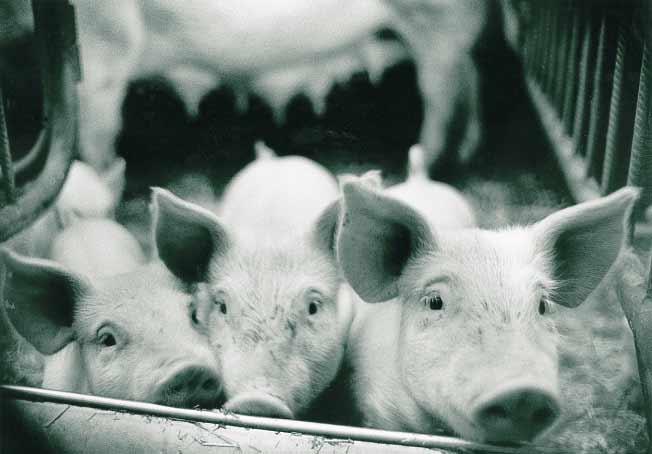
106 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1
Quota di UBG in %
1996199719981999200120022003 2000 0 80 50 60 70 40 30 20 10
Fonte: UFAG
Bovini
Altri animali che consumano foraggio grezzo
SuiniPollame
1.4 Valutazione della sostenibilità
L’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura prevede che nel Rapporto agricolo l’UFAG pubblichi ed illustri i risultati dell’analisi dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità.Ciò significa che vanno esposte e valutate la situazione dell’agricoltura sul piano economico,sociale ed ecologico nonché le ripercussioni della politica agricola.Di seguito si procede alla valutazione sulla base delle cifre attualmente disponibili.In base al concetto illustrato nel Rapporto agricolo 2001 concernente la valutazione della sostenibilità,nell’anno oggetto del rapporto sono stati condotti lavori in relazione all’elaborazione di indicatori quantitativi,che in futuro saranno utilizzati ai fini della valutazione della sostenibilità.
La situazione economica del 2003 è stata caratterizzata da un’estate lunga e secca. Rispetto alla media dell’ultimo triennio,la produzione del settore agricolo è diminuita del 4 per cento mentre le prestazioni preliminari sono aumentate del 2 per cento. L’aumento pari al 5 per cento in materia di pagamenti diretti non ha potuto compensare le perdite legate alla produzione e la crescita dei costi.Complessivamente il reddito netto del settore agricolo è stato di 2,790 miliardi di franchi,ossia del 13 per cento inferiore al valore medio del triennio precedente.Per il 2004 si prevede che tale importo raggiunga i 3,153 miliardi di franchi,il che significherebbe quasi raggiungere la media degli anni 2000/02.
I risultati dell’analisi centralizzata dei dati contabili mostrano che il reddito agricolo per azienda degli anni 2001/03 è inferiore del 16 per cento rispetto agli anni 1990/92.Nel medesimo lasso di tempo,i costi di terzi sono fortemente cresciuti (+18%) rispetto al reddito lordo (+7%).Il calo del reddito agricolo negli Anni ’90 ha potuto essere parzialmente compensato da un maggiore reddito accessorio (+20%).Il valore del reddito globale nel periodo 2000/02 è dunque inferiore al livello degli anni 1990/92 dell’8 per cento.Il livello degli investimenti e della quota di capitali di terzi è invece rimasto praticamente invariato.
Analogamente agli inizi degli Anni ’90,vi sono aziende che vedono minacciata la propria esistenza a lungo termine.In base alla media del periodo 2001/03 la situazione finanziaria del 38 per cento delle aziende è risultata insufficiente dal profilo della sicurezza a lungo termine dell’esistenza aziendale.Negli anni 1990/92 erano interessate da tale problema il 22 per cento delle aziende.
Nel complesso la situazione economica delle aziende è peggiorata rispetto all’inizio degli Anni ’90.Continuano ad esservi grandi differenze fra le varie aziende.Nel quarto quartile il reddito globale delle aziende (25% delle aziende con i migliori risultati) ammonta a più del doppio rispetto al primo quartile.In cifre assolute la differenza in tale lasso di tempo è cresciuta solo esiguamente.Come all’inizio degli Anni ’90,nel quarto quartile il profitto del lavoro per unità di manodopera della famiglia dell’azienda è stato superiore al salario comparabile.
1.4 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 1 107 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Economia
Un confronto concernente reddito e consumo fra aziende a titolo principale,complementare e accessorio mostra che il reddito globale dei tre tipi di aziende non si distanzia in modo sostanziale come invece lascerebbero supporre le differenze in materia di reddito agricolo.Le aziende gestite a titolo principale hanno conseguito il reddito globale più importante con 80’000 franchi,quelle gestite a titolo complementare hanno realizzato,con 74’000 franchi,un buon risultato,mentre quelle gestite a titolo accessorio si sono posizionate all’ultimo posto con 67’000 franchi.Le differenze in materia di reddito globale sono quasi cinque volte più contenute rispetto al reddito agricolo.Le aziende a titolo accessorio,con la loro attività non agricola,riescono a compensare in maniera considerevole il deficit legato al reddito agricolo.Nonostante il reddito globale mediamente più basso,esse costituiscono unità economicamente stabili.Il consumo privato medio è praticamente uguale per tutte e tre le forme di attività,come pure l’età media del capoazienda.Anche questo indica che tutte le forme di attività possono essere attrattive.
Nel 2003 il reddito globale medio determinante delle economie domestiche agricole è stato di 76’200 franchi,ossia poco meno del 2 per cento superiore rispetto agli anni 2000/02.Il consumo privato è invece leggermente diminuito (–0,5%) rispetto al valore medio dello stesso triennio e si è fissato a 62’900 franchi.
I risultati delle rilevazioni del reddito e dei consumi 2002 dell’Ufficio federale di statistica mostrano che,considerando le dimensioni dell’economia domestica,il reddito delle economie domestiche rurali interpellate è notevolmente inferiore a quello dei gruppi di confronto.Se il livello di reddito delle economie domestiche rurali è più basso, anche le uscite sono più contenute rispetto a quelle dei gruppi di confronto.Una parte di questa differenza concernente le uscite può essere ricondotta alle peculiarità delle economie domestiche rurali,ossia costi d’abitazione più bassi,autoapprovvigionamento con prodotti della stalla e dell’orto,nessun lungo tragitto per andare al lavoro né costi per i pasti fuori casa.Inoltre,anche le uscite da trasferimento (imposte e contributi alle assicurazioni sociali) sono più esigue a causa del basso reddito delle economie domestiche rurali.
In diversi Cantoni (VD,FR,ZH,BE,VS,AR,TG,SG,LU,NW e NE) esistono,in parte da anni,offerte statali o private riservate alle famiglie contadine in difficoltà.Nella maggioranza dei casi tali offerte si basano su strutture organizzative esistenti e su competenze specifiche.Un elemento importante è l’interconnessione delle competenze e/o delle organizzazioni.In tal modo la consulenza agricola beneficia in parte delle competenze specifiche di uno psichiatra e viceversa i responsabili dei servizi sociali possono far affidamento sulle conoscenze del consulente agricolo per quanto riguarda le peculiarità della realtà familiare e lavorativa contadina.I colloqui con i responsabili di tali offerte di consulenza hanno mostrato che esse sono un valido sostegno in un periodo in cui il primario deve far fronte a profondi mutamenti.Perché si possa garantire uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura è opportuno impiegare le risorse disponibili anche per seguire tali casi e non concentrarsi soltanto sulle aziende il cui futuro è garantito.
108 1.4 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 1
■ Aspetti sociali
Rispetto all’anno precedente,nel 2003 vi è stato un ulteriore incremento delle prestazioni fornite dall’agricoltura sul piano ecologico.Nel 2003 nella regione di pianura (zone campicole e zona collinare) le superfici di compensazione ecologica aventi diritto ai contributi ammontavano a 50’100 ettari,ossia al 3 per cento in più rispetto al 2002. Le aziende dedite all’agricoltura biologica gestivano complessivamente il 10,4 per cento della SAU,contro il 9,7 per cento del 2002.Rispetto al 61 per cento relativo allo scorso anno,nel 2003 il 65 per cento delle UBG sono state detenute in conformità delle regole del programma URA,mentre il 34 per cento giusta le disposizioni del programma SSRA,il che corrisponde ad un incremento di 4 punti percentuali rispetto al 2002.
Dall’inizio degli Anni ’90 fino al 1998 il carico ambientale riconducibile alle attività agricole è diminuito considerevolmente.Da quel momento è subentrata una stabilizzazione sia dell’impiego di concimi minerali che di prodotti fitosanitari.
Non è possibile offrire un’immagine ben definita relativamente all’evoluzione delle diverse emissioni di azoto di origine agricola rilevanti dal profilo ambientale nel periodo 1990–2002.Durante questo periodo le emissioni di ammoniaca sono diminuite considerevolmente il che significa che l’obiettivo agroecologico corrispondente ha potuto già essere raggiunto.Tuttavia a livello regionale sussistono ancora alcuni problemi.Gli obiettivi relativi al nitrato potranno presumibilmente essere raggiunti,i provvedimenti mirati giusta l’articolo 62a della legge sulla protezione delle acque si rivelano molto efficaci.

■ Ecologia 1.4 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 1 109
È invece stato mancato l’obiettivo agroecologico parziale che entro il 2005 prevedeva la riduzione,rispetto al 1994,di 22’000 tonnellate di azoto l’anno delle perdite di azoto rilevanti dal profilo ambientale.È perciò indispensabile effettuare ulteriori sforzi. Nel quadro delle prescrizioni ambientali e agricole vigenti sono previsti i provvedimenti seguenti:concimazione e gestione del suolo in funzione del potenziale di gestione delle aree ubicate nelle regioni sensibili,applicazione di limitazioni preventive delle emissioni giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico onde ridurre le emissioni di ammoniaca di origine agricola nonché realizzazione di piani cantonali per ridurre i carichi eccessivi di azoto.Si possono ottenere ulteriori progressi,apportando meno azoto al sistema «agricoltura».Ciò sarebbe possibile migliorando l’efficienza dell’impiego di azoto e mantenendo la produzione invariata (ad es.tramite migliori tecniche di spandimento dei concimi) o riducendo la produzione e il consumo di prodotti animali.Per ridurre i problemi regionali può anche essere considerata una ripartizione più uniforme dei concimi aziendali sulla superficie.Ciò può essere realizzato con una migliore ripartizione degli animali o con il trattamento di concimi aziendali.
Una risorsa ambientale decisiva per l’agricoltura è costituita dall’acqua,bene già insufficiente in alcune regioni della Terra.In futuro è atteso un ulteriore inasprimento di tale situazione.Per acqua virtuale si intende il quantitativo d’acqua utilizzato per ottenere un prodotto agricolo.Per la produzione di derrate alimentari di origine animale è necessaria più acqua che per la produzione di derrate alimentari vegetali.Il commercio di derrate alimentari permette di compensare le mancanze nelle regioni con una scarsa presenza di acqua.In qualità di Paese ricco di acqua ed in base a tale definizione è sensato che la Svizzera produca da sé le proprie derrate alimentari e che importi solo un quantitativo limitato di ulteriore acqua sotto forma di derrate alimentari – in determinate circostanze proveniente da regioni con problemi di scarsità d’acqua.
110 1.4 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 1

111 2
■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.Provvedimenti di politica agricola
I provvedimenti di politica agricola si suddividono in tre ambiti:
– Produzione e smercio: in questo ambito i provvedimenti si traducono in valide condizioni quadro per la produzione e lo smercio delle derrate alimentari.La legge prevede che le spese della Confederazione destinate alla produzione e allo smercio debbano essere ridotte di un terzo rispetto al livello del 1998 entro cinque anni dall’entrata in vigore.Nel 2003 è possibile destinare soltanto 800 milioni di franchi circa a favore di provvedimenti in tale ambito.
Pagamenti diretti: si tratta di pagamenti che indennizzano le prestazioni fornite nell’interesse della collettività come la cura del paesaggio,la salvaguardia delle basi vitali naturali e il contributo per l’occupazione decentrata del territorio nonché le prestazioni ecologiche particolari.I prezzi delle derrate alimentari non comprendono tali prestazioni data l’assenza di un mercato corrispettivo.Mediante i pagamenti diretti lo Stato assicura che l’agricoltura fornisca prestazioni a favore della collettività.
Miglioramento delle basi: con tali misure la Confederazione promuove e sostiene una produzione di derrate alimentari rispettosa dell’ambiente,sicura e efficiente.Nella fattispecie trattasi di provvedimenti volti a migliorare le strutture nonché di misure nei settori della ricerca,della consulenza,delle materie ausiliarie dell’agricoltura,della protezione dei vegetali e delle varietà.
112 2.PROVVEDIMENTI DI POLITICA AGRICOLA 2
–
–
2.1 Produzione e smercio
L’articolo 7 LAgr descrive gli obiettivi in materia di produzione e smercio dei prodotti agricoli.L’agricoltura è tenuta a produrre in modo sostenibile e vantaggioso,mentre gli agricoltori devono poter ricavare il massimo profitto dalla vendita dei loro prodotti.Per raggiungere tali obiettivi sono stati introdotti provvedimenti che riguardano i settori: qualità,promozione dello smercio e caratterizzazione dei prodotti,importazione ed esportazione,economia lattiera,produzione animale,produzione vegetale e vitivinicoltura.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 113 2
■ Mezzi finanziari – 2003
Nel 2003 alla promozione della produzione e dello smercio sono stati accordati circa 798 milioni di franchi.Rispetto all’anno precedente si è registrata una diminuzione delle uscite di circa 28 milioni di franchi (–3%).

Uscite per produzione e smercio Conto
■
Fonti:Conto
Con il secondo programma di sgravio,a partire dal 2005 vi saranno ulteriori riduzioni dei fondi iscritti al preventivo.
2003Preventivo 2004 Ambito di spesaImportoQuotaImportoQuota mio.fr.%mio.fr.% Promozione dello smercio597,4648,5 Economia lattiera56070,250467,0 Produzione animale253,1405,4 Produzione vegetale (compr.la vitivinicoltura)15419,314419,1 Totale798100751100
dello Stato,UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 114
Prospettiva
■ Promozione dell’operato concertato tramite il sostegno delle organizzazioni di categoria
Strumenti sovrasettoriali
Organizzazioni di produttori e di categoria
Le organizzazioni di categoria e dei produttori rivestono un ruolo importante per le imprese del settore alimentare quale piattaforma di discussione,negoziale e di coordinamento.Considerate la liberalizzazione del mercato agricolo e la riduzione delle uscite pubbliche,il miglioramento della competitività dei prodotti agricoli svizzeri assume un significato determinante.Le decisioni in materia di marketing-mix dei prodotti e determinate regole che influenzano l’andamento del mercato devono sfociare in soluzioni collettive coerenti.Grazie all’unificazione delle risorse,spesso limitate a livello delle singole aziende,sono disponibili prestazioni di servizio efficienti a livello collettivo (osservazione del mercato,controllo della qualità,informazione, consulenza imprenditoriale,ecc.).
Nell’ambito della legislazione agricola (art.8 e 9),il Consiglio federale può dichiarare vincolanti anche per i non membri misure per il miglioramento della qualità,la promozione dello smercio e l’adeguamento dell’offerta alla domanda decise da organizzazioni di produttori e di categoria.In questo caso si parla di «estensione» delle misure collettive.Il Consiglio federale dà il proprio sostegno a misure a favore di un intero settore o di un’intera categoria,ossia a misure di cui non approfittano solo i membri di un’organizzazione (problema degli «utilizzatori di frodo»).Senza l’intervento del Consiglio federale le imprese che non partecipano alle misure ma che ne approfittano potrebbero rapidamente compromettere l’esito di queste iniziative collettive.Con il suo intervento,il Consiglio federale promuove l’unione delle forze.
■ L’estensione è legata a severi oneri
Le esigenze che devono essere adempiute per un’estensione da parte del Consiglio federale sono:(1) le misure devono essere compromesse da imprese che approfittano di esse senza applicarle o senza partecipare al loro finanziamento;(2) l’organizzazione da sola non è autorizzata a svolgere un’attività commerciale;(3) essa deve essere rappresentativa e (4) i suoi membri devono aver approvato le misure a larga maggioranza.L’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori contiene le disposizioni d’esecuzione.Gli oneri posti in materia di rappresentatività delle organizzazioni e delle loro procedure decisionali sono particolarmente severi:le decisioni devono venir accettate dalle assemblee dei delegati con una maggioranza dei due terzi,gli stessi delegati devono essere stati eletti democraticamente dalla base.Nel caso di un’organizzazione di categoria,le decisioni vanno prese con i due terzi della maggioranza dei delegati a tutti i livelli della categoria.Con tali esigenze il Consiglio federale attribuisce particolare importanza alla legittimità e alla trasparenza delle organizzazioni.Inoltre,le misure per le quali viene richiesta un’estensione devono essere assolutamente nell’interesse di tutte le aziende di un settore o di una categoria e non possono portare a distorsioni della concorrenza fra i diversi operatori del mercato.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1.1
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 115 2
■ Esperienze in relazione allo strumento della promozione dello smercio
Con effetto al 1°gennaio 2004,il Consiglio federale ha deciso di estendere a tutte le aziende interessate le misure convenute da tre organizzazioni di produttori (Unione svizzera dei contadini,Produttori Svizzeri di Latte e GalloSuisse) e da quattro associazioni di categoria (Interprofession du Gruyère,Interprofession du Vacherin fribourgeois, Emmentaler Switzerland,Sbrinz GmbH).La maggior parte di tali misure concerne il finanziamento della promozione collettiva dello smercio.
Le organizzazioni che approfittano di un’estensione decisa dal Consiglio federale devono fornire al Dipartimento federale dell’economia un rapporto sull’esecuzione e sugli effetti delle misure.L’Ispettorato delle finanze dell’UFAG esegue controlli volti ad assicurare che i contributi prelevati dai non membri vengano effettivamente utilizzati per le misure collettive previste.
Promozione dello smercio
Il successo del marketing del settore agricolo dipende da un marketing-mix equilibrato, sviluppato in funzione del mercato bersaglio e da applicare in maniera professionale.La gestione del prodotto,dell’assortimento e della qualità,la formazione dei prezzi,la distribuzione e la comunicazione vanno coordinate.
Nel quadro della promozione dello smercio giusta l’articolo 12 LAgr è previsto un sostegno finanziario soltanto per la comunicazione e,in parte,per la ricerca di mercato. Ciò è motivato dal fatto che la Confederazione non vuole entrare nei rapporti di competitività intrasettoriale,ossia intende evitare distorsioni della concorrenza.Siccome la comunicazione è collettiva,sono prevalentemente le organizzazioni contadine che beneficiano di aiuti finanziari.Di regola queste non dispongono dell’intero marketingmix e non sono attive direttamente sul mercato.
La promozione dello smercio è organizzata in modo federalistico ed è finanziata in base al principio della sussidiarietà.Questo approccio incentiva l'autonomia dei singoli addetti e li responsabilizza.Le organizzazioni devono assumersi la responsabilità strategica ed operativa dei progetti e coprire almeno la metà dei costi.Ciò ne garantisce il coinvolgimento dal profilo tecnico ed organizzativo.L'immagine dell'agricoltura svizzera può essere migliorata soltanto con un ampio consenso e attraverso una comunicazione ben strutturata,comparabile a quella applicata a livello di impresa.
In un contesto di mercato caratterizzato da pressioni notevoli l'agricoltura deve essere in grado di comunicare quali prestazioni fornisce alla collettività e quali caratteristiche hanno i singoli prodotti.Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile che le misure vengano coordinate nell'interesse del settore primario nel suo insieme.Attraverso la concessione di aiuti finanziari,la Confederazione svolge un ruolo essenziale.I progetti di promozione dello smercio beneficiano di un sostegno finanziario soltanto se sono coordinati in modo ottimale almeno nel quadro dei settori di prodotti di mercato.In diversi ambiti,come ad esempio quello dei prodotti biologici,delle uova e dell'olio di colza,l'obiettivo della comunicazione collettiva è già stato raggiunto.I prodotti indigeni vengono evidenziati in modo mirato ed efficace rispetto a quelli d'importazione.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 116
■ Orientamento futuro
La promozione dello smercio è conforme all'OMC ed è un importante strumento nel contesto di un'agricoltura liberale.Il principio della sussidiarietà determina tuttavia diversi concetti di marketing di portata intersettoriale limitata.Il sistema applicato dalla Confederazione per promuovere lo smercio vuole andare contro tale tendenza. Nel quadro di progetti di comunicazione si dovrà badare anche in futuro al coordinamento fra contenuti del messaggio e altri provvedimenti degli operatori di mercato e delle ditte in questione.
Vista l'immagine eterogenea dei prodotti agricoli svizzeri,l'UFAG nutre notevoli speranze nel nuovo marchio di provenienza «Suisse Garantie».Esso potrebbe essere la base per una comunicazione più uniforme.A tal fine potrebbero rivelarsi utili le cosiddette «dichiarazioni positive»,che consentirebbero di evidenziare i vantaggi dei prodotti autoctoni rispetto alle merci d’importazione.Attualmente in Parlamento si sta dibattendo su questa tematica nel quadro dell’iniziativa parlamentare Ehrler:«Derrate alimentari:caratterizzazione di proprietà particolari sulla base della legislazione svizzera».
La promozione e la tutela della professionalità dei beneficiari di aiuti finanziari è un compito permanente.L’UFAG ha fissato esigenze precise per quanto riguarda la formazione dei responsabili di progetto e quando gli vengono inoltrate delle domande verifica pure la qualità del concetto di marketing.Inoltre a partire dal 2005 vigeranno condizioni precise e innovative in materia di controlling del marketing.
Nel quadro di questi strumenti sono necessarie iniziative collettive analoghe a quelle nel settore della promozione delle esportazioni o in quello della commercializzazione di specialità regionali.Simili compiti dovrebbero venir affidati a un'organizzazione che pratichi una politica molto incisiva e se ne assuma la responsabilità.L’UFAG sta appurando se una parte dei mezzi federali debba essere riservata a simili provvedimenti comuni rispettivamente a una simile organizzazione (base legale:art.12 cpv.3 LAgr).
■ Nuove disposizioni per la promozione dello smercio – 2004
Con effetto al 2004 nell’ordinanza sulla promozione dello smercio in agricoltura sono state inserite nuove disposizioni relative al vino e alla promozione dello smercio a livello regionale.
D’ora in avanti lo smercio di vino potrà essere sostenuto anche all'interno del Paese.Il vino viene così equiparato agli altri prodotti agricoli.L’aiuto finanziario non è finalizzato ad aumentare il consumo di vino,bensì a migliorarne l’immagine e quindi a stimolare i consumatori a privilegiare i prodotti autoctoni.Nel quadro della promozione dello smercio regionale i progetti vengono sostenuti dalla Confederazione durante una fase di consolidamento di quattro anni;la partecipazione finanziaria è tuttavia di minore entità rispetto a quella prevista nella fase iniziale.Inoltre – e ciò rappresenta un'importante innovazione – è espressa esplicitamente la possibilità di concedere un aiuto finanziario a progetti sovraregionali realizzati nell’interesse di specialità regionali.Per poter sfruttare pienamente le sinergie e ridurre i costi,segnatamente quelli legati alla comunicazione,è indispensabile che vi sia intesa tra i richiedenti già durante la procedura di domanda.A tal fine l’UFAG,dall'inizio del 2004,ha organizzato diverse manifestazioni.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 117 2
■ Stato del registro
Caratterizzazione
Il Registro delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) esiste dal 1997.Si tratta di uno strumento della proprietà intellettuale che protegge le denominazioni geografiche dei prodotti agricoli tradizionali (vino escluso).Nel 2003 nel Registro federale sono state iscritte tre DOC:Vacherin Mont d’Or,Abricotine e Cardon épineux genevois,nonché due IGP:Carne secca del Vallese e Saucisse neuchâteloise/Saucisson neuchâtelois.Al 31 dicembre 2003 il Registro contava 14 iscrizioni,mentre per altre 18 domande di riconoscimento di una DOP rispettivamente IGP era in corso la procedura di registrazione.
NumeroNumerott
Formaggio
L’EtivazDOC681270290OIC
GruyèreDOC3 10525925 12025 119OIC
SbrinzDOC24135--Procert
Tête de MoineDOC2589--OIC
Formaggio d’alpe TicineseDOP14---OIC
Vacherin Mont-d’OrDOC24211-592OIC
Prodotti carnei
Carne secca dei GrigioniIGP-11645658Procert
Saucisse d’AjoieIGP-14--OIC
Carne secca del ValleseIGP-53--OIC
Saucisse neuchâteloise / Saucisson neuchâtelois IGP-18--OIC
Bevande contenenti alcol di distillazione

Eau-de-vie de poire du ValaisDOC4197 OIC
Abricotine
Altri prodotti
DOC2223-OIC
Rheintaler RibelDOC1122728Procert
Cardon épineux genevoisDOC96-38
Totale4589429--
Fonte:UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 118
Registro DOP/IGP al 31 dicembre 2003
Denominazione Protezione Aziende agricole Aziende (trasformazione/ lavorazione) Volume di produzione certificato 2002 Volume di produzione certificato 2003 Organismo di certificazione 98 111 litri alcol al 100% 139 224 litri alcol al 100% 17 228 litri alcol al 100%
DOP/IGP
■ Procedura di ricorso
Con sei denominazioni protette DOC/DOP la categoria dei formaggi è la più importante in termini di aziende agricole coinvolte.Per la fabbricazione di formaggio contrassegnato da una denominazione protetta viene impiegato il latte di oltre 4'000 aziende lattiere svizzere.Una denominazione d’origine protetta è appannaggio soltanto del formaggio le cui proprietà tipiche vanno ricondotte all’area di produzione. Sulla base della tradizione casearia svizzera è stato possibile fissare cinque criteri.
–Il latte destinato alla fabbricazione di formaggio deve provenire da vacche cui non vengono somministrati insilati,bensì soltanto erba o fieno ed integratori alimentari.
–Il latte fresco viene trasformato in formaggio entro 24 ore dalla mungitura.
–I formaggi sono fabbricati da latte crudo,eccezion fatta per il Vacherin Mont d’Or, per la cui fabbricazione il latte viene sottoposto a trattamento termico.
–Nella fabbricazione del formaggio non sono autorizzati additivi e possono essere utilizzate soltanto colture tradizionali.
–Una durata minima di stagionatura consente lo sviluppo del potenziale organolettico del formaggio.
Questi criteri sono punti cardine per quanto riguarda le proprietà tipiche del formaggio svizzero,su cui è incentrata la fama internazionale di questo prodotto.
Con la sua prima decisione nell’ambito delle denominazioni DOC la Commissione di ricorso del DFE (REKO/EVD) ha confermato la decisione di registrazione del Pane di segale vallesano.L’opinione dei consumatori raccolta tramite un sondaggio demoscopico è fondamentale al fine di stabilire se si tratta di una denominazione d’origine o di una denominazione generica.Nel caso del Pane di segale vallesano,i consumatori collegano tale prodotto al Cantone Vallese e pertanto in questo caso non si tratta di una denominazione generica.Siccome la decisione non è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale,nel 2004 l’UFAG ha potuto registrare questa DOC.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 119 2
■ Provvedimenti differenziati per il disciplinamento delle importazioni
Strumenti del commercio esterno
A sostegno di un settore primario dedito alla produzione,le importazioni di prodotti agricoli vengono regolate mediante adeguate misure tariffali.I dazi all’importazione vengono impiegati in due modi come strumento regolatore:nel settore degli alimenti per animali è applicato il sistema del prezzo soglia che mediante aliquote di dazio variabili consente di mantenere il prezzo all’importazione entro una determinata fascia,per quanto riguarda gli altri prodotti agricoli,invece,vengono applicati contingenti doganali.I quantitativi che possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente sono limitati.È tuttavia consentito effettuare importazioni fuori del contingente doganale,che vengono gravate da dazi decisamente più elevati.
Le procedure amministrative per la regolamentazione delle importazioni devono essere possibilmente semplici.La soluzione migliore consisterebbe nella determinazione di un dazio unitario per ogni prodotto.Ciò garantirebbe una certa protezione alla produzione indigena,pur lasciando agire le forze di mercato.Per quanto riguarda la determinazione del dazio unitario,tuttavia,nel quadro delle trattative internazionali restano ancora aperte alcune domande relativamente all’ammontare e all’attuazione del cambio di sistema.Inoltre,soltanto a determinate condizioni questo strumento consente di tener conto del carattere stagionale di determinati prodotti.Per tali motivi, attualmente,per la regolamentazione delle importazioni si ricorre prevalentemente ai contingenti doganali.
Eccezion fatta per la procedura in base all’ordine d’entrata delle domande alla frontiera,l’UFAG è competente della ripartizione temporale e quantitativa dei contingenti doganali.Per l’assegnazione delle quote di contingente doganale si ricorre sempre più spesso alla vendita all’asta.Questa procedura presenta vantaggi economici e può anche fornire indicazioni utili circa l’ammontare di un eventuale dazio unitario in caso di soppressione dei contingenti doganali.I bandi d’asta e le attribuzioni sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.Attualmente è allo studio la possibilità di inoltrare le offerte utilizzando un accesso sicuro ad Internet.
Siccome in futuro l’amministrazione delle quote individuali di contingente doganale dovrebbe essere eseguita già alla frontiera,e non più posticipatamente da parte dell’UFAG sulla scorta di dati d’importazione,sarà soppresso il criterio di assegnazione noto come «prestazione e importazione nello stesso periodo».Questo tipo d’assegnazione non consente essenzialmente di attribuire le quote di contingente doganale prima dello sdoganamento,bensì soltanto dopo che l’importatore ha notificato le merci ritirate all’interno del Paese nel periodo corrispettivo.
Una panoramica di tutte le procedure d’assegnazione delle quote di contingente doganale,dei quantitativi assegnati e della relativa utilizzazione da parte delle ditte importatrici è riportata nel documento «Pubblicazione dell’assegnazione dei contingenti doganali» edito separatamente dal rapporto del Consiglio federale sulle misure doganali e tariffali,consultabile anche sul sito Internet dell’UFAG sotto «Rubriche > Importazione».
La procedura più semplice per l’assegnazione di quote di contingente doganale è l’attribuzione in base al criterio della sequenza degli sdoganamenti (ordine d'entrata delle domande di sdoganamento alla frontiera).Tuttavia anche questa procedura può presentare ostacoli che vengono di seguito illustrati mediante un confronto tra UE e Svizzera.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 120
■ La procedura in base all’ordine d’entrata delle domande è semplice e veloce?

Per l’assegnazione di quote di contingente doganale in Svizzera si impiegano due tipi di procedura in base all’ordine d’entrata delle domande.La procedura in base all’ordine d’entrata delle domande alla frontiera è applicata dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD).A titolo d’esempio,il contingente doganale delle uova di consumo viene assegnato in base alla sequenza degli sdoganamenti.I dati aggiornati sull’utilizzazione sono disponibili su Internet.Il presupposto è lo sdoganamento elettronico. Inoltre,per le uova di consumo è necessario un permesso generale d’importazione (PGI) dell’UFAG.Di norma l’unica condizione per il rilascio di un PGI è che la persona fisica o giuridica abbia domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.Il PGI è gratuito e ha validità illimitata,pertanto non deve essere rinnovato periodicamente oppure per ciascuna importazione.
Con la «procedura in base all’ordine d’entrata delle domande presso il servizio preposto alla concessione di permessi»,le quote di contingente doganale sono assegnate su richiesta dall’UFAG al titolare del PGI.Ai richiedenti sono assegnati i quantitativi desiderati fino ad esaurimento del contingente doganale.Onde evitare che un singolo richiedente richieda un intero contingente doganale,si fissa un quantitativo massimo per domanda e nel contempo viene limitato il periodo d’importazione.Esiste la possibilità di ridistribuire in un secondo tempo le quote inutilizzate.Se un richiedente utilizza il quantitativo assegnatogli in misura inferiore al 90 per cento e la domanda, per tale contingente,è superiore alla disponibilità,l’anno successivo verrà applicata una riduzione nell’attribuzione.Il sistema viene finanziato mediante tasse amministrative fatturate ad importazione avvenuta.
La procedura adottata nell’UE è diversa.Per il formaggio,ad esempio,la cosiddetta procedura di assegnazione dei titoli è stata fissata nel regolamento (CE) n.2535/2001 della Commissione,del 14 dicembre 2001,recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.La procedura,oltre ad essere più complessa perché nell’esecuzione sono coinvolti sia i servizi d’omologazione degli Stati membri sia la Commissione UE,comporta oneri maggiori per gli importatori interessati ad una quota di contingente doganale.L’UE applica pure una procedura in base all’ordine di entrata delle domande che rispetto alla procedura di assegnazione dei titoli rappresenta una considerevole semplificazione dal profilo amministrativo.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 121 2
Confronto tra la procedura svizzera in base all’ordine d’entrata delle domande e la procedura europea d’assegnazione dei titoli
Importazione in Svizzera 1
Su domanda l’UFAG rilascia un PGI 2
Domicilio/sede sul territorio doganale CH
Importazione nell’UE
Viene assegnato un numero d’autorizzazione se la procedura d’autorizzazione ha buon esito
Domicilio/sede nell’UE
Condizioni per gli importatori Richiesta di quote di contingente doganale
Per un intero gruppo di prodotti, p.es.formaggio
Rilascio di un PGI di validità illimitata
Domande per il rilascio di PGI sempre possibili
Iscrizione facoltativa nel registro di commercio –per l’assegnazione è tuttavia necessario fornire la prova che l’importazione della merce avviene a titolo professionale
Assegnazione una volta l’anno,senza interruzioni, fino ad esaurimento del CD
Numero illimitato di richieste.Inoltro al più presto il 1°giorno feriale di dicembre per l’anno successivo
Tetto massimo per domanda,nessun limite minimo
Nessun obbligo in riferimento al valore della merce
Nessuna cauzione
Soltanto per 1 prodotto
Autorizzazione valida 1 anno
Autorizzazione solo al 1°luglio
Prova «Commerciante» e «Attività regolare» (già l’anno precedente sono stati importati/esportati gli stessi prodotti,numero e quantitativo minimi sono definiti),documentazione sulla gestione aziendale e a seconda del Paese iscrizione nel registro e numero di imposta sulla cifra d’affari
Assegnazione in 2 tranche semestrali,ognuna con un termine di 10 giorni per l’inoltro delle richieste
È consentita solo 1 richiesta per contingente doganale e semestre (infrazione punibile con il ritiro di tutte le quote)
Max.10% del contingente doganale 3,min.10 t
Obbligo di rispettare un valore minimo Pagamento anticipato di una garanzia pari a 35 EUR/100 kg netti (cauzione)
I servizi preposti alla concessione di autorizzazioni devono inoltrare tempestivamente tutte le domande alla Commissione UE
Assegnazione
Importa- zione
L’UFAG applica riduzioni in maniera proporzionale soltanto per le domande inoltrate nel giorno in cui la domanda supera il contingente doganale
A seconda del prodotto da 3 mesi ad un anno intero
Diritto di utilizzazione trasferibile ad altri titolari di PGI previa notifica all’UFAG
Attestato della merce + prova di provenienza necessari
La Commissione rilascia titoli d’importazione agli Stati membri sulla base delle domande inoltrate,riduzione proporzionale per tutte le domande in caso di domanda superiore alla disponibilità
150 giorni di validità dal rilascio da parte del servizio preposto alla concessione di autorizzazioni dello Stato membro,tuttavia al massimo fino alla fine dell’anno civile
Assegnazione trasferibile alle persone autorizzate con notifica al servizio preposto alla concessione di autorizzazioni
Attestato della merce + prova di provenienza necessari
1 Per la procedura svizzera in base all’ordine di entrata delle domande alla frontiera non è necessaria altra autorizzazione all’infuori del PGI
2Il servizio preposto alla concessione di autorizzazioni in Svizzera è sempre l’UFAG.Nell’UE ogni Stato membro ha il suo servizio preposto alla concessione di autorizzazioni. Informazioni sui suddetti servizi sono disponibili sul sito Internet dell’UFAG sotto Rubriche > Esportazione
3 Su intervento della Svizzera,questo tetto massimo non sarà più in vigore a partire dalla seconda assegnazione del 2004
122 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2
Nell’anno oggetto del rapporto,le esportazioni di prodotti agricoli trasformati hanno avuto un andamento soddisfacente facendo segnare un aumento quantitativo dell’8 per cento circa.
Con una crescita di oltre il 14 per cento rispetto al 2002 (+30% dal 2001),le miscele di farina e la pasta cruda per la preparazione di pane,prodotti di panetteria e di pasticceria hanno contribuito in maniera essenziale a questo successo.Dal 2001 non si arresta la tendenza al ribasso fatta segnare da cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.Rispetto all’anno precedente,questi prodotti hanno registrato un calo pari al 6 per cento.Le caramelle e le gomme da masticare senza zucchero (+18% rispetto al 2002) come pure le mescolanze per fondue (+7% rispetto al 2002) sono prodotti di punta del gruppo di prodotti «preparazioni alimentari».Nello stesso gruppo rientrano gli integratori sportivi che però hanno segnato un’evoluzione negativa (–11%).

La quota di burro,importato ed esportato nel quadro del traffico di perfezionamento, si è ridotta di circa il 50 per cento toccando le 500 tonnellate.Le esportazioni di latte condensato nei prodotti trasformati hanno subito una flessione di oltre il 40 per cento. Al contrario è raddoppiato il volume delle esportazioni di latte fresco in prodotti trasformati.Evidentemente nella produzione il latte condensato è stato parzialmente sostituito da quello fresco.
Mediante un credito suppletivo il Parlamento ha riportato al livello OMC di 114,9 milioni di franchi l’importo iscritto a preventivo inizialmente ridotto a 100 milioni di franchi.Questo importo è stato completamente esaurito.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 123 2
■ Importazione ed esportazione di prodotti trasformati (legge sul cioccolato)
Avvertenza: Le quantità esportate si riferiscono anche a burro, semolino di grano duro e zucchero importati ed esportati nel quadro del traffico di perfezionamento
Il 25 novembre 2002 si sono conclusi a Bruxelles i negoziati sul nuovo Protocollo n.2 dell'Accordo di libero scambio del 1972.Nel corso dell’anno oggetto del rapporto si sono svolti altri due incontri per chiarire alcuni aspetti tecnici.In particolare si è discussa l’applicazione tecnica.Entrambe le parti sono disposte a sottoscrivere l’accordo unitamente agli altri fascicoli dei negoziati bilaterali II.
Quantità esportate In t Fonti:
DGD, UFAG
0 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 92 000 238 000 247 000 281 000 1991/92200120022003 Contributi all'esportazione mio. fr. Fonti: DGD, UFAG 0 200 150 100 50 180 98 115 115 1991/92200120022003 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 124
Provvedimenti 2003/04
2.1.2Economia lattiera
Dopo le difficoltà del 2002 che hanno portato alla chiusura di numerose aziende del settore caseario-lattiero,ad un eccedenza delle scorte di formaggio,a perdite di quote sul mercato caseario estero nonché ad un aumento delle scorte di burro e latte in polvere,nell’anno oggetto del rapporto il mercato lattiero si è leggermente ripreso.La situazione si è stabilizzata grazie ad una lieve diminuzione delle forniture di latte,ad un leggero aumento delle esportazioni di formaggio nonché all’incremento della produzione di prodotti a base di latte fresco.
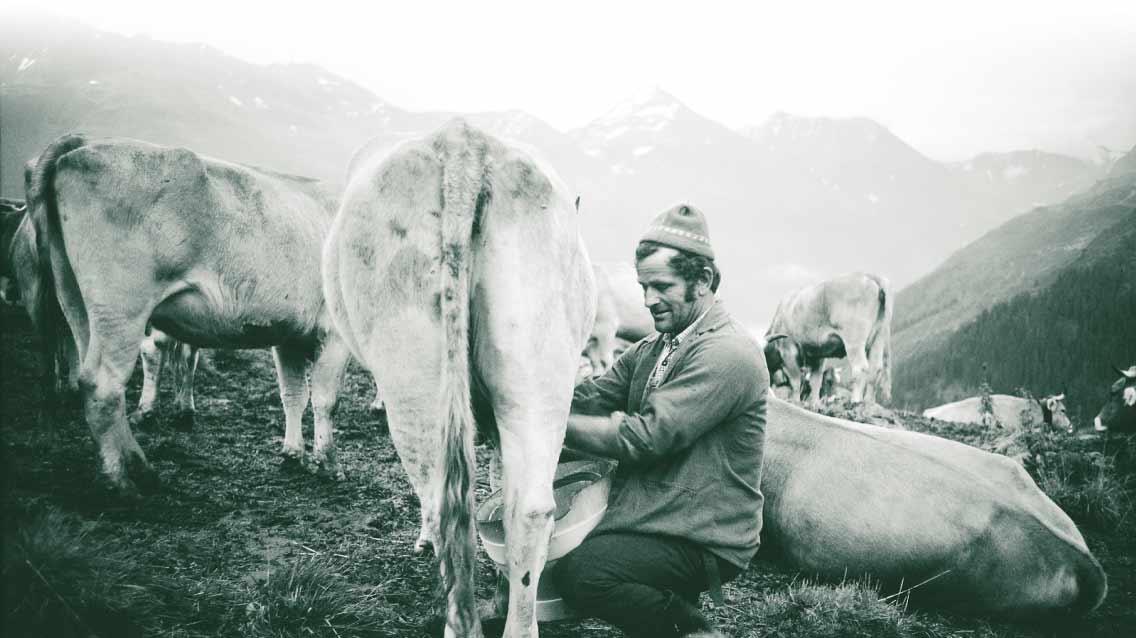
ProdottoFormaggioBurroLatte Latte Latte di consumo, scrematoin polverepanna,prodotti a base di latte fresco
1 Solo per determinati scopi d’utilizzazione
2 Solo in caso di rinuncia all importazione
3 Solo per esportazioni in altri Paesi all’infuori dell’UE e differenziati per tipo di formaggio
4 Escluso il latte di consumo
Rispetto al 2002 il prezzo alla produzione del latte è diminuito di quasi 3 centesimi al chilogrammo fissandosi a 75.5 centesimi al chilogrammo circa.I prezzi del latte di caseificio e del latte biologico sono calati in maniera più significativa rispetto a quello del latte industriale.I provvedimenti di sostegno sotto forma di supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati continuano ad essere destinati in primo luogo al settore caseario.Lo smantellamento del sostegno nell’ambito dei crediti quadro ha interessato gli aiuti.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Provvedimento Protezione alla frontiera ■■■■■ Supplementi ■ Aiuti all’interno del Paese ■ 1 ■ 1 ■ 2 Aiuti all’esportazione ■ 3 ■■ 4
Fonte:UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 125 2
■ Mezzi finanziari – 2003
In applicazione delle prescrizioni,nel corso del 2003 le uscite della Confederazione a favore dell’economia lattiera sono ulteriormente diminuite.Rispetto all’anno precedente,l’importo a disposizione è inferiore di circa 41 milioni di franchi (–6,8%).
Ripartizione dei mezzi – 2003
Totale 559,9 mio. fr.
Per il sostegno del prezzo nel settore lattiero sono stati stanziati complessivamente 559,9 milioni di franchi,di cui 378,4 a favore del formaggio (67,6%).Il settore del burro ha assorbito 93,1 milioni di franchi (16,6%),quello del latte in polvere e di altri latticini 81,3 milioni di franchi (14,5%).I costi amministrativi sono stati pari a 7,1 milioni di franchi (1,3%).

Aiuti all'interno del Paese 25%
Aiuti all'esportazione 11% Supplementi 63% Amministrazione 1% 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 126
Fonte: UFAG
Contingentamento lattiero
Nell'anno lattiero 2002/03 i produttori che commercializzano latte erano 34'671.Ciò rappresenta un calo del 4,3 per cento rispetto all’anno precedente o di circa il 13 per cento rispetto al 1999/2000.Nell’anno lattiero 2002/03,a livello nazionale,il contingente medio per azienda ha raggiunto gli 87'163 chilogrammi,facendo segnare un incremento pari a 3'756 chilogrammi (+4,5%) rispetto all’anno precedente.Il contingente medio nella regione di pianura ha superato per la prima volta i 100'000 chilogrammi,passando da 98'197 a 103'467 chilogrammi,mentre il contingente medio nella regione di montagna è cresciuto da 63'535 a 65'684 chilogrammi.Rispetto all'anno lattiero 2001/02 ciò rappresenta un incremento del 3,4 per cento.
L’estensione del periodo d’acquisto all’intero anno e l’aumento del contingente supplementare da 1'500 a 2'000 chilogrammi hanno comportato un notevole incremento delle domande di assegnazione di contingenti supplementari.Il numero di animali che danno diritto a quote di contingente ha raggiunto le 21'808 unità contro le 16'444 dell’anno precedente.Il quantitativo di contingente supplementare assegnato è cresciuto da 24,6 a 43,6 milioni di chilogrammi (+77%).
Nell’ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (OCL) sono state apportate le modifiche e gli adeguamenti di seguito elencati:
riduzione della tassa per superamento di contingente applicata alle aziende d'estivazione;
– prevenzione di trasferimenti abusivi di contingente e di forniture;
procedura per le domande inoltrate dalle organizzazioni di categoria;
– siccità 2003:permesso di trasferire le sottoforniture superiori a 5'000 kg all’anno lattiero seguente.
La tassa per superamento di contingente nella regione gestita tutto l’anno ammonta a 60 centesimi al chilogrammo,mentre quella applicata alle aziende d’estivazione a partire dal 1° maggio 2004 ammonta a 10 centesimi,nell’ottica di promuovere la gestione degli alpi.Se per il superamento di contingente deve venir pagato un importo pressoché identico a quello per la locazione annua di un contingente,i gestori possono essere spinti a trasferire tali contingenti alpestri all’azienda principale dove possono essere utilizzati con maggiore profitto.Onde prevenire questa evoluzione imprevista, sono state limitate le possibilità di trasferimento di contingenti (art.3,4 e 20 OCL).
L’articolo 31 LAgr consente all’intera categoria e a singole organizzazioni di categoria di fissare autonomamente il quantitativo di latte che i produttori affiliati desiderano produrre e commercializzare in un anno lattiero,nonché di chiedere al Consiglio federale di adeguare i contingenti dei produttori per il periodo in questione.Tale regolamentazione consente di adeguarsi ad un mercato segmentato e in rapida evoluzione.La responsabilità circa i quantitativi ed i prezzi è nelle stesse mani.Il Consiglio federale ha inoltre confermato che in futuro rinuncerà ad adeguamenti generalizzati dei quantitativi.A tal proposito nell’OCL è stata introdotta la Sezione 2a Adeguamento surichiestadiun'organizzazionedicategoria,che è finalizzata ad adeguare in maniera mirata i contingenti per i membri di una singola categoria.L’unico articolo contenuto in questa sezione fissa le modalità d’inoltro,i contenuti e gli allegati della domanda.In particolare l’organizzazione di categoria deve dimostrare che il quantitativo supple-
–
–
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2 127
■ Modifiche dell’ordinanza sul contingentamento lattiero
mentare può essere valorizzato e commercializzato;che è stata considerata la situazione sui mercati parziali,quali il mercato di prodotti biologici o i mercati regionali e che l’evoluzione auspicata dell’economia lattiera o della categoria non è compromessa.
Infine nell’anno lattiero 2003/04 i produttori hanno avuto la possibilità di trasferire all’anno successivo (anno lattiero 2004/05) un determinato quantitativo non esaurito a causa della siccità dell’estate 2003 (art.16 OCL).
La possibilità di scambio di contingenti continua ad essere utilizzata in maniera considerevole.Nell'anno lattiero 2003/04 5’697 produttori hanno acquistato un contingente,mentre 9’573 produttori lo hanno preso in affitto.La quantità trasferita ammonta a circa 297’300 tonnellate circa,ossia al 9,6 per cento del contingente di base.Alla fine dell'anno lattiero,121’120 tonnellate di contingenti presi in affitto sono state restituite ai locatori.
Commercio di contingenti
Il quantitativo trasferito giusta l’articolo 3 OCL (acquisto + locazione) nell’anno lattiero 2002/03 ha raggiunto i 234,4 milioni di chilogrammi circa pari al 7,8 per cento del contingente di base.Il quantitativo di contingenti locati ha segnato solamente una lieve crescita rispetto all’anno precedente (+2 mio.kg),a differenza di quello di contingenti acquistati che è aumentato considerevolmente (+19,1 mio.kg ovvero +26%).
Il quantitativo totale di contingenti locati nell’anno lattiero 2002/03 è ammontato a circa 388,5 milioni di chilogrammi,il che rappresenta il 12,9 per cento del contingente di base.Dall’introduzione del commercio di contingenti nell’anno lattiero 1999,quasi 300 milioni di chilogrammi di contingente sono stati acquistati definitivamente.In quest’anno lattiero 688 milioni di chilogrammi,ovvero il 22,8 per cento del contingente di base,sono stati utilizzati da altri produttori nel quadro di trasferimenti di contingente non vincolati alla superficie.
Unità 2001/02 1 2002/03 1 2003/04 2 Vendita Produttori partecipantiNumero2 4552 6923 911 Totale lattemio.kg72,491,6128,8 Per trasferimentokg29 49034 03732 888 Locazione Produttori partecipantiNumero7 3166 6847 405 Totale lattemio.kg140,8142,7168,5 Per trasferimentokg19 24521 34522 743 1Dati definitivi 2Dati provvisori Fonte:UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 128
■ Commercio di contingenti lattieri
■ Contingenti alpestri
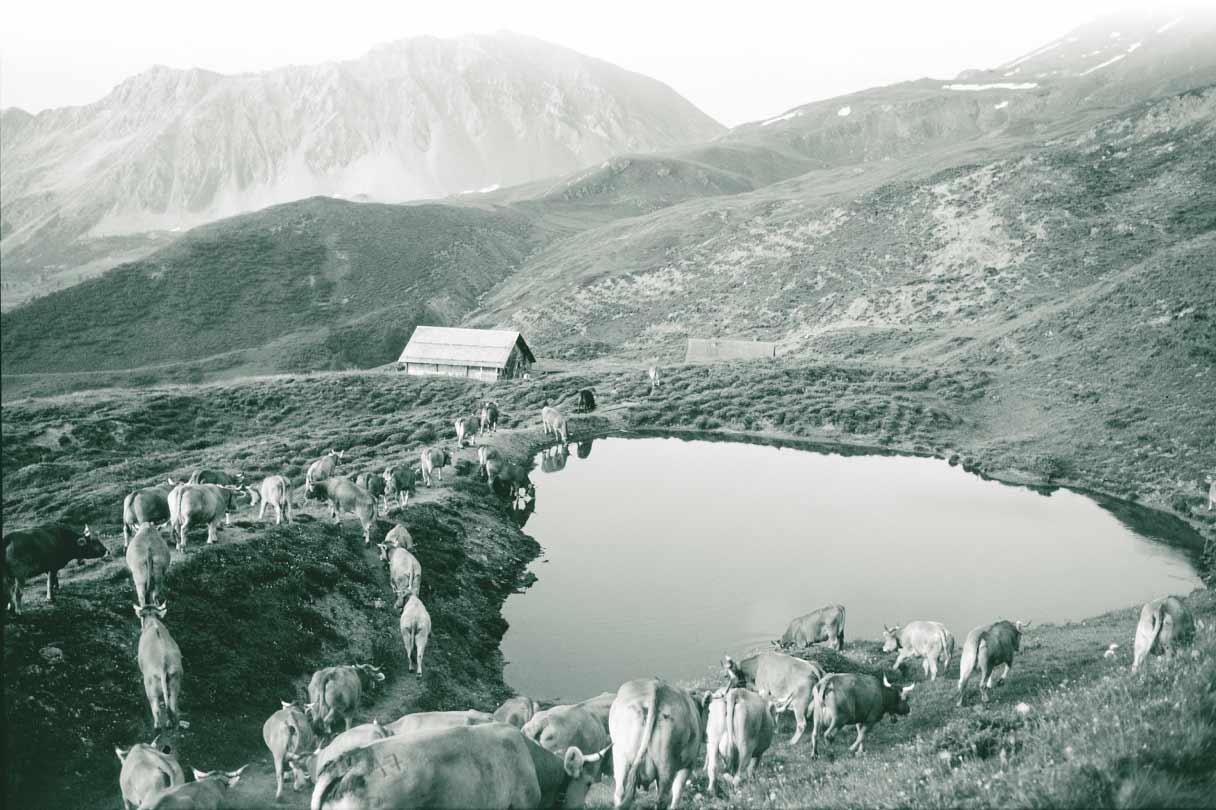
Rispetto al quantitativo totale commercializzato a livello nazionale pari a 3,2 milioni di tonnellate circa,la produzione lattiera delle 2'857 aziende d’estivazione è modesta. Con quasi 90 milioni di chilogrammi la produzione di latte durante il periodo d’estivazione 2003 ha rappresentato una quota inferiore al 3 per cento.19 produttori hanno dovuto versare una tassa di 60 centesimi al chilogrammo per il latte commercializzato in più rispetto al contingente assegnato,per un totale di 20'000 franchi circa.
La riduzione della tassa per superamento di contingente a 10 centesimi al chilogrammo ha ridimensionato notevolmente l’efficacia dello strumento del contingentamento lattiero.Se non si fosse proceduto a un rapido adeguamento dell’ordinanza concernente il contingentamento lattiero,molti contingenti alpestri sarebbero stati trasferiti alle aziende principali,dove sarebbero stati utilizzati per uso personale o trasferiti ad altri produttori.Inoltre si è dovuto tenere in considerazione il fatto che gli alpigiani avrebbero trasferito eventuali forniture in eccedenza dall’azienda principale al contingente alpestre.Per tale motivo la possibilità di trasferire contingenti alpestri ad aziende nella regione di pianura o di montagna è stata soppressa.Il latte commercializzato può essere trasferito all’azienda d’estivazione soltanto fino a concorrenza del contingente alpestre.Queste limitazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004. Resta possibile trasferire i contingenti ad aziende d’estivazione.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 129 2
■ Ripresa del contingente locato per uso proprio
In Svizzera nell’anno lattiero 2002/03 quasi 11'000 produttori hanno locato contingenti lattieri per un totale di 380 milioni di chilogrammi circa.Si stima che i locatori abbiano incassato annualmente 40 milioni di franchi.Essi temevano che con l’abbandono anticipato del contingentamento lattiero questo reddito potesse andare perso nel giro di soli due anni.Per questo motivo molti locatori avrebbero voluto vendere il proprio contingente al più presto.Siccome molti locatari non avrebbero potuto permettersi di acquistare il contingente finora locato,nell’interesse dei produttori lattieri attivi doveva essere rapidamente vietata la ripresa speculativa dei contingenti lattieri.Come misura immediata è stato necessario modificare l’ordinanza sul contingentamento lattiero.Dal 1° maggio 2004 la restituzione del contingente locato può essere richiesta dal locatore soltanto se questi vuole utilizzarlo nella propria azienda.Al contrario non è più consentito vendere o locare ulteriormente il contingente di cui è stata chiesta la restituzione.Onde evitare che questa limitazione all’ulteriore trasferimento venga aggirata con la chiusura di comunità aziendali settoriali,anche in questo caso non è consentito utilizzare il contingente di cui è stata chiesta la restituzione.La vendita rispettivamente l’ulteriore locazione da parte del titolare continua invece ad essere possibile se il locatario ha disdetto il contratto d’affitto.Non vengono bloccati nemmeno i contingenti locati soltanto per un periodo di contingentamento (compensazione dei saldi a fine periodo di contingentamento).
■ Adeguamento e rinnovo degli accordi di prestazione con le federazioni lattiere
La vigilanza sull’esecuzione del contingentamento lattiero e l’attività di controllo sono di competenza della Confederazione mentre l’amministrazione e l’esecuzione concreta dei provvedimenti sono delegati a servizi esterni.Con l’introduzione del nuovo disciplinamento del mercato lattiero al 1° maggio 1999,l’esecuzione del contingentamento lattiero è stata delegata,mediante accordi di prestazione,a 13 servizi d’amministrazione del contingentamento lattiero,che di norma sono le federazioni lattiere regionali.I contratti sono scaduti il 30 aprile 2004.Senza disdetta scritta entro il termine fissato ad aprile essi sono validi ancora per un anno.Alla luce dell’evoluzione strutturale in atto dal 1999 e del previsto abbandono del contingentamento lattiero nel 2009,nell’estate 2003 sono state avviate nuove trattative con le federazioni lattiere per adeguare i contratti alla nuova situazione.
La tipologia e la portata dei compiti sono stabilite dettagliatamente in un elenco degli obblighi.In particolare,per ogni produttore che commercializza latte le federazioni lattiere devono registrare i dati principali e le forniture,allestire il conteggio del contingente e registrare le modifiche relative al contingente.Inoltre devono trasmettere all’UFAG una ricapitolazione per ogni anno lattiero dei dati di tutti i produttori attivi nel proprio comprensorio.Il numero delle aziende da amministrare ammonta a 45'000 unità circa e comprende tutte le aziende dedite alla produzione lattiera incluse quelle d’estivazione,nonché le aziende con contingente congelato e quelle che hanno locato il proprio contingente.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 130
■ Prospettiva: abbandono anticipato del contingentamento lattiero
Per le prestazioni fornite nel quadro del contingentamento lattiero le federazioni lattiere sono indennizzate annualmente con un importo pari a 3,5 milioni di franchi circa.L’importo totale è rimasto invariato rispetto al 1999,mentre l’indennità per singola federazione lattiera nel 2003 è stata determinata in base a nuovi criteri.Nella formula di calcolo sono stati presi in considerazione essenzialmente la percentuale di posti necessari,i costi medi d’esercizio e quelli legati ai sistemi informatici dei servizi d’amministrazione,il numero di aziende produttrici di latte,i maggiori costi dei servizi d’amministrazione più piccoli e la maggior spesa in caso di plurilinguismo.
La fine del contingentamento lattiero si avvicina.In linea di massima la soppressione della limitazione dei quantitativi secondo il diritto pubblico avverrà nella primavera 2009.Tuttavia il legislatore ha previsto la possibilità per i produttori di abbandonare anticipatamente il contingentamento lattiero al 1° maggio 2006,2007 e 2008.Questa primavera l’UFAG ha sottoposto alle cerchie interessate un disegno d’ordinanza concernente l’abbandono anticipato del contingentamento lattiero,con lo scopo di farla entrare in vigore il 1° maggio 2005.La limitazione dei quantitativi,finora disciplinata dallo Stato,non sarà semplicemente smantellata con un abbandono anticipato. La responsabilità relativa al volume di latte prodotto sarà delegata alle organizzazioni che abbandonano il contingentamento lattiero.In base al disegno d’ordinanza,se un’organizzazione desidera aumentare il proprio volume di produzione,deve dimostrare alla Confederazione che il quantitativo supplementare richiesto non è superiore a quello necessario per la fabbricazione dei prodotti.Se non può essere incrementato lo smercio indigeno,i quantitativi supplementari devono essere esportati.
Le condizioni quadro per l’abbandono anticipato saranno stabilite entro la fine del 2004.Successivamente la palla passerà ai produttori:spetterà a loro decidere rispettivamente organizzarsi e prepararsi per l’abbandono del contingentamento lattiero.
La categoria manifesta un notevole interesse per l’abbandono anticipato del contingentamento lattiero.Si moltiplicano le richieste d’informazioni sulle condizioni da osservare nell’eventualità di un abbandono anticipato del contingentamento.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 131 2
Sostegno del mercato mediante supplementi ed aiuti
Gli strumenti per il sostegno del mercato nel 2003 non sono stati oggetto di modifiche di rilievo.Tuttavia,in seguito alla già citata riduzione del sostegno di 41 milioni di franchi,diversi aiuti hanno dovuto subire dei tagli.In riferimento ai mezzi finanziari a disposizione nel 2004,per la prima volta,e con effetto al 1° maggio 2004,anche i supplementi per il latte trasformato in formaggio hanno dovuto essere ridotti da 20 a 19 centesimi al chilogrammo.Sempre dal 1° maggio 2004 anche gli ultimi aiuti all’esportazione di formaggio nell’UE sono stati soppressi e l’importo di quelli all’esportazione verso altri Paesi sono stati ridotti di 50 centesimi.Anche gli aiuti all’esportazione per equivalente-composizione sono stati ridotti al 1° maggio 2004 di 2 centesimi a 29 centesimi per equivalente-composizione.Nell’ordinanza del DFE concernente l’importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all’importazione di latte intero in polvere sono state abrogate le disposizioni concernenti la fabbricazione di miscele di burro e gli oneri nel settore del burro.
Il prezzo d’obiettivo (art.1 dell’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte) è stato soppresso.Terminata la fase di transizione al nuovo disciplinamento,esso non ha più ragione di essere per il futuro funzionamento del mercato lattiero.Con l’abrogazione, nel quadro della PA 2007,dell’articolo 29 LAgr non esiste più alcuna base legale in merito.Finora il prezzo del latte utilizzato per la fabbricazione di burro è stato sostenuto mediante aiuti differenziati.Si era optato per tale soluzione al fine di garantire una transizione ordinata al nuovo disciplinamento del mercato lattiero.Già all’epoca, tuttavia,era stata palesata l’intenzione di allineare il sistema di sostegno nel settore del burro a quello applicato per il latte trasformato in formaggio sin dall’inizio della transizione.In tal modo si vuole garantire un sostegno uniforme ai segmenti di mercato del burro che necessitano ancora di un aiuto.Anche oggi viene mantenuta la stessa linea;viene concesso,infatti,un aiuto soltanto al burro disidratato e non disidratato a scopo industriale-artigianale.

2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 132
Provvedimenti 2003
2.1.3 Produzione animale
La protezione alla frontiera sotto forma di dazi e contingenti doganali costituisce il principale strumento di sostegno della produzione indigena di carne.A favore del mercato della carne e delle uova nonché dell'esportazione di bestiame da allevamento e da reddito vengono pure versati aiuti.
di bestiame da allevamento e da reddito
Effettivi massimi
Fonte:UFAG
Con effetto al 1° gennaio 2004 il Consiglio federale ha deciso di aumentare del 50 per cento gli effettivi massimi di suini,vitelli,polli da ingrasso,tacchini e galline ovaiole. Nel contempo ha abrogato gli effettivi massimi per le pollastrelle.Le modifiche non dovrebberoavere alcun risvolto negativo dal profilo ecologico e della protezione degli animali,in quanto le prescrizioni in materia di protezione delle acque e la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate pongono già determinati limiti.Data la buona situazione di mercato Proviande non ha adottato provvedimenti di sgravio.Non sono state effettuate azioni di sgombero del mercato per quanto concerne bovini,vitelli, suini ed equini nei macelli,né vendite a prezzo ridotto di carne bovina,di vitello o di maiale.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Animale/ProdottoBoviniVitelliSuiniEquiniOviniCapriniPollameUova Provvedimento Protezione alla frontiera ■■■■■■■■ Sgombero del mercato sui mercati pubblici ■■■ Sgombero del mercato nei macelli ■■■■■ Azioni d’immagazzinamento ■■■ Azioni di vendita a prezzo ridotto ■■■ Esperimenti conformi alla pratica ■ Contributi per incentivare la riconversione ■ Contributi agli investimenti per la costruzione di stalle ■ Azioni di spezzatura e altri provvedimenti di commercializzazione ■ Contributi per la valorizzazione della lana di pecora ■ Aiuti all’esportazione
■■■■
■■■■
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 133 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
■ Mezzi finanziari – 2003
Dei 43,6 milioni di franchi iscritti nel preventivo federale per provvedimenti nel settore della produzione animale ne sono stati spesi soltanto 24,9 milioni.I mezzi rimanenti sono stati in gran parte impiegati per compensare i crediti suppletivi concessi in altri settori:7 milioni di franchi per la valorizzazione del raccolto di uva e 9,4 milioni di franchi per pagamenti diretti generali ed ecologici.In virtù dell’ordinanza sulle uova,la Confederazione ha inoltre aumentato i pagamenti diretti per i sistemi di detenzione di ovaiole particolarmente rispettosi degli animali attingendo al preventivo per la produzione animale.
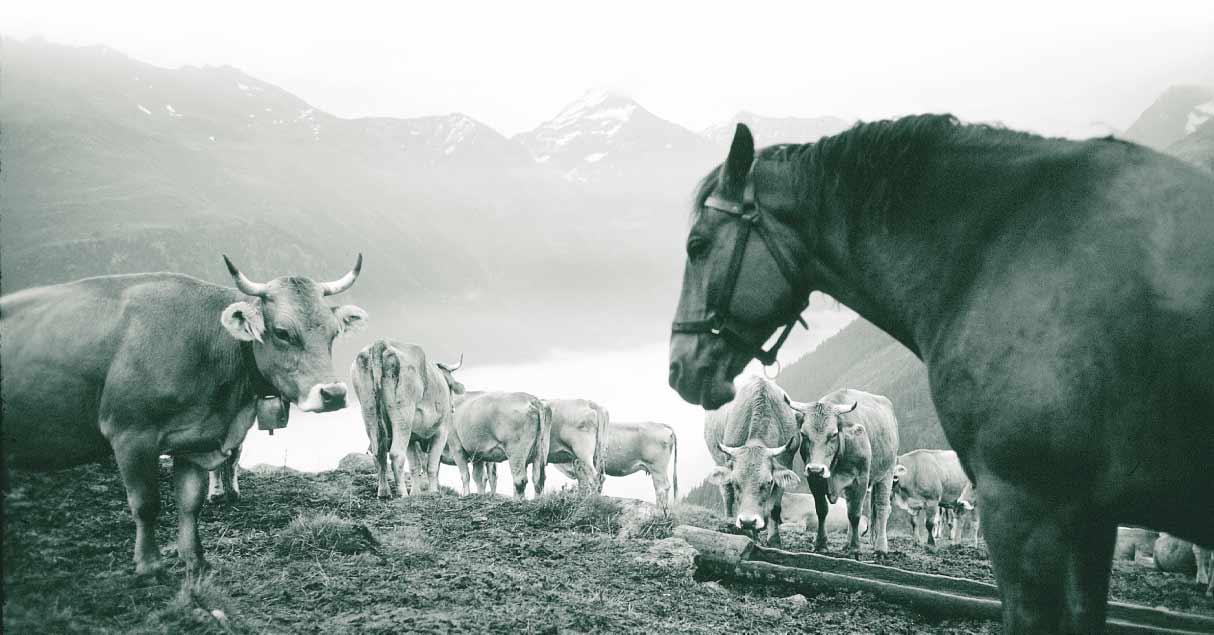
All'origine della minor spesa nel settore della produzione animale vi è essenzialmente l'ottima situazione della domanda sul mercato della carne e delle uova nonché le esportazioni,ancora contenute,di animali da allevamento e da reddito.Con decisione del Consiglio dell’agricoltura dell’UE del 17 novembre 2003,la Comunità ha riconosciuto l’equiparabilità delle prescrizioni svizzere in materia di ESB.Di conseguenza,le barriere commerciali introdotte da singoli Paesi membri dell'UE nei confronti dei bovini svizzeri sono illegali.Dalla fine dell’anno oggetto del rapporto i bovini svizzeri,in linea di massima,possono essere nuovamente esportati in tutta Europa.
Ripartizione dei mezzi – 2003
Totale 24,9 mio. fr.
Contributi per la valorizzazione della lana di pecora 2%
Contributi per azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto per la carne bovina e di vitello 19%
Contributi a sostegno della produzione indigena di uova 12%
Contributi per l'esportazione di bestiame da allevamento e da reddito 37%
Fonte: Conto dello Stato
Accordi di prestazione Proviande 30% 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 134
Dal 1° gennaio 2000 la Proviande adempie mandati dell’UFAG sui mercati pubblici per il bestiame da macello e gli ovini nonché nei macelli.Dal 1° gennaio 2004 sono entrati in vigore nuovi accordi di durata limitata.Dal profilo del personale e finanziario la classificazione neutrale della qualità di animali vivi e di carcasse è il compito principale della Proviande.
1.Classificazione neutrale della qualità
Il servizio ad hoc della Proviande ha provveduto alla classificazione neutrale della qualità di oltre l’80 per cento degli animali macellati delle specie bovina,suina,ovina, caprina ed equina.Inoltre ha determinato la qualità di tutti gli animali delle specie bovina ed ovina sui mercati pubblici.Per queste attività sono stati impiegati oltre 140 collaboratori a tempo pieno e parziale.Nel complesso hanno fornito 48'000 ore di lavoro in macelli e hanno garantito la loro presenza in circa 1'700 mercati pubblici di bestiame da macello e di ovini.
La quota di carne magra,determinante per la qualità delle carcasse di suini da macello è rilevata servendosi di appositi apparecchi.Il valore medio della quota di carne magra su un campione di 925'000 macellazioni (35% di tutte le macellazioni) ammonta al 55 per cento.Rispetto al 2002,quindi,non si sono registrate variazione di rilievo.La qualità del grasso dei suini è un altro fattore determinante per la consistenza e la resistenza all’ossidazione degli insaccati.La determinazione della qualità del grasso è invece facoltativa per i macelli.
Distribuzione delle carcasse in funzione delle classi di muscolatura – 2003 In %
■
Bestiame da macello e carne:accordi di prestazione
Fonte: Proviande
C H T A X VaccheTorelliVitelli Classe di muscolatura AgnelliCapretti 0 70 50 60 40 30 20 10 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 135 2
C = molto bene in carne, H = bene in carne, T = muscolatura media, A = scarnato, X = molto scarnato
Per gli animali delle specie bovina,ovina,caprina ed equina la qualità delle carcasse viene determinata otticamente.Esistono cinque classi relativamente alla muscolatura: C = molto bene in carne,H = bene in carne,T = muscolatura media,A = scarnato e X = molto scarnato.Anche per la valutazione del tessuto grasso ci si avvale di cinque classi.Dalla valutazione di un campione del 2003 sono emerse notevoli differenze tra le carcasse di torelli e vacche.Il campione comprendeva il 60 per cento circa di tutti i capi macellati.Un quarto delle vacche è risultato scarnato e un altro quarto molto scarnato.Rispetto al 2002 la quota degli animali molto scarnati è diminuita di altri 3 punti percentuali.Per quanto concerne i torelli,il 95 per cento dei capi compresi nel campione presentava una muscolatura media o era molto bene in carne.Dall’anno precedente si è registrato un aumento della corrispondente quota pari al 50 per cento. Nell’anno oggetto del rapporto la quota di carne degli animali della specie bovina è stata superiore ai valori del 2002.Per gli agnelli la quota maggiore è risultata essere quella con muscolatura media (51%).Dalla classificazione svolta dagli esperti oltre due terzi dei capretti macellati sono risultati bene in carne,il che è riconducibile ad un buon metodo d’ingrasso.
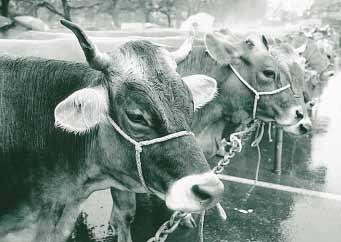
2.Sorveglianza dell'andamento del mercato nei macelli nonché organizzazione dei provvedimenti tesi a sgravare il mercato
Le organizzazioni contadine locali e/o i servizi cantonali hanno organizzato 76 mercati di bestiame grosso,18 mercati di vitelli e 96 mercati di ovini.Le piazze dove si tengono mercati di bestiame grosso si trovano in 20 Cantoni,quelle per mercati di vitelli in 7 e quelle per mercati di ovini in 17.Il numero di ovini presentati ai mercati è aumentato del 21 per cento rispetto al 2002,mentre quello di bovini del 3 per cento.L’offerta straordinariamente significativa sui mercati di ovini non è stata esaurita su base volontaria dai commercianti di bestiame.Pertanto la Proviande ha dovuto assegnare ai macelli o ai commercianti tenuti a ritirare animali sul piano indigeno un totale di 15'957 pecore e agnelli (17,5% degli animali presentati ai mercati),ovvero dieci volte il numero di capi dell’anno precedente.Per gli animali invenduti e assegnati Proviande ha applicato i prezzi solitamente praticati sul mercato.Per quanto riguarda il bestiame grosso ed i vitelli gli animali invenduti e assegnati nel quadro di azioni di sgombero del mercato sono stati rispettivamente 1'001 e 56.
Cifre inerenti ai mercati pubblici sorvegliati – 2003
CaratteristicaUnità VitelliBestiame Animali della grossospecie ovina
Mercati pubblici sorvegliatiNumero465911350
Animali presentatiCapi52 61873 00291 099
Quota degli animali presentati rispetto alle macellazioni%181933
Animali assegnati (sgombero del mercato)Capi561 00115 957
Fonte:Proviande
Per il congelamento e l’immagazzinamento di carne di vitello e di vacca l’UFAG ha versato aiuti per un totale di 4,6 milioni di franchi.In primavera le aziende hanno congelato 1'003 tonnellate di carne di vitello e nei mesi di agosto–settembre 539 tonnellate di carne di vacca.Entro la fine dell’anno oggetto del rapporto tutte le scorte di carne erano state nuovamente immesse sul mercato.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 136
3.Registrazione e controllo delle domande di quote di contingente doganale
Nel complesso sono state inoltrate 854 domande per l’assegnazione di quote di contingente doganale.Dal 2000,quando ne furono presentate 1'003,il numero delle domande è costantemente diminuito.Proviande ha controllato le notifiche delle prestazioni all'interno del Paese onde appurarne la completezza e la plausibilità.In particolare ha esperito sopralluoghi in tutte le aziende che hanno notificato muscoli di manzo salati,mentre per quanto concerne le altre notifiche di prestazioni all'interno del Paese,come macellazioni e acquisti di lombi,le verifiche sono state attuate per campionatura un centinaio di aziende.Al termine della registrazione e del controllo dei dati inerenti alla prestazione all'interno del Paese,Proviande li ha trasmessi all'UFAG. Sulla base di tali indicazioni,il 19 novembre 2003 quest’ultimo ha assegnato quote di contingente doganale a 840 persone fisiche o giuridiche.A 711 persone sono state assegnate quote per carne di animali della specie bovina (muscoli di manzo esclusi),a 417 per carne di animali della specie suina,a 171 per carne di animali della specie ovina,a 158 per muscoli di manzo,a 34 per carne di animali della specie equina e a 29 per carne di animali della specie caprina.Non è stato possibile entrare nel merito di 14 domande,in quanto inoltrate tardivamente o perché non raggiungevano il livello minimo di prestazione all'interno del Paese.Per la carne di pollame non hanno dovuto essere inoltrate domande.L’assegnazione delle quote del contingente doganale si basa sulle notifiche mensili della prestazione all’interno del Paese (acquisti diretti di carne di pollame dal macello indigeno) all’UFAG.Nell’anno oggetto del rapporto i titolari di quote di contingente doganale di carne di pollame sono stati 85.
Le quote di contingente doganale consentono di effettuare importazioni all’aliquota di dazio del contingente che è più bassa rispetto all’aliquota di dazio fuori contingente. Nell’anno oggetto del rapporto esse sono state assegnate in base a diversi criteri di determinazione delle prestazioni all’interno del Paese.La prestazione all’interno del Paese nel periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 è servita da base per l’assegnazione di quote di contingente doganale nell’anno civile 2004.Fa eccezione la carne di pollame per cui entrambi i periodi corrispondono esattamente all’anno oggetto del rapporto.Come mostra il grafico seguente,le quote di contingente doganale si concentrano per tutte le categorie di carne su poche persone fisiche e giuridiche.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 137 2
■ Struttura dei titolari di quote di contingente doganale
doganale
carne –
1 In % Fonte: UFAG 1 Carne di pollame – 2003 Carne d'agnello Carne bovina (muscoli di manzo esclusi) Muscoli di manzo Carne di cavallo Carne di maiale Carne di pollame Quota dei principali titolari di quote di contingente doganale Quota dei 5 principali titolari di quote di contingente doganale Quota dei 10 principali titolari di quote di contingente doganale 0 90 100 70 80 50 60 40 30 20 10
Titolari di quote di contingente
di
2004
La concentrazione maggiore si riferisce alla carne di pollame.Il titolare principale possiede,da solo,una quota di oltre un terzo del contingente doganale.Per quanto riguarda la carne suina ed equina la macellazione è l’unico criterio della prestazione all’interno del Paese.Per tale motivo dalla struttura dei titolari di contingente doganale si evince immediatamente anche la struttura delle aziende di macellazione.Un suino su quattro e un cavallo su cinque viene macellato in grandi aziende;nelle dieci maggiori aziende viene macellato il 73 rispettivamente l’80 per cento dei suini e dei cavalli.Per quanto riguarda la carne di bovini (muscoli di manzo esclusi) valgono gli stessi criteri applicati alla carne d’agnello come pure agli acquisti di lombi dal macello.Nell’ambito della carne bovina si riscontrano i maggiori titolari di quote di contingente doganale. I dieci principali titolari dispongono di oltre il 64 per cento delle quote di contingente doganale,mentre il restante 36 per cento è ripartito tra 701 persone.
I mercati pubblici di bestiame da macello e di ovini sono finalizzati a raggruppare e a rendere più trasparente l’offerta.Proviande è incaricata dall’UFAG di vigilare su questi mercati,di effettuare la classificazione neutrale di tutti gli animali e di assegnare i capi invenduti alle aziende tenute a ritirare animali sul piano indigeno.Per queste attività la Confederazione versa circa 2 milioni di franchi all’anno.I Cantoni di Berna,Friburgo, Grigioni,Giura,Neuchâtel,Obwaldo e Vaud promuovono i mercati pubblici mediante mezzi finanziari supplementari.I beneficiari di questi fondi sono produttori di bestiame da macello che portano gli animali ai mercati e di norma anche gli organizzatori dei mercati.I produttori ricevono premi per ogni animale presentato al mercato.Per il bestiame grosso tali premi sono costituiti da un contributo di base (contributo di presentazione) e da supplementi per la distanza di trasporto nonché per la qualità L’importo varia da 50 a 250 franchi per animale.Per quanto riguarda gli ovini,soltanto il Cantone Grigioni versa dei premi.L’importo varia,a dipendenza della distanza di trasporto sul mercato,da 6 a 9 franchi per animale.In tutti i Cantoni vitelli e agnelli sono esclusi dai premi.Gli organizzatori di mercati sono di norma organizzazioni contadine come ad esempio cooperative di bestiame da macello e associazioni contadine cantonali.Le loro spese sono coperte mediante mezzi finanziari cantonali e da contributi alle spese dei produttori.Questi contributi variano da 3.40 franchi per ovino a 37.50 franchi per capo di bestiame bovino.
Contributi cantonali a favore dei mercati pubblici di bestiame da macello – 2003
CantoneUnità Premi per Premi per Contributi per Totale produttori di produttori di organizzatori bestiame da ovinidi mercati macello
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 138
Bernafr.2 316 532-241 8492 558 381 Friburgofr.614 695--614 695 Grigionifr.595 118158 687110 400864 205 Giurafr.638 335--638 335 Neuchâtelfr.916 800--916 800 Obwaldofr.131 380-13 620145 000 Vaudfr.820 000-267 6151 087 615 Totalefr.6 032 860158 687633 4846 825 031 Fonte:Amministrazioni cantonali
■ Sostegno cantonale dei mercati pubblici di bestiame da macello
■ Uova:provvedimenti a sostegno della produzione indigena e misure di valorizzazione
Il Cantone Grigioni versa pure dei premi per il bestiame bovino commercializzato direttamente.Ha diritto a premi anche il bestiame bovino allevato nel quadro di uno speciale programma label o macellato in un macello nel Cantone.
La cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova fino alla fine del 2003 è stata alimentata da aliquote di dazio a destinazione vincolata.Nell'anno oggetto del rapporto era disponibile un importo di 10 milioni di franchi circa per il sostegno della produzione indigena di uova e per misure di valorizzazione.Dal 2004 i mezzi per il sostegno del mercato provengono da fondi generali della Confederazione. Anche nell’anno oggetto del rapporto l'UFAG ha concesso contributi agli investimenti per la ristrutturazione e la costruzione di pollai rispettosi delle esigenze degli animali. I contributi vengono erogati esclusivamente per pollai destinati alla produzione di uova,non devono venir rimborsati e non sono gravati da interessi.Complessivamente è stato prospettato il versamento di 471'000 franchi a 26 aziende con ovaiole,4 aziende con pollastrelle e 2 aziende con ovaiole e pollastrelle.Oltre ai contributi versati nel 2002,nell'anno oggetto del rapporto l'UFAG ha provveduto allo stanziamento di contributi agli investimenti per un importo di 598'000 franchi.Le aziende che hanno beneficiato di tali contributi detengono mediamente 2'600 ovaiole e/o 4'300 pollastrelle.Delle 32 aziende che nell’anno oggetto del rapporto hanno ottenuto un contributo,15 (47%) osservano i criteri della produzione biologica.Ciò spiega anche i minori effettivi di animali delle aziende beneficiarie di contributi rispetto all’anno precedente.
Dopo la Pasqua e nei mesi estivi la domanda di uova indigene è minore rispetto ai periodi precedenti il Natale e la Pasqua.Onde attutire le ripercussioni delle fluttuazioni stagionali della domanda,l'UFAG mette a disposizione 3 milioni di franchi per il finanziamento di misure di valorizzazione.Le azioni di spezzatura svolte dalle ditte che fabbricano prodotti a base di uova hanno interessato 16,9 milioni di uova indigene.Tali azioni sono sostenute mediante il versamento di un contributo di 9 centesimi per uovo spezzato.Le azioni di riduzione del prezzo,di cui approfittano i consumatori,hanno interessato 11,9 milioni di uova.Il contributo concesso agli offerenti ammonta a 5 centesimi per uovo.L'UFAG ha verificato l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di azioni di spezzatura e di riduzione del prezzo,eseguendo sopralluoghi e controlli dei documenti probatori.
Nell’anno oggetto del rapporto l'UFAG ha concesso contributi per un ammontare di circa 205'000 franchi a sostegno degli esperimenti sul pollame conformi alla pratica e della divulgazione dei risultati a livello di formazione e consulenza.Ne hanno beneficiato l’Aviforum a Zollikofen e l'IRAB a Frick.I seguenti progetti sono stati sostenuti con fondi della cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova: ottimizzazione della detenzione di ovaiole con uscita sull’erba – gestione e allevamento;influsso della proteina grezza e del tenore di metionina nonché dell’origine ibrida su prestazione,tasso di decesso e piumaggio delle ovaiole;valutazione dei risultati zootecnici di due ibridi di ovaiole nutriti con foraggio biologico rispettivamente con un supplemento di foraggio biologico.

2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 139 2
■ Cavalli da reddito e per la pratica di sport: vendita all’asta di quote di contingente doganale
Anche nell’anno oggetto del rapporto l’UFAG ha pubblicato e venduto all’asta il contingente doganale «animali della specie equina (esclusi riproduttori,asini,muli e bardotti)».I due bandi comprendevano ciascuno 1'461 capi.In occasione di ogni vendita all'asta,più di 180 persone hanno inoltrato offerte per oltre 2'000 capi;il prezzo medio d'aggiudicazione ammontava a 351 franchi per cavallo da reddito e per la pratica di sport.Il ricavo della vendita all’asta a favore della Cassa federale è stato di 1 milione di franchi.
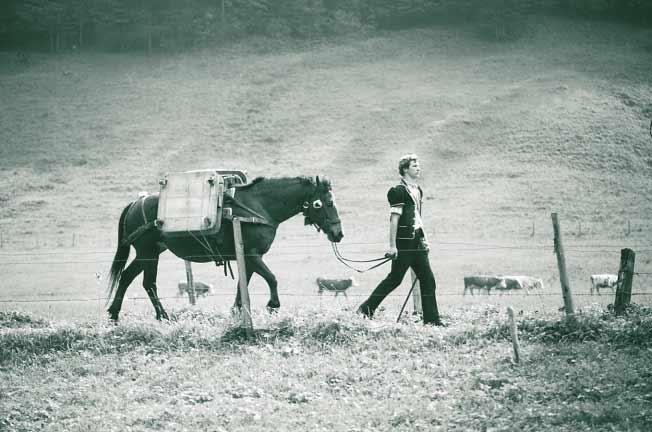
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 140
Provvedimenti – 2003
2.1.4Produzione vegetale
Nell’anno oggetto del rapporto,nel settore della produzione vegetale non sono intervenute modifiche di rilievo nell’elenco dei provvedimenti di sostegno del prezzo indigeno.In campicoltura la protezione alla frontiera resta il principale sostegno dei prezzi alla produzione.Il conflitto di obiettivi all’interno del primario tra un elevato ricavo alla produzione nella coltivazione di cereali da foraggio,leguminose a granelli e semi oleosi e prezzi di costo più contenuti per alimenti concentrati per i detentori di animali da reddito ha intensificato la spinta verso la riduzione dei dazi per i componenti degli alimenti concentrati.

La protezione alla frontiera rappresenta il provvedimento principale anche per quanto riguarda frutta,verdura e fiori recisi.Nel settore della frutta rivestono un significato considerevole anche la partecipazione finanziaria alla trasformazione delle eccedenze di frutta da sidro nonché i provvedimenti di sgravio del mercato per la frutta a nocciolo.
1A dipendenza dello scopo di utilizzazione o della voce di tariffa non vi è imposizione doganale o vengono applicati dazi ridotti
2Riguarda solo una parte del quantitativo raccolto (somministrazione allo stato fresco ed essiccazione di patate,riserva di mercato per i concentrati di frutta a granella)
3Per prodotti di patate commestibili
4Soltanto per le patate da semina
5Trasformazione di 2'655 tonnellate di uva in prodotti analcolici
■■■■■■■■■■■■■■■■
Protezione alla frontiera 1 ■■■■■■■■ Contributi di trasformazione ■■ 2 ■■ 2 ■ 5 ■ 2 Contributi di coltivazione ■■■ Contributi all’esportazione ■ 3 ■ 4 ■
Provvedimento
Fonte:UFAG Coltura Cereali Leguminose a granelli Semi oleosi Patate Barbabietole da zucchero Sementi Verdura,fiori recisi, vitivinicoltura Frutta 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 141 2
■ Mezzi finanziari
Rispetto all’anno precedente i mezzi finanziari a disposizione per il sostegno del mercato nel settore della produzione vegetale sono aumentati da 146 a 154 milioni di franchi (compr.la promozione dello smercio in vitivinicoltura:5,1 mio.fr.),di cui 4,5 milioni di franchi sono riconducibili all’ampliamento delle superfici messe a leguminose a granelli e a semi oleosi.3 milioni di franchi sono stati versati ai coltivatori di semi oleosi.I contributi per la coltivazione delle leguminose a granelli sono aumentati di 1,5 milioni di franchi (+24%).

Ripartizione
Totale 154 mio. fr.
Contributi all'esportazione
11%
Diversi 7%
Contributi alla trasformazione e alla valorizzazione 54%
Diversi: compresa promozione dello smercio di vino
Contributi di coltivazione
28%
Fonte: Conto dello Stato
Le uscite per la trasformazione di semi oleosi per scopi alimentari,da foraggio o per fini tecnici sono rimasti stabili a 8,5 milioni di franchi.
dei mezzi – 2003
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 142
Ripartizione dei mezzi secondo le colture mio.
Barbabietole da zucchero
PatateLeguminose a granelli Semi oleosiMaterie prime rinnovabili
200120022003
1 Compresa la promozione dello smercio
Totale
Produzione di sementi
FruttaVitivinicoltura 1
Fonte: Conto dello Stato
Esportazione di altri prodotti di frutta a granelli 3,0%
Esportazione di ciliege 2,1%
Valorizzazione indigena di mele e pere 4,1%
Esportazione di concentrato di succo di mela 52,3%
Esportazione di concentrato di succo di pera 36,8%
Altro 1,7% di cui sgravio del mercato di ciliege e prugne 0,8%
Fonte: UFAG
Nell’anno oggetto del rapporto il sostegno per la valorizzazione della frutta è stato pari a 17,8 milioni di franchi.Rispetto al 2002 le uscite per l’esportazione di concentrato di succo di pera hanno registrato un aumento di 3,6 milioni di franchi.Quasi nella stessa misura sono invece diminuite le uscite per l’esportazione di concentrato di succo di mela.
fr.
0 45 50 40 35 30 25 20 15 10 5
Uscite per la valorizzazione della frutta – 2003
17,8 mio. fr
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 143 2
■
Colture campicole
Nell’ambito delle colture campicole le patate stanno assumendo un ruolo sempre più importante,in quanto vengono messe in commercio sia fresche che come prodotti trasformati.Il consumo privato di patate fresche ammonta a circa 130'000 tonnellate (70%).Il 70 per cento dei prodotti di trasformazione,invece,sono destinati al consumo fuori casa.Le diverse condizioni poste in materia di qualità da addetti alla trasformazione e consumatori finali determinano,per i produttori di patate,un notevole impegno relativamente alla scelta delle varietà e ai volumi di produzione.
Evoluzione delle strutture nella coltivazione di patate
Gli strumenti per il sostegno del mercato delle patate erano orientati verso un disciplinamento liberale del mercato già prima dell’attuazione della Politica agricola 2002. Dal 1997 l’evoluzione strutturale è proseguita ininterrottamente.Il numero delle aziende produttrici di patate è in calo mentre le superfici coltivate hanno toccato i 14'000 ettari circa.Alla luce di questa evoluzione la superficie coltiva media per azienda è salita a 1,4 ettari.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 144
Provvedimenti relativi al mercato delle patate
ha risp. n. d'aziende ha Numero di aziende Totale superficie coltiva Media Fonte: swisspatat 1997 0 18 0001,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003
mercato
di patate
di patate) 2002 20012003200220012003200220012003200220012003 In 1 000 t Esportazioni Importazioni Produzione indigena Patate da seminaPatate da tavolaPatate da trasformare Prodotti di patate Fonti: swisspatat, DGD, UFAG 0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
Volumi di patate e di prodotti di patate adatti alle esigenze
di
(prodotti
in equivalenti
Il volume medio di patate che soddisfano le esigenze di mercato ammonta complessivamente a 350'000 tonnellate.La garanzia del rendimento nell’ambito della coltivazione delle patate è strettamente vincolata alle condizioni climatiche,visto che in caso di eccessiva umidità aumenta il rischio di malattie e,in caso di siccità i tuberi possono presentare dimensioni non adatte allo scopo finale.Anche i volumi d’importazione a copertura del fabbisogno nazionale variano di conseguenza,superando,laddove necessario,l’accesso minimo garantito pari a 22'250 tonnellate previsto nel quadro degli accordi GATT/OMC.Dal 1997 al 2003 il rapporto tra quota delle importazioni e produzione indigena è passato dal 12 al 22 per cento per le patate da semina,dal 3 al 9 per cento per le patate da tavola e dal 2 al 18 per cento per le patate da trasformazione. Dal 1997 i volumi d’esportazione di patate da semina e fresche si sono mantenuti su livelli esigui.Anche il commercio transfrontaliero di prodotti di trasformazione (prodotti semilavorati o finiti) – calcolati in equivalenti di patate – ha ricoperto un ruolo marginale relativamente al consumo indigeno.Il rapporto tra prodotti di trasformazione importati ed esportati varia dal 47 al 113 per cento.L’assegnazione dei contingenti d’importazione per i prodotti di trasformazione avviene mediante vendita all’asta mentre le patate fresche possono essere importate proporzionalmente alla prestazione fornita all’interno del Paese.
I principali strumenti di sostegno al mercato per la coltivazione di patate sono la protezione alla frontiera e i contributi alla valorizzazione (2003:18 mio.fr.).Inoltre vengono sostenuti con contributi anche la valorizzazione di patate da semina (2003:2,6 mio.fr.) e l’esportazione di prodotti a base di patate (2003:0,9 mio.fr.).Se le patate non cernite,per motivi legati alla qualità o alla domanda,non trovano uno sbocco nel settore alimentare,previo controllo e declassamento da parte della competente organizzazione di controllo possono essere valorizzate richiedendo i rispettivi contributi.Per provvedimenti di valorizzazione aventi diritto a contributi s’intende il foraggiamento con patate declassate fresche,la gestione delle scorte di patate da tavola e la trasformazione di patate non cernite nonché l’essiccazione di patate da tavola e da trasformazione a scopo foraggero.Per la valorizzazione delle patate sulla scorta di un accordo di prestazione la categoria riceve un contributo di 18,0 milioni di franchi che è libera di destinare alla promozione del foraggiamento allo stato fresco,della gestione delle scorte o dell’essiccazione.Le patate scartate perché non conformi alle esigenze di mercato possono sono utilizzate per il foraggiamento di animali,senza tuttavia beneficiare di contributi.Con lo stanziamento di aiuti finanziari per la valorizzazione di patate

2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 145 2
Valorizzazione delle eccedenze di patate In 1 000 t Foraggiamento fresco con aiuti finanziari EssiccazioneForaggiamento senza aiuti finanziari Fonte: swisspatat 1997 0 250 200 150 100 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003
■ Prospettiva
non cernite si riducono in particolare i rischi legati alle condizioni climatiche che possono pregiudicare le colture.
Per mantenere le quote di mercato relative alla detenzione di suini e di pollame in una situazione che volge verso una graduale liberalizzazione,i detentori di animali intendono contenere i costi degli alimenti concentrati chiedendo la riduzione dei dazi.Ciò comporterebbe anche il calo dei prezzi dei cereali da foraggio indigeni con conseguente conflitto d’obiettivi all’interno del primario.In relazione agli imperativi di risparmio ed alla ridistribuzione dei pagamenti diretti richiesta dai produttori,verrà esaminata una riduzione dei dazi che tuttavia potrà essere attuata al più presto a metà del 2005.
Il contingente di cereali panificabili di 70'000 tonnellate fino al 2003 è stato messo all’asta su base semestrale mentre nel 2004 è stato assegnato in quattro tranches dato lo scarso raccolto nell’anno oggetto del rapporto.Dalla categoria è giunta la richiesta di passare,dal 2005,dalla procedura di vendita all’asta a quella in base all’ordine d’entrata delle domande con assegnazione in quattro tranches.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 146
2.2 Pagamenti diretti
I pagamenti diretti sono uno degli elementi principali della politica agricola.Da un lato consentono di tracciare una linea di demarcazione tra politica dei prezzi e politica dei redditi,dall’altro indennizzano le prestazioni richieste dalla società.Si distingue fra pagamenti diretti generali e pagamenti diretti ecologici.

Uscite per i pagamenti diretti
Ambito
Avvertenza:Non è possibile effettuare un paragone diretto con i dati del Conto dello Stato.I valori indicati nella parte 2.2 «Pagamenti diretti» si riferiscono all’intero anno di contribuzione,mentre il Conto dello Stato riporta le spese sostenute durante un anno civile.Le riduzioni si riferiscono alle deduzioni dovute alle limitazioni e alle sanzioni giuridiche e amministrative.
Fonte:UFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■
mio.fr.mio.fr.mio.fr.mio.fr.mio.fr. Pagamenti
8041 9291 9951 999 Pagamenti diretti ecologici326361413452477 Riduzioni2423172117 Totale 2 0812 1422 3252 4262459
di spesa19992000200120022003
diretti generali1 7791
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 147
■ Indennizzo di prestazioni a favore della collettività
2.2.1Importanza dei pagamenti diretti
Le prestazioni dell’agricoltura a favore della collettività vengono indennizzate tramite i pagamenti diretti generali.Tra questi rientrano i contributi di superficie e quelli per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo.Questi contributi sono finalizzati a garantire la gestione e la cura delle superfici sull’intero territorio nazionale.Nella regione collinare e in quella di montagna i gestori percepiscono inoltre contributi di declività e contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione. Tali provvedimenti consentono di tenere in considerazione le difficoltà di gestione con le quali sono confrontati coloro che operano in queste regioni.I pagamenti diretti (esclusi i contributi d’estivazione) sono concessi soltanto agli agricoltori che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER).
■ Indennizzo di prestazioni ecologiche particolari
I pagamenti diretti ecologici costituiscono un incentivo a fornire prestazioni ecologiche particolari che vanno oltre la PER e le esigenze previste dalla legge.Tra questi rientrano i contributi ecologici,per la qualità ecologica,d’estivazione e per la protezione delle acque.Mediante questi contributi s’intende conservare e aumentare la biodiversità nelle regioni agricole,ridimensionare l’uso di concimi e prodotti fitosanitari,incentivare la detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze,ridurre il carico di nitrato e fosforo nei corsi d’acqua e gestire in modo sostenibile la regione d’estivazione.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 148
■
Nel 2003 i pagamenti diretti corrispondevano a circa due terzi delle uscite dell’UFAG. Il 59 per cento dei pagamenti diretti è andato a beneficio delle regioni di montagna e collinare.
Non è possibile effettuare un paragone diretto con i dati del Conto dello Stato.I valori indicati nella parte 2.2 «Pagamenti diretti» si riferiscono all’intero anno di contribuzione,mentre il Conto dello Stato riporta le spese sostenute durante un anno civile.Le riduzioni si riferiscono alle deduzioni dovute alle limitazioni e alle sanzioni
Pagamenti diretti – 2003 Tipo di contributoTotaleRegione Regione Regione di pianuracollinaredi montagna 1 000 fr. Pagamenti diretti generali1 999 091735 200515 759737 608 Contributi di superficie1 317 956650 201327 052340 704 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo287 69278 58873 870135 234 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione287 2894 15680 886202 246 Contributi di declività generali95 6302 25533 95059 424 Contributi di declività per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate10 524 Pagamenti diretti ecologici476 552190 336105 51185 471 Contributi ecologici381 319190 336105 51185 471 Contributi per la compensazione ecologica124 92772 12831 63521 164 Contributi giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE)14 6384 4414 4485 749 Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza (produzione estensiva)31 25521 5208 895841 Contributi per l’agricoltura biologica27 1358 1615 58113 393 Contributi per la detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze (SSRA,URA)183 36384 08754 95344 323 Contributi d’estivazione91 381 Contributi per la protezione delle acque4 024 Riduzioni17 138 Totale pagamenti diretti2 458 677925 537621 270823 079 Pagamenti diretti per azienda (fr.)42 71838 01839 87646 648
Avvertenza:
giuridiche e amministrative.
Fonte:UFAG
Importanza
pagamenti diretti –
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 149 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
economica dei
2003
Quota dei pagamenti diretti rispetto al reddito lordo delle aziende di riferimento,per regione – 2003
CaratteristicaUnitàTotaleRegioneRegioneRegione di di pianuracollinaremontagna
AziendeNumero2 6631 219745699
SAU in Øha19,1019,7918,4818,60
Pagamenti diretti generalifr.36 93629 84336 51348 846
Contributi ecologicifr.7 4748 2217 8565 878
Totale pagamenti direttifr.44 41038 06444 36854 725
Reddito lordofr.203 189247 188186 427148 901
Quota dei pagamenti diretti
sul reddito lordo%21,915,423,836,8
Fonte:Agroscope FAT Tänikon

L’importo dei pagamenti versato per ettaro lievita proporzionalmente al grado di difficoltà gestionali con cui sono confrontate le regioni collinare e di montagna.La contemporanea diminuzione del reddito causa un aumento della quota di pagamenti diretti rispetto al reddito lordo della regione di pianura e di montagna.
Per avere diritto ai pagamenti diretti i gestori devono adempiere una serie di esigenze. Tra queste rientrano condizioni di natura generale come la forma giuridica,il domicilio di diritto civile,eccetera,ma anche criteri strutturali e sociali come ad esempio il volume di lavoro minimo,l’età del gestore,il reddito e la sostanza.A ciò si aggiungono condizioni specifiche di carattere ecologico in base al concetto della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.Le esigenze poste dalla PER comprendono: bilancio di concimazione equilibrato,quota adeguata di superfici di compensazione ecologica,avvicendamento disciplinato delle colture,protezione adeguata del suolo, utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari e detenzione degli animali da reddito agricoli rispettosa delle loro esigenze.L’infrazione delle prescrizioni determinanti comporta sanzioni sotto forma di riduzione o diniego dei pagamenti diretti.
Tabelle 41a–42,pagine A46–A49
150 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2
■ Esigenze poste per l’ottenimento di pagamenti diretti
■ Sistema d’informazione sulla politica agricola
La maggior parte dei dati statistici sui pagamenti diretti proviene dalla banca dati sviluppata dall’UFAG,denominata AGIS/SIPA (sistema d’informazione sulla politica agricola).In questo sistema affluiscono i dati delle rilevazioni annuali delle strutture effettuate dai Cantoni e i dati sui versamenti (superfici ed effettivi di bestiame che hanno beneficiato dei contributi e rispettivi importi) per tutti i tipi di pagamenti diretti. La banca dati serve in primo luogo per assicurare un controllo,sul piano amministrativo,degli importi versati dai Cantoni ai gestori.Il sistema consente inoltre di allestire statistiche di carattere generale sui pagamenti diretti.Grazie alla ricchezza d’informazioni e all’efficienza delle applicazioni informatiche è possibile illustrare un gran numero di aspetti inerenti alla politica agricola.
Delle 63'418 aziende,al disopra del limite di rilevazione federale e registrate nel 2003 nell’AGIS/SIPA,57'566 hanno adempiuto i presupposti per l’ottenimento di pagamenti diretti.
■ Effetti delle graduazioni e delle limitazioni
Graduazioni e limitazioni si ripercuotono sulla ripartizione dei pagamenti diretti.Tra le limitazioni rientrano i limiti di reddito e di sostanza nonché il contributo massimo per unità standard di manodopera (USM),mentre le graduazioni si riferiscono alla riduzione progressiva dei contributi per superfici ed animali.
Effetti delle limitazioni dei pagamenti diretti – 2003
LimitazioneAziende Importo totale Quota rispetto al Quota rispetto interessatedelle deduzionicontributo totale all’importo dei delle aziendepagamentidiretti
Le limitazioni comportano la riduzione dei pagamenti diretti,in particolare per le 213 aziende che dispongono di una sostanza troppo elevata.Nel 2003 le aziende che hanno superato il limite di reddito sono state circa 980.Per esse la riduzione dei pagamenti diretti è stata mediamente del 10,2 per cento.Le limitazioni hanno comportato una riduzione di 9 milioni di franchi dell’importo dei pagamenti diretti,ovvero dello 0,37 per cento rispetto all’importo totale.
Numerofr.%% per USM (55'000 fr.)259601 1786,180,02 a causa del reddito9784 736 97410,170,19
a causa della sostanza2133 663 27659,970,15 Fonte:UFAG
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 151 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
Effetti delle graduazioni dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali – 2003
Riduzione Quota rispetto Quota rispetto interessateeffettivo al contributo all'importo di animalidelle aziendedei pagamenti per aziendadiretti
Le graduazioni previste dall’ordinanza sui pagamenti diretti hanno interessato complessivamente 8'265 aziende.Nella maggior parte dei casi sono state applicate deduzioni per diversi provvedimenti.Le riduzioni ammontano complessivamente a 34 milioni di franchi circa.Commisurate a tutti i pagamenti diretti,i quali sono graduati,rappresentano una quota dell'1,6 per cento.La riduzione progressiva dei contributi si ripercuote in modo massiccio soprattutto sui contributi di superficie.In questi casi le graduazioni interessano oltre 7'000 aziende (circa il 12% delle aziende che beneficiano di pagamenti diretti).Tra le aziende che percepiscono contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 212 si sono viste ridurre i contributi,in quanto altre limitazioni specifiche previste nell’ambito di questo provvedimento,come il limite di promozione e la deduzione per il latte commercializzato,espletano i loro effetti prima della graduazione dei pagamenti diretti.Le riduzioni dei contributi hanno interessato anche i pagamenti diretti ecologici.Ad esempio,circa 2'656 aziende (esclusi doppi versamenti) hanno subito riduzioni del 10,2 per cento (SSRA) rispettivamente dell’8,1 per cento (URA) dei pagamenti diretti per la detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze (URA e SSRA),mentre 705 aziende dedite all’agricoltura biologica hanno dovuto sopportare riduzioni del 7,4 per cento.
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 152
ProvvedimentoAziende
Numeroha o UBGfr.%% Contributi di superficie7 02641,929 115 3897,4%2,21% Contributi per la detenzione
reddito che consumano foraggio grezzo21258,3596 7315,8%0,21% Contributi di declività generali8734,743 7603,40,05 Contributi di declività per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate130,97770,70,01 Contributi per la compensazione ecologica849,788 81620,90,07 Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza (produzione estensiva)4936,834 0634,80,11 Contributi per l’agricoltura biologica70540,2539 4637,41,99 Contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali1 62166,91 420 27210,23,28 Contributi per l’uscita regolare all’aperto2 32663,32 120 1208,11,51 Totale8 265 1 33 959 3918,11,63 1Esclusi doppi versamenti Fonte:UFAG
Superficie/
di animali da
■ Esecuzione e controllo
Conformemente all’articolo 66 dell’ordinanza sui pagamenti diretti,il controllo in relazione alla PER è delegato ai Cantoni.Per l’esecuzione essi possono avvalersi di organizzazioni accreditate che garantiscono controlli obiettivi e imparziali.I Cantoni verificano,per campionatura,l’attività di controllo esercitata da tali organizzazioni.Le aziende dedite all’agricoltura biologica aventi diritto a pagamenti diretti,oltre agli oneri relativi all’agricoltura biologica,devono adempiere le condizioni poste dalla PER e detenere tutti gli animali da reddito in base alle esigenze poste dal programma URA. Tali aziende vengono sottoposte a controllo da parte di enti di certificazione accreditati.I Cantoni sorvegliano il corretto svolgimento di questi controlli.L’articolo 66 capoverso 4 dell’ordinanza sui pagamenti diretti precisa i criteri in base ai quali i Cantoni o le organizzazioni alle quali essi si sono rivolti devono controllare le aziende.
I controlli devono riguardare: –tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi corrispondenti; –tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei controlli dell’anno precedente e –almeno il 30 per cento delle altre aziende scelte a caso.
In caso di infrazioni della PER,come ad esempio la fornitura di indicazioni non veritiere, le aziende vengono sanzionate in base a criteri uniformi.A tal fine la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura ha approvato uno schema di sanzioni.
■ Controlli eseguiti e sanzioni – 2003
Nel 2003 le aziende aventi diritto a contributi ammontano a 57'566,di cui 38'999 (68%) sono state sottoposte a controllo in merito al rispetto della PER da parte dei Cantoni rispettivamente dai competenti servizi di controllo.Tuttavia la quota delle aziende controllate varia notevolmente da Cantone a Cantone (35–100%).Sono state erogate sanzioni per mancato adempimento delle prescrizioni relative alla PER nei confronti di 2'159 aziende (6% delle aziende controllate).
In virtù dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutte le aziende dedite all’agricoltura biologica devono essere controllate su base annuale.Il 4 per cento delle aziende ha ricevuto una sanzione per infrazione.
Nell’ambito dei programmi SSRA e URA è stato controllato rispettivamente il 78 per cento (30–100%) ed il 72 per cento (32–100%) delle aziende aventi diritto a contributi.Nel quadro di entrambi i programmi sono state erogate sanzioni nei confronti del 3 per cento delle aziende controllate.
Complessivamente sono state constatate oltre 6'136 lacune,che hanno comportato riduzioni di contributi pari a 8,2 milioni di franchi circa.
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 153
Notifica tardiva,registrazioni lacunose,detenzione degli animali da reddito non rispettosa delle loro esigenze,compensazione ecologica insufficiente,fasce tampone ed inerbite insufficienti,bilancio di concimazione non equilibrato, mancato avvicendamento disciplinato delle colture,mancata protezione adeguata del suolo, mancata selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento delle piante
Notifica tardiva,sfruttamento troppo precoce o non autorizzato,indicazioni non veritiere sulle superfici,malerbe,impiego di concimi e prodotti per il trattamento delle piante non autorizzati, indicazioni non veritiere sul numero di alberi.
Notifica tardiva,raccolto finalizzato all’estrazione di granelli effettuato prima della piena maturazione,indicazioni non veritiere sulle superfici, impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati Indicazioni non veritiere,notifica tardiva,impiego di concimi e prodotti per il trattamento delle piante non autorizzati in agricoltura biologica Notifica tardiva,detenzione non conforme alle prescrizioni di alcuni animali della medesima categoria,mancanza di un sistema di stabulazione ad aree multiple,area di riposo insufficiente,illuminazione delle stalle insufficiente, indicazioni non veritiere
Giorni d’uscita insufficienti,registrazioni lacunose,detenzione non conforme alle prescrizioni di alcuni animali della medesima categoria, corte insufficiente,notifica tardiva,indicazioni non veritiere
Notifica tardiva,carico inferiore/superiore a quello usuale,gestione dei pascoli inadeguata, utilizzo di superfici non destinate al pascolo, indicazioni non veritiere su superficie/effettivo di animali/date/durata dell'estivazione
Indicazioni non veritiere sulle superfici,indicazioni non veritiere sull'azienda o sul gestore, indicazioni non veritiere sull'effettivo di animali e sull'estivazione
Nessuna indicazione possibile
Nessuna indicazione possibile
Nessuna indicazione possibile
Tabelle
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 154 Ricapitolazione
Aziende AziendeSanzioniMotivi
a contributi NumeroNumeroNumerofr. PER57 56638 9992 1593 247 646 SCE54 564-790585 422 Produzione estensiva17 784-4222 379 Biologico6 1826 26823493 531 SSRA18 47716 932540421 317 URA36 61827 0979311 050 681 Estivazione7 4811 227 326783 607 Dati di base--6371 146 395 Protezione delle acque--410 834 028 Protezione della na---5836 227 tura e del paesaggio Protezione --3623 800 dell’ambiente Totale--6 1638 245 033 Fonte:rapporti cantonali concernenti i controlli e le sanzioni
delle sanzioni – 2003 CategoriaAziende
principali aventi dirittocontrollatesanzionate
43a–43b,pagine A50–A51
■
In casi specifici,in cui le condizioni della PER non possono essere rispettate affatto o soltanto in parte per motivi di forza maggiore,il Cantone può concedere deroghe in virtù dell’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza sui pagamenti diretti.Il mantenimento del diritto ai contributi si basa su una domanda precedentemente accolta.Nel 2003,i Cantoni,di comune accordo con l’UFAG,hanno concesso autorizzazioni eccezionali in ambito di compensazione ecologica,bilancio delle sostanze nutritive e protezione del suolo a causa della straordinaria siccità.
■
In casi speciali,riconducibili a condizioni atmosferiche o locali particolari,onde proteggere le piante vengono autorizzati prodotti fitosanitari o determinati trattamenti che non sono consentiti nell’ambito della PER.In virtù dell’allegato 6,4 dell’ordinanza sui pagamenti diretti,i servizi fitosanitari cantonali possono concedere autorizzazioni speciali.Nel 2003 per 7’651 ettari di SAU sono state rilasciate 2'975 autorizzazioni speciali.Analogamente agli anni precedenti,nella maggior parte dei casi sono stati autorizzati trattamenti contro le malerbe sui prati naturali.Si è trattato principalmente di trattamenti contro romice e ranuncolacee.Rispetto all’anno precedente è aumentato l’impiego d’insetticidi,dato che,a causa del caldo e della siccità,è stata superata la soglia di tolleranza relativa alla criocera del frumento.

2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 155
Autorizzazioni speciali rilasciate nel settore fitosanitario – 2003 ProdottoAutorizzazioniSuperficie Numero%ha% Erbicidi in preemergenza1545,26738,8 Insetticidi81327,32 18928,6 Granulati per il granturco692,32543,3 Granulati per le barbabietole32310,993612,2 Erbicidi per i prati1 51651,02 78636,4 Altri1003,481310,6 Totale2 9751007 651100 Fonte:UFAG
Autorizzazioni speciali nel settore della protezione fitosanitaria
Mancato adempimento della PER per motivi di forza maggiore
■ Obiettivo:gestione globale delle superfici
2.2.2 Pagamenti diretti generali
Contributi di superficie
Mediante i contributi di superficie vengono indennizzate le prestazioni a favore della collettività come la protezione e la cura del paesaggio colturale,l’assicurazione della produzione di derrate alimentari e la conservazione delle basi vitali naturali.Nel 2001 tali contributi sono stati integrati con un contributo supplementare per i terreni coltivi aperti e per le colture perenni.
Aliquote 2003fr./ha 1
– fino a 30 ha1 200
– da 30 a 60 ha900
– da 60 a 90 ha600
– oltre 90 ha0
1Il contributo supplementare per i terreni coltivi aperti e le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro all’anno e soggiace alla graduazione delle superfici
Nel caso di superfici gestite per tradizione famigliare nella zona economica estera le aliquote dei pagamenti diretti legati alle superfici sono ridotte del 25 per cento.Dal 1984 nella zona economica estera vengono gestiti complessivamente 5'001 ettari.
Contributi di superficie – 2003 (compreso il contributo supplementare)
Il contributo supplementare è stato concesso per 272’141 ettari di terreni coltivi e 17'872 ettari di colture perenni.
■■■■■■■■■■■■■■■■
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna Superficieha477 077262 050288 1951 027 321 AziendeNumero24 23215 54417 62157 397 Superficie per aziendaha19,716,916,417,9 Contributo per aziendafr.26 83221 04019 33522 962 Totale contributi1 000 fr.650 201327 0521 317 956 Totale contributi 20021 000 fr.649 864327 7261 316 183 Fonte:UFAG
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 156
Tabelle 32a–32b,pagine A32–A33
Ripartizione delle aziende e della SAU secondo le classi di dimensione – 2003
La riduzione dei contributi ha interessato l’8,9 per cento della SAU.In media,per ettaro viene versato un contributo di superficie di 1'283 franchi (compr.il contributo supplementare).Le aziende con una superficie fino a 10 ettari gestiscono complessivamente il 9,5 per cento della SAU.Soltanto l’1,2 per cento delle aziende dispone di una superficie superiore ai 60 ettari.Tali aziende gestiscono il 4,8 per cento della SAU totale.

Classi di dimensione in ha Aziende SAU <30 SAU 30–60 SAU 60–90 SAU >90 30 20 2010 0201030 oltre 90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 fino a 5 1,61,60,5 20,0 27,5 17,7 14,7 7,9 12,0 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 20,3 18,2 21,0 18,5 1,6 5,9 Aziende in % SAU in % 8,8 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 157
Fonte: UFAG
■ Utilizzazione delle superfici inerbite
Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo
Questo provvedimento è finalizzato a mantenere la competitività della produzione di carne mediante foraggio grezzo e nel contempo a garantire,attraverso la gestione,la cura globale delle superfici nel nostro Paese a vocazione pastorizia.

I contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo vengono concessi a favore degli animali tenuti nella rispettiva azienda durante il foraggiamento invernale (periodo di riferimento:1° gennaio fino al giorno di riferimento dell’anno di contribuzione).Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo si intendono quelli delle specie bovina ed equina nonché ovini,caprini,bisonti, cervi,lama e alpaca.I contributi vengono versati a favore delle superfici permanentemente inerbite e dei prati artificiali.Le diverse categorie di animali vengono convertite in unità di bestiame grosso che consumano foraggio grezzo (UBGFG) e sono limitate per ettaro.La limitazione è graduata in funzione delle zone.
Limitazione della promozioneUBGFG/ha
– zona campicola,zona intermedia ampliata e zona intermedia2,0
zona collinare1,6
– zona di montagna I1,4
– zona di montagna II1,1
zona di montagna III0,9
– zona di montagna IV0,8
–
–
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 158
Le UBGFG sono suddivise in due gruppi di contribuzione.Per gli animali delle specie bovina ed equina,i bisonti,le capre lattifere e le pecore lattifere vengono versati 900 franchi per UBGFG,mentre a favore delle altre capre e pecore nonché di cervi, lama e alpaca l’importo dei contributi scende a 400 franchi per UBGFG.
Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo – 2003
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
UBGFG che danno diritto
ai contributiNumero91 34285 850159 699336 891
AziendeNumero10 69811 13815 86137 697
UBGFG per azienda che danno diritto ai contributiNumero8,57,710,18,9
Contributi per aziendafr.7 3466 6328 5267 632
Totale contributi1 000 fr.78 58873 870135 234287 692
Totale contributi 20021 000 fr.76 71473 489133 018283 221
Fonte:UFAG
Nel 2003,per ogni 4'400 chilogrammi di latte fornito nell’anno precedente i produttori di latte commerciale hanno subito la detrazione di una UBGFG dall’effettivo avente diritto ai contributi.Rispetto all’anno precedente l’importo dei contributi è aumentato di 4,5 milioni di franchi circa,il che è riconducibile essenzialmente alla cessazione della produzione lattiera in circa 1'500 aziende.
Contributi ad aziende con e senza latte commercializzato – 2003
CaratteristicaUnità Aziende Aziende con latte senza latte commercializzato commercializzato AziendeNumero20 09817 599
Animali per aziendaUBGFG23,612,8
Deduzione per la limitazione dei contributi sulla base della superficie inerbitaUBGFG1,21,2
Deduzione per il latteUBGFG15,80,0
Animali che danno diritto ai contributiUBGFG6,611,6
Contributi per aziendafr.5 8159 706
Fonte:UFAG
Le aziende che commercializzano latte ricevono contributi UBGFG decurtati di 3'900 franchi rispetto a quelle che non producono latte commerciale,ma approfittano del sostegno del mercato previsto nel settore dell’economia lattiera (p.es.supplemento per il latte trasformato in formaggio).
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 159
■ Indennizzo delle difficoltà di produzione
Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione
Mediante questi contributi vengono indennizzate le condizioni difficili di produzione con le quali sono confrontati i detentori di animali nella regione di montagna e nella zona collinare.Contrariamente ai contributi generali per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo,volti in primo luogo a promuovere lo sfruttamento e la cura dei pascoli,questa misura persegue anche obiettivi sociali,strutturali e di politica d’insediamento.Le categorie di animali sussidiabili sono le stesse di quelle che beneficiano dei contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo.I contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione vengono concessi per un massimo di 20 UBGFG per azienda.
Aliquote per UBGFG – 2003fr./UBG
– zona di montagna
Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione – 2003
Regione di Regione Regione di Totale pianura 1 collinaremontagna
Rispetto all’anno precedente il mutamento strutturale in corso ha comportato una diminuzione di 2,3 milioni di franchi circa dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione.Per le UBGFG aventi diritto ai contributi si registra un calo di poco meno di 4'700 unità.Il numero delle aziende è ancora diminuito,segnatamente di 312 unità
–
collinare260
I440
II690 – zona di montagna III930 – zona di montagna IV1 190
zona
– zona di montagna
UBGFG che danno diritto ai contributiNumero46 951233 589244 622525 163 AziendeNumero2 64914 75916 99134 399 UBGFG per aziendaNumero17,715,814,415,3 Contributi per aziendafr.1 5695 48011 9038 352 Totale contributi1 000 fr.4 15680 886202 246287 289 Totale contributi 20021 000 fr.4 15782 449202 966289 572
CaratteristicaUnità
Fonte:UFAG
1 Aziende
che
gestiscono una parte della superficie nella regione di montagna e in quella collinare
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 160
Ripartizione degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo in condizioni difficili di produzione secondo le classi di dimensione – 2003
Nell'anno di contribuzione 2003,il 40 per cento circa dell'effettivo di UBGFG si trovava presso aziende aventi diritto ai contributi,interessate dal limite.In queste aziende la quota di UBGFG senza contributi è stata del 33 per cento.
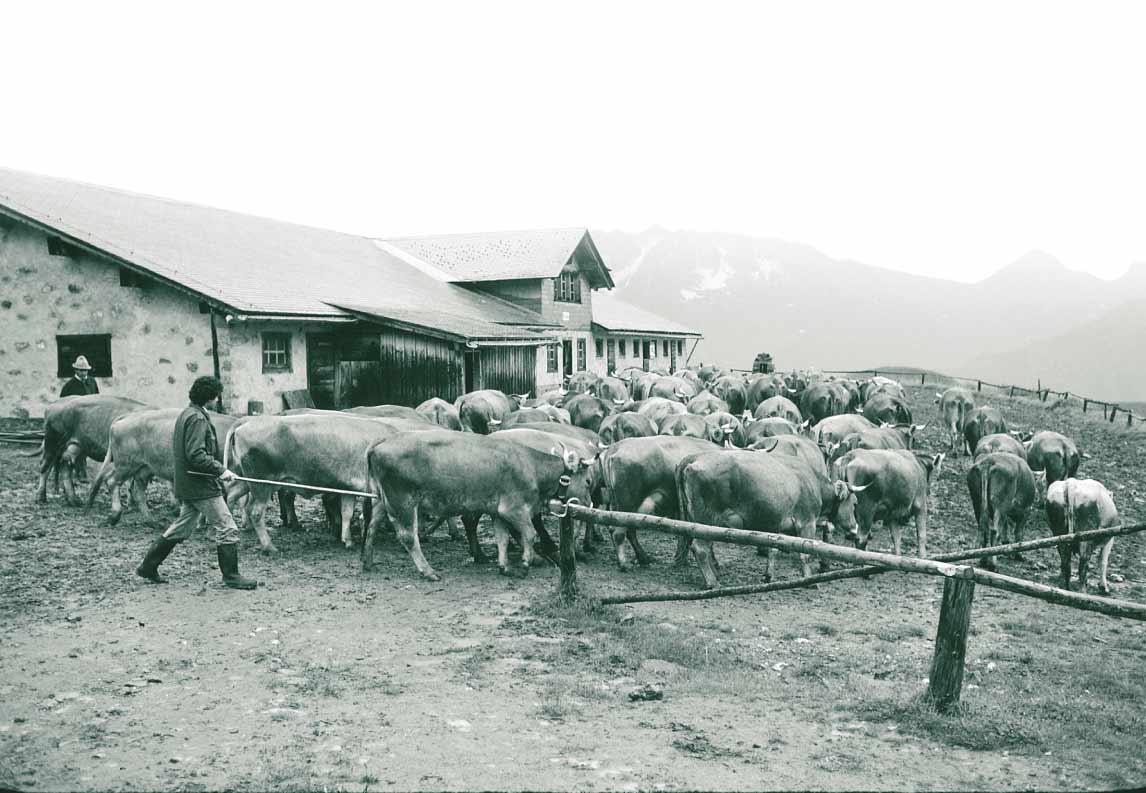
45–90 Aziende in centinaiaUBGFG in migliaia 30 –45 20 –30 15–20 10–15 5–10 fino a 5
Classi di dimensione in UBGFG Aziende (in centinaia) Animali (in migliaia) con contributi Animali (in migliaia) senza contributi 100 50 0 50100 150200 250 3142 8559 168 1140 76 42 9 84 40 13 65 60 57 25 35 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 161
Fonte: UFAG
■ Contributi di declività generali per l’indennizzo delle condizioni difficili di gestione delle superfici
Contributi di declività
Mediante i contributi di declività generali vengono indennizzate le difficoltà connesse alla gestione delle superfici declive nelle regioni collinare e di montagna.Tali contributi sono versati soltanto per prati,terreni da strame e superfici coltive.I prati devono essere falciati almeno una volta l’anno mentre i terreni da strame da uno a tre anni.Le zone declive sono suddivise in due categorie.
L’entità delle superfici notificate varia di anno in anno.Ciò dipende dalle condizioni climatiche che esercitano un influsso sul tipo di gestione (estensione maggiore o minore dei pascoli o dei prati da sfalcio).
Aliquote 2003fr./ha – 18–35 per cento di declività 370 – oltre 35 per cento di declività 510
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianura 1 collinaremontagna Superfici aventi diritto ai contributi: – 18–35 per cento di declività ha4 30865 92873 928144 164 – oltre 35 per cento di declività ha1 29618 74562 94982 990 Totaleha5 60484 673136 877227 154 AziendeNumero2 05513 85616 37532 286 Contributo per aziendafr.1 0972 4503 6292 962 Totale contributi1 000 fr.2 25533 95059 42495 630 Totale contributi 20021 000 fr.2 31134 38859 11295 811 1Aziende con superfici nella regione di montagna o in quella collinare Fonte:UFAG
Contributi per le superfici declive – 2003
Aziende con contributi di declività
Fonte: UFAG Declività <18% 59% Declività 18–35% 26% Declività >35% 15%
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 162
– 2003
Totale 558 642 ha
Mediante questi contributi di declività s’intende conservare i vigneti situati nelle zone in forte pendenza e terrazzate.Per tenere in considerazione le condizioni dei vigneti degni di essere sostenuti finanziariamente,si distingue tra vigneti in pendenza e in forte pendenza da un canto e vigneti terrazzati retti da muri di sostegno dall’altro. I contributi per i vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate vengono concessi soltanto a favore delle superfici con una declività di oltre il 30 per cento.Le aliquote di contribuzione non sono in funzione delle zone.
Aliquote 2003fr./ha
superfici con una declività del 30 fino al 50%1 500 – superfici con una declività di oltre il 50%3 000
superfici in zone terrazzate5 000
Contributi per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate – 2003
La quota di vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate rispetto alla superficie vignata totale corrisponde al 28 per cento circa,mentre la quota di aziende commisurata all’insieme delle aziende dedite alla viticoltura è del 50 per cento.

–
–
Unità Superfici aventi diritto
contributi in totaleha3 423 Declività dal 30 al 50%ha1 701 Declività di oltre il 50%ha319 Zone terrazzateha1 403 Numero di aziendeNumero2 841 Superficie per aziendaha1,2 Contributo per aziendafr.3 704 Totale contributi1 000 fr.10 524 Totale contributi 20021 000 fr.10 051 Fonte:UFAG
ai
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 163
■ Contributi di declività per la conservazione dei vigneti nelle zone in forte pendenza e terrazzate
2.2.3Pagamenti diretti ecologici
Contributi ecologici
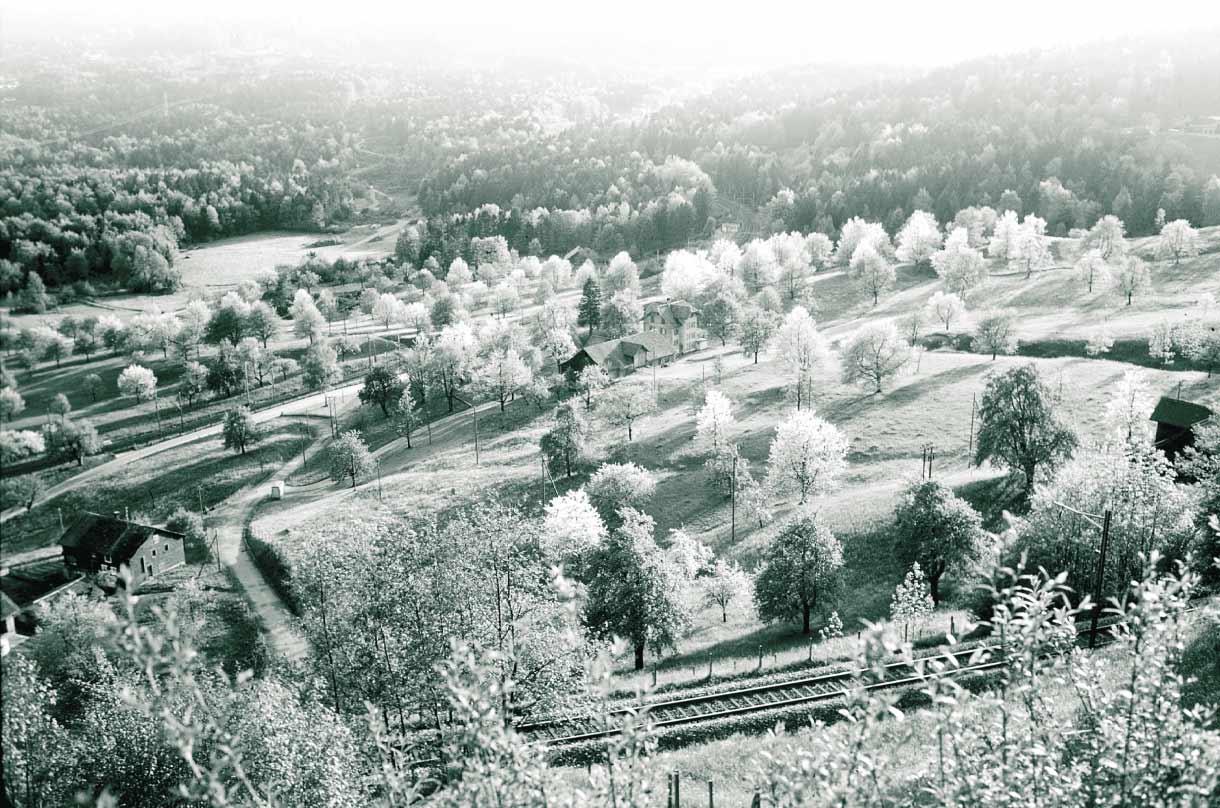
Mediante i contributi ecologici vengono indennizzate prestazioni ecologiche particolari che soggiacciono a condizioni più severe rispetto a quelle previste nel quadro della PER.Ai gestori vengono offerti programmi con partecipazione facoltativa.I programmi sono indipendenti gli uni dagli altri e i contributi possono venir cumulati.
Tabelle 33a–33b,pagine A34–A35 Ripartizione dei contributi ecologici tra i vari programmi – 2003 Fonte: UFAG
381,3 mio. fr.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Compensazione ecologica
Produzione estensiva
URA
SSRA
Agricoltura biologica
OQE
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 164
Totale
33%
8%
37%
11%
7%
4%
■ Prati sfruttati in modo estensivo
Compensazione ecologica
Attraverso la compensazione ecologica s’intende conservare e se possibile ampliare nuovamente lo spazio vitale della fauna e della flora indigene nelle regioni a vocazione agricola.La compensazione ecologica contribuisce pure alla conservazione delle strutture e degli elementi paesaggistici tipici.Determinati elementi della compensazione ecologica fruiscono dei contributi e possono nel contempo venir tenuti in considerazione per la compensazione ecologica obbligatoria nel quadro della PER.Altri,invece, sono computabili unicamente per la compensazione ecologica in relazione alla PER e non sono indennizzati mediante contributi.
Elementi della compensazione ecologica con e senza contributi
Elementi computabili per la PER Elementi computabili per la PER con contributi senza contributi
Prati sfruttati in modo estensivoPascoli sfruttati in modo estensivo Prati sfruttati in modo poco intensivoPascoli boschivi
Terreni da strameAlberi indigeni,isolati o in viali alberati Siepi,boschetti campestri e rivieraschiFossati umidi,stagni,pozze
Maggesi fioritiSuperfici ruderali,cumuli di pietra, affioramenti rocciosi
Maggesi da rotazioneMuri a secco
Fasce di colture estensive Sentieri e accessi naturali non consolidati Alberi da frutto ad alto fusto nei campiVigneti con elevata biodiversità Altre superfici di compensazione ecologica sulla SAU definite dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura
Le superfici non devono essere concimate,devono esistere per sei anni ed essere falciate al più presto tra metà giugno e metà luglio a dipendenza della zona.Lo sfalcio tardivo assicura la completa maturazione dei semi e promuove la biodiversità attraverso l’inseminazione naturale.Inoltre,invertebrati,uccelli che nidificano al suolo e mammiferi di piccola taglia dispongono di un periodo di tempo sufficiente per riprodursi.
I contributi per prati sfruttati in modo estensivo,terreni da strame,siepi,boschetti campestri e rivieraschi sono disciplinati in maniera uniforme e sono calcolati in base alla zona in cui si trova la superficie.Negli ultimi anni la quota di prati sfruttati in modo estensivo è costantemente aumentata.
Aliquote 2003fr./ha
– zona campicola e zone intermedie1 500
zona collinare1 200
– zone di montagna I e II700
zone di montagna III e IV450
–
–
Tabelle 34a–34d,pagine A36–A39
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 165
■ Terreni da strame
Contributi per prati sfruttati in modo estensivo – 2003
■ Siepi,boschetti campestri e rivieraschi
Per terreni da strame s’intendono le superfici inerbite gestite in modo estensivo in luoghi bagnati o umidi.Il prodotto dello sfalcio,effettuato di regola in autunno o in inverno,viene utilizzato come lettiera.
Contributi per terreni da strame – 2003
Per siepi e boschetti campestri o rivieraschi s’intendono siepi basse,arbustive e arboree, siepi frangivento,gruppi di alberi,scarpate boscate e boschetti rivieraschi a forma di siepe.Le superfici devono essere gestite e curate correttamente per sei anni consecutivi.
Contributi per siepi,boschetti campestri e rivieraschi – 2003
Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione
pianuracollinaremontagna AziendeNumero18 5919 2799 79537 665 Superficieha24 1109 72914 85648 695 Superficie per aziendaha1,301,051,521,29 Contributo per aziendafr.1 9001 0638001 407 Contributi1 000 fr.35 3149 8597 83853 011 Contributi 20021 000 fr.33 4179 3327 43650 186 Fonte:UFAG
di Totale
CaratteristicaUnità Regione
pianuracollinaremontagna AziendeNumero1 8011 8813 1416 823 Superficieha1 8311 4643 5336 828 Superficie per aziendaha1,020,781,121,00 Contributo per aziendafr.1 497756709930 Contributi1 000 fr.2 6951 4212 2286 345 Contributi 20021 000 fr.2 5201 3752 1666 061 Fonte:UFAG
di Regione Regione di Totale
AziendeNumero5 3912 7001 0429 133 Superficieha1 3267162932 336 Superficie per aziendaha0,250,270,280,26 Contributo per aziendafr.364271186316 Contributi1 000 fr.1 9617321942 887 Contributi 20021 000 fr.1 9377271962 860 Fonte:UFAG
CaratteristicaUnità
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 166
■ Prati sfruttati in modo poco intensivo
Sui prati sfruttati in modo poco intensivo è autorizzato spandere quantitativi molto limitati di letame o composta.
Aliquote 2003fr./ha – zona campicola fino a zona collinare650 – zone di montagna I e II450
zone di montagna III e IV300
Contributi per prati sfruttati in modo poco intensivo – 2003
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
AziendeNumero8 5698 49510 35327 417
Superficieha7 5837 71919 96035 263
Superficie per aziendaha0,880,911,931,29
Contributo per aziendafr.567501656580
Contributi1 000 fr.4 8624 2586 79415 913
Contributi 20021 000 fr.5 2104 4647 04916 724
■ Maggesi fioriti
Per maggesi fioriti s’intendono le fasce pluriennali,seminate con sementi di erbe selvatiche indigene,non concimate,di almeno 3 metri di larghezza.I maggesi fioriti sono finalizzati alla protezione delle erbe selvatiche minacciate.Essi rappresentano un habitat e una fonte di nutrimento ideali anche per insetti e piccoli esseri viventi. Offrono rifugio pure a lepri ed uccelli.Per i maggesi fioriti vengono versati 3'000 franchi per ettaro.I contributi vengono applicati per superfici della zona campicola fino alla zona collinare compresa.

–
Fonte:UFAG
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 167
Contributi per maggesi fioriti – 2003
In relazione alla liberalizzazione del mercato cerealicolo i maggesi fioriti rappresentano un’alternativa economicamente interessante alle colture campicole.
Per maggesi da rotazione si intendono le superfici che per uno o due anni vengono seminate con sementi di erbe campicole indigene,non concimate e che misurano almeno 6 metri di larghezza e 20 are.Essi fungono da habitat ideale per uccelli che nidificano al suolo,lepri e insetti.In zone idonee è consentito anche l’inerbimento spontaneo.Per i maggesi da rotazione nella zona campicola fino alla zona collinare compresa vengono stanziati 2'500 franchi per ettaro.
Contributi per maggesi da rotazione – 2003
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 168
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna1 AziendeNumero2 16842152 594 Superficieha2 07035122 423 Superficie per aziendaha0,950,830,350,93 Contributo per aziendafr.2 8642 5031 0442 802 Contributi1 000 fr.6 2091 05457 268 Contributi 20021 000 fr.5 86198546 850 1Trattasi di aziende che gestiscono superfici nella regione collinare o di pianura
Fonte:UFAG
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna1 AziendeNumero8001433946 Superficieha1 12118821 311 Superficie per aziendaha1,401,320,781,39 Contributo per aziendafr.3 4993 2901 9503 463 Contributi1 000 fr.2 79947063 276 Contributi 20021 000 fr.2 88142833 312 1Trattasi
Fonte:UFAG
di aziende che gestiscono superfici nella regione collinare o di pianura
■ Maggesi da rotazione
■ Fasce di colture estensive in campicoltura
Le fasce di colture estensive rappresentano uno spazio vitale ideale per la flora campicola collaterale.Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo,larghe almeno 3 e al massimo 12 metri,coltivate a cereali,colza,girasoli,piselli proteici,favette e soia ma non a granturco.Nel 2003 sono stati versati 1'500 franchi per ettaro.I contributi vengono concessi soltanto a superfici ubicate nella regione di pianura o collinare.
Contributi per le fasce di colture estensive – 2003
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna1
AziendeNumero106300136
Superficieha256031
Superficie per aziendaha0,240,190,000,23
Contributo per aziendafr.3562850340
Contributi1 000 Fr.389046
Contributi 20021 000 Fr.448052
1Trattasi di aziende che gestiscono superfici nella regione collinare o di pianura
■ Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Vengono concessi contributi per alberi da frutto a nocciolo e a granelli ad alto fusto che non fanno parte di frutteti nonché per i castagni e per i noci in selve curate.Nel 2003 sono stati versati 15 franchi per albero notificato.
Contributi per alberi da frutto ad alto fusto nei campi – 2003
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
Alberi per aziendaNumero70,6571,6449,4867,73
Contributo per aziendafr.1 0601 0757421 016 Contributi1 000 fr.18 25113 8324 09936 182
20021 000 fr.18 35313 8944 05336 300
Fonte:UFAG
AziendeNumero17 22412 8725 52335 619 AlberiNumero1 216 925922 119273 2892 412 333
Contributi
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 169
Fonte:UFAG
Ripartizione delle superfici di compensazione ecologica1 2003

Totale 96 887 ha
Fasce di colture estensive 0,0% Maggesi fioriti 2,5%
Maggesi da rotazione 1,4%
Prati sfruttati in modo poco intensivo 36,4% Boschetti campestri e rivieraschi 2,4%
1 Esclusi gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Prati sfruttati in modo estensivo 50,3%
Terreni da strame 7,0%
Fonte: UFAG
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 170
Ordinanza sulla qualità ecologica
Il 1° maggio 2001 è entrata in vigore l’ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (ordinanza sulla qualità ecologica,OQE;RS 910.14).
Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie,la Confederazione promuove,mediante aiuti finanziari,SCE di qualità biologica superiore e l'interconnessione di SCE sulla SAU.Le esigenze che devono essere adempiute dalle superfici per poter beneficiare dei contributi giusta l'OQE sono fissate dai Cantoni.La Confederazione verifica quanto stabilito dai Cantoni sulla base di esigenze minime.Se le esigenze cantonali corrispondono alle esigenze minime della Confederazione e la partecipazione finanziaria regionale è garantita,la Confederazione accorda aiuti finanziari per i contributi versati dai Cantoni agli agricoltori.A dipendenza della capacità finanziaria del Cantone,l'aiuto finanziario varia dal 70 al 90 per cento dei contributi computabili. Il 10–30 per cento rimanente dev'essere corrisposto da terzi (Cantone,Comune, privati,enti).I contributi per la qualità biologica e per l'interconnessione sono cumulabili.L'ordinanza si basa su principi quali volontarietà,incentivi finanziari e considerazione delle differenze regionali per quanto riguarda la biodiversità
Aliquote computabili
Aliquote 2003fr.
qualità biologica500.–/ha – qualità biologica degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi20.–/albero – interconnessione500.–/ha
Una SCE contribuisce a conservare e a favorire la varietà naturale delle specie se presenta determinate piante indicatrici e caratteristiche strutturali e/o se è ubicata in un luogo interessante dal profilo ecologico.Nell'ambito della qualità ecologica il singolo gestore di una SCE può annunciarsi direttamente,mentre per quanto riguarda l'interconnessione di SCE è necessario un progetto che interessi almeno un'unità agricola ed ecologica.
Contributi giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica – 2003
CaratteristicaUnità Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
AziendeNumero5 0494 4716 91416 434
Superficie 1 ha6 8997 58814 55929 046
Superficie 1 per aziendaha1,371,702,111,77
Contributo per aziendafr.879995832891
Contributi1 000 fr.4 4414 4485 74914 638
Contributi 20021 000 fr.2 6563 5002 7788 934
1 Conversione degli alberi ad alto fusto:1 albero = 1 araFonte:UFAG
–
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 171
■ Applicazione dell’ordinanza sulla qualità ecologica nel progetto d’inteconnessione
Seedorf
Contributi per la qualità biologica e l'interconnessione – 2003
CaratteristicaUnità Qualità Inter-Qualità biobiologica connessionelogica e interconnessione 1
Prati sfruttati in modo estensivo,prati sfruttati in modo poco intensivo,terreni da strame
AziendeNumero11 6131 0881 790
Superficieha17 3271 2045 865
Contributi1 000 fr.6 6345802 458
Siepi e boschetti campestri e rivieraschi
AziendeNumero475536215
Superficieha11017073
Contributi1 000 fr.437648
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
AziendeNumero3 412388826
AlberiPezzi200 46315 61879 892
Contributi1 000 fr.3 232711 007
Altri elementi
AziendeNumero-951-
Superficieha-1 337-
Contributi1 000 fr.-489-
1 Programmi unificati Fonte:UFAG
Nel villaggio di Seedorf del Comune friburghese di Noréaz un agricoltore intraprendente,in collaborazione con altri contadini,ha avviato un progetto d'interconnessione secondo l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE).Sin dall’inizio i contadini sono stati sostenuti dall’Istituto agricolo di Grangeneuve.Il progetto interessa 6 aziende e 267 ettari di superficie agricola utile.I terreni pianeggianti sono destinati alla foraggicoltura e alla campicoltura,mentre quelli in pendenza sono utilizzati per la produzione di erba oppure come pascolo.Nel patrimonio naturale del comprensorio rientrano il lago di Seedorf,prezioso habitat di anfibi e libellule,le distese paludose che lo circondano,i ruscelli e le loro sponde,le coltivazioni di alberi da frutto ad alto fusto,i pendii a sud,in prossimità della foresta,e le radure.
L’agricoltore ha spiegato che tra i motivi all’origine della sua iniziativa vi sono la disponibilità di elementi naturali dal notevole potenziale ecologico e il fatto che le sue api apprezzano i fiori degli alberi da frutto ad alto fusto,dei maggesi fioriti e dei prati gestiti in modo estensivo.I contributi federali e cantonali rappresentano un incentivo finanziario interessante.Inoltre consentono di proporre e sviluppare proprie idee.
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 172
La direttiva concernente l’OQE del Cantone Friburgo è strutturata secondo il cosiddetto principio «bottom-up».Contrariamente al principio denominato «top-down»,finora utilizzato nell’ambito della politica agricola,le autorità non emanano prescrizioni dettagliate sul da farsi.L’accento è posto sullo spirito d’iniziativa dei diretti interessati. Sulla base di condizioni quadro,i responsabili di progetto locali decidono come strutturare e realizzare il progetto d'interconnessione.
Per l’elaborazione e la gestione del progetto gli agricoltori si sono rivolti ad un biologo, che ha stilato una lista dettagliata delle superfici di compensazione ecologica esistenti e di altri elementi naturali.Sono state stabilite specie bersaglio e indicatrici,che dovranno essere promosse con i provvedimenti adottati.I criteri utilizzati sono stati: presenza e diffusione nel comprensorio,pericolo secondo la lista rossa,elementi naturali caratteristici del comprensorio e esigenze legate al territorio.Tra le specie scelte spiccano la lepre comune,il picchio verde,lo zigolo giallo,il codirosso,l’allodola, la lucertola,la latonia,i calotterigi splendidi e la felce palustre.
Per ogni singola azienda sono stati stabiliti obiettivi e proposti provvedimenti.Agli agricoltori è lasciata la possibilità di scegliere tra diverse alternative.Onde raggiungere la distanza massima di 200 metri tra due elementi naturali,necessaria per un’interconnessione,sono state pianificate nuove superfici di compensazione ecologica.Tra le altre cose è previsto l’impianto di prati gestiti in modo estensivo larghi almeno 5 metri lungo i corsi d’acqua e 10 metri lungo le acque stagnanti,di fasce di maggesi fioriti e di bordi di boschi nonché di alberi da frutto ad alto fusto.Inoltre i prati gestiti in modo poco intensivo vengono trasformati in prati gestiti in modo estensivo,vengono mantenute le strisce di cotica erbosa vecchia e gli elementi strutturali quali cumuli di pietra e rami vengono rimessi in sesto.Per il progetto sono state sfruttate sinergie con l’Ufficio forestale (manutenzione dei bordi dei boschi),l’Ufficio cantonale della protezione di natura e paesaggio (manutenzione delle zone di protezione naturale),l’Istituto agricolo di Grangeneuve (coordinamento con il progetto di protezione delle acque ai sensi dell’art.62a della legge sulla protezione delle acque) e con la Stazione ornitologica di Sempach (monitoraggio della fauna ornitologica).
Onde poter effettuare una verifica,i provvedimenti attuati sono stati riportati su una cartina e controllati dal responsabile del progetto,incaricato anche di svolgere rilevazioni su flora e fauna e redigere un rapporto intermedio e finale dopo tre rispettivamente sei anni.
Oltre a migliorare gli spazi vitali di flora e fauna,il progetto OQE aiuta a sensibilizzare gli agricoltori e la popolazione in merito alla biodiversità.Inoltre,promuove la responsabilità individuale e la collaborazione degli agricoltori,il che non fa che migliorare l’immagine dell’agricoltura.

2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 173
Produzione estensiva di cereali e colza
Mediante questo provvedimento s’intende promuovere la coltivazione di cereali e colza senza ricorrere a regolatori della crescita,fungicidi,stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali e insetticidi.Tali esigenze devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda coltivate a cereali panificabili,a colza o a cereali da foraggio. Nel 2003 sono stati versati 400 franchi per ettaro.
Produzione estensiva di cereali e colza – 2003
Ripartizione delle superfici per la produzione estensiva – 2003
Totale 78 425 ha
foraggio 42%
CaratteristicaUnità Regione
Regione di Totale pianuracollinaremontagna AziendeNumero10 5896 32187417 784 Superficieha54 06422 2602 10278 425 Superficie per aziendaha5,113,522,404,41 Contributo per aziendafr.2 0321 4079621 757 Contributi1 000 fr.21 5208 89584131 255 Contributi 20021 000 fr.21 7309 26694031 938 Fonte:UFAG
di Regione
Cereali panificabili
UFAG
51% Colza 7% Cereali da
Fonte:
174 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2
Tabella 35,pagina A40
Agricoltura biologica
A complemento del maggior ricavo che può essere ottenuto sul mercato,la Confederazione promuove l’agricoltura biologica come forma di produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente.Per poter beneficiare dei contributi i gestori devono rispettare,sull’insieme delle superfici dell’azienda,almeno le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica,nella versione rivista dell’agosto 2000.

Gli agricoltori rinunciano totalmente all'utilizzo di materie ausiliarie ottenute mediante sintesi chimica come concimi commerciali o pesticidi.Ciò consente di risparmiare energia e di proteggere l'acqua,l'aria e il suolo.Per l’agricoltore è quindi particolarmente importante tenere in considerazione i cicli e i processi naturali.Benché il contadino che pratica l'agricoltura biologica necessiti di una quantità maggiore di energia per infrastrutture e macchine,questo metodo di coltivazione risulta essere più efficiente per quanto riguarda la gestione delle risorse disponibili.Ciò è un indicatore importante della sostenibilità del sistema di produzione.
La rinuncia all'uso di erbicidi favorisce lo sviluppo di un gran numero di erbe accessorie.Una flora ricca è fonte di nutrimento per un numero maggiore di piccoli esseri viventi.Ciò contribuisce a migliorare la «dieta» dei vertebrati predatori come i carabidi e crea i presupposti per una lotta naturale agli organismi nocivi.La presenza massiccia di vegetali,animali e microrganismi irrobustisce l'ecosistema.
Grazie a concimi organici,metodi di gestione rispettosi del suolo e alla rinuncia a prodotti fitosanitari i contadini dediti all'agricoltura biologica promuovono la diffusione e la varietà degli organismi presenti nel suolo.L'attività biologica influisce positivamente sulla fertilità del suolo.Aumenta il tenore in humus,migliora la struttura del suolo e diminuisce il rischio d'erosione.
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 175
Per raggiungere un equilibrio ottimale fra piante,suolo,animali e uomo all'interno dell'azienda,il contadino dedito all'agricoltura biologica provvede affinché i cicli di nutrienti siano chiusi.Ciò è possibile vincolando l'allevamento di animali alla base foraggera propria dell'azienda.La coltivazione di leguminose aumenta il tenore di azoto nel suolo.I concimi aziendali e il materiale organico risultante dalla semina a sovescio e dal raccolto garantiscono un adeguato approvvigionamento delle piante in nutrienti,grazie anche all'operato dei microrganismi presenti nel suolo.
Nel settore dell'allevamento di bestiame da reddito devono essere adempiute le esigenze URA.Esse rappresentano le esigenze minime per la detenzione di animali nel quadro dell'agricoltura biologica.Sono pure vietati impianti quali il pastore elettrico e l'utilizzo di mangimi medicati.Il fatto che venga utilizzato prevalentemente foraggio prodotto nell'azienda garantisce una produttività adeguata e il benessere degli animali.In caso di necessità viene data la preferenza a metodi terapeutici naturali.
Nel 2003 l’agricoltura biologica veniva praticata sul 10,3 per cento dell’intera SAU.
Aliquote
– superfici inerbite e terreni da strame200
Contributi per l’agricoltura biologica – 2003
– colture speciali1 200 – superficie
speciali800
2003fr./ha
coltiva aperta senza colture
CaratteristicaUnità
di
Regione di
pianuracollinaremontagna AziendeNumero1 1671 3973 6186 182 Superficieha20 62322 95666 554110 134 Superficie per aziendaha17,6716,4318,4017,82 Contributo per aziendafr.6 9933 9953 7024 389 Contributi1 000 fr.8 1615 58113 39327 135 Contributi 20021 000 fr.7 7055 34312 43625 484 Fonte:UFAG
Regione
Regione
Totale
Regione di pianura 19% Regione di montagna 60% Fonte: UFAG Totale 110 134 ha Regione collinare 21% 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 176
Tabella 33a,pagina A34 Quota delle superfici gestite in modo biologico, per regione
– 2003
■ Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA)
Detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze
In questo ambito rientrano i programmi SSRA e URA illustrati di seguito (cfr.pure la parte 1.3.2).
Viene promossa la detenzione di animali in sistemi di stabulazione che rispondono a requisiti il cui livello è di gran lunga superiore a quanto prescritto dalla legislazione in materia di protezione degli animali.
Aliquote 2003fr./UBG – animali della specie bovina,capre,conigli90 – suini155

ovaiole,pollastrelle e galletti,galline e galli da allevamento,pulcini280 – polli da ingrasso e tacchini180
Contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali – 2003 CaratteristicaUnità
–
Regione
AziendeNumero8 7345 8023 94118 477 UBGNumero219 832109 99155 145384 969 UBG per aziendaNumero25,1718,9613,9920,84 Contributo per aziendafr.2 8522 1741 4542 341 Contributi1 000 fr.24 91312 6165 72943 257 Contributi 20021 000 fr.22 86611 2244 94039 030 Fonte:UFAG
di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 177
Tabella 37,pagina A42
■ Uscita regolare all’aperto (URA)
Viene promossa l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito.Per uscita regolare all’aperto si intende l’uscita al pascolo,in una corte o in un’area con clima esterno che risponde alle esigenze degli animali.
Aliquote 2003fr./UBG – animali delle specie bovina ed equina,bisonti,ovini,caprini, daini,cervi e conigli180
Contributi per l’uscita regolare all’aperto – 2003
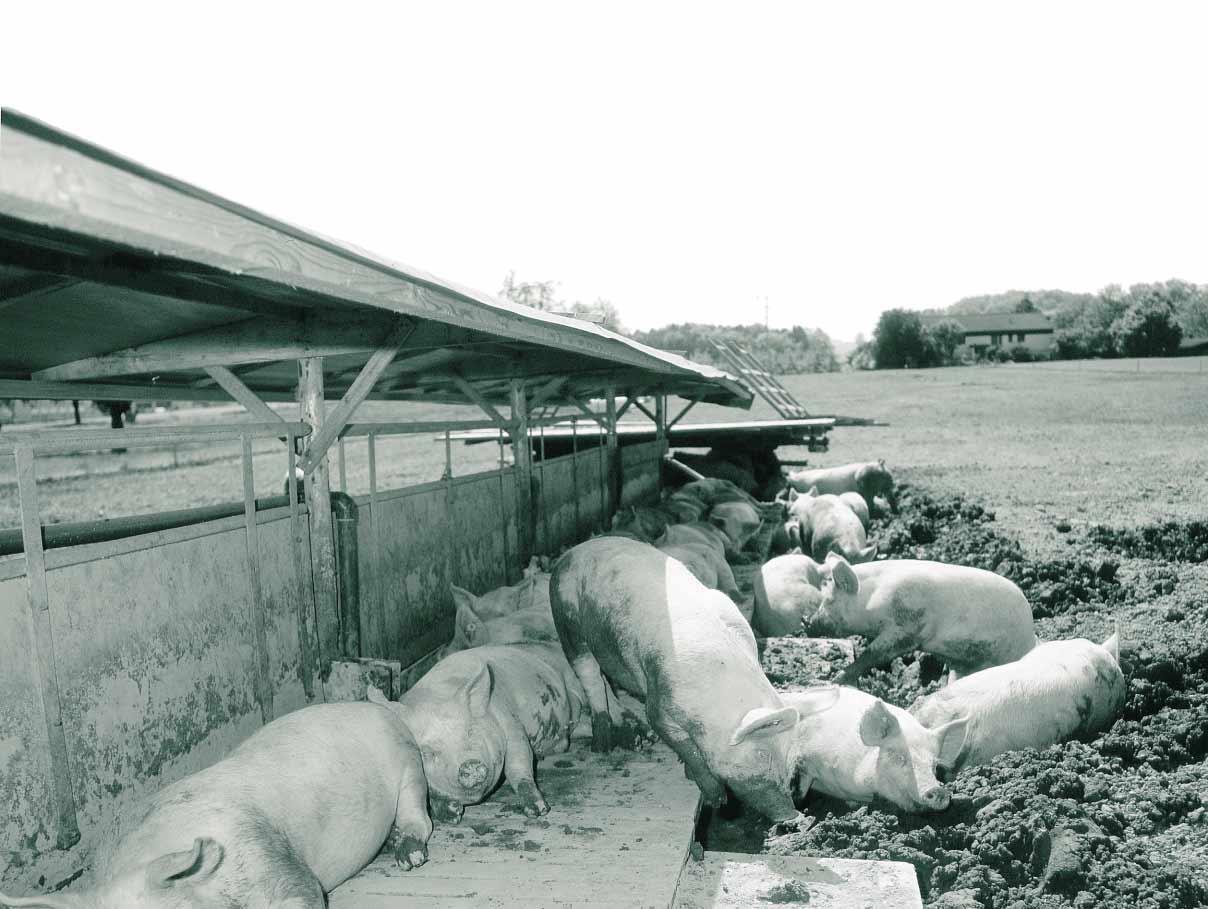
– suini155 – pollame280
Regione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna AziendeNumero13 52910 84012 24936 618 UBGNumero338 989238 940215 588793 517 UBG per aziendaNumero25,0622,0417,6021,67 Contributo per aziendafr.4 3743 9063 1513 826 Contributi1 000 fr.59 17542 33738 595140 106 Contributi 20021 000 fr.55 99839 58436 072131 654 Fonte:UFAG
CaratteristicaUnità
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 178
Tabella 37,pagina A42
sostenibile delle regioni d'estivazione
Contributi d’estivazione
Mediante i contributi d’estivazione s’intende garantire la gestione e la cura dei vasti pascoli d’estivazione nelle Alpi,nelle Prealpi e nel Giura.La regione d’estivazione viene gestita e curata con oltre 300'000 UBG.I contributi vengono versati per carico normale (CN) o per UBG.Per CN si intende l’estivazione di una UBG durante 100 giorni.
Nel 2003 è stato possibile stanziare i primi contributi d’estivazione per ovini (escluse le pecore lattifere) in maniera differenziata a seconda del sistema di pascolo.Con contributi più elevati per pascoli da rotazione e sorvegliati vengono indennizzati i costi maggiori,da un lato,e dall’altro,analogamente ai contributi ecologici,viene incentivata l’estivazione del bestiame ovino particolarmente ecologica.Aumentando i contributi per sorveglianza e pascoli da rotazione l’importo stanziato a favore degli ovini è cresciuto di 1,5 milioni di franchi circa rispetto all’anno precedente.
Aliquote 2003fr.
– per UBG di vacche munte,pecore lattifere e capre lattifere (estivazione di 56–100 giorni)300
per CN di ovini,eccettuate le pecore lattifere
in caso di sorveglianza
pascoli120
– per CN di altri animali che consumano foraggio grezzo300
Contributi d’estivazione – 2003
1Questa cifra indica il totale delle aziende d’estivazione aventi diritto a contributi (senza doppi versamenti)
–
permanente300 – per pascoli da rotazione 220 –
–
per altri
risp.CN 1 000 fr.Numero Numero Vacche munte,capre lattifere e pecore lattifere16 5332 24055 167 Ovini,eccettuate le pecore lattifere4 5881 03225 580 Altri animali che consumano foraggio grezzo70 2606 801234 409 Totale91 3817 493 1 Totale 200289 5617 527 1
CaratteristicaContributiAziendeUBG
Gestione
Fonte:UFAG ■
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 179 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
Tabella 40,pagina A45
Contributi per la protezione delle acque
Mediante l’articolo 62a della legge sulla protezione delle acque la Confederazione può promuovere i provvedimenti presi dagli agricoltori per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze nelle acque superficiali e sotterranee.L’accento è posto sulla riduzione del carico di nitrato nell’acqua potabile e del carico di fosforo nelle acque superficiali in regioni nelle quali la PER,l’agricoltura biologica,divieti e precetti nonché i programmi facoltativi promossi dalla Confederazione (produzione estensiva,compensazione ecologica) non sono sufficienti.
In virtù dell’ordinanza sulla protezione delle acque,i Cantoni sono tenuti a designare un settore d’alimentazione per le captazioni di acque superficiali e sotterranee nonché a ordinare provvedimenti di risanamento qualora la qualità dell’acqua fosse insufficiente.Questi provvedimenti possono comportare limitazioni significative rispetto allo stato della tecnica per quanto concerne l’utilizzazione del suolo nonché perdite finanziarie insopportabili per le aziende.I contributi ai costi concessi dalla Confederazione ammontano all’80 per cento per gli adeguamenti strutturali e al 50 per cento per i provvedimenti di gestione.Nel 2003 sono stati stanziati circa 4 milioni di franchi.
Vista la maggiore partecipazione al programma sul nitrato rispetto all'anno precedente,si è registrato un aumento dei contributi versati dalla Confederazione.
Ricapitolazione dei progetti – 2003
CantoneRegione,Durata ComprensorioTotale costi Contributi Comuneprobabile del del progettoprevisti2003 progetto
180 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2
Annohafr.fr. LULago di Sempach1999–2004 1 4 9058 811 1661 037 278 LULago di Baldegg2000–2005 1 5 6009 559‘6941 279 038 LU/AGLago di Hallwil2001–2006 1 3 7865 029906980 762 AGWohlenschwil2001–200962547 69652 498 AGBirrfeld2002–20078131 909 50087 142 VDThierrens1999–200817121 23617 614 VDMorand2000–2008391760 18368 166 VDBavois prov.2003–200455 647 ZHBaltenswil2000–2008130428 35332 920 BEWalliswil2000–2005 54381 10848 043 SHKlettgau2001–20063571 136 221147 758 FRAvry-sur-Matran2000–2005 37158 23227 463 FRMiddes2000–200645159 99623 819 FRCourgevaux2003–2008 27164 83820 880 SOGäu I2000–2005658965 640130 929 SOGäu II2003–2008 5551 217 04063 680 Totale 17 4424 023 637 Totale 200215 2993 637 383
1 Proroga necessaria Fonte:UFAG
■ Prevenzione del convogliamento e del dilavamento
2.3Miglioramento delle basi
Mediante i provvedimenti denominati «Miglioramento delle basi» viene promossa e sostenuta la produzione di derrate alimentari rispettosa dell’ambiente ed efficiente nonché incoraggiato lo svolgimento dei compiti previsti in virtù del principio della multifunzionalità.
Aiuti finanziari per il miglioramento delle basi
ProvvedimentoConto Conto Preventivo 200220032004
mio.fr.
Contributi per i miglioramenti strutturali90102 1 99
Crediti di investimento707984
Aiuti per la conduzione aziendale91237
Aiuti per la riqualificazione--2
Consulenza e contributi per la ricerca242424
Lotta alle malattie delle piante e agli organismi nocivi943
Produzione vegetale e allevamento212222
Totale223242271
1 Compreso il credito suppletivo per il maltempo (7 mio.fr.)
Fonte:UFAG
Gli obiettivi dei provvedimenti nel campo del miglioramento delle basi sono: –rafforzamento della competitività attraverso la riduzione dei costi di produzione; –promozione delle aree rurali; –strutture aziendali moderne e superfici agricole utili ben accessibili; –produzione efficiente e rispettosa dell’ambiente; –varietà possibilmente resistenti e ad alto rendimento nonché prodotti di alta qualità; –protezione della salute dell’uomo,degli animali e dell’ambiente; –diversità genetica.

■■■■■■■■■■■■■■■■
181 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
2.3.1 Miglioramenti strutturali e misure sociali collaterali
Miglioramenti strutturali
I provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali consentono di migliorare le condizioni di vita ed economiche nelle aree rurali.Ciò riguarda in particolare la regione di montagna e le regioni periferiche.
Gli aiuti agli investimenti vengono concessi a favore di provvedimenti individuali o collettivi.Sono disponibili due strumenti: –contributi (a fondo perso) con partecipazione dei Cantoni,prevalentemente per provvedimenti collettivi; –crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interessi,prevalentemente per provvedimenti individuali.
Attraverso gli aiuti agli investimenti l’agricoltura può sviluppare e mantenere strutture competitive senza tuttavia contrarre debiti insopportabili.Anche in altri Paesi,in particolare nell’UE,gli aiuti agli investimenti rientrano tra i principali provvedimenti volti a promuovere le aree rurali.
Per rafforzare la competitività delle aziende e per promuovere le aree rurali,nel quadro della Politica agricola 2007 sono previste nuove possibilità di sostegno nel settore dei miglioramenti strutturali.
Il sostegno al ripristino periodico di bonifiche fondiarie mediante il versamento di contributi forfettari assicura la funzionalità a lungo termine di edifici ed impianti. L’agricoltura ha assolutamente bisogno di infrastrutture adeguate quali vie d’accesso, strade agricole ed alpestri nonché di impianti per risanare e migliorare il bilancio idrico del suolo.I lavori vengono eseguiti conformemente a un programma specifico,a intervalli di almeno otto o dieci anni.

Una novità consiste nel sostegno dei provvedimenti per diversificare le attività agricole e vicine all’agricoltura tramite crediti d’investimento,al fine di offrire alle aziende contadine ulteriori possibilità di conseguire un reddito.I mutui devono inoltre poter essere concessi per l’avvio dell’attività in un nuovo settore aziendale in una nicchia di produzione o per attività che si combinano sensatamente con l’azienda agricola,ad esempio vacanze in fattoria,vendita diretta,eccetera.
Anche la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà può essere sostenuta con crediti d’investimento intesi nel senso di un aiuto iniziale.In particolare spiccano il coordinamento interaziendale dell’impiego di manodopera ausiliaria,lo scambio di possibilità di produzione,l’assistenza nell’organizzazione aziendale,lo scambio di conoscenze particolari e il miglioramento dell’accesso al mercato.
182 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Nuovi provvedimenti dal 2004
Conformemente alla LAgr è possibile promuovere tramite contributi i progetti per lo sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali che coinvolgono prevalentemente il primario.In tal modo si estendono le possibilità d’applicazione dei miglioramenti strutturali e si rafforza l’orientamento regionale dei progetti.In vista dell’elaborazione delle disposizioni d’esecuzione,l’UFAG ha avviato diversi progetti di ricerca e pilota.
Nel 2003 l’importo disponibile per le bonifiche fondiarie e gli edifici agricoli ammontava a 102 milioni di franchi.L’UFAG ha approvato nuovi progetti con contributi federali per un importo complessivo di 106 milioni di franchi.Il volume d’investimento è stato di 410 milioni di franchi.L’ammontare dei contributi federali relativi ai progetti approvati non è identico all’importo iscritto nella rubrica del preventivo «Miglioramenti strutturali agricoli»,in quanto l’assicurazione di un contributo e il relativo versamento avvengono soltanto eccezionalmente nello stesso anno.Per un progetto approvato viene spesso assicurata soltanto una tranche di credito.
Nel 2003 l’importo versato dalla Confederazione sotto forma di contributi è stato del 13 per cento superiore all’anno precedente.Tale incremento è riconducibile in larga misura al ripristino delle opere danneggiate dal maltempo nel 2002.A tale scopo nel 2003 il Parlamento ha autorizzato un credito suppletivo di 7 milioni di franchi.Inoltre, nelle rubriche ordinarie 2000 e 2001 è previsto un aumento dei crediti della Confederazione per riparare i danni provocati dal maltempo.
183 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2
■ Mezzi finanziari per i contributi 22,0 05101520253035 15,1 9,1 31,0 25,7 3,1 67% 15% 17%
Ricomposizioni particellari comprese le infrastrutture Costruzione di strade agricole Acquedotti Danni per maltempo e altri provvedimenti del genio civile Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo Altri provvedimenti nel settore delle costruzioni rurali mio.
di pianura Regione collinare Regione di montagna
Contributi della Confederazione – 2003
fr. Regione
Fonte: UFAG
Tabelle 44–45,pagine A52–A53
Contributi della Confederazione alle bonifiche fondiarie e
Nel 2003 i Cantoni hanno accordato crediti d’investimento per un ammontare complessivodi 264,3 milioni di franchi a beneficio di 2’193 casi.L’89,9 per cento di tale importo è stato destinato al finanziamento di provvedimenti individuali,mentre il 10,1 per cento al sostegno di provvedimenti collettivi.A favore dei progetti collettivi nella regione di montagna possono venir concessi anche crediti di transizione,ossia crediti di costruzione con una decorrenza di tre anni al massimo.
Crediti d’investimento – 2003
DisposizioneCasiImportoQuota Numeromio.fr.%
Provvedimenti individuali2’024237,589,9
Provvedimenti collettivi,crediti di costruzione esclusi12112,04,5
Crediti di costruzione4814,85,6 Totale2 193264,3100
Fonte:UFAG
I crediti per i provvedimenti individuali sono stati utilizzati quale aiuto iniziale nonché per la costruzione,la trasformazione o il miglioramento di edifici d’abitazione,agricoli o alpestri.Vengono rimborsati mediamente sull’arco di 14 anni.
Nel settore dei provvedimenti collettivi sono state sostenute finanziariamente soprattutto bonifiche fondiarie e misure edili (edifici alpestri,edifici ed installazioni per l’economia lattiera nonché per la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti agricoli).
Il Fonds de roulement,istituito nel 1963,comprende 1,9 miliardi di franchi.Nel 2003 la Confederazione ha accordato ai Cantoni nuovi mezzi finanziari per un importo di 79,4 milioni di franchi.Essi,unitamente agli importi costantemente rimborsati, vengono utilizzati per la concessione di nuovi crediti.
edifici
1995 199419961997199819992000200120022003 mio. fr. Fonte: UFAG 0 20 40 60 80 100 120 85 106858275758710290102
agli
agricoli 1994–2003
184 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Mezzi finanziari per i crediti d’investimento

Crediti d'investimento secondo le categorie di provvedimenti, crediti di costruzione esclusi – 2003 Edifici rurali Aiuto iniziale Edifici d'abitazione Acquisto in comune dell'inventario, lavorazione e stoccaggio di prodotti agricoli Acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario Bonifiche fondiarie mio. fr. Regione di pianura Regione collinare Regione di montagna 105,0 020406080100120140 86,8 40,7 9,1 5,0 2,9 Fonte: UFAG 24,3% 45,2% 30,5% 185 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Aiuti di riqualificazione
Misure sociali collaterali
Gli aiuti per la conduzione aziendale sono concessi sotto forma di mutui esenti da interessi e servono ad evitare o a far fronte a ristrettezze finanziarie temporanee non imputabili al gestore.Gli effetti degli aiuti per la conduzione aziendale corrispondono a quelli dello sdebitamento indiretto della singola azienda.
Nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale,nel 2003 sono stati concessi mutui per un importo totale di circa 29,8 milioni di franchi a favore di 249 casi.L’importo del mutuo medio ammonta a 119'737 franchi e viene rimborsato in 13 anni.
30 casi,per un totale di 726'000 franchi,riguardano mutui esenti da interessi conformemente all’ordinanza del 5 novembre 2003 concernente i provvedimenti nell’agricoltura in seguito alla siccità del 2003 (ordinanza sulla siccità).Tali provvedimenti sono limitati fino al 31 dicembre 2004.
Mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale – 2003
DisposizioneCasiImporto Numeromio.fr.
Rifinanziamento di debiti esistenti21228,6 Superamento di una difficoltà finanziaria eccezionale371,2
Totale24929,8
Fonte:UFAG
Il Fonds de roulement,istituito nel 1963 con nuovi mezzi finanziari della Confederazione e importi rimborsati,ammonta,unitamente alle quote dei Cantoni,a 190,7 milioni di franchi.Nel 2003 ai Cantoni è stato messo a disposizione un ulteriore importo di 11,7 milioni di franchi.I fondi sono vincolati a una prestazione adeguata da parte del Cantone che a dipendenza della sua capacità finanziaria varia fra il 20 e l’80 per cento della quota federale.I nuovi mezzi finanziari della Confederazione e dei Cantoni,unitamente agli importi costantemente rimborsati,vengono utilizzati per concedere nuovi mutui.
Gli aiuti di riqualificazione sono una nuova misura sociale collaterale e dal 2004 agevolano la conversione ad una professione non agricola delle persone indipendenti attive nel settore primario.Tale misura prevede contributi ai costi di riqualificazione e di sostentamento per capiazienda che non hanno ancora compiuto 52 anni.La concessione di un aiuto presuppone l’abbandono dell’azienda agricola.
186 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Aiuti per la conduzione aziendale
Riduzione dei costi nell’ambito delle costruzioni rurali
Gli investimenti attuati in relazione agli edifici agricoli possono gravare considerevolmente sui costi di produzione di un’azienda.Essi dovrebbero quindi essere il più bassi possibile. È necessario trovare il giusto equilibrio fra i costi di costruzione e l’auspicata agevolazione del lavoro.Agroscope FAT Tänikon,su incarico dell’UFAG,ha condotto uno studio nell’ambito del quale è stato rilevato il fabbisogno d’investimento per gli edifici agricoli ed ha effettuato un confronto tra i costi di costruzione in Svizzera e nei Paesi limitrofi.I risultati di tali analisi sono stati illustrati alla pagina 230 del Rapporto agricolo 2003.
Nel quadro del sostegno tramite aiuti agli investimenti per la costruzione di un edificio rurale l’UFAG e i Servizi cantonali competenti analizzano i costi di costruzione.Un sondaggio effettuato presso i Cantoni,le esperienze raccolte con i sopralluoghi e i progetti di costruzione esaminati forniscono ulteriori informazioni relative a questa tematica.Di seguito sono illustrati i risultati di tali accertamenti.

L’analisi dei progetti di costruzione eseguiti negli ultimi anni indica che vi è una tendenza a realizzare edifici sempre meno costosi.Questo è principalmente dovuto ai seguenti fattori:
trasformazione degli aiuti agli investimenti in importi forfettari
I costi di costruzione perdono l’influsso diretto sull’ammontare del sostegno,in quanto gli aiuti agli investimenti non vengono più fissati secondo i costi residui.In questo modo vengono promosse soluzioni semplici e meno costose (stabulazioni libere non isolate,stalle con più locali,rifugi per vacche,ecc.).Inoltre,con gli importi forfettari si stimola l’agricoltore a fornire prestazioni proprie.
– aumento dei limiti
L’aumento dei limiti da 40 ad 80 UBG per contributi,rispettivamente da 60 a 120 UBG per mutui esenti da interessi (CI),funge da incentivo alla costruzione e alla gestione in comune,poiché le unità più grandi comportano costi specifici più contenuti.
– importi forfettari per elementi principali
Con gli importi forfettari per gli elementi principali stalla,fienile,silo,impianti per concimi aziendali e rimessa viene facilitata la procedura a tappe e si riduce il dispendio amministrativo.
– procedura semplice e rapida
Per progetti di notevole entità i possibili aiuti finanziari vengono prospettati tempestivamente con un preavviso.Sulla base di una richiesta da parte del Cantone, l’UFAG emana una decisione inerente gli aiuti agli investimenti che autorizza l’agricoltore a negoziare l’aggiudicazione dei lavori nel momento più adatto e alle condizioni meno onerose.
sistema di prezzi a moduli unitari della FAT
Il sistema di prezzi a moduli unitari della FAT,che ogni due o tre anni viene adeguato ai costi di costruzione attuali, è un buono strumento di lavoro per la stima precoce dei costi di costruzione preventivabili e per il confronto fra varianti.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 187 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
–
–
■ La trasformazione dei contributi in importi forfettari mostra i suoi effetti
■ Dove si vedono potenziali di risparmio?
In un progetto di costruzione di un edificio agricolo i costi possono essere ripartiti come segue:

Ambito
Lavori sul posto: scavo, cemento armato, lavori di muratura, montaggio Copertura standard di edifici: travatura, facciate, pareti, tetto Installazioni, strutture: produzione del latte, immagazzinamento di alimenti per animali, foraggiamento, box
paglia
corsia
foraggiamento fieno mangiatoia
min. 13 m2 superficie del pavimento/ UBG per riposo, alimentazione, foraggiamento, mungitura
Quota rispetto al totale dei costi 30–45% 20% ca. 10–40% Durata di utilizzazione minima 30 anni 30 anni 10 anni
per il liquame
corte fosse
di
188 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Ulteriori possibilità per ridurre i costi
Generalmente i lavori sul posto vengono effettuati da imprese locali.I costi più elevati riguardano pertanto le solette e gli impianti per lo stoccaggio di concimi aziendali.In Svizzera la copertura delle fosse per il liquame viene spesso utilizzata quale corte,fatto che relativizza la maggior spesa rispetto ai sili standard per il liquame situati all’aperto. Inoltre,a causa delle emissioni di ammoniaca,la maggior parte dei Cantoni impone, per i nuovi impianti,depositi per il liquame coperti.
Le coperture di edifici di semplice esecuzione e con materiali economici comportano a breve termine un risparmio sui costi,sempre che durante il periodo di utilizzazione non si debbano effettuare grandi riparazioni.Dopo l’uso i materiali di costruzione devono essere smaltiti nel rispetto dell’ambiente.Ciò può comportare costi notevoli.Le coperture standard di edifici possono essere acquistate in Paesi meno cari ed essere montate dalla ditta estera.Questa parte rappresenta però solo il 20 per cento dei costi di costruzione. È necessario verificare che il montaggio sia eseguitoconformemente alle norme svizzere (statica,contratti collettivi di lavoro,prevenzione degli infortuni durante e dopo la costruzione,ecc.).Gli accertamenti effettuati presso ditte svizzere ed estere, che offrono edifici finiti a prezzi fissi,hanno dato risultati deludenti.L’interesse per il piccolo mercato svizzero è scarso.Inoltre,anche per gli edifici finiti,le placche di supporto,le fondamenta e altri lavori di costruzione devono essere affidati ad altri, generalmente ad imprese indigene.
Per le installazioni si può risparmiare sui costi,distinguendo gli elementi prettamente necessari da quelli accessori.Spesso,purtroppo,i risparmi sugli edifici vengono azzerati da installazioni lussuose e costose.L’aspetto preoccupante è dato dal fatto che se per gli edifici è possibile contare su una durata di utilizzazione superiore ai trent’anni (sempre che siano stati costruiti con elementi flessibili),per le installazioni la durata è di dieci anni.
Nonostante il perdurare della crisi edilizia, è improbabile che nella costruzione grezza (scavo,opere da capomastro,cemento armato,opere da carpentiere,finestre,porte, cancelli,tetto,facciate,ecc.) vengano praticate notevoli riduzioni di prezzo.
Vi sono diverse possibilità per limitare i costi di costruzione.Una procedura di gara pubblica per i lavori sul posto (scavo,cemento armato,opere da capomastro,ecc.) effettuata su larga scala può portare ad offerte vantaggiose.A tal scopo è raccomandabile che un autore del progetto esperto rediga la documentazione per le offerte,con la quale possono venir individuate anche le offerte estremamente basse.Esse comportano infatti il rischio di superamento dei costi in seguito a lavori a regia,ritardi,esecuzione non professionale della costruzione,eccetera.
Se i lavori vengono eseguiti a regia,ad esempio da cooperative edili con l’aiuto dell’agricoltore, è necessario procedere ad un controllo coscienzioso delle ore di lavoro e delle forniture di materiali,al fine di ridurre il rischio che,in caso di brutto tempo, lavoratori e macchinari restino sul posto a carico del committente.Anche nel quadro delle prestazioni proprie vi sono molteplici possibilità di riduzione dei costi.Esse devono tuttavia essere pianificate in modo mirato.Non devono essere trascurati rischi ed imprevisti quali incidenti,responsabilità dell’agricoltore,reclami,eccetera.
189 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Di seguito sono citate ulteriori possibilità di riduzione dei costi di costruzione:
– ottimizzare il concetto aziendale e il progetto di costruzione con soluzioni globali;in particolare considerare varianti che implicano una collaborazione con un’azienda vicina (ad es.rinuncia alla detenzione di bestiame giovane,nessuna produzione di latte per caseificio,riconversione dell’azienda sulla detenzione di vacche madri, ecc.);
integrare le costruzioni esistenti;
scegliere un progetto che consente di fornire prestazioni proprie,ad esempio con edifici bassi e materiali da costruzione semplici come il legno,eccetera;
– utilizzare cemento e muratura nella minor misura possibile;
– effettuare rilevamenti,al fine di integrare l’edificio nel terreno in modo ottimale con lo scopo di limitare al minimo scavi e riempimenti;
costruire a tappe prevedendo possibilità di ampliamento;
evitare l’innovazione a tutti i costi se è possibile riprendere soluzioni già esistenti;
assumere un progettista esperto per i grandi lavori sul posto e richiedere offerte per i lavori principali;
– affidare agli artigiani che hanno offerto prezzi fissi forfettari le opere di carpentiere, concernenti il tetto,le strutture,le installazioni,eccetera;
richiedere riduzioni e sconti facendo leva sul fatto che con gli aiuti agli investimenti pubblici il finanziamento è stato stabilito in modo serio ed è sicuro;
– procedere all’aggiudicazione dei lavori nel momento più vantaggioso,quando l’imprenditore ha i portafogli ordini ancora vuoti;
informare il committente in merito ai suoi diritti e doveri rispetto al progettista e agli imprenditori;
– stabilire tempestivamente i costi residui sopportabili sulla base del preventivo aziendale e dei possibili aiuti agli investimenti;le riduzioni dei progetti effettuate in un secondo tempo spesso non portano i risparmi auspicati;
osservare una certa prudenza per ciò che concerne installazioni e strutture; eventualmente possono venir attuati dapprima i provvedimenti edilizi,in modo da agevolare la posa in un secondo tempo;
assegnare incarichi chiari e stilare contratti e capitolati d’oneri con il progettista,gli imprenditori e i fornitori;
– evitare modifiche e ampliamenti del progetto;
– appurare gli aspetti finanziari in caso di responsabilità civile e superamento dei costi.
190 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Per la valutazione dei costi di costruzione e dell’utilità di edifici rurali,non si dovrebbero trascurare la visione d’assieme e il controllo dei vari investimenti dell’azienda agricola.Spesso ci si procura macchinari,si acquistano contingenti lattieri,si riprendono terreni ed aziende o vengono costruite abitazioni senza che ci si interroghi in merito ai vantaggi e alla necessità dal profilo economico.
Un sondaggio indica che anche i Cantoni attribuiscono notevole importanza all’economicità delle costruzioni e che in fase d’esecuzione concedono all’agricoltore la massima libertà nel quadro delle condizioni legali.Diversi Cantoni offrono agli agricoltori consulenza edile oppure tengono corsi per coloro che hanno intenzione di realizzare delle costruzioni.Tuttavia alcuni uffici dovrebbero prestare più attenzione all’economicità delle costruzioni e all’idoneità delle soluzioni scelte.Rilevamenti statistici dei costi di costruzione fornirebbero informazioni sicure in materia di costi specifici.Non va sottovalutato che generalmente un agricoltore effettua delle costruzioni una sola volta nella vita,mentre gli uffici dispongono di una pluriennale esperienza basata su innumerevoli progetti.Presso di essi sono reperibili anche informazioni utili sui progettisti e sulle imprese di costruzione locali.

191 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Cosa fanno i Cantoni?
■ Agroscope – La ricerca agronomica sotto un nuovo nome
2.3.2 Ricerca,Istituto di allevamento equino, consulenza,formazione professionale,CIEA
Ricerca agronomica e Istituto d’allevamento equino
Le Stazioni federali di ricerche agricole sono subordinate all’UFAG.Il 60 per cento delle loro attività riguarda la ricerca applicata mentre il 40 per cento è dedicato all’esecuzione e al controllo dei prodotti.Grazie all’unione fra ricerca applicata ed esecuzione e controllo viene garantito un utilizzo ottimale del più attuale know-how e di un’infrastruttura di alta qualità
Agroscope è il nome sotto il quale si sono riunite le cinque Stazioni federali di ricerche agricole (ALP Liebefeld-Posieux,FAL Reckenholz,FAT Tänikon,FAW Wädenswil e RAC Changins) dal 1° gennaio 2004.Agroscope è un’unità dell’UFAG.
Il nome è stato scelto per sottolineare l’attenzione rivolta verso l’agricoltura: è composto dalle parole greche «agrós» (coltura,campo) e «skopein» (considerare,osservare).Sotto il nome Agroscope ogni istituto copre concretamente un particolare settore di ricerca e la mutua collaborazione viene ulteriormente intensificata.La scelta di un’identità comune consente anche di sfruttare le sinergie nel settore della comunicazione.
■ Fusioni di Stazioni federali di ricerca
Nel quadro del programma di sgravio 2003 della Confederazione,entro il 2006 le Stazioni federali di ricerche agricole devono realizzare un taglio dei costi pari a circa 5 milioni di franchi.Sono state elaborate diverse proposte risolutive che comportano, fra l’altro,anche alcune varianti per le fusioni delle Stazioni federali di ricerche. Partendo da tali proposte è stata decisa la fusione di FAL e FAT e di FAW e RAC.Le attuali sedi resteranno operative.Da ciò il motto:un’unica direzione per due sedi. Risale ormai a qualche tempo fa,invece,la decisione secondo cui le Stazioni federali di ricerche lattiere (FAM) e per la produzione animale (RAP) sarebbero state riunite nell’Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) a partire dal 1° gennaio 2004.
La FAW e la RAC si occuperanno della produzione vegetale e l’ALP della produzione animale.Con la FAL e la FAT i settori trasversali di economia,ecologia e tecnologia agricole verranno riuniti sotto lo stesso tetto.
La ricerca agronomica della Confederazione si potrà quindi profilare in modo ancora migliore,poiché la collaborazione sarà più semplice e l’immagine proiettata verso l’esterno sarà quella di una maggiore unità.Le tre nuove unità apriranno nuove prospettive di ricerca grazie a forze più specializzate.La competitività sul mercato nazionale ed internazionale verrà incrementata.
192 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Obiettivi raggiunti nella misura del 95 per cento
Le prestazioni nell’ambito della ricerca sono valutate sulla base di indicatori e standard concreti.Gli obiettivi sono stati raggiunti nella misura del 95 per cento circa.Agroscope ha così potuto mantenere l’alto livello di prestazione raggiunto l’anno precedente.Solo pochi progetti non hanno potuto essere realizzati a causa della mancanza di personale specializzato o perché nel corso dell’anno sono state introdotte nuove priorità
Il mandato di prestazione 2000–2003 è scaduto.Durante questo periodo la ricerca agronomica ha fornito,in particolare con i suoi compiti di controllo e omologazione nel settore dei mezzi di produzione,un contributo determinante per una maggiore sicurezza delle derrate alimentari.La qualità dei prodotti vegetali ed animali nonché la protezione dell’ambiente sono stati punti cardine delle attività svolte in questi anni.La ricerca sostiene le aziende agricole sviluppando nuove forme di produzione (ingrasso estensivo,ecc.) ed elaborando raccomandazioni (ottimizzazione del parco macchine, impiego di nuove tecniche).
I risultati dell’Istituto nazionale d’allevamento equino relativi al 2003 sono molto soddisfacenti.Dei 39 obiettivi prefissati nel mandato di prestazione,ben 38 (97%) sono stati raggiunti o addirittura superati.Le condizioni di detenzione degli stalloni nell’Istituto nazionale d’allevamento equino devono ancora essere migliorate,in modo da corrispondere pienamente alle direttive dell’UFV pubblicate nel 2001.
■ Nuovo mandato di prestazione per il periodo 2004–2007 per Agroscope
Il nuovo mandato di prestazione per Agroscope è il risultato di tre anni di lavoro svolto in più tappe:strategia a lungo termine della ricerca agronomica (foresight),concetto di ricerca 2004–2007 e mandato di prestazione (2004–2007).In base a questi diversi imperativi e dopo un’attenta indagine svolta presso i clienti,le Stazioni federali di ricerca hanno redatto il loro programma d’attività 2004–2007.

Nel mandato di prestazione ogni gruppo di prodotti ha stabilito i propri obiettivi per il periodo in questione.
Gruppo di prodotti 1:campicoltura,superfici inerbite e agroecologia
Il gruppo di prodotti 1 sostiene l’orientamento ecologico della produzione con la ricerca di relazioni di causa-effetto nei sistemi di campicoltura.A tal scopo l’agricoltura biologica riveste un ruolo particolare.Attraverso l’ottimizzazione della gestione ecologica di prati e pascoli il gruppo di prodotti 1 promuove lo sviluppo di sistemi di foraggicoltura ed economia alpestre sostenibili.L’obiettivo principale consiste nell’aumento della sicurezza dei sistemi agricoli al servizio di una produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali sana e alta dal profilo qualitativo.
Il gruppo di prodotti 1 elabora le basi necessarie alla sicurezza e alla conservazione a lungo termine delle risorse naturali e della biodiversità.Al centro di queste vi sono la diagnosi precoce e la valutazione della minaccia per le risorse naturali nonché la stima delle opportunità e dei rischi legati all’uso,in agricoltura,di vegetali transgenici e organismi esotici.Il controllo del successo agroecologico verifica l’efficacia dei diversi provvedimenti e fornisce le basi per l’ulteriore sviluppo degli obiettivi e dei provvedimenti agroecologici e di politica ambientale.
193 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Gruppo di prodotti 2:frutticoltura,viticoltura e orticoltura
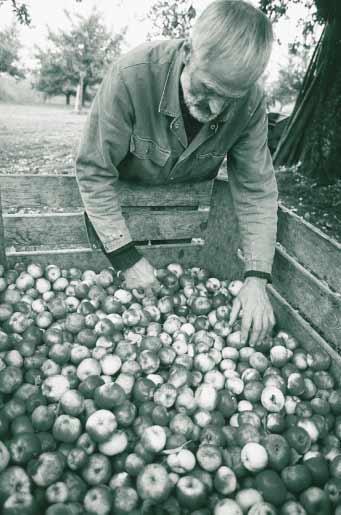
Attraverso la propria attività il gruppo di prodotti 2 contribuisce ad un’agricoltura sostenibile con un settore di colture speciali forte,competitivo e orientato verso le esigenze del mercato nelle regioni principali a vocazione agricola e nelle regioni periferiche.Grazie al suo importante contributo a favore della qualità e della sicurezza dei prodotti delle colture speciali (frutta,bacche,verdure,piante medicinali) e dei loro derivati (ad es.succhi di frutta,vino),il gruppo di prodotti 2 rappresenta un vero e proprio vantaggio per le colture speciali svizzere.La qualità ineccepibile e una buona immagine promuovono la fiducia della popolazione per prodotti sani,sicuri,invitanti e conformi agli alti standard ecologici.
Il gruppo di prodotti 2 genera un valore aggiunto per produttori (inclusi i settori a monte e a valle),opinione pubblica (consumatori) e Stato (politica e autorità) tramite le sinergie che scaturiscono dalla ricerca applicata,dal trasferimento di conoscenze e dall’esecuzione di compiti centrali svolti sotto un solo nome.Grazie alla collaborazione con i partner svizzeri ed esteri il gruppo di prodotti 2 può ampliare le sue competenze e rafforzare la sua importante funzione di fonte di innovazioni.Tale gruppo lavora in modo interdisciplinare e promuove un approccio sistematico (dalla coltivazione all’immagazzinamento attraverso la trasformazione di prodotti provenienti dalle colture speciali). È in grado di impiegare nuove tecnologie (ad es.metodi biologico-molecolari) e di ponderarne opportunità e rischi.
Gruppo di prodotti 3:produzione animale e derrate alimentari di origine animale
Il gruppo di prodotti 3 elabora basi scientifiche e tecniche nel settore della produzione animale (ad es.latte,carne) e delle derrate alimentari di origine animale.In tal modo cerca di prevedere le principali tendenze nei settori:qualità,sicurezza,alimentazione, salute e risorse naturali.Inoltre fornisce le basi per condizioni quadro,guide,controlli e per agevolare l’esportazione dei prodotti agricoli svizzeri (in particolare per il formaggio).La ricerca e la consulenza inerenti alla pratica hanno quale obiettivo la fabbricazione di derrate alimentari sane e sicure,il miglioramento della competitività, la promozione di una produzione ecologica conforme al mercato e il sostegno di sistemi di produzione nelle regioni periferiche.Gli elementi importanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono:
– conoscenze sull’influsso della qualità degli alimenti per animali,del foraggiamento, della detenzione degli animali e di ulteriori parametri su produzione,qualità e sicurezza di latte,carne e prodotti apicoli;
– tecnologie sostenibili per la fabbricazione di formaggio e basi per la trasformazione di latte e carne;
– compiti pertinenti all’esecuzione e laboratori di riferimento nei settori degli alimenti per animali e dell’economia lattiera;
applicazione dei risultati di ricerca per la prassi e il pubblico.
–
194 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Gruppo di prodotti 4:economia e tecnologia agricole
Il gruppo di prodotti 4 elabora conoscenze legate all’economia e alla tecnologia agricole nonché basi per facilitare le decisioni e provvedimenti esecutivi in base ai seguenti punti chiave:
analisi economiche,prognosi,concetti e valutazioni del settore agricolo;
– sviluppo e messa in funzione di sistemi di informazione tecnico-economici per la consulenza politica ed agricola;
metodi di economia aziendale e del lavoro,analisi,concetti e valutazioni per processi di produzione e imprese agricole compresi gli strumenti idonei alla gestione rispettosa dell’ambiente;
– sviluppo di processi tecnici nell’ambito della produzione vegetale e detenzione di animali secondo criteri funzionali,economici,che promuovono la qualità e il rispetto dell’ambiente e degli animali;
– studi sullo sfruttamento sostenibile del potenziale energetico e delle biomasse nonché dei sottoprodotti.
Nel suo mandato di prestazione 2004–2007,l’Istituto nazionale di allevamento equino si posiziona quale centro di competenze nazionalmente ed internazionalmente riconosciuto che,in considerazione degli altri obiettivi di politica agricola in Svizzera,sostiene la detenzione agricola competitiva e sostenibile degli equini.Nei settori formazione, allevamento e ricerca fornisce prestazioni che soddisfano le esigenze dei produttori e dei loro partner.
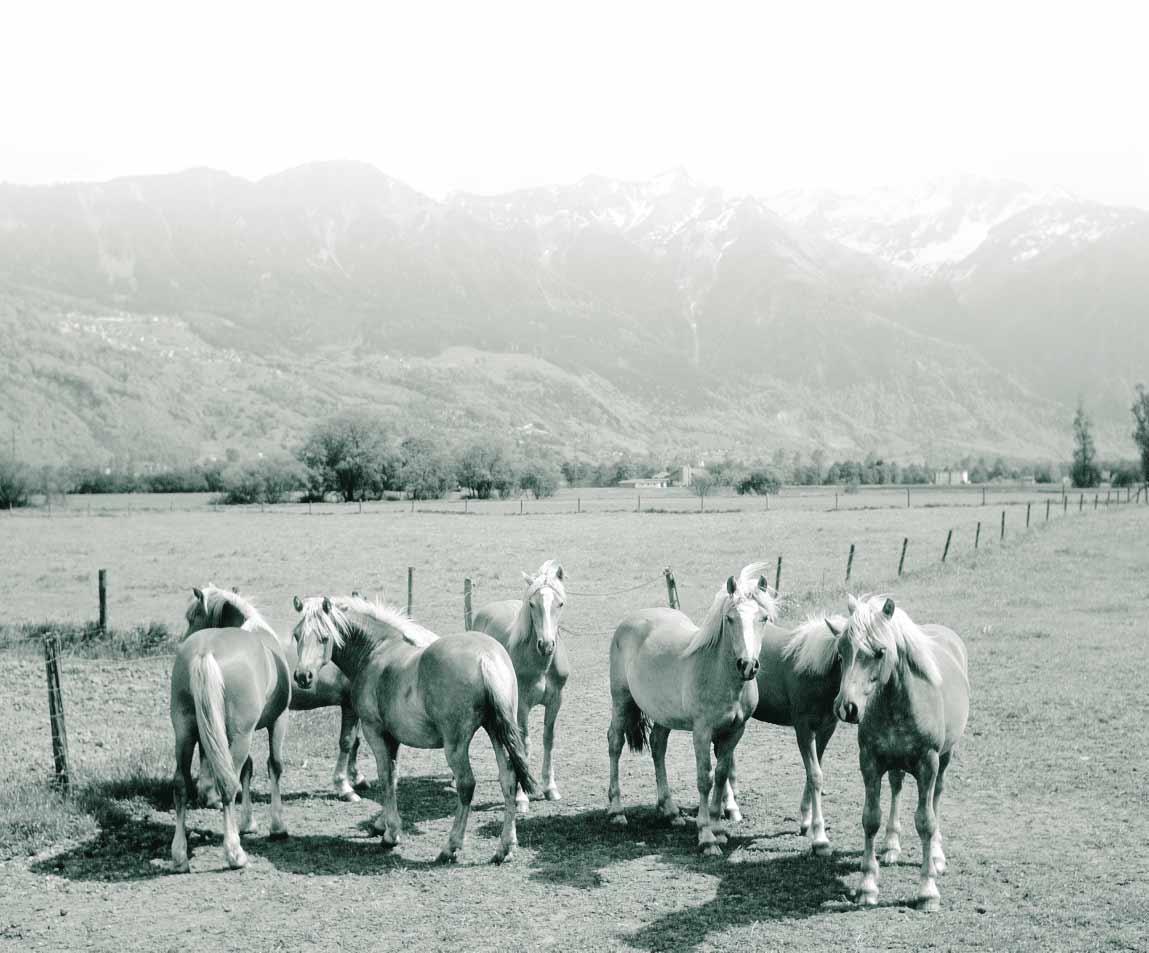
–
–
195 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Istituto nazionale di allevamento equino
Consulenza agricola e in economia domestica rurale
La Confederazione versa aiuti finanziari a favore della consulenza.Tali aiuti concorrono a supplire mediamente al 20–25 per cento delle spese sostenute dai servizi di consulenza e a circa il 55 per cento di quelle dell’Associazione svizzera per la consulenza nell’agricoltura (ASCA).L’ASCA sostiene le centrali di consulenza di Lindau (LBL) e di Losanna (SRVA).
Uscite per la consulenza – 2003
BeneficiariImporto mio.fr.
Servizi cantonali di consulenza agricola8,2 Servizi cantonali di consulenza in economia domestica rurale0,8 Servizi di consulenza speciali delle organizzazioni agricole0,9 Associazione svizzera per la consulenza nell’agricoltura8,4 Totale18,3
Fonte:Conto dello Stato
Ogni anno i servizi cantonali di consulenza rendono conto delle loro prestazioni di consulenza nei singoli settori d’attività.Nel 2002 l’accento è stato posto sulla consulenza inerente alla produzione e ai settori d’attività economia aziendale, economia domestica e tecnica.
Nella produzione vegetale le consulenze hanno interessato soprattutto il nuovo bilancio di concimazione (Suisse-Bilanz),le ispezioni in campo,l’offerta di corsi di frutticoltura,le questioni sulla protezione dei vegetali e la consulenza sulla riconversione all’agricoltura biologica.Oltre a ciò è stato dedicato molto tempo alla formazione continua e alle informazioni sulla nuova ordinanza sulla qualità ecologica.Nella produzione animale i consulenti cantonali si sono impegnati principalmente nell’ambito della produzione lattiera.I servizi cantonali di consulenza si sono confrontati con l’abbandono della produzione,la riorganizzazione,come ad esempio le possibilità relative alla trasformazione del latte biologico da produrre in futuro,nonché con la collaborazione extraaziendale di aziende dedite alla produzione lattiera.Tuttavia, hanno avuto un ruolo importante anche le questioni inerenti alla foraggicoltura,come ad esempio la lotta al senecio velenoso e aspetti della tecnica di foraggiamento, nonché corsi sulla detenzione di vacche madri e l’illustrazione di alternative,nonché di possibilità di estensificazione o di intensificazione della produzione lattiera,analisi dei costi e consulenza tecnica.
Nel settore economia aziendale,economia domestica e tecnica è stata fornita consulenza soprattutto in relazione a cessione dell’azienda e progetti edilizi quali investimenti nella casa o nella stalla,acquisto di terreni e prescrizioni edili nonché questioni finanziarie inerenti alla costruzione di stalle,al risanamento di abitazioni e all’acquisto di macchinari.Inoltre sono state richieste le competenze dei consulenti in materia di contratti concernenti le comunità di detentori di animali e di gestione tra generazioni nonché il diritto sui fitti agricoli.

196 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Produzione lattiera in primo piano
■ Consulenze individuali pari al 30 per cento del lavoro
Nel settore d’attività aree rurali e basi vitali naturali sono state effettuate consulenze principalmente in merito a progetti ecologici d’interconnessione,alla protezione della natura,in particolare sulla protezione delle acque,nonché relativamente allo smercio e alla collaborazione nelle aree regionali.
Nel settore orientamento del mercato sono state trattate soprattutto questioni sulla produzione con marchi e label.
Nel settore sviluppo personale si sono tenuti alcuni corsi di formazione imprenditoriale destinata a capiazienda donne e a contadine.
Accanto alla distinzione in settori d’attività,i servizi cantonali di consulenza si suddividono le loro prestazioni in cosiddette categorie di prestazione.Nel 2002 i consulenti cantonali si sono impegnati ognuno in misura del 30 per cento circa a favore di manifestazioni informative e a scopo di perfezionamento nonché per consulenze individuali.A livello di consulenze individuali,il tempo utilizzato per interessi privati è stato di tre volte superiore a quello impiegato per interessi pubblici.L’accompagnamento del progetto e del processo hanno occupato una quota pari a circa il 16 per cento del tempo totale lavorativo.Rispetto allo scorso anno,sono cambiate leggermente le quote temporali relative alle consulenze individuali nelle due categorie manifestazioni informative/a scopo di perfezionamento professionale e accompagnamento dei progetti.Il tempo restante è stato dedicato all’acquisizione delle basi,ad attività di informazione,orientamento e documentazione nonché al proprio perfezionamento professionale e alla collaborazione intercantonale.
■ Interconnessioni internazionali
Per le centrali e i servizi di consulenza diventano sempre più importanti i rapporti internazionali.I consulenti svizzeri ne traggono vantaggio,partecipando ad esempio a seminari all’estero o a giornate di perfezionamento professionale,come quelli offerti ogni anno dalla «Internationale Akademie land- und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater» (IALB).Dall’altro lato gli specialisti svizzeri assumono mandati all’estero, per i quali sono richieste conoscenze specificatamente svizzere.
L’anno scorso,diverse istituzioni di una ventina di Paesi impegnate nello scambio di conoscenze agricole si sono riunite nel Rural Extension Network in Europe.Accanto ad una ricca offerta di perfezionamento professionale e di seminari, è stato posto l’accento sullo scambio di esperienze a livello internazionale.Le questioni inerenti allo sviluppo nelle aree rurale hanno acquisito sempre più importanza.
Mentre entrambe le Centrali di consulenza LBL e SRVA offrono a volte escursioni congiunte all’estero,i servizi cantonali di consulenza di confine elaborano progetti specifici direttamente con i loro partner d’oltrefrontiera.Le istituzioni ufficiali come la IALB o ufficiose come la rete di consulenti biologici favoriscono lo scambio di esperienze.
197 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Formazione professionale agricola
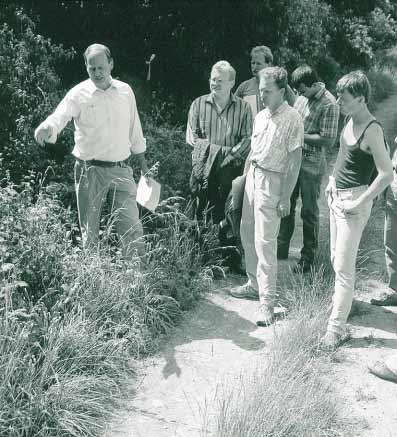
La nuova legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e l’ordinanza d’esecuzione (OFPr) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004.Conformemente alla Costituzione federale si applicano per la formazione professionale di tutti i rami economici.Le formazioni professionali agricole,quindi,non rientrano più sotto la LAgr.Esse soggiacciono alla stessa regolamentazione applicabile per le formazioni nei settori tecnica, industria,commercio,salute,opere sociali e arte.La legge prevede un termine di cinque anni per l’adeguamento delle disposizioni sulle formazioni di agricoltore,orticoltore, frutticoltore,viticoltore,tecnologo del vino,pollicoltore,stalliere,cavallerizzo,fantino, custode di cavalli nonché formazioni simili nel terziario.La revisione di tali testi è compito comune di Confederazione,Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (art.1 cpv.1 LFPr).
Ogni ciclo di formazione,inclusa la procedura di qualificazione, è disciplinato in un’ordinanza,elaborata dai tre partner definiti nell’articolo 1 LFPr.Inoltre,questi fissano gli obiettivi generali e specifici quali la durata della formazione,la procedura di qualificazione e i metodi di sviluppo della qualità.Tali basi,che costituiscono una sintesi delle posizioni dei diversi partner,garantiscono a coloro che seguono la formazione un’alta qualifica equiparabile a livello nazionale e adatta alla situazione del mercato del lavoro (cfr.l’art.1 cpv.1 LFPr).Esse vengono completate con ulteriori documenti come l’elenco degli obiettivi di prestazione,in cui sono descritti gli obiettivi didattici per ogni tipo di formazione (scuola,aziende,ciclo scolastico pratico,tirocinio,ecc.).
I cicli di formazione che si concludono con un esame che porta al certificato federale di formazione pratica hanno una durata di due anni mentre quelli che portano all’attestato federale di capacità richiedono da tre a quattro anni.
198 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Modifica di legge
■ Formazione professionale di base
■ Formazione professionale superiore
Tutti i regolamenti d’esame vanno aggiornati conformemente alla LFPr.Alle organizzazioni del mondo del lavoro è stato concesso un termine transitorio fino a fine 2009 per effettuare tali adeguamenti.Prima della fine del 2004,dovrebbe entrare in vigore una nuova ordinanza sulle prescrizioni minime per il riconoscimento di cicli di formazione superiore e corsi di postdiploma presso le scuole specializzate superiori.Essa riguarderebbe anche le scuole specializzate superiori dei settori agricolo e silvicolo.
■ Nuovi compiti e responsabilità per le associazioni professionali
La nuova legge delega la responsabilità del contenuto delle formazioni disciplinate (obiettivi didattici) e il loro orientamento verso le esigenze e le aspettative del mercato del lavoro alle organizzazioni del mondo del lavoro attive a livello nazionale.Al fine di designare associazioni competenti per le diverse professioni agricole, è necessario chiarire quali associazioni hanno un interesse economico e politico nell’incoraggiamento e nella garanzia di nuove leve.
La responsabilità per la formazione agricola spetta evidentemente a quelle associazioni per le quali la formazione costituisce uno strumento utile a rappresentare gli interessi.
■ Aiuti finanziari dell’UFFT per la formazione professionale agricola
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) sostiene la formazione professionale agricola con un contributo di circa 10 milioni di franchi l’anno.In tal modo si assume una parte dei costi computabili delle scuole agricole aventi diritto ai contributi,delle istituzioni e delle associazioni.Per organizzazioni professionali e scuole d’importanza extracantonale vi è una particolare quota di partecipazione ai costi computabili del 43 per cento.
La LFPr,entrata in vigore il 1° gennaio 2004,prevede di passare da un sistema di finanziamento del dispendio al finanziamento forfettario.Fino alla fine del 2007 gli aiuti finanziari verranno ancora fissati in base al sistema previgente.Dopo la quadriennale fase di transizione,ogni Cantone riceve – in base al numero di persone in scuole professionali a tempo pieno e in simili formazioni di base organizzate del settore agricolo – un cosiddetto importo forfettario cantonale,con cui vengono compensate tutte le prestazioni della formazione professionale fornite dai Cantoni.La ripartizione o l’utilizzazione dei mezzi è compito dei Cantoni.
La fase di transizione offre ai Cantoni l’opportunità di emanare le norme necessarie per il finanziamento futuro e di concludere accordi intercantonali.
In futuro la Confederazione si dovrà concentrare soprattutto sul rispetto della LFPr (catalogo di prestazione giusta l’art.53 cpv.2) e dovrà fare in modo che la quota della partecipazione della Confederazione ai costi per la formazione professionale dell’ente pubblico – nel quadro dei crediti autorizzati – venga aumentata progressivamente dall’attuale 18 al 25 per cento circa.
199 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ CIEA 2004: «formazione continua a favore delle aree rurali»
Centre international d’études agricoles (CIEA)
I seminari del CIEA sono importanti manifestazioni di perfezionamento professionale organizzate dall’UFAG in collaborazione con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e,a partire dal 1995,con la scuola superiore svizzera di agronomia (SHL).Scopo dei seminari è offrire l’opportunità agli insegnanti e ai consulenti del settore agricolo provenienti dai diversi Paesi del mondo di aggiornarsi su conoscenze specialistiche e metodologiche nonché di favorire lo scambio globale di esperienze.La manifestazione che ha avuto luogo a Grangeneuve nell’agosto 2004 era all’insegna del motto «formazione continua a favore delle aree rurali».Ad essa hanno partecipato 86 persone provenienti da 39 Paesi.
■ Apprendimento strutturato in modo consapevole
Il seminario CIEA 2004 ha fornito un contributo al processo di apprendimento «consapevole».Questo tipo di apprendimento presenta,fra l’altro,le seguenti caratteristiche:
– l’apprendimento avviene in modo consapevole ed intenzionale;
l’apprendimento persegue determinati obiettivi chiaramente definiti;si impara a raggiungere veramente questi obiettivi;
– gli studenti ricordano e applicano ciò che hanno appreso durante un determinato periodo di tempo.
In tal modo l’apprendimento si trasforma in un processo consapevole e fruttuoso che consente agli specialisti e ai professionisti del settore agricolo di affrontare e superare importanti sfide.
■ Nuovo sito Internet
Ulteriori informazioni sul CIEA sono disponibili al sito Internet www.ciea.ch,nel quale è presentata anche l’idea alla base del concetto «formazione continua»,valido per tutti: «nel corso della vita intera di un uomo può e deve aver luogo un apprendimento consapevole».
200 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
–
■ Elevato grado di autoapprovvigionamento in cereali e patate
2.3.3 Mezzi di produzione
Sementi e materiale vegetale
Per tutti i tipi di cereali (esclusa la segale) e per le patate,l’agricoltura svizzera può contare su un’elevata quota di sementi e materiale vegetale certificati indigeni.In alcuni anni i volumi di frumento e triticale esportati hanno superato nettamente quelli importati.Per segale,granturco,soia e sementi di piante foraggere è stato in parte raggiunto un grado di autoapprovvigionamento fino al 40 per cento.Per sementi di colza,girasole e barbabietole vi è una totale dipendenza dalle aziende di moltiplicazione estere.
Produzione e commercio esterno di sementi e materiale vegetale – 1999/2002
100% = Consumo globale
Frumento Orzo
Triticale Avena
Granturco
Segale Spelta Soia Colza
Girasole
Patate da semina Barbabietole Trifoglio 1
Produzione indigena Importazioni nette ( = import – export)
La produzione in Svizzera di sementi e materiale vegetale certificati è indicata sotto diversi punti di vista.Tra questi vanno citati i brevi tragitti di trasporto,il fatto che organismi nocivi particolarmente pericolosi non (ancora) esistenti potrebbero venir introdotti nel nostro Paese con il materiale di moltiplicazione nonché il mantenimento di un livello di valore aggiunto.
Il vantaggio di sementi e materiale vegetali certificati rispetto alla riproduzione propria risiede nella garanzia della conformità,dell’elevata germinabilità e dell’ottima salute del vegetale.Grazie alla certificazione può essere garantita la tracciabilità,un elemento fondamentale sempre più richiesto dalle aziende di trasformazione.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 201 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■■■■■■■■■■■■■■■■
Fonti: swisssem, DGD
020406080100 in
1 Per il trifoglio la produzione indigena si riferisce soltanto al trifoglio pratense
%
Evoluzione della produzione di sementi e materiale vegetale

Le esigenze dei mercati si rispecchiano anche nelle partite di sementi e materiale vegetale riconosciute.Per fare in modo che i quantitativi necessari siano disponibili al momento giusto è importante una buona intesa tra i diversi partner di mercato.Essi sono raggruppati in varie organizzazioni di categoria.
Omologazione di concimi
L’UFAG è competente per l’omologazione di mezzi di produzione agricoli,il che concerne prodotti fitosanitari,concimi,sementi e alimenti per animali.
I concimi che si desidera commercializzare necessitano di un’omologazione.Essi devono prestarsi all’impiego previsto,essere adatti ad un uso conforme alle prescrizioni privo di rischi per uomo,animali e ambiente nonché consentire la produzione di derrate alimentari conformi alla legge.
I concimi sono sostanze o prodotti che nutrono le piante.Ne promuovono la crescita, ne aumentano la resa o ne migliorano la qualità.I prodotti autorizzati legalmente quali concimi omologati sono elencati nell’ordinanza sulla messa in commercio di concimi (OCon,RS 916.171).Ai sensi della legge anidride carbonica,acqua e luce non rientrano nei concimi.
Per l’omologazione di concimi vi sono,in principio,due modalità:l’omologazione via elenchi o l’autorizzazione.
202 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Varietà 1999200020012002 In t Patate27 03532 24727 11828 670 Frumento18 08717 69417 43617 850 Orzo7 1357 0045 9636 413 Triticale1 7132 1822 3742 465 Avena1 2831 3421 1581 113 Granturco615419697690 Spelta258361361488 Segale450433485308 Trifoglio83536651 Soia33172639 Fonte:swisssem
Omologazione
Elenco
■ Soggetti all’obbligo di notifica (OLCon, allegato 1, parti 3–6)
■ Non soggetti all’obbligo di notifica (OLCon, allegato 1, parti 1+2)
Autorizzazione
Nell’ordinanza sul libro dei concimi (OLCon,RS 916.171.1) sono elencati alcuni tipi di concime che,per l’omologazione,necessitano soltanto di una notifica;per determinati prodotti generalmente conosciuti non è necessaria nemmeno quest’ultima.Sono soprattuttoconcimi che possono venire designati come «CONCIME CEE» ed essere commercializzati liberamente anche nella CE.Evidentemente anche tali concimi devono adempiere le disposizioni legali e rispettare le prescrizioni in materia di caratterizzazione.
Un concime che non corrisponde ad alcuno dei tipi di concime elencati o che contiene microrganismi può essere commercializzato soltanto con un’autorizzazione dell’UFAG. A tal scopo va inoltrata la necessaria documentazione presso l’UFAG,che procederà in seguito a verificare l’impatto sull’ambiente e l’efficacia del prodotto da omologare.
Per la valutazione di concimi e altri mezzi di produzione l’UFAG lavora in stretta collaborazione con le Stazioni federali di ricerche agronomiche.Nella procedura di omologazione vengono coinvolti anche l’Ufficio federale dell’ambiente,delle foreste e del paesaggio (UFAFP),l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Ufficio federale di veterinaria (UFV).
Attualmente,presso l’UFAG ogni anno vengono autorizzati o notificati 200 prodotti.Il controllo del mercato spetta ai Cantoni.L’UFAG svolge tali compiti in modo ausiliario e coordina i compiti pertinenti all’esecuzione dei Cantoni.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 203 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
La messa in commercio di concimi
OLCon = ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DFE sul libro dei concimi)
Controllo cantonale di mercato
Prodotti fitosanitari nell’acqua –un pericolo per l’uomo e l’ambiente?
I rilevamenti di prodotti fitosanitari in corsi d’acqua destano ogni volta l’attenzione della stampa.Nel 2003,la pubblicazione di uno studio sulla presenza di prodotti fitosanitari nella falda freatica ha provocato una campagna mediatica e nell’autunno dello stesso anno sono apparsi nuovamente articoli che mettevano in relazione i problemi della fertilità maschile con la presenza di prodotti fitosanitari nell’acqua potabile e ad uso domestico.Rapporti di questo genere creano nella popolazione paure e dubbi che portano a interrogativi di questo tipo:in Svizzera l’acqua del rubinetto è inquinata? Perché non si vietano i prodotti fitosanitari se sono così nocivi? I prodotti fitosanitari non avvelenano animali e vegetali che vivono in ruscelli e laghi? Queste domande devono essere prese sul serio ed è necessario rispondervi fornendo informazioni precise.

I prodotti fitosanitari sono indispensabili per un’agricoltura che si vuole produttiva e nella quale la produzione vegetale occupa un posto importante.Malattie,parassiti e malerbe costituiscono una minaccia continua e determinate malattie crittogamiche possono dare origine a prodotti metabolici nocivi per la salute dell’uomo.I prodotti fitosanitari sono impiegati nella produzione convenzionale,integrata e biologica.
Essi,però,non hanno solo ripercussioni utili.A causa della loro attività biologica, possono comportare anche rischi per l'ambiente,l'uomo e gli animali,in particolare se vengono utilizzati inadeguatamente o senza che ne siano stati appurati gli effetti.In Svizzera,i prodotti fitosanitari devono pertanto essere controllati e possono essere messi in commercio o importati soltanto se omologati.Per poter valutare i rischi legati all’uso di prodotti fitosanitari e per avere una buona base decisionale utile all’omologazione,devono essere svolti ampi studi per la valutazione delle possibili ripercussioni su utilizzatore,ambiente e consumatori,i cui risultati devono venir inoltrati alle autorità competenti in materia di omologazione per un’ulteriore valutazione.Un prodotto fitosanitario può essere commercializzato solo se tale valutazione indica che esso è idoneo all’uso previsto e che,se utilizzato conformemente alle prescrizioni,non comporta alcun effetto collaterale né sulle colture da proteggere né su ambiente,uomo ed animali.
Dagli studi devono scaturire soprattutto informazioni sulla possibilità che tracce del prodotto fitosanitario possano ritrovarsi nell’acqua,in particolare in quella potabile e nella falda freatica,e sull’eventualità di effetti collaterali inammissibili per l’ambiente e la salute dell’uomo e degli animali.
A tal scopo gli studi devono illustrare il comportamento e le ripercussioni di un prodotto fitosanitario in corsi d’acqua e acque stagnanti nonché nella falda freatica. Per ottenere tali dati,il comportamento del prodotto fitosanitario viene testato in laboratorio,su diversi suoli e in pieno campo,segnatamente in relazione alla degradazione,ma anche alla possibilità di un suo arricchimento.Viene pure testato se e come avviene la decomposizione in presenza di acqua e luce nonché se e come si infiltra nel suolo e viene dilavato in profondità fino a raggiungere la falda freatica.
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 204
Da questo e altri studi ambientali si deduce che quantitativo di un determinato prodotto fitosanitario e dei suoi prodotti di degradazione potrebbe essere ritrovato nell’acqua.Le condizioni di omologazione stabiliscono tuttavia che questi residui possono essere al massimo tracce.
In un secondo tempo si deve chiarire se e quali ripercussioni hanno tali tracce di prodotti fitosanitari su ambiente,animali e uomo.Per l’ecosistema acquatico si stanno conducendo analisi su organismi che possono essere considerati bioindicatori.In queste analisi rientrano,fra l’altro,gli studi sulla tossicità per carpe,idi e trote.Inoltre viene esaminato l’influsso sulle alghe,sugli animali che fungono da nutrimento per i pesci e su alcuni anfipodi.
Un prodotto fitosanitario può essere autorizzato e commercializzato solo se la concentrazione di tracce riscontrabili nell’acqua è di molto inferiore a quella che ha ripercussioni inammissibili sugli esseri viventi acquatici.Per varietà sensibili,come è il caso dei pesci,in occasione dell’esame standard per l’omologazione viene stabilito che la concentrazione massima deve essere inferiore di un coefficiente di 100 a quella alla quale si sono potuti osservare effetti nocivi inammissibili.

2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 205
L’omologazione non si basa quindi sull’esigenza,irrealizzabile,della concentrazione zero di prodotti fitosanitari nell’acqua,bensì su principi scientifici.Questi si fondano soprattutto sul principio basilare della tossicologia,valido fin dalla sua formulazione da parte di Paracelso: «Non ci sono sostanze tossiche,ci sono solo dosi tossiche».Alla base di una decisione di omologazione vi è la determinazione di concentrazioni tollerabili,secondo il principio succitato.Ciò vale per gli esseri viventi acquatici,ma anche per uomo e animali.
La richiesta di una concentrazione zero comporterebbe,di fatto,l’impossibilità di omologare qualsiasi prodotto fitosanitario,il che equivarrebbe a rinunciare ad un’agricoltura che si vuole produttiva.Con i metodi di analisi attuali è anche possibile dimostrare la presenza di ultratracce di prodotti fitosanitari – e altre sostanze –nell’acqua.Attualmente è infatti possibile rilevare concentrazioni per litro d’acqua pari a 0,000’000’1 grammi,o perfino inferiori.Per rendere l’idea,ciò significa che se volessimo sciogliere un cubetto di zucchero nell’acqua fino ad averlo in tale concentrazione avremmo bisogno dell’acqua contenuta in un vagone ferroviario a serbatoio lungo circa 3 chilometri!
L’omologazione deve garantire che in nessun caso vi siano pericoli,nemmeno per i consumatori di acqua potabile che contiene ultratracce di prodotti fitosanitari.A tal scopo devono venir inoltrati alle autorità dati esaurienti relativi alle analisi tossicologiche su modelli animali.Essi comprendono,fra l’altro,i tipi di studio citati di seguito:
– analisi sulla tossicità acuta in caso di assunzione per via orale,cutanea o respiratoria;
prova di irritazione cutanea e delle mucose;
– studi sulla tossicità cronica,ad esempio su ratti e topi che durante tutta la vita assumono alimenti che contengono determinate concentrazioni di un principio attivo;
– analisi relative alla cancerogenicità,ossia se vi è la possibilità che si sviluppino tumori e a quali dosi;

– studi sulla riproduttività utili a verificare se l’assunzione di un principio attivo da parte degli animali genitori potrebbe avere ripercussioni negative sui discendenti.
Tutti questi studi servono a valutare la quantità di un prodotto fitosanitario che può essere assunta nel corso della vita senza che insorga alcun pericolo per la salute.Tale quantitativo tollerato comporta elevati margini di sicurezza – un coefficiente da 100 a 1000 – dalla quantità critica dal punto di vista tossicologico,alla quale possono subentrare le prime ripercussioni negative.
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 206
–
Concentrazione di un prodotto fitosanitario nell’acqua
effetti inammissibili fattori di sicurezza
Concentrazione
concentrazione tollerabile (stabilita scientificamente)

0,1 ppb valore di tolleranza (obiettivo di qualità)
0
L’importanza particolare che riveste l’acqua per uomo,animali e ambiente è sottolineata anche nel diritto svizzero.Infatti,le esigenze legali vanno ben oltre i valori scientificamente tollerabili sin qui descritti sia per la falda freatica che per l’acqua potabile. L’ordinanza sulla protezione delle acque stabilisce che un prodotto fitosanitario organico può essere presente in un litro d’acqua nella misura di 0,000’000’1 grammi, ossia di 0,1 ppb.Sono comunque fatti salvi altri valori,segnatamente quelli stabiliti nella procedura di omologazione sulla base di valutazioni scientifiche.Per l’acqua potabile,l’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti fissa la stessa concentrazione di 0,1 ppb quale valore di tolleranza per ogni singolo prodotto fitosanitario.Il valore di tolleranza è la concentrazione massima il cui superamento comporta la contaminazione o la diminuzione del valore dell’acqua potabile.Tali valori non sono assodati scientificamente.Si tratta piuttosto di obiettivi di qualità fissati legalmente di cui è necessario garantire il rispetto nella procedura di omologazione.
Le disposizioni indicano che in caso di riscontro di prodotti fitosanitari in concentrazione inferiore al livello di tolleranza di 0,1 ppb non vi è alcun pericolo per ambiente, animali e uomo.Questo è piuttosto il risultato di metodi di misurazione analitici incredibilmente sensibili e la rilevabilità non è sinonimo di pericolo.Lo stesso dicasi per le concentrazioni comprese fra il valore di tolleranza legale e il limite fissato scientificamente.Il diritto svizzero prevede per questi casi che l’autorità stabilisca tipo e entità della contaminazione e che vengano adottati i provvedimenti necessari a ristabilire lo stato dell’acqua richiesto dal diritto.

2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 207 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
Infine va fornita una risposta all’interrogativo sull’eventuale pericolo nei casi di superamento della concentrazione scientificamente tollerata.Visto che al momento del calcolo di tale concentrazione vengono tenuti in considerazione grandi coefficienti di sicurezza e inoltre viene ipotizzato un apporto o un’esposizione durante un lungo periodo,anche in questo caso risulta un superamento lieve e occasionale che non comporta pericoli.Vi è tuttavia da temere se viene raggiunta la concentrazione alla quale sono intervenuti i primi effetti negativi in occasione degli studi scientifici.La concentrazione tollerabile è quindi una soglia d’allarme effettiva e giustificata.In questo caso le autorità devono appurarne la causa e adottare i provvedimenti di correzione necessari affinché si possa ristabilire lo stato dell’acqua richiesto dal diritto.
Osservando i rapporti sui rilevamenti di prodotti fitosanitari nei corsi d’acqua svolti lungo gli anni,si constata che nella maggior parte dei casi vengono rilevate concentrazioni inferiori al valore di tolleranza politico-legale di 0,1 ppb,il che significa che non si tratta di casi da contestare a livello scientifico o legale.Molto meno spesso si redigono rapporti su rilevamenti che superano gli 0,1 ppb,ma che sono inferiori alla concentrazione scientificamente tollerabile.In questi casi sono stati e vengono adottati i provvedimenti richiesti dalla legge;ad esempio è limitato l’uso dell’erbicida Atrazin nella maiscoltura e proibito per le traversine dei binari del treno,i bordi stradali nelle regioni carsiche e nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2).
In alcuni casi rari,nei quali i prodotti fitosanitari hanno provocato veri danni all’ecosistema acquatico, è emerso che erano dovuti all’applicazione non conforme alle prescrizioni o all’impiego inadeguato.A titolo di esempio si possono citare incidenti,avarie o impiego inadeguato di resti di poltiglia per irrorazione.
In generale si può osservare che,in Svizzera,le severe esigenze imposte per l’omologazione di prodotti fitosanitari assicurano,insieme alle disposizioni del diritto concernente la protezione delle acque,un’alta qualità dell’acqua segnatamente di quella potabile.
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
208
■ La legislazione zootecnica svizzera riconosciuta dall’UE
2.3.4Allevamento di animali
Nel quadro dei negoziati bilaterali è stato stabilito che la legislazione zootecnica svizzera adempie tutte le esigenze e le direttive fissate dall’UE.Dall’entrata in vigore degli accordi le federazioni d’allevamento svizzere sono equiparate a quelle dell’UE. Ciò comporta,fra le altre cose,il riconoscimento reciproco dei certificati d’ascendenza e con esso la semplificazione del traffico di animali fra Svizzera e UE.
■ Importazione ed esportazione di animali da allevamento e di sperma
La domanda di razze bovine e sperma di provenienza estera è,tuttora,importante. Mentre negli ultimi anni l’importazione di razze di bestiame minuto era diminuita,la domanda di cavalli riproduttori è rimasta stabile.Al contrario del contingente doganale di bovini riproduttori,quelli di equini,suini,ovini e caprini non sono stati esauriti.Per il contingente doganale del bando di vendita all’asta dell’anno oggetto del rapporto pari a 800 bovini riproduttori sono state inoltrate oltre 3’000 offerte.
L’esportazione di animali da allevamento riacquista importanza.Nel 2003,circa 5’500 bovini da allevamento delle razze pezzata,svittese e holstein sono stati esportati in Germania,Francia,Inghilterra,Spagna,Bosnia,Kossovo,Polonia e Irlanda.

2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■
209
Ogni anno in Svizzera vengono prodotte circa 900 tonnellate di lana di pecora.La domanda insoddisfacente di lana grezza e i bassi prezzi di mercato determinano la quasi impossibilità,per gli allevatori di ovini,di realizzare un valore aggiunto dalla vendita della lana.La corretta valorizzazione è divenuta quindi un problema.La lana di pecora viene sempre più smaltita come scarto o in modi inquinanti.Il sostegno della Confederazione costituisce una base importante affinché la lana di pecora,prodotto naturale pregiato,possa essere valorizzata in modo adeguato e sostenibile dal profilo economico,ecologico ed etico.Anche gli allevatori di ovini e gli addetti alla trasformazione devono intraprendere grandi sforzi per la valorizzazione della lana di pecora indigena,quali la realizzazione di progetti innovativi o il marketing accorto di prodotti di lana indigena.
In virtù del nuovo articolo 51bis della LAgr la Confederazione verserà contributi per la raccolta,la cernita,la pressatura,lo stoccaggio e la commercializzazione della lana indigena.Inoltre potranno essere promossi con contributi anche progetti innovativi di allevatori di ovini e addetti alla trasformazione della lana per la valorizzazione della lana indigena in Svizzera.Per tali provvedimenti,a partire dal 2004 la Confederazione stanzierà annualmente un contributo di 800’000 franchi.

210 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Valorizzazione della lana di pecora indigena
2.5 Ulteriore sviluppo della politica agricola
Nel 2004 hanno iniziato ad essere applicate le modifiche di legge varate dal Parlamento nel giugno 2003 nel quadro della Politica agricola 2007.Gli elementi fondamentali sono la decisione relativa all’abbandono del contingentamento lattiero nel 2009 e l’introduzione della vendita all’asta dei contingenti per l’importazione di carne entro il 2007.Il 26 novembre 2003 il Consiglio federale ha decretato le relative disposizioni d’esecuzione.
Anche dopo il 2007 l’agricoltura svizzera dovrà confrontarsi con altre sfide.Nel 2007 il mercato caseario sarà completamente aperto all’UE e la conclusione del prossimo ciclo di negoziati dell’OMC (Doha Round) potrebbe portare con sé un’ulteriore riduzione della protezione alla frontiera.La Politica agricola 2011 è finalizzata a creare le condizioni affinché l’agricoltura e il settore alimentare nel loro insieme possano affrontare le sfide future.
2.5 ULTERIORE SVILUPPO DELLA POLITICA AGRICOLA 2 214
■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Approntamento della Politica agricola 2011 2002200320042005200620072008200920102011 Basi costituzionali (art. 104 Cost.) Politica agricola 2011 Politica agricola 2002 Direttrici -> Revisione parziale LAgr + crediti quadro 08-11 Ulteriori negoziati con l’EU Accordi agricoli OMC Doha Accordi agricoli UE (Accordi bilaterali I) Politica agricola 2007 Rapporto lattiero Negoziati OMC
La fase preparatoria della Politica agricola 2011 è in pieno svolgimento.I seguenti elementi rivestono una particolare valenza.
– L’articolo sull’agricoltura della Costituzione federale (art.104) continua incontestabilmente ad essere il cardine della politica agricola futura.
Si deve partire dal presupposto che dal Doha Round dell’OMC scaturirà un’ulteriore riduzione della protezione alla frontiera,del sostegno interno al mercato e dei sussidi all’esportazione (cfr.parte 3.1).L’applicazione degli impegni assunti nel quadro dei negoziati di Doha sarà avviata presumibilmente tra il 2008 e il 2011 e durerà per un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni. È probabile che nel momento in cui si dovrà elaborare e dibattere la Politica agricola 2011 non saranno ancora disponibili i risultati definitivi dei negoziati dell’OMC.Lo saranno soltanto in una fase molto avanzata del dibattito.
– Il Programma di sgravio 04 proposto dal Consiglio federale prevede per il 2008 un risparmio nel quadro delle finanze federali pari a 1,5 miliardi di franchi circa,di cui 130 milioni da applicare nel settore dell’agricoltura.Il programma di sgravio dovrebbe essere effettivo già a partire dal 2006.In ambito agricolo,la prevista soppressione del rimborso dell'imposizione degli oli minerali dovrebbe comportare un risparmio diretto pari a 70 milioni di franchi.I restanti 60 milioni di franchi saranno recuperati nel quadro del sostegno al mercato,dei crediti d’investimento, degli aiuti alla conduzione aziendale e dei contributi per l’esportazione di prodotti trasformati.I tagli non interesseranno i pagamenti diretti.
Onde garantire un passaggio ordinato ad un disciplinamento del mercato lattiero che non prevede più il contingentamento lattiero,con la Politica agricola 2007 il Parlamento ha introdotto nella legge sull’agricoltura alcune disposizioni transitorie limitate al 2012.Ha pure incaricato il Consiglio federale di presentare entro il 2006 un rapporto informativo sul disciplinamento del mercato lattiero e sulle misure d’accompagnamento previste dopo l’abbandono del contingentamento lattiero. Affinché agricoltori,organizzazioni e associazioni possano essere informati per tempo sulle future condizioni quadro,il Consiglio federale presenterà questo rapporto al Parlamento già nella primavera 2005.
2.5 ULTERIORE SVILUPPO DELLA POLITICA AGRICOLA 2 215
–
–
Il processo e le discussioni concernenti l’ulteriore sviluppo della politica agricola devono essere gestiti per quanto possibile in maniera aperta e trasparente.Le cerchie interessate devono pertanto essere coinvolte ampiamente e per tempo.
– La Commissione consultiva Agricoltura,istituita dal Consiglio federale per il periodo 2004–2007,ha avviato i propri lavori sotto la direzione del nuovo presidente,il Consigliere di Stato Christian Wanner (SO).Si è posta l’obiettivo di elaborare le direttrici per l’agricoltura svizzera,le quali serviranno per impostare la strategia e la struttura concreta dei provvedimenti.
– Nel «Forum dei produttori» sono rappresentate oltre 20 organizzazioni specializzate del primario.A scadenze periodiche si svolgono incontri con rappresentanti dell’UFAG.In tale sede vengono discussi principalmente gli adeguamenti d’ordinanza a breve termine.Quest’anno nel Forum dei produttori sono state discusse anche le possibilità di applicazione dei mandati di risparmio (PS04).
– In una cosiddetta «assemblea popolare» l’UFAG informa semestralmente tutte le cerchie del mondo agricolo e politico interessate sullo stato della Politica agricola 2011.
216 2.5 ULTERIORE SVILUPPO DELLA POLITICA AGRICOLA 2
■ Processo più trasparente 20042005 3456789101112123456789 Consultaz. Indagine conoscitiva Assemblea popolare Forum dei produttori Forum dei produttori Forum dei produttori Assemblea popolare Politica agricola 2011 Direttrici agricoltura 2015 Rapporto lattiero O / Preventivo 2005 / PS 04

3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 3.Aspetti internazionali 217
L’ampliamento delle relazioni commerciali internazionali riguarda vieppiù l’agricoltura. Essa,infatti,è stata inglobata nella normativa internazionale dell’OMC.Dal punto di vista della concentrazione geografica del commercio agricolo,gli accordi con l’UE e la progressiva integrazione nel panorama europeo rivestono un notevole significato per la Svizzera.
Al fine di mantenere ed ampliare le proprie possibilità di esportazione,la Svizzera necessita di un accesso ai mercati esteri possibilmente libero.Inoltre,essa si impegna notevolmente a livello internazionale affinché gli accordi internazionali tengano maggiormente in considerazione la multifunzionalità dell’agricoltura.
Il Rapporto agricolo tiene conto di questi sviluppi sul piano internazionale,trattandone gli aspetti principali nel terzo capitolo.
–La parte 3.1 contiene informazioni sullo stato attuale nel fascicolo Europa e sui negoziati dell’OMC nonché sul seminario concernente la multifunzionalità svoltosi nel settembre 2004 in Svizzera.
–Nella parte 3.2 vengono effettuati confronti sul piano internazionale.Nel presente rapporto si prosegue con i confronti tra prezzi a livello internazionale,già avviati nel 2000.
3.ASPETTI INTERNAZIONALI 3 218
3.1 Sviluppi sul piano internazionale
Gli sviluppi politici a livello internazionale procedono a ritmi differenziati.Benché influiscano sull’evoluzione della politica agricola elvetica,per la Svizzera le possibilità di imporsi sono limitate.Contro le aspettative di alcuni osservatori,nel periodo oggetto del rapporto non si è trovato un accordo su un’ulteriore fase di liberalizzazione né in riferimento all’apertura del mercato nel quadro degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE né in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
–La richiesta,attesa da tempo,da parte dell’UE di ampliare il campo d’applicazione dell’accordo bilaterale è stata rinviata dalla Commissione UE che ha dato la priorità alle richieste dei Paesi dell’Est entrati recentemente nell’UE.Questi hanno chiesto il mantenimento delle preferenze tariffali che la Svizzera aveva loro accordato nel quadro di otto accordi agricoli bilaterali.Quale contropartita,è stato possibile ottenere dall’UE alcune concessioni per le materie prime ed i prodotti agricoli trasformati svizzeri.
–La Conferenza dei ministri dell’OMC tenutasi a Cancun nel settembre 2003 non è servita ad appianare le divergenze d’opinione in merito al fascicolo agricolo. Tuttavia,il buon esito del ciclo di negoziati dell’OMC avviati nel novembre 2001 in occasione della Conferenza dei ministri di Doha dipende dalla possibilità di trovare un consenso anche sul fascicolo agricolo.
Di seguito vengono illustrati i due fascicoli internazionali che rivestono una particolare valenza per l’agricoltura svizzera.Gli altri avvenimenti possono essere riassunti nella maniera seguente.
–La riforma della Politica agricola comune (PAC),decisa il 26 giugno 2003,comprende essenzialmente i seguenti aspetti:versamento di contributi individuali non vincolati alla produzione,bensì a prescrizioni in materia di protezione dell’ambiente, sicurezza delle derrate alimentari,salute e benessere degli animali nonché alla condizione che tutte le superfici agricole siano gestite in modo rispettoso dal profilo agronomico e biologico («cross compliance»);politica di maggior sviluppo agricolo con un incremento dei mezzi finanziari e nuove misure di promozione per l’ambiente,la qualità e il benessere degli animali;riduzione progressiva dei pagamenti diretti («modulazione») per il finanziamento della nuova politica di sviluppo delle aree rurali.Nell’ambito della politica di mercato sono stati decisi tagli asimmetrici dei prezzi nel settore lattiero (riduzione del prezzo d’intervento del 25 per cento in quattro anni per il burro e del 15 per cento in tre anni per il latte scremato in polvere) nonché il dimezzamento dei supplementi mensili nel settore cerealicolo,nel quale è stato mantenuto il prezzo d’intervento.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 219 ■■■■■■■■■■■■■■■■
3.ASPETTIINTERNAZIONALI
–Nel quadro degli Accordi bilaterali 2,congiuntamente con l’UE,ha potuto essere varato il Protocollo 2 dell’Accordo del 1972 sul libero scambio che è stato ampliato e che concerne i prodotti agricoli trasformati.Le novità introdotte riguardano:
– semplificazione del meccanismo di compensazione dei prezzi: l’UE abolisce completamente i propri dazi e sussidi alle esportazioni,mentre la Svizzera provvede a ridurre ed eventualmente a sopprimere i suoi;
– estensione del campo d’applicazione: il campo d’applicazione di questo meccanismo di compensazione,che prevede la riduzione di dazi e sussidi alle esportazioni,viene esteso ad altri prodotti.
Gli esportatori svizzeri ottengono accesso,esente da dazio,ad un mercato che conta 450 milioni di consumatori.L’estensione ad altri prodotti aumenta di un terzo circa i volumi commerciali stabiliti dal Protocollo 2.Le possibilità di esportazione della nostra industria alimentare risultano migliori,il che va a beneficio anche dei produttori svizzeri di materie prime agricole.
–Con il Cile è stato sottoscritto un nuovo accordo di libero scambio dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).Nel 2004 sono stati portati a termine i negoziati con Libano e Tunisia.Entrambi gli accordi sono stati siglati in occasione della Conferenza dei ministri tenutasi nel giugno 2004.Sono in corso altre trattative con Egitto e Paesi membri della SACU (unione doganale per l’Africa del Sud,di cui fanno parte Botswana,Namibia,Lesotho,Repubblica sudafricana e Swaziland).Gli accordi di libero scambio garantiscono all’industria e a determinati settori del terziario svizzeri un accesso al mercato a condizioni comparabili con quelle dei loro concorrenti nell’UE.Per le materie prime agricole sono state fatte concessioni in accordi bilaterali agricoli separati.Questi negoziati hanno lo scopo di continuare a tutelare l’agricoltura svizzera senza fare concessioni per i prodotti sensibili.Inoltre consentono di raggiungere condizioni d’importazione più favorevoli anche per i prodotti agricoli svizzeri d’esportazione.
–Quest’anno l’OCSE ha effettuato una nuova stima dei mezzi finanziari versati da consumatori e contribuenti a favore dell’agricoltura.L’indicatore principale è il valore PSE (Producer Support Estimate),attraverso il quale viene rilevato il reddito delle aziende agricole,compresa la quota della protezione alla frontiera.Secondo i calcoli dell’OCSE,nel 2003 il PSE della Svizzera ammontava al 74 per cento.Con questo valore,stabile rispetto al 2002,la Svizzera risulta nuovamente al primo posto davanti a Norvegia (72%),Islanda (70%),Corea (60%) e Giappone (58%).Il PSE dell’UE è stato del 37 per cento,segnando una lieve crescita rispetto al 2002.Le singole componenti del PSE consentono pure di illustrare gli effetti delle riforme agrarie nazionali e l’evoluzione dei vari provvedimenti.Nel 2003 in Svizzera il 66 per cento del sostegno globale era rappresentato dal sostegno al mercato (compr.protezione alla frontiera),contro il 90 per cento toccato negli anni 1986–88.

3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 220
■ Sviluppi
Accordo agricolo Svizzera – UE
L’accordo del 21 giugno 1999 tra UE e Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) è entrato in vigore il 1°giugno 2002.Esso mira a migliorare il reciproco accesso al mercato per i prodotti agricoli attraverso la riduzione di dazi, sussidi alle esportazioni e ostacoli tecnici al commercio;viene riconosciuta l’equiparabilità delle prescrizioni tecniche in materia di protezione fitosanitaria,agricoltura biologica e,parzialmente,quelle in ambito veterinario nonché le norme di qualità per frutta, verdura,eccetera.Fulcro della parte dedicata alla tariffa doganale è la completa e reciproca liberalizzazione del commercio caseario.Dal 1°luglio 2007 il commercio di tutti i tipi di formaggio tra Svizzera e UE avverrà liberamente,ovvero senza limitazioni dei quantitativi,dazi,né aiuti alle esportazioni.
Nel settore della carne spicca la soppressione,da fine 2003,del divieto d’importazione di prodotti svizzeri decretato da Italia ed Austria in relazione alla problematica dell’ESB.I contingenti di carne secca garantiti da entrambe le parti potranno entrare in vigore il 1°gennaio 2005.
In virtù dell’articolo 6 dell’accordo agricolo è stato istituito un Comitato agricolo misto, che si occupa dell’amministrazione e della regolare applicazione dell’accordo.Sotto la presidenza svizzera,il Comitato si è riunito l’11 giugno 2003 a Berna e il 4 dicembre 2003 a Bruxelles.L’accento è stato posto sull’attività dei dieci gruppi di lavoro incaricati di approntare gli adeguamenti e gli aggiornamenti agli allegati dell’accordo. L’aggiornamento si è reso necessario in seguito agli sviluppi del diritto comunitario nonché all’introduzione delle agevolazioni commerciali in virtù dell’articolo 5 dell’accordo,con cui le parti contraenti si impegnano a ridurre ulteriormente gli ostacoli tecnici al commercio.Per assicurare l’equiparabilità tra le norme svizzere e quelle dell’UE nonché il corretto funzionamento dell’accordo,sono state apportate o prospettate modifiche tecniche nei seguenti allegati:allegato 4 (protezione fitosanitaria), allegato 7 (prodotti vitivinicoli),allegato 8 (bevande alcoliche),allegato 9 (prodotti ecologici),allegato 10 (frutta e verdura) nonché allegato 11 (accordo in ambito veterinario).
Un altro tema centrale dei lavori in corso è quello delle indicazioni geografiche.I fascicoli più complessi trattati da questo gruppo riguardano Emmentaler,Raclette e Gruyère.Il gruppo di lavoro «DOC»,istituito dal Comitato e per ora informale, dovrebbe diventare un organo negoziale formale con il compito di stilare una lista delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette attualmente riconosciute reciprocamente.
A seguito dell’allargamento ad Est dell’UE le concessioni fissate nell’ambito degli accordi di libero scambio tra Svizzera e i nuovi Paesi membri sono state estese a tutta l’UE.Quale contropartita l’UE concede alla Svizzera nuovi contingenti a dazio zero di rimonte da ingrasso e cicoria belga.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 221 3.ASPETTIINTERNAZIONALI
■ Lavori in seno al Comitato agricolo misto
■ Clausola evolutiva
La clausola evolutiva contenuta nell’accordo (art.13) consente di ampliare ulteriormente il campo d’applicazione.Con l’accordo agricolo le parti si impegnano «a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli» nonché «ad addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo,su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe».
L’UE ha varato un mandato negoziale che consente alla Commissione di rivolgere richieste alla Svizzera e di intavolare negoziati per nuove concessioni.La stesura di una lista di richieste è stata provvisoriamente rinviata dando priorità all’allargamento ad Est e non dovrebbe essere disponibile prima del 2005.Anche l’agricoltura svizzera,nel frattempo,ha individuato nuove possibilità d’esportazione per numerosi prodotti di cui si dovrebbe tener conto in questi negoziati.
Allargamento dell’UE
Il 1°maggio 2004 sono diventati membri dell’UE dieci Paesi:Estonia,Lituania, Lettonia,Polonia,Repubblica ceca,Slovacchia,Ungheria,Slovenia,la parte greca di Cipro e Malta.Questo allargamento contribuisce in maniera notevole alla sicurezza, alla stabilità e al benessere dell’Europa,ampliando il mercato europeo di 76 milionidi consumatori.
Dal 1°maggio 2004 l’accordo bilaterale agricolo siglato nel 1999 da Svizzera e UE si applica automaticamente anche agli altri dieci Paesi membri.Ciò agevola il commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e questi Paesi mediante una riduzione dei dazi e la soppressione degli ostacoli non tariffali al commercio (equiparazione delle prescrizioni fitosanitarie,delle norme di qualità minime e delle disposizioni in ambito veterinario). Per la Svizzera si aprono nuove opportunità d’esportazione di prodotti agricoli,che per tradizione rappresentano il suo punto di forza.L’accordo,tuttavia,rappresenta una sfida in quanto vengono agevolate anche le importazioni da quei Paesi (soprattutto formaggio prodotto industrialmente e perciò meno caro).
Infine vengono migliorate le condizioni per l’esportazione di prodotti agricoli trasformati (biscotti,cioccolata,ecc.) nei nuovi Paesi dell’UE.Il nuovo già citato Protocollo 2 dell’accordo del 1972 di libero scambio tra Svizzera e UE offre più vantaggi del Protocollo A in vigore tra la Svizzera e i Paesi succitati prima della loro adesione all’UE. In virtù dell’accordo sulla libera circolazione delle persone,dal secondo semestre del 2005,eventualmente anche prima,le persone che risiedono per meno di tre mesi in Svizzera o i prestatori di servizi la cui azienda ha sede sul territorio di uno dei nuovi Paesi membri,non avranno più bisogno di un permesso per esercitare la loro attività in Svizzera.Ciò significa che per l’agricoltura sarà disponibile più manodopera stagionale.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 222
■ Doha Round: rilancio dei negoziati
OMC
Dopo il fallimento della Conferenza dei ministri dell’OMC di Cancun,Messico,tenutasi nel settembre 2003,all’inizio del 2004 i membri dell’OMC hanno deciso di riprendere quanto prima le questioni rimaste sul tappeto.Nella notte del 1°agosto 2004 a Ginevra i membri dell’OMC hanno raggiunto un consenso che consente di proseguire il ciclo di negoziati di Doha.
L’incontro mirava a dare nuovo impulso alle trattative e a prendere le decisioni operative necessarie.Si sono raggiunti accordi quadri («frameworks») in ambito agricolo e per quanto concerne i prodotti industriali.Sono state inoltre avviate trattative sulle agevolazioni commerciali.Per quanto concerne le prestazioni di servizi e gli altri temi dei negoziati è stato dato un nuovo impulso per il proseguimento delle trattative.Infine si è convenuto che la prossima Conferenza ordinaria dei ministri dell’OMC avrà luogo nel dicembre 2005 a Hong Kong.
■ Negoziati in ambito agricolo
Dall’inizio del Doha Round i negoziati agricoli rivestono un’importanza fondamentale. Oggetto delle trattative in atto da marzo 2003 è stata la determinazione del quadro negoziale nei tre ambiti:accesso al mercato,sostegno interno e sussidi alle esportazioni.Si è trattato unicamente di giungere a un’impostazione quadro («framework») e non di trattare aspetti concreti («modalities»),fatte salve due eccezioni nell’ambito del sostegno interno.
Fatta astrazione dei promotori dell’iniziativa sul cotone,a Ginevra si sono riuniti essenzialmente sei gruppi di Paesi membri:UE,USA (entrambi mirano ad un risultato positivo viste le dimissioni dei rispettivi ministri competenti),G-20 con Argentina, Bolivia,Brasile,Cile,Cina,Colombia,Costa Rica,Cuba,Ecuador,Egitto,El Salvador, Guatemala,India,Messico,Pakistan,Perù,Filippine,Sudafrica,Tailandia e Venezuela, Gruppo Cairns con Australia,Argentina,Bolivia,Brasile,Cile,Costa Rica,Guatemala, Indonesia,Canada,Colombia,Malesia,Nuova Zelanda,Paraguay,Filippine,Sudafrica, Tailandia e Uruguay,G-10 con Bulgaria,Islanda,Israele,Giappone,Liechtenstein, Corea,Mauritius,Norvegia,Taiwan e Svizzera quale coordinatrice,nonché un gruppo molto eterogeneo di Paesi meno sviluppati (G-90,tra cui Unione africana e Paesi ACP), la cui preoccupazione principale è la perdita dei propri vantaggi di mercato a causa delle preferenze tariffali.
Siccome l’impostazione quadro relativa a molti settori nasconde le divergenze tra i membri dietro formulazioni vaghe,le trattative che precederanno la Conferenza dei Ministri di Hong Kong saranno intense e complesse.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 223
Rispetto alla proposta rigettata a Cancun,per la Svizzera si profilano essenzialmente dei miglioramenti in quanto l’approccio è più dettagliato e presenta meno zone d’ombra.Il contenuto del «framework» può essere riassunto come segue.
Accesso al mercato
Riduzione dei dazi sostanziale ed armonizzata.I dazi più elevati subiscono una diminuzione maggiore rispetto a quelli più bassi (introduzione di fasce di dazio con la cosiddetta «tiered formula»).Il «capping» (determinazione di un’aliquota massima di dazio per linea tariffale,p.es.100 o 150 per cento del valore della merce ai prezzi del mercato mondiale),richiesto con veemenza dagli USA,ha potuto essere fortemente attenuato rispetto al testo di Cancun (soltanto «verifica»).Ai prodotti sensibili è riservato un trattamento più mite rispetto a quanto previsto dalla formula di riduzione applicata alle singole fasce di dazio.Il prezzo da pagare sarà un certo ampliamento dei contingenti doganali e/o un’ulteriore riduzione dei dazi.
Sostegno interno Riduzione del sostegno vincolato alla produzione.La riduzione sarà consistente nei Paesi con un maggiore sostegno (come nel caso dell’accesso al mercato:riduzione sostanziale ed armonizzata).La proposta di una riduzione globale del sostegno del 60 per cento,che rappresenta il margine di manovra dell’UE,può essere applicata come variante massima.Per gli USA,tuttavia,ciò comporterà qualche difficoltà.Verrà infine introdotto un tetto massimo per il sostegno ad ogni singolo prodotto («product specific capping»).
Sussidi alle esportazioni
Soppressione di tutte le forme di aiuti alle esportazioni (sussidi e crediti all’esportazione con validità superiore ai 180 giorni,alcune pratiche di imprese commerciali statali,alcuni tipi di aiuti alimentari).Il calendario di questo smantellamento andrà fissato nella fase di negoziazione delle modalità (periodo di transizione 5–10 anni).
Valutazione
L’applicazione degli impegni che potrebbero scaturire dal vertice di Doha potrebbe coincidere con la PA 2011.I tempi saranno verosimilmente più lunghi per quanto riguarda la riduzione dei sussidi alle esportazioni.La portata degli effetti,tuttavia, potrebbe essere notevolmente superiore a quella dell’Uruguay Round e richiedere due periodi di riforma per poter essere socialmente sostenibile.
È evidente che le riforme già avviate dovranno essere attuate a ritmo serrato,affinché l’agricoltura svizzera sia all’altezza delle sfide internazionali future,continuando ad adempiere il proprio mandato costituzionale relativamente ad una produzione sostenibile e in grado di soddisfare le esigenze di mercato.A tal scopo,oltre agli sforzi individuali,è indispensabile la collaborazione di tutta la società.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 224
■ Modello OMC dell’UFAG
Nel 2003 l’UFAG,in stretta collaborazione con la categoria,ha rilevato,per ognuna delle 2'246 linee tariffali che nell’OMC rientrano nella categoria «agricoltura»,i prezzi all’ingrosso e quelli di produzione dei prodotti d’importazione.Questi prezzi,i dazi praticati e notificati a Ginevra nonché il valore della produzione agricola dei prodotti direttamente sostituibili sono uno strumento grazie al quale oggi è possibile rispondere ad alcune domande d’importanza vitale per la nostra agricoltura.L’UFAG può confrontare gli effetti delle varie formule di riduzione dei dazi su produzione,prestazioni preliminari e valore aggiunto del settore primario.Inoltre,con una determinata formula è possibile minimizzare le perdite a livello produttivo,designando le voci di tariffa che potrebbero beneficiare delle disposizioni per i prodotti sensibili previste nell’accordo quadro del luglio 2004.
Paesi meno sviluppati
Il Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale a concedere ai Paesi in via di sviluppo preferenze tariffali generali (decreto sulle preferenze tariffali).Con la proroga di tale decreto fino al 2006 verrà verificata anche l’opportunità di sostenere i 49 Paesi meno sviluppati (LDC) senza eccezioni né limitazioni mediante contingenti a dazio zero.
Sono già state attuate due tappe di riduzione.La prima,avviata il 1°gennaio 2002,ha comportato una diminuzione media del 30 per cento dei dazi su tutti i prodotti agricoli, che ammontano ora al 70 per cento della tariffa normale (ordinanza sulle preferenze tariffali).La riduzione dei dazi varia dal 10 al 50 per cento a seconda del grado di sensibilità dei prodotti.Nella seconda tappa,avviata il 1°aprile 2004,i dazi rimanenti sono stati ridotti della metà.Attualmente essi ammontano mediamente al 35 per cento dei dazi normali.
In caso gli effetti delle riduzioni di dazio sugli scambi commerciali andassero a tangere gli interessi economici della Svizzera,il Consiglio federale può modificare o sopprimere le preferenze a condizione che le circostanze lo impongano (clausola di salvaguardia autonoma).Dall’introduzione delle preferenze,tuttavia,non si è ancora ricorsi a tale clausola.

3.ASPETTIINTERNAZIONALI 3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 225
■ Conferenza internazionale sul tema «Agricoltura e contributo alla società»
Multifunzionalità
A Charmey,dall’8 al 10 settembre 2004,si è tenuta la conferenza internazionale intitolata «Agricoltura e contributo alla società»,cui hanno partecipato una sessantina di Paesi,oltre a rappresentanti di istituzioni internazionali quali FAO,OMC,OCSE, numerosi Governi e Amministrazioni come pure cerchie accademiche.
Per la prima volta al mondo,la conferenza ha riunito le differenti tendenze emerse in seno alle principali organizzazioni internazionali interessate nonché correnti di pensiero accademiche.Mentre la FAO lavora sui «ruoli dell’agricoltura»,in seno all’OCSE si parla di «multifunzionalità» e all’OMC di «considerazioni non di ordine commerciale» (NTC’s;Non Trade Concerns).Date le divergenze di vedute dei diversi partecipanti,era illusorio pensare che in questa conferenza si potesse raggiungere un consenso in merito ai contributi dell’agricoltura.Visti i presupposti,erano stati fissati i seguenti obiettivi:
–valutazione del modo in cui vengono percepiti l’evoluzione dell’agricoltura e il relativo contributo alla società da parte delle tre istituzioni precedentemente menzionate e dei Paesi rappresentati.A tal proposito la scelta degli invitati è stata effettuata in modo che il plenum risultasse composto in modo ottimale e rappresentativo delle varie tendenze; –agevolazione del dibattito e degli scambi tra diversi Governi e ambienti universitari onde migliorare la reciproca comprensione dei rispettivi approcci ed esortare i partecipanti ad ampliare le proprie vedute a questo proposito; –analisi della posizione dei consiglieri politici nei confronti degli approcci accademici in materia.
■ Contenuto
Di seguito vengono riassunti i diversi approcci in seno alle istituzioni internazionali.
Obiettivi principaliSfide
Ruoli dell’agricoltura (FAO)
Multifunzionalità
(OCSE) Considerazioni non di ordine commerciale (OMC)
Valutazione dei ruoli dell’agricoltura e della loro importanza nei differenti contesti di sviluppo.
Elaborazione di una terminologia comune per la definizione delle principali questioni politiche e messa a punto di un quadro d’analisi che consenta di attuare politiche agricole ottimali.
Considerazione delle funzioni di ordine non commerciale dell’agricoltura nel quadro dei negoziati.
Identificazione e determinazione dei contributi dell’agricoltura onde far fronte adeguatamente alle diverse sfide.
Attuazione di misure mirate per la fornitura di beni e servizi dell’agricoltura diversi da quelli di base in modo che la distorsione dei mercati sia ridotta al minimo.
Realizzazione degli obiettivi di ordine non commerciale e riduzione al minimo della distorsione dei mercati a livello delle misure.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 226
I lavori della conferenza,strutturati sotto forma di workshops,si sono concentrati sui punti seguenti:
1.fattori esterni ambientali;
2.cultura,agricoltura e percezione;
3.sicurezza alimentare;
4.agricoltura,occupazione e sviluppo delle aree rurali.
Le discussioni del primo workshop (fattori esterni ambientali) hanno mostrato fino a che punto la problematica legata ai fattori esterni in agricoltura ha una dimensione locale e dipendente dalle varie circostanze o caratteristiche regionali o microregionali. Si è dibattuto sulla difficoltà di attuare provvedimenti di macroeconomia per sottolineare l’importanza dell’analisi degli effetti delle politiche o delle misure a livello individuale,familiare o aziendale.Nel complesso,dal dibattito è emerso che si deve ancora ovviare alla mancanza di consigli pratici per valutare i vari programmi e attuare provvedimenti adeguati.
L’espressione coreana «have you eaten your rice today?»,che significa «come stai oggi?»,riassume egregiamente i dibattiti del secondo workshop (cultura,agricoltura e percezione).In effetti,anche in una società moderna come quella coreana,l’importanza delle tradizioni agricole è ancora notevole per quanto concerne l’impatto sulle basi della cultura nazionale.Dalle discussioni è emerso come il ruolo dell’agricoltura venga percepito in molti modi differenti,fortemente legati al livello di sviluppo sociale. La percezione è molto negativa per le popolazioni povere e può essere molto «romantica» – seppur in grado di influenzare sensibilmente l’atteggiamento dei consumatori – nelle società ricche.Inoltre la percezione della popolazione urbana sembra differire notevolmente da quella della popolazione rurale.Tuttavia non si tratta di una nozione statica;infatti la percezione evolve parallelamente allo sviluppo sociale.
Nel quadro del terzo workshop (sicurezza alimentare),lo scambio d’opinioni ha mostrato come la sicurezza alimentare non sia un concetto legato alla multifunzionalità quando riguarda le economie domestiche.Al contrario,a livello nazionale,la produzione indigena può,in certe condizioni,essere un mezzo per garantire questa sicurezza.Dagli interventi e dai commenti dei partecipanti è emersa la varietà degli approcci e delle percezioni in riferimento a tale problematica.In certi casi,si preferisce garantire la sicurezza alimentare attraverso il libero scambio e eventualmente creare scorte per limitare i rischi legati ai periodi di crisi.Si pensa che un livello di sicurezza alimentare sufficiente possa essere garantito soltanto da un commercio internazionale prevedibile,trasporti sicuri e frontiere aperte.In altri casi,la produzione di prodotti di base indigeni in agricoltura resta la componente principale della sicurezza alimentare di un Paese.Anche il livello di sviluppo di un Paese determina la propria scelta strategica in materia.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 227
■ Conclusioni
Il quarto workshop ha trattato delle relazioni tra agricoltura,occupazione e sviluppo delle aree rurali.Per quanto riguarda i Paesi industrializzati,è difficile affermare che l’agricoltura è ancora una componente primaria dello sviluppo rurale.In certe condizioni,può tuttavia risultare essenziale.Infatti,se il primario è forte a livello regionale, la migrazione dalle campagne ai centri urbani è limitata e l’occupazione del territorio è densa.Alla luce di simili considerazioni è evidente che l’agricoltura può rivestire una certa valenza nello sviluppo rurale.La produttività agricola,la capacità di vendere,di adattarsi o ancora il dinamismo delle parti chiamate in causa sono,per contro,fattori da tenere in considerazione affinché il contributo dell’agricoltura allo sviluppo rurale sia sostenibile.Le tavole rotonde hanno anche mostrato l’importanza di eliminare gli ostacoli allo sviluppo (p.es.diritto fondiario) nonché di favorire la diversificazione dell’economia locale,la differenziazione dei prodotti e l’adeguamento strutturale.Se tali condizioni vengono adempiute,l’interazione tra sviluppo rurale ed agricoltura può favorire l’occupazione nelle aree rurali e dunque la rispettiva sostenibilità economica e sociale.
Il seminario ha evidenziato come le sfide chiamino in causa tutte le parti,nonostante gli approcci delle istituzioni internazionali e le politiche agricole nazionali siano divergenti.Le sfide principali sono:
–migliore accesso al mercato per i Paesi in via di sviluppo; –attuazione di misure efficaci affinché l’agricoltura possa servire da motore per lo sviluppo economico e da strumento di contenimento della povertà. –necessità di riformare le politiche agricole per ottenere un buon equilibrio tra libero scambio (principalmente accesso al mercato per gli esportatori molto competitivi) e produzione di beni diversi dai prodotti di base (in caso di «insuccesso del mercato»); –migliore armonizzazione dei concetti d’attuazione di forme di sostegno agricolo adeguate ai diversi contesti,cercando di ridurre al minimo le distorsioni di mercato.
Con la conferenza di Charmey è stato possibile prendere atto dei progressi realizzati nell’analisi e nel dibattito politico.Quest’ultimo è divenuto più obiettivo e meno appassionato di quanto non fosse una decina d’anni fa.I termini utilizzati,infatti,danno meno adito a discussioni che in passato,anche se gli approcci restano divergenti. I legami creatisi a Charmey tra consiglieri politici e mondo accademico incideranno sicuramente in modo positivo su questa evoluzione.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 228
3.2Confronti sul piano internazionale
Perché fare un confronto internazionale?
Il confronto internazionale dei prezzi serve per «conoscersi» meglio.Mette in evidenza la differenza dei costi di produzione tra i Paesi considerati;fa luce sui motivi del turismo degli acquisti e serve a definire i provvedimenti da adottare alla frontiera (dazi doganali e sussidi all’esportazione).Inoltre,questo confronto mostra al contribuente i notevoli sforzi profusi dall’agricoltura svizzera dal profilo della competitività in termini di prezzi.

3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 ■■■■■■■■■■■■■■■■
229
Metodo e definizione
Per effettuare il confronto internazionale dei prezzi ci si è basati su mercati identici, simili o importanti.Ciò presenta tuttavia alcune difficoltà,tra cui la scelta dei prodotti, la disponibilità dei dati,la rilevanza dei singoli parametri,i diversi metodi di produzione e di commercializzazione nonché gli influssi monetari.Per quanto concerne i prezzi utilizzati per il confronto internazionale di cui nel presente capitolo si tratta di:
–valori medi su scala nazionale:i valori minimi e massimi a seconda della regione o della trasformazione dei prodotti (prezzo alla produzione) vengono ignorati;
–parametri:i prodotti (qualità,labels) i presupposti per la commercializzazione (quantità,livello di commercializzazione),i canali di distribuzione e i metodi di calcolo del valore medio si differenziano da Paese a Paese;

–prezzi lordi,ossia: –i prezzi osservati sul mercato (nel quadro della politica agricola adottata dai singoli Paesi).I prezzi alla produzione s’intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto,che tuttavia è inclusa nei prezzi al consumo,in quanto si tratta di un’imposta che dev’essere versata dai consumatori; –i prezzi non sono corretti in base al diverso potere d'acquisto dei singoli Paesi.A tal proposito si rinvia alla pubblicazione:«Prix et salaire.Une comparaison du pouvoir d’achat dans le monde»,UBS,2003 (http://www.ubs.com/1/f/media_ overview/media_switzerland/mediareleases?newsId=60256)
Non si tratta quindi di valori assoluti,bensì di variazioni registrate nel tempo.
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 230
■ Prezzi alla produzione
I ricavi dei produttori derivati dalla vendita di un paniere standard fungono da base di confronto.Il paniere standard è composto dalla produzione media (1998–2000) svizzera di 15 dei 17 prodotti agricoli oggetto del presente confronto internazionale dei prezzi.Le statistiche sui prezzi delle barbabietole da zucchero e della colza praticati negli USA non erano disponibili e pertanto questi prodotti sono stati esclusi dal paniere standard.Il paniere è costituito da 3,2 milioni di tonnellate di latte,2,7 milioni di suini, 35,5 milioni di polli,eccetera.La composizione della produzione svizzera è applicata ai Paesi presi a confronto.
I prezzi dell’UE (UE-4/6) si riferiscono alle quattro nazioni confinanti con la Svizzera.Gli altri due Stati considerati sono i Paesi Bassi e il Belgio.Essi sono presi in considerazione per i prodotti per i quali si raggiungono volumi ragguardevoli di produzione.Il calcolo del prezzo medio per l’UE-4/6 si basa sul volume di produzione del 1995/2001 degli Stati considerati.Questi quattro,rispettivamente sei Paesi presi in esame producono più della metà del volume globale di produzione dei 15 Paesi membri.La composizione del paniere standard ed il peso dell’UE-4/6 sono considerati fissi nel tempo onde evidenziare soltanto le fluttuazioni di prezzo.
Qual è lo stato attuale (2001/03) dei prezzi agricoli svizzeri rispetto all’UE e agli USA?
–Se gli agricoltori dell’UE-4/6 o degli USA avessero prodotto il paniere standard svizzero e lo avessero rivenduto nel 2001/03 a livello nazionale,avrebbero ottenuto circa la metà (risp.il 54 e il 51%) dei ricavi dei loro colleghi svizzeri.
–Tuttavia vi sono differenze tra i singoli Paesi dell’UE.Il ricavo del paniere standard nel periodo osservato rappresenta in Italia il 63 per cento,in Germania il 54 per cento,in Francia il 53 per cento e in Austria il 52 per cento del prezzo del valore svizzero.
–Emergono differenze anche in funzione del prodotto.Nel 2001/03,per i prezzi dei prodotti campicoli quali il frumento (29% del prezzo svizzero),l’orzo (33%),la colza (43%) e le patate (44%) praticati nell’UE-4/6 si sono registrati valori particolarmente bassi.Unica eccezione la barbabietola da zucchero che nell’UE è sottoposta a contingentamento (51%).Il prezzo del latte,prodotto anch’esso contingentato,ha raggiunto un valore abbastanza elevato nell’UE-5 (62%).
–Dal confronto «Paese-prodotto» emergono differenze ancor più marcate.Nel 2000/03 in Francia le pere venivano vendute ad un prezzo pari al 99 per cento di quello svizzero,mentre nel periodo 2001/03 in Austria il prezzo delle carote raggiungeva soltanto il 23 per cento di quello svizzero.
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 231
Tabelle 52–53,pagine A59–A61
Evoluzione dei prezzi alla produzione nell'UE e in Svizzera
Latte (10 kg) Bestiame grosso(kg PM) Vitelli (kg PM) Suini (kg PM) Polli (2 kg PV) Uova (20 pz.) Frumento (10 kg) Orzo (10 kg)
Mais da granella(10 kg)
Barbabietole da zucchero (100 kg)
Patate (20 kg) Colza (5 kg) Mele (10 kg) Pere (10 kg) Carote (10 kg) Cipolle (10 kg)
Pomodori (5 kg)
Paniere standard (mia. fr./anno)
Fonti: UFAG, UST, Banca nazionale svizzera, USC, Eurostat, ZMP, Agreste
Prezzi alla produzione della Svizzera rispetto all'UE
Latte Bestiame grosso Vitelli Suini Polli Uova Frumento Orzo
1990/922001/03
Mais da granella
Barbabietole da zucchero
Patate Colza Mele Pere Carote Cipolle
Pomodori
Paniere standard
Fonti: UFAG, UST, Banca nazionale svizzera, USC, Eurostat, ZMP, Agreste
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 232
CH 1990/92UE 1990/92
CH 2001/03 UE 2001/03 0 16 14 12 10 8 6 4 2
Supplemento
Supplemento
In fr.
0 100 90 80 70 60 40 50 30 20 10
Indice (CH = 100)
I prezzi agricoli svizzeri si avvicinano maggiormente a quelli praticati nell’UE o negli USA?
– Nell’arco di tempo fra il 1990/92 e il 2001/03 si è osservato un calo dei prezzi alla produzione (espressi in franchi svizzeri) per il paniere standard non soltanto in Svizzera (–24%),bensì anche nei Paesi dell’UE (–20%).Il calo dei prezzi nell’UE è riconducibile,oltre che alle riforme agricole,alle fluttuazioni dell'euro che ha perso un buon 16 per cento rispetto al franco svizzero.
– Il divario relativo tra Svizzera e UE nel periodo osservato è diminuito marginalmente. Il prezzo del paniere standard nell’UE ammontava al 51 per cento del prezzo svizzero nel 1990/92 contro l’attuale 54 per cento (2001/03).
– In valori assoluti l’allineamento ai prezzi è ancor più significativo.La differenza fra i prezzi del paniere standard praticati in Svizzera e quelli nei Paesi confinanti ammontava al 49 per cento (3'553 mio.fr.) del prezzo del paniere svizzero nel 1990/92 ed è scesa al 46 per cento (2'545 mio.fr.) nel 2001/03.Ne consegue che il divario, espresso in valori assoluti,tra i prezzi in Svizzera e quelli nell'UE è diminuito.
– Tuttavia vi sono differenze tra i singoli Paesi dell’UE.Nel suddetto arco di tempo,la differenza di prezzi del paniere standard,espressa in valori assoluti, è diminuita soprattutto rispetto alla Francia (–33%),alla Germania (–28%) e all’Italia (–27%), mentre il divario dei prezzi con l’Austria,che è entrata a far parte dell’UE soltanto dal 1° gennaio 1995, è diminuito meno sensibilmente (–7%).
– Emergono differenze anche in funzione del prodotto.Tra gli anni 1990/92 e gli anni 2001/03 il divario,espresso in valori assoluti,tra UE e Svizzera è diminuito soprattutto per quanto concerne colza (–71%),frumento (–42%),uova (–48%) e latte (–39%),mentre la differenza dei prezzi relativi a suini (–15%) e bestiame grosso (–5%) è diminuita lievemente.Nel caso delle cipolle (+97%) il divario è addirittura aumentato.
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 233
1990/92199719981999200020012002 2003 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 100 CHUE-4/6USA
Indice (CH 1990/92 = 100)
Evoluzione dei prezzi alla produzione per il paniere standard
Fonti: UFAG, UST, Banca nazionale svizzera, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, U.S. Department of agriculture
– Negli Stati Uniti,dal 1990/92 si è osservata una tendenza differente.I prezzi alla produzione (espressi in franchi svizzeri) hanno subito un rialzo (+28%) fino al 2001, per poi segnare un ribasso.Nel 2001/03 il prezzo del paniere standard negli USA è ritornato su livelli simili a quelli del periodo di riferimento 1990/92 tuttavia mantenendo una crescita dell’8 per cento.Quest’ultima è riconducibile essenzialmente all’aumento del corso del dollaro rispetto al franco svizzero (+9%) tra i due periodi in osservazione.Se confrontata con il periodo di riferimento (1990/92),la differenza del prezzo del paniere standard rispetto agli USA si è ridotta sia in valori relativi (dal 35% negli anni 1990/92 al 42% dei prezzi svizzeri negli anni 2001/03),sia in valori assoluti (–42%).
Il prezzo è un fattore determinante per la competitività dell’agricoltura svizzera, tuttavia non è l’unico.Qualità,sicurezza e fama dei prodotti,pubblicità,rete di distribuzione,potere di vendita e prestazioni legate ai prodotti sono tutte componenti essenziali per il successo di mercato.

3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 234
■ Prezzi al consumo
Il divario dei prezzi relativi alle derrate alimentari al dettaglio tra la Svizzera e i Paesi in esame è stato calcolato in base ai prezzi di un paniere standard al dettaglio IVA inclusa.Questo paniere standard corrisponde a grandi linee al consumo annuo medio di un abitante della Svizzera (cfr.tabella 10) delle 21 derrate alimentari oggetto del confronto internazionale dei prezzi di cui si parla.Si sottolinea a grandi linee in quanto la categoria della carne di manzo è rappresentata soltanto dall’arrosto di manzo. Il paniere comprende 380 kg o il 91 per cento dei 417 kg di derrate alimentari (vino escluso) consumati annualmente da un abitante della Svizzera.La sua composizione è indicata nel dettaglio in calce alla tabella 55 dell’allegato.
Com’è il caso per i prezzi alla produzione,del gruppo UE-4 fanno parte i Paesi limitrofi, ossia Germania,Francia,Italia e Austria.Per quanto riguarda l’Italia,come base di riferimento sono stati considerati i prezzi relativi alla città di Torino.Per le verdure e laddove non sono disponibili dati dei Paesi confinanti sono state prese in considerazione le cifre del Belgio.Inoltre,in base ai prezzi nazionali minimi e massimi, è stato determinato un valore medio superiore e inferiore relativo ai Paesi UE-4/5.
Il peso dei singoli Paesi UE-4/6 (uscite delle economie domestiche nel 1998) e la composizione del paniere standard sono fissi onde evidenziare soltanto le fluttuazioni di prezzo durante l’anno.
Nel 2001/03 il prezzo al consumo del paniere standard nell’UE ammontava al 62 per cento di quello dello stesso paniere acquistato in Svizzera,a fronte del 54 per cento del suo prezzo alla produzione.I motivi per cui il prezzo al consumo europeo è più elevato rispetto a quello alla produzione possono essere riassunti nella maniera seguente: diversa composizione del paniere standard al consumo da quella del paniere standard alla produzione,influenza delle derrate alimentari importate come pure imposta sul valore aggiunto più elevata nell’UE (circa 7% con variazioni tra Paesi e prodotti) rispetto alla Svizzera (2,4%).
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 235
1990/921997199819992000200120022003 CHMedia superiore UE UE-4/5 0 60 50 40 30 20 10 70 80 90 110 100 Media inferiore UE USA
Tabelle 54–55,pagine A62–A63
Indice (CH 1990/92 = 100)
Evoluzione dei prezzi al consumo per il paniere standard
Fonti: UFAG, UST, ZMP (D), Uffici nazionali di statistica di F, B, A, USA, Ufficio di statistica di Torino (I)
In Svizzera,il prezzo al consumo del paniere standard è rimasto praticamente invariato tra i due periodi in osservazione 1990/92 e 2001/03 mentre nell’UE è stata registrata una diminuzione dell’11 per cento.Di conseguenza,la differenza fra i prezzi praticati in Svizzera e quelli nei Paesi confinanti ammontava al 31 per cento (697 fr.) del prezzo del paniere svizzero nel 1990/92 ed è salita al 38 per cento (873 fr.) nel 2001/03.
Ne consegue che il divario,in termini assoluti,tra i prezzi in Svizzera e quelli nell'UE è cresciuto,registrando una tendenza inversa a quella dei prezzi alla produzione.Questa evoluzione può essere spiegata,in parte,dal rialzo significativo osservato per le label svizzere (Bio,M-7,Coop Natura Plan),segnatamente nel settore della carne.
Le differenze tra i singoli Paesi rimangono comunque enormi.Mentre il prezzo al consumo del latte in Italia (Torino) supera quello svizzero e lo zucchero costa di più nell’UE,il prezzo delle cotolette di maiale è la metà di quello svizzero,poiché nei Paesi UE-4 la carne di maiale proviene in gran parte da allevamenti convenzionali.Il 60 per cento della carne di maiale venduta nei negozi svizzeri nel 2001,invece, è carne label.
Tra i periodi 1990/92 e 2001/03,i prezzi al consumo negli USA sono aumentati del 28 per cento mentre in Svizzera non hanno registrato variazioni di rilievo.Il divario rispetto alla Svizzera è dunque diminuito,passando dal 51 per cento nel 1990/92 al 38 per cento del prezzo svizzero nel 2001/03.Questo incremento è riconducibile al fatto che il dollaro ha guadagnato un buon 9 per cento rispetto al franco svizzero.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 236
3 237
Collaborazione al Rapporto agricolo 2004
■ Direzione del progetto, Werner Harder
segreteria
■ Autori
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Ruolo e situazione dell’agricoltura
L’agricoltura,parte integrante dell’economia
Alessandro Rossi
Mercati
Ursula Gautschi,Simon Hasler,Katja Hinterberger,Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Situazione economica
Vinzenz Jung
Aspetti sociali
Esther Grossenbacher
Ecologia ed etologia
Brigitte Decrausaz,Ruth Badertscher,Anton Candinas,Benedikt Elmiger,Heinz Hänni, Esther Grossenbacher,Deborah Renz
Valutazione della sostenibilità
Vinzenz Jung
■ Provvedimenti di politica agricola
Produzione e smercio
Ursula Gautschi
Strumenti sovrasettoriali
Frédéric Brand,Friedrich Brand,Jean-Marc Chappuis,Emanuel Golder,Samuel Heger
Economia lattiera
Katja Hinterberger
Produzione animale
Simon Hasler
Produzione vegetale
Beat Ryser,Hans-Ulrich Tagmann
Pagamenti diretti
Thomas Maier,Simone Aeschbacher,Hugo Roggo,Olivier Roux,Samuel Vogel
238
Miglioramento delle basi
Miglioramenti strutturali e aiuti per la conduzione aziendale
René Weber,Peter Klaus,Willi Riedo
Ricerca,Istituto di allevamento equino,consulenza, formazione professionale,CIEA
Anton Stöckli,Fabio Cerutti,Jacques Clément,Urs Gantner,Geneviève Gassmann, Roland Stähli
Mezzi di produzione
Lukas Barth,Olivier Félix,Markus Hardegger,Martin Huber,Albrecht Siegenthaler
Allevamento di animali
Karin Wohlfender
Sezione Ispettorato delle finanze
Rolf Enggist
Ulteriore sviluppo della politica agricola
Thomas Meier
■ Aspetti internazionali
Sviluppi sul piano internazionale
Nicole Bays,Christoph Eggenschwiler,Jacques Gerber,Jean Girardin
Confronti sul piano internazionale
Jean Girardin
■ Servizi di traduzione Italiano:Patrizia Singaram,Gisella Crivelli,Simona Stückrad
Tedesco:Yvonne Arnold
Francese:Christiane Bokor,Pierre-Yves Barrelet,Yvan Bourquard, Giovanna Mele,Elisabeth Tschanz,Marie-Thérèse Von Graffenried, Magdalena Zajac
■ Internet Denise Vallotton
■ Assistenza tecnica Hanspeter Leu,Peter Müller
239
240
ALLEGATO A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Allegato Tabelle Strutture A2 Tabelle Mercati A4 Tabelle Risultati economici A14 Conto economico dell’agricoltura A14 Risultati d’esercizio A16 Tabelle Uscite della Confederazione A27 Uscite Produzione e smercio A27 Uscite Promozione dello smercio A27 Uscite Economia lattiera A28 Uscite Produzione animale A29 Uscite Produzione vegetale A30 Uscite Pagamenti diretti A31 Uscite Miglioramento delle basi A52 Uscite Agricoltura e alimentazione A58 Tabelle Aspetti internazionali A59 Atti legislativi,Terminologia e metodi A64 Abbreviazioni A65 Bibliografia A67
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Strutture
Evoluzione delle aziende agricole,della superficie agricola utile e delle unità di bestiame grosso
A2 ALLEGATO
Tabella 1
ClassididimensioniinhaAziendeSuperficieagricolautileUnitàdibestiamegrosso disuperficieagricola utile199019962003199019962003199019962003 NumeroNumeroNumerohahahaNumeroNumeroNumero 0-16 6295 0542 9792 8952 1231 05382 55054 58856 267 1-313 1907 1134 13923 82812 6147 60734 46622 52214 350 3-58 2596 9264 49532 24327 00417 96342 47334 35523 675 5-1018 83315 14811 725141 403113 65488 437209 784156 778113 828 10-1518 92015 90712 487233 888197 421155 382341 563273 225206 007 15-2012 71011 97010 590218 771207 194183 671290 523268 163234 776 20-256 6777 2487 155147 772161 294159 381173 896187 984192 345 25-303 3644 1434 61391 271112 886125 91597 680120 265138 037 30-402 6743 6694 50590 726124 930153 71087 709119 097157 969 40-508751 3511 71138 67259 90475 87532 21450 95669 636 50-705077281 10828 84941 22663 77223 17232 76153 325 70-10012716627710 37113 28722 3257 4149 49017 882 > 1005056827 8029 33911 9646 3156 0058 931 Totale928157947965866106849010828761067055142975913361891287028 Fonte:UST
Evoluzione del numero di persone occupate nell'agricoltura CategoriaOccupatiatempopienoOccupatiatempoparzialeTotale 199019962003199019962003199019962003 CapiaziendaUomini62 72059 56046 73926 16920 83122 74288 88980 39169 481 Donne1 4561 5055592 4701 3751 9583 9262 8802 517 Altri membri della famigliaUomini21 79613 8287 85022 72925 11818 52444 52538 94626 374 Donne14 36722 04313 42565 77036 63445 88680 13758 67759 311 ManodoperafamiliareTotale10033996936685731171388395889110217477180894157683 Manodopera extrafamigliare,svizzeriUomini12 45311 43510 1732 9496 1884 62415 40217 62314 797 Donne3 2002 8512 3873 3044 9763 9486 5047 8276 335 Manodopera extrafamigliare,stranieriUomini10 9108 7267 6691 7584 9492 97112 66813 67510 640 Donne6631 5281 7148473 6022 0101 5105 1303 724 ManodoperaextrafamiliareTotale27226245402194388581971513553360844425535496 PersoneoccupateTotale12756512147690516125996103673102663253561225149193179 Fonte:UST
Tabelle 2
Tabella 3
Conto della produzione nei settori a monte e a valle del primario (in base al CEA)
ALLEGATO A3
2001p NOGASettoriVPLPPQuota2001VAL1 Settoriamonte 10-14Industria mineraria ed estrazione di materiali lapidei e terra1 8071 0820.022016 15-16Fabbricazione di derrate alimentari e generi voluttuari27 15619 4120.0357276 20Industria del legno e dei prodotti in legno 6 0733 4780.022057 23-24Industria chimica,trasformazione degli oli minerali39 11527 0710.0526633 26Fabbricazione di altri prodotti da minerali non metalliferi4 4822 6780.022040 27Produzione e trasformazione di metalli4 7883 2910.022033 28Fabbricazione di prodotti in metallo16 6128 9020.0220170 29Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici30 80019 2590.0337389 40-41Approvvigionamento in energia e acqua26 23816 1830.0220221 45Edilizia 42 60321 2100.0220471 51Intermediari del commercio e commercio all'ingrosso 37 94812 9630.00049 52Commercio al dettaglio,riparazione di oggetti d'uso31 53510 4630.0159335 55Industria alberghiera21 08810 0630.0141155 60-62Trasporti terrestri,acquatici ed aerei20 60812 7090.0188148 65Intermediazione finanziaria66 51518 3960.02901 395 66Assicurazioni 27 75816 3980.0290329 71+74Noleggio beni mobili,servizi per imprese43 00615 1930.0286795 72Informatica 13 0905 9220.0220158 73Ricerca e sviluppo2 8621 7830.022024 75Pubblica amministrazione,assicurazioni sociali pubbliche74 68421 0420.02761 482 80Istruzione 7 7842 9080.009446 85Sanità e assistenza sociale27 9268 6010.0086166 91-92Organizzazioni associative,attività culturali e sportive11 4116 8110.010749 Totalesettoriamonte7397 01CEAAgricoltura1024358200.00004424 Settoriavalle 0141BServizi connessi alla produzione orticola1 6627470.3887356 15-16Fabbricazione di derrate alimentari e generi voluttuari27 15619 4120.96437 468 17Industria tessile2 9071 8090.032936 19Industria del cuoio e delle calzature3782530.04255 51Intermediari del commercio e commercio all'ingrosso37 94812 9630.17664 413 52Commercio al dettaglio,riparazione di oggetti d'uso31 53510 4630.38758 166 Totalesettoriavalle20444 Totaledelvaloreaggiuntonelsettorealimentare32264 p = provvisorio VPL = valore di produzione lordo PP = prestazioni preliminari VAL = valore aggiunto lordo 1 Quota dei settori a monte e a valle dell'agricoltura rispetto al valore aggiunto lordo totale
Fonte:UST
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Mercati
A4 ALLEGATO
Tabella
Prodotto1990/9220012002200311990/92–2001/03 hahahaha% Cereali207292179576173482166846-16.4 Cerealipanificabili102840950189530388640-9.6 Frumento96 17389 68289 34584 449-8.7 Spelta2 1602 0192 1491 766-8.4 Farro,piccola spelta 2 138181Segale4 4323 2843 6281 990-22.0 Miscele di cereali panificabili75334325446.7 Cerealidaforaggio104453845587817978206-23.1 Orzo59 69543 84539 16139 392-31.7 Avena10 4343 9234 0354 424-60.4 Miscele di cereali da foraggio23824439734438.0 Mais da granella25 73924 32920 50621 128-14.6 Triticale8 34712 21714 08012 91856.6 Leguminose225832754375540392.7 Piselli da foraggio (proteici)2 1122 9243 9894 99187.9 Favette146300308311109.3 Lupini-5178101Sarchiate36385340733384033029-7.5 Patate (comprese quelle da semina)18 33313 78513 46013 579-25.8 Barbabietole da zucchero14 30817 75718 17517 54524.6 Barbabietole da foraggio3 7442 5312 2051 905-40.9 Semioleosi1820317005209682288911.4 Colza16 73012 01914 24714 883-18.0 Girasole-4 5795 1145 478Soia1 4744071 6072 5282.7 Materieprimerinnovabili-124311751233Colza-1 1161 0631 123Altre (kenaf,canapa,ecc.)-127112110Verdureinpienocampo82508390861984592.9 Maisverdeedasilo382044126840202403886.3 Maggeseverdeefiorito3193514415242001141.2 Altra superficie coltiva aperta8301 8771 8021 834121.3 Superficiecoltivaaperta311741290221288615284281-7.7 Pratiartificiali9443611854411897812266527.1 Altra superficie coltiva3 9772 7883 0902 985-25.7 Totalesuperficiecoltiva4101544115534106834099310.1 Frutticoltura7 1626 8956 7996 584-5.6 Viticoltura14 91915 08615 01414 9290.6 Miscanthus sinensis32552492398 155.6 Prati naturali,pascoli638 900627 338627 059626 446-1.9 Altra utilizzazione nonché strame e torba7 39410 00311 4448 92636.9 Superficieagricolautile1078600107113010697701067055-0.9 1 Dati provvisori 2 Registrazione separata dal 2002 Fonti:USC,UST,Vino:UFAG
4 Superficie agricola utile secondo le forme di utilizzazione
1 Media degli anni 1990/93
2 Variazione 1990/93–2000/03
e latticini:USC (1990–98),dal 1999 TSM
e semi oleosi:USC,tutte le quantità 2003 provvisorie
svizzera frutta
svizzera dell'orticoltura Vino:UFAG,Cantoni
ALLEGATO A5 Tabella
Produzione ProdottoUnità1990/922001200220031990/92–2001/03 % Latteelatticini Latte di consumot549 810505 048503 325494 635-8.9 Pannat68 13367 99768 87363 997-1.7 Burrot38 76641 90442 22640 8577.5 Latte in polveret35 84444 52754 56955 53643.8 Formaggiot134 400172 218160 403160 16522.2 Carneeuova Carne di manzot PM130 710102 824104 808102 789-20.8 Carne di vitellot PM36 65635 03634 95134 127-5.3 Carne suinat PM266 360234 298235 736229 658-12.4 Carne ovinat PM5 0655 9045 9306 17818.5 Carne caprinat PM541572481475-5.8 Carne equinat PM1 2121 1381 0901 031-10.4 Pollamet peso di vendita20 73328 70331 19632 35848.3 Uova in gusciomio.di pezzi6386807036807.8 Cereali Grano tenerot546 733496 200508 500426 300-12.8 Segalet22 97818 60021 50010 200-27.0 Orzot341 774245 200247 200218 100-30.7 Avenat52 80719 80021 50021 600-60.3 Mais da granellat211 047217 600189 00090 800-21.4 Triticalet43 94071 30089 80067 90073.7 Altrit11 46910 70011 30010 300-6.1 Sarchiate Patatet750 000518 000526 200468 000-32.8 Barbabietole da zuccherot925 8671 050 1991 407 9101 258 71433.8 Semioleosi Colzat46 11439 36750 34344 400-3.1 Altrit3 65813 03020 30023 000413.3 Frutta(datavola) Melet91 503 1 94 963105 64093 8648.8 2 Peret-14 39715 08316 529Albicocchet3 407 1 4001 850845-56.4 2 Cilieget1 818 1 1 2872 0451 704-0.4 2 Prugnet2 837 1 1 8592 2143 228-14.8 2 Fragolet4 2635 1014 9805 10918.8 Verdure(fresche) Carotet49 16250 09067 94254 08016.7 Cipollet23 50524 20126 81027 93912.0 Sedano rapat8 50610 65110 3349 59819.8 Pomodorit21 83030 60629 65730 05037.9 Lattuga cappucciot18 82115 39917 05716 114-14.0 Cavolfioret8 3316 1476 5735 591-26.7 Cetriolit8 6088 8399 2589 1455.5 Vino Vino rossohl550 276570 164546 595486 455-2.9 Vino biancohl764 525603 725565 804483 639-27.9
5
Latte
Uova:GalloSuisse Cereali,sarchiate
Frutta:Associazione
Verdura:Centrale
Fonti:
Carne:Proviande
A6 ALLEGATO
Produzione di latticini Prodotto1990/922001200220031990/92–2001/03 tttt% Totaleformaggio13440017221816040316016522.2 Formaggio fresco4 38735 90936 48637 101732.0 Mozzarella-12 13612 90613 321Altro formaggio fresco-23 77323 58023 780Formaggio a pasta molle4 8126 9786 9496 77943.4 Tomme1 2491 0381 9131 88929.2 Formaggio a crosta fiorita,da semigrasso a grasso1 5732 3771 8481 64124.3 Altri formaggi a pasta molle1 9903 5633 1883 24967.5 Formaggio a pasta semidura40 55648 16447 43546 65016.9 Appenzeller8 7258 7907 9128 061-5.4 Tilsiter7 7366 1675 9775 201-25.3 Formaggio per raclette9 89814 26514 13913 25640.3 Altro formaggio a pasta semidura14 19718 94219 40720 13237.3 Formaggio a pasta dura84 62980 52468 88168 927-14.0 Emmentaler56 58845 65735 53234 632-31.8 Gruyère22 46427 04124 96525 70815.3 Sbrinz4 6593 0412 4752 147-45.2 Altro formaggio a pasta dura9184 7855 9096 440522.1 Prodotti speciali 1 156436527084 351.1 Totaleprodottiabasedilattefresco6808227088517054807128344.1 Latte di consumo549 810505 048503 325494 635-8.9 Altri131 012203 802202 155218 19958.8 Totaleburro387664190442226408577.5 Burro speciale27 2007 5167 6437 213-72.6 Altro11 56634 38834 58333 644195.7 Totalepanna68133679976887363997-1.7 Totalelatteinpolvere3584444527545695553643.8 1 Formaggio di solo latte di pecora o di capra Fonti:USC (1990–98),dal 1999 TSM Tabella 7 Valorizzazione del latte commercializzato Prodotto1990/922001200220031990/92–2001/03 1000tlatte1000tlatte1000tlatte1000tlatte% Lattediconsumo549461456454-16.8 Lattetrasformato24902749273526999.5 in formaggio1 5311 4201 2981 295-12.6 in burro35646550649637.4 in panna430259263247-40.4 in altri latticini173605667661272.4 Totale30393209319131524.8 Fonti:USC (1990–98),dal 1999 TSM
Tabella
6
Tabella 8
Valorizzazione del raccolto della produzione vegetale
1 Media degli anni 1990/93
2 Variazione 1990/93–2000/03
Fonti: Patate:Regia federale degli alcol,swisspatat Frutta da sidro:UFAG;bevande contenenti alcol di distillazione:Regia federale degli alcol Verdure per la trasformazione:Centrale svizzera dell'orticoltura
ALLEGATO A7
Prodotto1990/922001200220031990/92–2001/03 tttt% Patate Patate da tavola285 300173 500167 400162 800-41.1 Patate destinate alla trasformazione114 700130 200131 400116 1009.8 Patate da semina35 93327 60028 40027 200-22.8 Somministrazione allo stato fresco agli animali225 967114 000123 000106 400-49.3 Trasformazione in alimenti per animali146 90063 40068 50050 400-58.6 Meleeperesvizzeredasidro (trasformazioneinstabilimentiartigianali)183006197556131861122032-17.02 Quantitativo di frutta da sidro per succo grezzo182 424 1 97 252131 745121 845-16.8 2 fresco da torchio10 477 1 7 9399 90511 039-10.5 2 sidro per la fabbricazione di acquavite3 297 1 6478722-87.3 2 succo concentrato165 263 1 87 553118 005109 044-15.1 2 altri succhi (compreso l'aceto)3 387 1 1 6963 7571 040-50.3 2 Frutta pigiata582 1 304116187-65.0 2 Fabbricazionedibevandecontenenti alcoldidistillazione di mele e pere svizzere40 255 1 21 22917 05619 772-47.6 2 di ciliege e prugne svizzere23 474 1 11 04810 85812 834-48.3 2 Verduresvizzerefrescheperlafabbricazione diderratealimentari Verdure congelate26 06124 10525 15826 474-3.1 Verdure da conserva (fagiolini,piselli,carote parigine)19 77615 11112 94012 585-31.5 Crauti8 0915 8126 5345 315-27.2 Rape1 5351 0591 0011 003-33.5
A8 ALLEGATO
Commercio esterno Prodotto1990/922001200220031990/92–2001/03 tttt% Esporta-Importa-Esporta-Importa-Esporta-Importa-Esporta-Importa-Esporta-Importazionizionizionizionizionizionizionizionizionizioni Latteelatticini Latte1923 007622 9022722 83911822 303164.9-1.4 Yogurt1 195173 9811513 80819210 642718414.11 980.4 Panna909256772245693491 062882-15.41 840.0 Burro04 15455 5291 3061 9826531 7510.0-25.7 Latte in polvere8 1583 2664 90578416 16883719 05440964.0-79.3 Formaggio62 48327 32853 09931 24549 90731 18749 59731 866-18.615.0 Carne,uovaepesce Carne di manzo2807 8738305 8979696 8321 0437 474238.3-14.5 Carne di vitello0916045205670395--48.5 Carne suina2881 9565066 9661768 6139011 567-10.6362.6 Carne ovina56 48906 45806 53706 465-100.00.0 Carne caprina0403026803550389--16.3 Carne equina04 60004 37804 05103 945--10.3 Pollame1039 94222344 54338743 70866345 9714 143.312.0 Uova031 401025 411025 5041524 850--19.6 Pesci,crostacei e molluschi62031 1325937 09713234 39512934 647-82.813.6 Cereali Frumento6232 13472259 413126295 55028313 8121 081.624.8 Segale03 05702 79408 52102 066-45.9 Orzo43644 504332 7503048 7541737 985-96.2-10.5 Avena13160 885352 0321753 513646 858-93.4-16.6 Mais da granella19460 51228116 23649539 819307121 80286.0-2.0 Sarchiate Patate9 6958 7221 54622 9951 56526 64293733 381-86.1217.3 Zucchero40 882124 065158 427168 915168 357208 693218 282245 503344.467.4 Semioleosi Semi oleosi489134 57059479 65157971 21264272 03723.7-44.8 Oli e grassi vegetali18 68057 7651 94297 0221 912103 5282 090108 686-89.478.4 Frutta(fresca) Mele683 1 12 169 1 2 2277 5159059 9731 8707 72696.4 2 -29.4 2 Pere491 1 11 803 1 1679 057949 095759 135-75.7 2 -25.6 2 Albicocche226 1 10 578 1 59 661179 456218 179-88.3 2 -13.5 2 Ciliege256 1 1 062 1 01 16211 2514868-97.4 2 3.9 2 Prugne e susine12 1 3 290 1 15 92795 233225 484-33.2 2 59.7 2 Fragole15011 0232510 5431911 602710 944-88.70.1 Uva2333 6911641 162534 293935 601-57.19.9 Agrumi161135 78037126 50875121 69934125 582-69.8-8.2 Banane8577 896073 429374 326474 327-97.2-5.0 Verdure(fresche) Carote711 71007 590586 53807 197-72.8315.6 Cipolle8623 44416 6681517 87205 778-94.196.7 Sedano rapa0206022071902450.059.3 Pomodori40235 700743 4422641 513740 922-96.717.5 Lattuga cappuccio373 954102 88902 27012 443-90.0-35.9 Cavolfiore119 98508 84509 09608 669-100.0-11.2 Cetrioli6517 4793716 728417 184516 660-76.3-3.6 Vino Vino rosso (in hl)3 4991 494 2947 3591 421 0514 9261 370 0517 0161 409 87983.9-6.3 Vino bianco (in hl)7 59076 8356 095225 2146 721240 7646 474196 793-15.3187.5 1 Media degli anni 1990/93 2 Variazione 1990/93–2000/03 Fonti: Latte e latticini,uova,cereali,sarchiate,semi oleosi,frutta,verdura e vino:DGD Zucchero:réservesuisse
Tabella 9
Tabella 10
Commercio esterno di formaggio
1 0406.1010,0406.1020,406.1090
2 0406.2010,0406.2090
3 0406.3010,0406.3090
4 0406.4010,0406.4021,0406.4029,0406.4081,0406.4089
5 0406.9011,0406.9019
6 0406.9021,0406.9031,0406.9051,0406.9091
7 0406.9039,0406.9059,0406.9060,0406.9099
ALLEGATO A9
Prodotto1990/922001200220031990/92–2001/03 tttt% Importazioni Formaggio fresco 1 4 1758 6168 8259 187112.6 Formaggio grattugiato 2 233342605634126.2 Formaggio fuso 3 2 2212 4152 2972 2494.5 Formaggio a crosta fiorita 4 2 2762 3742 2432 167-0.6 Formaggio a pasta molle 5 6 6285 8085 7215 796-12.9 Formaggio a pasta semidura 6 11 795 4 3504 2344 772 Formaggio a pasta dura 7 7 3407 2627 061 -1.1 Totaleformaggioericotta2732831245311873186615.0 Esportazioni Formaggio fresco 1 24384522 883.3 Formaggio grattugiato 2 104739471-23.7 Formaggio fuso 3 8 2455 1474 6094 431-42.6 Formaggio a crosta fiorita 4 071180.0 Formaggio a pasta molle 5 30109154175386.7 Formaggio a pasta semidura 6 54 102 7 7537 2987 124 Formaggio a pasta dura 7 39 96737 65837 736 -15.3 Totaleformaggioericotta62483530994990749597-18.6
Fonte:DGD
A10 ALLEGATO Tabella 11 Consumo pro capite Prodotto1990/9220012002200311990/92–2001/03 kgkgkgkg% Latteelatticini Latte di consumo104.3784.4083.4081.40-20.4 Panna6.436.609.208.4025.5 Burro6.206.005.705.60-7.0 Formaggio16.9019.9019.6019.9017.2 Formaggio fresco3.466.005.906.1073.4 Formaggio a pasta molle1.831.901.901.903.8 Formaggio a pasta semidura5.655.805.805.702.1 Formaggio a pasta dura5.966.206.006.202.9 Carneeuova Carne di manzo13.719.7310.6410.15-25.8 Carne di vitello4.253.763.763.67-12.2 Carne suina29.7325.2725.4825.15-14.9 Carne ovina1.421.531.461.474.7 Carne caprina0.120.100.100.10-16.7 Carne equina0.750.670.620.60-16.0 Pollame8.059.629.7110.0921.8 Uova in guscio (pz.)199188190183-6.0 Cereali Pane e prodotti da forno50.7050.5051.0050.00-0.4 Sarchiate Patate e prodotti di patate44.1743.7843.0843.00-2.0 Zucchero (compreso lo zucchero nei prodotti trasformati)42.3746.8348.2948.0012.6 Semioleosi Oli e grassi vegetali12.8014.1715.9816.0020.2 Frutta(datavola) Mele15.26 2 13.9215.7113.53-3.7 3 Pere-3.233.303.47Albicocche2.04 2 1.401.551.22-28.3 3 Ciliege0.39 2 0.340.450.352.6 3 Prugne e susine0.91 2 1.081.021.1815.8 3 Fragole2.242.172.272.18-1.5 Agrumi20.0917.5716.6617.03-15.0 Banane11.5310.2010.1810.08-11.9 Verdure(fresche) Carote7.538.0110.198.3117.4 Cipolle3.864.294.734.5717.2 Sedano rapa1.291.481.511.3411.8 Pomodori8.4610.289.759.6316.8 Lattuga cappuccio3.372.542.652.52-23.7 Cavolfiore2.712.082.151.93-24.3 Cetrioli2.972.792.902.77-5.1 Vino Vino rosso (in l)31.9728.6027.4327.12-13.3 Vino bianco (in l)14.4712.4012.2511.66-16.3 Totale vino (in l)46.4341.0039.6838.78-14.2 1 Dati in parte provvisori 2 Media degli anni 1990/93 3 Variazione 1990/93–2000/03 Fonti: Latte e latticini,uova,sarchiate,cereali e semi oleosi:USC Carne:Proviande Frutta,verdura e vino:UFAG
1 Media degli anni 1990/93
2 Variazione 1990/93–2000/03
3 Pagamento residuo non considerato,il prezzo effettivo è del 10–15% superiore
4 Stima
Fonti:
Latte:UFAG
Bestiame da macello,pollame,uova:USC
Cereali,sarchiate e semi oleosi:Agroscope FAT Tänikon
Frutta:Associazione svizzera frutta,Interprofession des fruits et légumes du Valais
Verdure:Centrale svizzera dell'orticoltura
ALLEGATO A11 Tabella 12 Prezzi alla produzione ProdottoUnità1990/922001200220031990/92–2001/03 % Latte Totale Svizzeracts./kg104.9779.9078.3975.54-25.7 Latte trasformato in formaggio (solo dal 1999) cts./kg-79.7378.5675.16Latte biologico (solo dal 1999)cts./kg-95.3293.1789.21Bestiamedamacello Vacche T3fr./kg PM7.824.534.465.78-37.0 Giovani vacche T3fr./kg PM8.135.625.496.48-27.9 Torelli T3fr./kg PM9.286.857.238.19-20.0 Buoi T3fr./kg PM9.836.506.928.18-26.7 Manzi T3fr./kg PM8.666.616.897.89-17.7 Vitelli T3fr./kg PM14.3912.0311.7712.15-16.7 Suini da carnefr./kg PM5.834.544.244.47-24.2 Agnelli fino a 40 kg T3fr./kg PM15.4012.3812.6111.53-21.0 Pollameeuova Polli cl.I,dalla fattoriafr./kg PV3.722.762.722.72-26.5 Uova d'allevamento al suolo,a negozifr./100 pz.41.0240.9835.4636.00-8.6 Uova d'allevamento in libertà,a negozifr./100 pz.46.2147.0549.1942.670.2 Uova vendute ai centri di raccolta >53 gfr./100 pz.33.2923.1223.4423.44-29.9 Cereali Frumentofr./100 kg99.3455.6556.6361.13-41.8 Segalefr./100 kg102.3650.9147.2246.76-52.8 Orzofr./100 kg70.2445.0844.8845.82-35.6 Avenafr./100 kg71.4045.2245.1647.84-35.5 Triticalefr./100 kg70.6946.3345.9045.49-35.1 Mais da granellafr./100 kg73.5443.3345.1746.31-38.9 Sarchiate Patatefr./100 kg38.5535.1534.9436.21-8.1 Barbabietole da zuccherofr./100 kg14.8413.3011.6411.87-17.3 Semioleosi Colzafr./100 kg203.6779.57 3 78.56 3 81.69 3 -60.7 Girasolefr./100 kg-81.64 3 84.59 3 85.73 3Frutta Mele:Golden Delicious Ifr./kg1.12 1 1.040.821.21-12.3 2 Mele:Maigold Ifr./kg1.35 1 1.160.951.40-17.8 2 Pere:Conférencefr./kg1.33 1 1.170.921.24-20.9 2 Albicocchefr./kg2.09 1 3.692.102.8028.7 2 Ciliegefr./kg3.20 1 3.503.403.406.3 2 Prugne:Fellenbergfr./kg1.40 1 1.851.951.7025.0 2 Fragolefr./kg4.775.504.805.409.8 Verdure Carote (scorte)fr./kg1.091.201.281.3416.8 Cipolle (scorte)fr./kg0.891.191.211.2536.7 Cavolo rapa (scorte)fr./kg1.621.722.242.4130.8 Pomodori tondifr./kg2.421.902.322.69-4.8 Lattuga cappucciofr./kg2.373.473.053.6743.3 Cavolfiorefr./kg1.852.082.222.6725.8 Cetriolifr./kg1.662.021.972.2024.5
1 Media degli anni 1990/93
1990/93–2000/03
(paniere con carne label e convenzionale):UFAG
vegetale e prodotti di origine vegetale:UFAG,UST
A12 ALLEGATO Tabella 13 Prezzi al consumo ProdottoUnità1990/922001200220031990/92–2001/03 % Latteelatticini Latte intero,pastorizzato,imballatofr./l1.851.551.561.53-16.4 Latte drink,pastorizzato,imballatofr./l1.851.551.561.53-16.4 Latte scremato UHTfr./l-1.451.451.46Emmentalerfr./kg20.1520.5920.3320.892.2 Gruyèrefr./kg20.4020.3720.8821.021.7 Tilsiterfr./kg-17.7217.7817.86Camembert 45% (grasso s.s.)125 g-2.702.812.86Formaggio a pasta molle,a crosta fiorita150 g-3.513.633.67Mozzarella 45% (grasso s.s.)150 g-2.342.402.34Burro speciale200 g3.463.133.193.19-8.4 Il Burro (burro da cucina)250 g3.443.033.062.99-12.0 Panna intera,imballata 1⁄2 l-4.924.924.80Panna per caffè,imballata 1⁄2 l-2.522.542.48Yogurt,aromatizzato o alla frutta180 g0.890.690.700.70-21.7 Carnebovina Controfiletto,tagliatofr./kg48.3648.1051.1653.395.2 Fettine,nocefr./kg37.5937.4239.6641.735.4 Arrosto,spallafr./kg26.3425.9626.3527.160.6 Carne macinatafr./kg15.0015.4915.6316.656.2 Carnedivitello Costolette,tagliatefr./kg35.3240.4041.4941.3016.3 Arrosto,spallafr./kg32.5633.8634.5035.146.0 Spezzatinofr./kg21.6728.3029.0729.7634.0 Carnesuina Costolette,tagliatefr./kg19.8820.7420.4021.324.7 Fettine,nocefr./kg24.4826.2227.3827.7010.7 Arrosto,spallafr./kg18.4319.3119.3519.905.9 Spezzatino,spallafr./kg16.6918.3418.3419.2211.6 Carned'agnello,indigena,fresca Cosciotto senza osso femoralefr./kg26.3427.7128.6829.488.7 Costolette,tagliatefr./kg30.3234.2335.7537.2817.9 Prodotticarnei Prosciutto cotto di coscia,nello stampo,affettatofr./kg25.5628.4930.2429.9915.7 Salame indigeno I,affettatofr./100 g3.093.813.914.0026.4 Polli Indigeni,freschifr./kg8.419.139.358.908.5 Produzionevegetaleeprodottidioriginevegetale Farina biancafr./kg2.051.671.601.71-19.1 Pane bigiofr./500 g2.081.761.781.81-14.3 Pane semibiancofr./500 g2.091.751.741.80-15.6 Panini al lattefr./pz.0.620.690.710.7414.9 Cornettifr./pz.0.710.830.850.8820.0 Spaghettifr./500 g1.661.651.691.711.4 Patatefr./kg1.432.032.082.1646.2 Zucchero cristallinofr./kg1.651.421.471.59-9.5 Olio di girasolefr./l5.053.753.884.30-21.2 Frutta(indigenaedestera) Mele:Golden Deliciousfr./kg3.15 1 3.413.813.6713.3 2 Perefr./kg3.25 1 3.463.603.698.6 2 Albicocchefr./kg3.93 1 5.545.486.2939.9 2 Ciliegefr./kg7.35 1 10.468.758.9726.1 2 Prugnefr./kg3.42 1 4.043.974.3615.8 2 Fragolefr./kg8.699.9810.4710.9620.5 Verdure(perconsumofresco;indigeneedestere) Carote (scorte)fr./kg1.912.112.092.2612.7 Cipolle (scorte)fr./kg1.862.292.562.3929.8 Sedano rapa (scorte)fr./kg3.143.474.103.9422.2 Pomodori tondifr./kg3.733.213.753.67-5.0 Lattuga cappucciofr./kg4.465.831.691.96-29.1 Cavolfiorefr./kg3.584.154.024.419.4 Cetriolifr./kg2.803.103.604.4532.7
Fonti: Latte,carne
Produzione
2 Variazione
Tabella 14
Grado di autoapprovvigionamento
1 Compresi i prodotti della molitura e i cereali panificabili germogliati,esclusi i panelli oleosi;le variazioni delle scorte non sono state tenute in considerazione
2 Compresi grano duro,avena commestibile,orzo commestibile e granturco
3 Mele,pere,ciliege,prugne,susine,albicocche e pesche
4 Quota della produzione indigena rispetto al peso della carne e dei prodotti carnei pronti per la vendita
5 Compresa la carne equina,caprina,di coniglio e la selvaggina,nonché pesci,crostacei e molluschi
6 Energia assimilabile in Joules,comprese le bevande alcoliche
7 Esclusi i prodotti di origine animale ottenuti a partire da alimenti per animali importati
8 Produzione indigena ai prezzi alla produzione,importazioni ai prezzi della statistica sul commercio (franco frontiera,non sdoganati)
ALLEGATO A13
Prodotto1990/922000200120021990/92–2000/02 Percentualequantitativa:%%%%% Cerealipanificabili 1188910282-36 Cerealidaforaggio1 617669676 Totalecereali264626459-5 Patate da semina1011029394-7 Zucchero4663476115 Grassi e oli vegetali22192020-2 Frutta 3 728071764 Verdura555153561 Lattediconsumo 979797970 Burro 898588989 Formaggio 137116122113-24 Totalelatteelatticini110103107107-3 Carne di vitello 4 979298981 Carne bovina 4 93859689-4 Carne suina 4 99929695-4 Carne ovina 4 393539412 Pollame 4 374340436 Carnedituttiitipi4576687170-6 Uova e conserve di uova444847473 Percentualedienergiaalimentare:6 Derratealimentaridioriginevegetale 434740452 Derratealimentaridiorigineanimalelorde 97919494-3 Totalederratealimentarilorde606258611 Totale derrate alimentari nette 7 58555356-2 Percentualeinvaloretotalederratealimentari872636263-9
Fonte:USC
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Risultati economici
A14 ALLEGATO
Tabella 15 Produzione del settore agricolo,in 1 000 fr. 1990/9220012002200311990/92–200422001/03–2001/032004 %% Prodottiagricoli13089023937378495390559213949-28.498143224.7 Produzionevegetale5915309430392445332654218235-26.447432449.0 Cereali (compr.sementi)1 116 180487 342504 783410 572-58.1462 822-1.0 Frumento543 264261 549279 105242 427-52.0266 3342.0 Orzo306 591100 845102 00589 955-68.293 819-3.9 Mais da granella153 80378 04869 12435 926-60.361 3740.6 Altri cereali112 52246 90054 54942 264-57.441 295-13.8 Piante industriali261 445237 109289 201277 8022.5299 06711.6 Semi e frutti oleosi (compr.sementi)96 23066 99785 49189 906-16.095 80518.6 Piante proteiche (compr.sementi)10 2828 53312 83015 25118.715 46526.7 Tabacco grezzo16 94520 66922 50023 89931.922 200-0.7 Barbabietole da zucchero136 590136 683164 486144 3528.7160 4588.0 Altre piante industriali1 3984 2273 8944 394198.55 13923.2 Piante foraggere1 833 6231 101 8521 199 0951 049 043-39.11 429 50028.0 Mais da foraggio210 597148 75898 194117 426-42.3183 98351.5 Sarchiate da foraggio31 76114 61313 32212 130-58.010 378-22.3 Altre piante foraggere1 591 264938 4811 087 579919 487-38.31 235 13925.8 Prodotti d'orticoltura e floricoltura1 237 6051 281 4691 355 6571 366 7257.81 360 4231.9 Verdura fresca387 355473 530503 967547 38731.2540 8676.4 Piante e fiori850 250807 939851 690819 338-2.8819 556-0.8 Patate (compr.patate da semina)276 669191 807187 636183 077-32.2178 492-4.8 Frutta701 314552 308556 475526 418-22.3582 9146.9 Frutta fresca323 630289 398310 523314 407-5.8338 21811.0 Uva377 683262 910245 952212 011-36.4244 6961.8 Vino465 258430 643418 009385 918-11.5416 0271.1 Altri prodotti di origine vegetale23 21421 39422 40918 680-10.313 999-32.8 Produzioneanimale7173714506986050057904995714-30.050710780.9 Bovini1 743 669924 226951 6511 047 917-44.11 109 15613.8 Suini1 517 1881 082 0471 033 3011 058 263-30.31 083 6962.4 Equini15 0027 8177 8806 524-50.65 937-19.8 Ovini e caprini62 47159 12859 79653 732-7.953 143-7.7 Pollame180 626179 864193 510198 8355.6204 5567.2 Altri animali32 12912 38717 76816 507-51.616 7447.7 Latte3 396 1492 613 8362 546 3602 420 690-25.62 406 693-4.8 Uova211 437180 540188 685183 124-12.9179 692-2.4 Altri prodotti di origine animale15 04510 0156 83910 122-40.211 46127.5 Produzioneprestazioniagricole42519856260355970258188733.65892283.7 Prestazioni agricole425 198525 876523 909545 69125.1552 9004.0 Locazione di contingenti lattieri036 72735 79336 196-36 3280.2 Produzioneagricola135142219936387100987579795836-26.4104035504.6 Attivitàaccessorienonagricole(nonseparabili)355464306987281826256835-20.7274373-2.7 Trasformazione di prodotti agricoli276 878179 999183 406160 515-36.9171 008-2.1 Altre attività accessorie non separabili (beni e servizi)78 586126 98898 42096 32036.5103 365-3.6 Produzionedelsettoreagricolo13869686102433741038058310052671-26.3106779234.4 1Dati provvisori,stato 13.9.2004 2 Stima,stato 13.9.2004 Fonte:UST
ALLEGATO A15 Tabella 16 Conto economico dell'agricoltura ai prezzi correnti,in 1 000 fr. 1990/9220012002200311990/92–200422001/03–2001/032004 %% Produzionedelsettoreagricolo13869686102433741038058310052671-26.3106779234.4 Totaleprestazionipreliminari6627403581979960101796032961-10.263136986.0 Sementi e materiale vegetale346 577314 429313 900318 882-8.9320 2131.4 Energia,lubrificanti334 723393 964378 790389 12915.7396 5032.4 Concimi e sostanze ammendanti250 334146 534154 738153 176-39.5157 1513.7 Prodotti fitosanitari e per la lotta agli organismi nocivi138 587138 178131 820127 863-4.3132 7110.1 Veterinario e medicamenti156 121163 674159 764162 8253.8163 5740.9 Alimenti per animali3 654 3542 585 2082 758 8942 682 394-26.82 914 0298.9 Manutenzione di macchine e apparecchiature353 833394 031420 431432 39617.5440 7176.0 Manutenzione di impianti agricoli119 443154 043158 219184 94538.8187 44413.1 Prestazioni di servizio agricole425 198562 603559 702581 88733.6589 2283.7 Altri beni e servizi848 232967 135973 921999 46415.61 012 1283.3 Valoreaggiuntolordoaiprezziallaproduzione7242283442357543704044019710-41.043642252.2 Ammortamenti2 014 6341 917 2281 924 6541 922 888-4.61 944 2861.2 Attrezzature1 013 2171 015 3331 027 0011 034 4791.21 057 6843.1 Edifici915 779792 918783 177771 642-14.5766 352-2.1 Impianti82 09598 45498 40898 97420.199 5280.9 Altro3 54310 52316 06817 793317.620 72240.1 Valoreaggiuntonettoaiprezziallaproduzione5227649250634724457502096822-55.124199393.0 Imposte sulla produzione43 606327 542328 174335 131657.4338 2622.4 Sovvenzioni (non vincolate ai prodotti)878 2112 609 4202 708 7972 706 800204.62 741 4092.5 Redditodeifattori6062254478822548263734468491-22.648230862.7 Costo della manodopera1 233 8401 138 1581 124 6881 135 511-8.21 138 1840.5 Eccedenzaaziendalenetta/ redditoindipendente4828414365006737016853332980-26.236849023.5 Canoni d'affitto192 569201 995202 526200 6604.8201 178-0.3 Interessi pagati552 714391 143393 038342 276-32.1331 175-11.8 Redditosettorialenetto34083131305692931061212790044-26.931525495.6 1Dati provvisori,stato 13.09.2004 2 Stima,stato 13.09.2004 3 Nella bibliografia e nel metodo Eurostat viene indicato come utile aziendale nettoFonte:UST
Tabella 17
Risultati d’esercizio:tutte le regioni
(Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF294653441027417274203335612.1 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)Fonte:Agroscope
A16 ALLEGATO
CaratteristicaUnità1990/9220002001200220032000/02–2003 % Aziende di riferimentoNumero4 302 3 419 3 067 2 379 2 663 -9.9 Aziende rappresentateNumero62 921 53 896 52 470 51 421 50 516 -4.0 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha16.06 18.78 19.10 19.38 19.10 0.1 Superficie coltiva apertaha4.90 5.17 5.17 5.25 4.76 -8.4 Manodopera aziendaleULA1.88 1.70 1.68 1.65 1.62 -3.4 di cui:manodopera familiareULAF1.39 1.30 1.29 1.28 1.24 -3.9 Totale vaccheNumero12.9 13.5 14.0 13.9 13.6 -1.4 Totale animaliUBG23.2 23.8 24.7 24.6 22.9 -6.0 Strutturadelcapitale Totale attivifr.606 321 716 645 732 058 734 566 749 781 3.0 di cui:attivo circolantefr.116 932 144 196 140 469 133 572 133 220 -4.4 di cui:inventario vivofr.60 662 44 706 45 448 43 507 46 012 3.3 di cui:attivo immobilizzatofr.428 727 527 743 546 141 557 487 570 549 4.9 di cui:attivo aziendafr.558 933 662 417 680 487 692 767 702 760 3.6 Quota di capitale di terzi%43 41 41 41 43 4.9 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.19 808 15 193 13 319 12 880 10 383 -24.7 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.184 762 199 145 192 972 194 365 203 189 3.9 di cui:pagamenti direttifr.13 594 39 307 43 162 45 630 47 046 10.2 Spese materialifr.91 735 108 460 114 173 117 279 123 272 8.8 Reddito aziendalefr.93 027 90 685 78 799 77 086 79 917 -2.8 Costo della manodopera salariatafr.13 775 12 369 12 097 11 661 11 978 -0.5 Interessi passivifr.11 361 8 001 8 492 8 411 7 309 -12.0 Canoni d'affittofr.5 069 5 640 5 776 5 514 5 601 -0.8 Costi di terzifr.121 941 134 470 140 539 142 865 148 160 6.4 Reddito agricolofr.62 822 64 675 52 434 51 500 55 029 -2.1 Reddito accessoriofr.16 264 19 208 18 633 18 577 21 210 12.8 Reddito totalefr.79 086 83 883 71 067 70 077 76 238 1.6 Consumo della famigliafr.59 573 62 650 63 779 63 237 62 896 -0.5 Formazione del capitale propriofr.19 513 21 233 7 288 6 840 13 343 13.2 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.46 914 44 964 47 469 43 695 47 580 4.9 Cash flow 3 fr.44 456 46 043 39 389 41 177 45 285 7.3 Rapporto cash flow-investimenti 4 %95 102 83 94 95 2.2 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %66 67 60 66 69 7.3 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %52 52 42 41 45 0.0 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %26 25 17 18 23 15.0 Aziende con reddito insufficiente 8 %10 12 22 22 17 -8.9 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 11 19 20 15 -10.0 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA49 473 53 426 47 027 46 648 49 356 0.7 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha5 796 4 829 4 125 3 977 4 185 -2.9 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%16.7 13.7 11.6 11.1 11.4 -6.0 Redditività Redditività del capitale totale 10 %0.8 -0.6 -2.7 -2.9 -2.3 11.3 Redditività del capitale proprio 11 %-2.2 -3.2 -6.8 -7.0 -5.9 4.1 Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF31025380993035630262358869.1
FAT Tänikon
Tabella 18
Risultati d’esercizio:regione di pianura*
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione di pianura:zona campicola più zone intermedie
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
ALLEGATO A17
CaratteristicaUnità1990/9220002001200220032000/02–2003 % Aziende di riferimentoNumero2 356 1 517 1 376 1 006 1 219 -6.2 Aziende rappresentateNumero29 677 25 094 24 183 23 072 22 533 -6.6 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha16.66 19.41 19.93 20.68 19.79 -1.1 Superficie coltiva apertaha8.34 9.13 9.26 9.82 8.77 -6.7 Manodopera aziendaleULA2.05 1.80 1.77 1.78 1.68 -5.8 di cui:manodopera familiareULAF1.36 1.26 1.26 1.25 1.19 -5.3 Totale vaccheNumero12.8 13.3 13.8 13.8 13.7 0.5 Totale animaliUBG22.9 23.5 24.7 25.1 23.7 -3.0 Strutturadelcapitale Totale attivifr.706 406 814 917 832 078 852 833 849 670 2.0 di cui:attivo circolantefr.149 871 179 657 172 076 168 801 160 321 -7.6 di cui:inventario vivofr.61 461 44 637 45 969 44 560 46 513 3.2 di cui:attivo immobilizzatofr.495 074 590 623 614 033 639 472 642 837 4.6 di cui:attivo aziendafr.642 757 746 171 773 158 797 415 793 919 2.8 Quota di capitale di terzi%41 39 40 41 43 7.5 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.23 633 17 549 15 362 14 923 11 760 -26.2 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.225 249 242 054 233 144 242 450 247 188 3.3 di cui:pagamenti direttifr.7 248 32 944 38 399 40 791 40 265 7.7 Spese materialifr.110 193 129 262 135 711 143 609 150 032 10.2 Reddito aziendalefr.115 056 112 792 97 433 98 841 97 157 -5.7 Costo della manodopera salariatafr.20 784 18 330 17 349 17 799 16 905 -5.2 Interessi passivifr.13 463 9 051 9 835 10 147 8 717 -9.9 Canoni d'affittofr.7 015 7 673 7 796 7 493 7 405 -3.3 Costi di terzifr.151 456 164 316 170 690 179 048 183 059 6.8 Reddito agricolofr.73 794 77 738 62 453 63 402 64 129 -5.5 Reddito accessoriofr.16 429 17 805 17 043 16 743 20 642 20.0 Reddito totalefr.90 223 95 543 79 496 80 145 84 771 -0.3 Consumo della famigliafr.67 985 69 756 70 993 71 999 70 092 -1.2 Formazione del capitale propriofr.22 238 25 787 8 503 8 146 14 679 3.8 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.56 951 52 271 52 828 50 533 51 053 -1.6 Cash flow 3 fr.52 079 53 548 45 267 47 438 51 149 4.9 Rapporto cash flow-investimenti 4 %92 102 86 94 100 6.4 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %64 69 61 65 68 4.6 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %52 54 42 41 43 -5.8 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %24 23 17 15 23 25.5 Aziende con reddito insufficiente 8 %12 13 23 23 18 -8.5 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 10 18 21 16 -2.0 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA56 050 62 635 55 134 55 395 57 708 0.0 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha6 908 5 810 4 889 4 779 4 909 -4.9 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%17.9 15.1 12.6 12.4 12.2 -8.7 Redditività Redditività del capitale totale 10 %2.1 0.9 -1.3 -1.3 -1.0 76.5 Redditività del capitale proprio 11 %0.0 -0.5 -4.4 -4.4 -3.7 19.4 Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF36924478913752338758439486.2 (Valore medio) Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF361864456134671358554260211.1 (Valore mediano)
Tabella 19
Risultati d’esercizio:regione collinare*
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione collinare:zona collinare e zona di montagna I
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
A18 ALLEGATO
CaratteristicaUnità1990/9220002001200220032000/02–2003 % Aziende di riferimentoNumero1 125 1 017 907 698 745 -14.8 Aziende rappresentateNumero17 397 14 588 14 343 13 946 14 062 -1.6 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha15.30 17.83 17.95 18.09 18.48 2.9 Superficie coltiva apertaha3.08 3.15 3.04 2.85 2.82 -6.4 Manodopera aziendaleULA 1.81 1.62 1.60 1.54 1.58 -0.4 di cui:manodopera familiareULAF1.40 1.29 1.26 1.24 1.26 -0.3 Totale vaccheNumero14.4 15.3 15.8 16.0 15.0 -4.5 Totale animaliUBG26.0 27.0 27.8 27.9 24.8 -10.0 Strutturadelcapitale Totale attivifr.553 876 677 784 686 002 685 062 716 978 5.0 di cui:attivo circolantefr.95 672 122 136 122 814 110 023 117 869 -0.4 di cui:inventario vivofr.66 366 49 901 49 611 48 151 49 785 1.1 di cui:attivo immobilizzatofr.391 838 505 747 513 577 526 888 549 325 6.6 di cui:attivo aziendafr.516 933 626 182 628 230 650 611 674 799 6.3 Quota di capitale di terzi%46 45 44 44 45 1.5 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.17 271 13 318 11 653 11 650 9 549 -21.8 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.170 201 183 249 178 588 179 713 186 427 3.3 di cui:pagamenti direttifr.15 415 39 135 41 649 43 917 46 494 11.9 Spese materialifr.85 602 102 222 108 086 111 844 113 382 5.6 Reddito aziendalefr.84 599 81 027 70 502 67 870 73 045 -0.1 Costo della manodopera salariatafr.9 943 9 183 9 655 8 446 9 488 4.3 Interessi passivifr.10 915 8 330 8 265 8 045 7 120 -13.3 Canoni d'affittofr.3 903 4 789 5 086 5 121 4 996 -0.1 Costi di terzifr.110 363 124 525 131 092 133 456 134 985 4.1 Reddito agricolofr.59 838 58 725 47 496 46 257 51 442 1.2 Reddito accessoriofr.14 544 21 814 20 557 19 369 21 671 5.3 Reddito totalefr.74 382 80 539 68 053 65 626 73 114 2.4 Consumo della famigliafr.55 272 59 963 61 333 60 218 59 442 -1.8 Formazione del capitale propriofr.19 110 20 576 6 720 5 408 13 672 25.4 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.41 428 39 674 47 007 40 781 54 334 27.9 Cash flow 3 fr.41 445 43 650 37 263 39 152 43 742 9.3 Rapporto cash flow-investimenti 4 %100 110 79 96 81 -14.7 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %68 68 58 68 69 6.7 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %50 50 43 39 44 0.0 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %30 31 19 20 26 11.4 Aziende con reddito insufficiente 8 %8 8 18 22 15 -6.3 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 11 20 20 15 -11.8 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA 46 654 50 119 44 191 44 049 46 211 0.2 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha5 533 4 545 3 927 3 753 3 954 -3.0 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%16.4 12.9 11.2 10.4 10.8 -6.1 Redditività Redditività del capitale totale 10 %0.4 -1.1 -3.3 -3.5 -3.0 13.9 Redditività del capitale proprio 11 %-3.3 -4.5 -8.4 -8.5 -7.5 5.1 Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF30335353362845827817332098.8 (Valore medio) Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF29520331562660425797308118.0 (Valore mediano)
Tabella 20
Risultati d’esercizio:regione di montagna*
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione di montagna:zone di montagna II a IV Fonte:Agroscope FAT Tänikon
ALLEGATO A19
CaratteristicaUnità1990/9220002001200220032000/02–2003 % Aziende di riferimentoNumero821 885 784 675 699 -10.5 Aziende rappresentateNumero15 847 14 214 13 944 14 403 13 921 -1.9 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha15.76 18.63 18.85 18.55 18.60 -0.4 Superficie coltiva apertaha0.44 0.28 0.26 0.25 0.24 -8.9 Manodopera aziendaleULA1.63 1.60 1.60 1.55 1.55 -2.1 di cui:manodopera familiareULAF1.42 1.39 1.38 1.35 1.31 -4.6 Totale vaccheNumero11.4 11.8 12.4 11.8 11.9 -0.8 Totale animaliUBG20.5 21.0 21.5 20.6 19.6 -6.8 Strutturadelcapitale Totale attivifr.476 486 583 036 605 967 593 049 621 232 4.6 di cui:attivo circolantefr.78 573 104 230 103 814 99 941 104 862 2.1 di cui:inventario vivofr.52 902 39 497 40 263 37 323 41 392 6.1 di cui:attivo immobilizzatofr.345 011 439 309 461 890 455 785 474 979 5.0 di cui:attivo aziendafr.448 089 551 742 573 520 565 949 583 451 3.5 Quota di capitale di terzi%45 40 40 40 41 2.5 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.15 432 12 957 11 491 10 798 8 997 -23.4 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.124 931 139 707 138 099 131 524 148 901 9.1 di cui:pagamenti direttifr.23 476 50 719 52 979 55 041 58 581 10.7 Spese materialifr.63 905 78 140 83 081 80 364 89 948 11.7 Reddito aziendalefr.61 026 61 567 55 018 51 161 58 952 5.4 Costo della manodopera salariatafr.4 860 5 116 5 500 4 940 6 518 25.7 Interessi passivifr.7 918 5 808 6 397 5 984 5 221 -13.9 Canoni d'affittofr.2 707 2 922 2 986 2 725 3 292 14.4 Costi di terzifr.79 390 91 986 97 964 94 013 104 979 10.9 Reddito agricolofr.45 541 47 721 40 135 37 512 43 921 5.1 Reddito accessoriofr.17 853 19 011 19 414 20 748 21 662 9.8 Reddito totalefr.63 394 66 732 59 549 58 260 65 583 6.6 Consumo della famigliafr.48 548 52 865 53 783 52 126 54 736 3.4 Formazione del capitale propriofr.14 846 13 867 5 766 6 133 10 847 26.3 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.34 138 37 494 38 648 35 562 35 138 -5.6 Cash flow 3 fr.33 482 35 247 31 384 33 108 37 352 12.3 Rapporto cash flow-investimenti 4 %98 94 81 93 106 18.7 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %70 65 60 66 71 11.5 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %54 51 41 42 49 9.7 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %26 23 16 19 20 3.4 Aziende con reddito insufficiente 8 %8 14 25 21 17 -15.0 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 12 18 18 14 -12.5 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA37 418 38 532 34 399 33 018 37 936 7.4 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha3 874 3 304 2 919 2 758 3 170 5.9 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%13.6 11.2 9.6 9.0 10.1 1.7 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.3 -3.8 -5.1 -5.7 -4.4 -9.6 Redditività del capitale proprio 11 %-7.4 -8.2 -10.5 -11.4 -9.0 -10.3 Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF212012506420809198162663121.6 (Valore medio) Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF207072285118484183552481724.7 (Valore mediano)
Tabella 21a
Risultati d’esercizio secondo i tipi di azienda* – 2001/03
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
* Nuova tipologia aziendale FAT99
A20 ALLEGATO
ProduzionevegetaleDetenzionedianimali Mediadi CaratteristicaUnitàtutteleCampi-ColtureLatteVaccheAltri aziendecolturaspecialicommercialemadribovini AAziende di riferimentoNumero2 703 99 64 1 108 75 146 Aziende rappresentateNumero51 469 3 193 2 897 18 399 1 950 3 744 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha19.19 23.89 12.72 18.86 17.62 16.17 Superficie coltiva apertaha5.06 19.57 6.01 0.93 0.85 0.20 Manodopera aziendaleULA1.65 1.42 2.15 1.62 1.26 1.41 di cui:manodopera familiareULAF1.27 1.09 1.29 1.33 1.09 1.25 Totale vaccheNumero13.8 3.1 1.8 16.8 15.3 9.0 Totale animaliUBG24.0 7.6 3.3 24.7 19.0 16.5 Strutturadelcapitale Totale attivifr.738 802 758 395 764 596 678 477 661 575 549 146 di cui:attivo circolantefr.135 754 160 540 227 645 115 105 112 823 94 183 di cui:inventario vivofr.44 989 15 291 8 408 46 449 41 682 36 717 di cui:attivo immobilizzatofr.558 059 582 564 528 543 516 923 507 070 418 246 di cui:attivo aziendafr.692 004 711 002 699 986 637 899 627 325 512 710 Quota di capitale di terzi%42 38 34 42 43 42 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.12 194 13 353 14 055 11 078 11 044 9 022 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.196 842 221 892 235 014 166 024 129 145 117 006 di cui:pagamenti direttifr.45 280 46 814 25 569 45 680 58 341 56 498 Spese materialifr.118 241 126 473 124 096 97 266 75 654 73 171 Reddito aziendalefr.78 601 95 419 110 918 68 759 53 490 43 835 Costo della manodopera salariatafr.11 912 11 135 33 829 8 172 4 659 3 851 Interessi passivifr.8 071 8 725 7 117 7 287 6 890 5 303 Canoni d'affittofr5 631 9 047 6 074 4 832 3 202 2 390 Costi di terzifr.143 854 155 381 171 116 117 558 90 405 84 716 Reddito agricolofr.52 988 66 511 63 898 48 466 38 740 32 290 Reddito accessoriofr.19 473 21 974 18 874 18 224 31 455 21 886 Reddito totalefr.72 461 88 485 82 773 66 690 70 194 54 176 Consumo della famigliafr.63 304 76 741 74 235 58 088 59 540 51 086 Formazione del capitale propriofr.9 157 11 744 8 537 8 602 10 654 3 090 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.46 248 40 783 38 540 43 610 41 594 34 484 Cash flow 3 fr.41 950 47 147 42 813 37 704 38 408 25 812 Rapporto cash flow-investimenti 4 %91 121 116 87 92 76 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %65 66 66 66 65 61 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %43 43 37 43 49 36 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %19 16 19 21 23 18 Aziende con reddito insufficiente 8 %20 22 28 20 15 25 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %18 19 17 16 13 21 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA47 677 66 958 51 903 42 473 42 542 31 097 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 096 3 987 8 742 3 645 3 030 2 712 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%11.4 13.4 15.9 10.8 8.5 8.5 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.6 0.3 -2.0 -3.8 -3.0 -6.7 Redditività del capitale proprio 11 %-6.6 -1.4 -4.7 -8.7 -7.2 -13.4 Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF321684884538857281702548618561 (Valore medio)
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
Tabella 21b
Risultati d’esercizio secondo i tipi di azienda* – 2001/03
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
* Nuova tipologia aziendale FAT99
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
ALLEGATO A21
DetenzionedianimaliAziendecombinate MediadiEquini,Latte CaratteristicaUnitàtutteleovini,Trasforma-comm./VaccheTrasformaaziendecaprinizionecampicolt.madrizioneAltre Aziende di riferimentoNumero2 703 26 51 301 27 503 303 Aziende rappresentateNumero51 469 1 495 1 193 5 073 582 5 908 7 035 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha19.19 12.61 11.74 25.39 21.81 19.43 20.50 Superficie coltiva apertaha5.06 0.49 1.16 13.38 9.48 6.43 6.75 Manodopera aziendaleULA 1.65 1.39 1.54 1.88 1.45 1.78 1.68 di cui:manodopera familiareULAF1.27 1.22 1.18 1.31 1.13 1.28 1.25 Totale vaccheNumero13.8 1.6 11.5 19.8 17.2 15.7 14.7 Totale animaliUBG24.0 11.7 48.6 29.0 23.3 39.1 26.0 Strutturadelcapitale Totale attivifr.738 802 477 287 932 907 874 140 870 973 889 631 786 305 di cui:attivo circolantefr.135 754 83 033 129 636 174 553 163 625 146 286 141 908 di cui:inventario vivofr.44 989 21 678 66 904 53 756 50 038 63 069 54 422 di cui:attivo immobilizzatofr.558 059 372 576 736 367 645 831 657 310 680 276 589 975 di cui:attivo aziendafr.692 004 453 348 898 869 814 105 803 250 838 519 729 522 Quota di capitale di terzi%42 42 47 39 44 43 44 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.12 194 8 034 14 454 14 874 13 530 14 459 12 376 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.196 842 93 774 307 915 250 221 204 697 279 681 206 387 di cui:pagamenti direttifr.45 280 40 461 32 140 46 965 65 261 42 636 44 908 Spese materialifr.118 241 60 793 213 028 148 906 123 775 179 845 124 992 Reddito aziendalefr.78 601 32 981 94 887 101 315 80 922 99 836 81 395 Costo della manodopera salariatafr.11 912 3 965 12 355 17 611 11 744 16 136 13 217 Interessi passivifr.8 071 5 450 13 152 8 961 10 007 10 021 9 228 Canoni d'affittofr.5 631 1 310 2 431 9 392 8 025 6 544 6 190 Costi di terzifr.143 854 71 518 240 967 184 870 153 551 212 546 153 628 Reddito agricolofr.52 988 22 256 66 949 65 351 51 146 67 135 52 759 Reddito accessoriofr.19 473 32 671 17 106 14 398 29 095 16 411 19 995 Reddito totalefr.72 461 54 926 84 055 79 749 80 241 83 546 72 754 Consumo della famigliafr.63 304 50 864 69 684 69 492 70 072 68 708 65 671 Formazione del capitale propriofr.9 157 4 063 14 371 10 258 10 170 14 838 7 083 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.46 248 27 153 72 268 61 336 58 767 61 698 41 147 Cash flow 3 fr.41 950 26 460 56 758 50 585 45 080 55 936 42 618 Rapporto cash flow-investimenti 4 %91 98 86 83 79 92 107 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %65 69 65 62 62 64 65 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %43 42 43 45 45 44 41 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %19 17 18 16 15 21 20 Aziende con reddito insufficiente 8 %20 16 15 23 14 19 19 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %18 24 24 16 26 16 20 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA 47 677 23 325 61 684 53 857 55 868 56 238 48 499 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 096 2 636 8 074 3 992 3 706 5 140 3 971 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%11.4 7.2 10.6 12.5 10.2 11.9 11.2 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.6 -9.7 0.6 -1.5 -1.7 -0.6 -2.5 Redditività del capitale proprio 11 %-6.6 -19.3 -1.7 -4.4 -5.3 -3.1 -6.9 Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF32168113254440538570333114132132296 (Valore medio)
Tabella 22
Risultati d’esercizio per quartili:tutte le regioni – 2001/03
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF321684134227103705067634 (Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF29400 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia
A22 ALLEGATO
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero2 703 579 683 725 716 Aziende rappresentateNumero51 469 12 873 12 866 12 870 12 860 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha19.19 14.69 17.10 20.03 24.95 Superficie coltiva apertaha5.06 2.78 3.19 5.15 9.12 Manodopera aziendaleULA 1.65 1.55 1.65 1.63 1.76 di cui:manodopera familiareULAF1.27 1.25 1.35 1.30 1.17 Totale vaccheNumero13.8 10.8 13.3 14.8 16.4 Totale animaliUBG24.0 18.8 22.2 25.0 30.3 Strutturadelcapitale Totale attivifr.738 802 676 150 660 366 746 908 871 883 di cui:attivo circolantefr.135 754 111 650 117 863 144 157 169 372 di cui:inventario vivofr.44 989 36 765 41 836 46 797 54 567 di cui:attivo immobilizzatofr.558 059 527 734 500 666 555 954 647 945 di cui:attivo aziendafr.692 004 633 484 620 271 694 733 819 623 Quota di capitale di terzi%42 42 41 40 43 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.12 194 11 178 11 013 12 534 14 052 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.196 842 134 657 163 559 202 173 287 054 di cui:pagamenti direttifr.45 280 38 556 43 204 45 954 53 410 Spese materialifr.118 241 98 402 101 564 117 732 155 297 Reddito aziendalefr.78 601 36 255 61 996 84 441 131 757 Costo della manodopera salariatafr.11 912 8 849 9 059 10 346 19 400 Interessi passivifr.8 071 7 807 7 151 7 536 9 790 Canoni d'affittofr.5 631 3 245 4 036 5 930 9 314 Costi di terzifr.143 854 118 303 121 810 141 543 193 801 Reddito agricolofr.52 988 16 354 41 750 60 629 93 253 Reddito accessoriofr.19 473 30 211 18 279 15 931 13 465 Reddito totalefr.72 461 46 565 60 029 76 560 106 718 Consumo della famigliafr.63 304 53 948 57 160 66 037 76 082 Formazione del capitale propriofr.9 157 -7 383 2 870 10 523 30 636 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.46 248 43 053 37 198 41 767 62 986 Cash flow 3 fr.41 950 24 443 31 865 42 892 68 623 Rapporto cash flow-investimenti 4 %91 57 86 104 109 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %65 55 64 69 72 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %43 26 40 49 54 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %19 10 16 20 31 Aziende con reddito insufficiente 8 %20 35 23 16 7 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %18 29 20 14 8 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA 47 677 23 377 37 568 51 719 74 808 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 096 2 468 3 625 4 214 5 286 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%11.4 5.7 10.0 12.2 16.1 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.6 -8.2 -5.5 -2.0 3.3 Redditività del capitale proprio 11 %-6.6 -16.5 -11.5 -5.2 3.8
FAT Tänikon
(ULAF)Fonte:Agroscope
Tabella 23
Risultati d’esercizio per quartili:regione di pianura* – 2001/03
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF400777929303744557579836 (Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF37707 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
* Regione di pianura:zona campicola e zone intermedie
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
ALLEGATO A23
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero1 200 273 308 312 307 Aziende rappresentateNumero23 263 5 837 5 806 5 820 5 800 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha20.13 16.32 18.34 19.83 26.08 Superficie coltiva apertaha9.28 6.99 7.93 8.65 13.57 Manodopera aziendaleULA 1.75 1.67 1.72 1.72 1.87 di cui:manodopera familiareULAF1.23 1.22 1.31 1.26 1.14 Totale vaccheNumero13.8 11.6 13.8 14.4 15.2 Totale animaliUBG24.5 20.7 22.7 25.3 29.3 Strutturadelcapitale Totale attivifr.844 860 845 819 763 386 832 160 938 311 di cui:attivo circolantefr.167 066 154 035 152 704 169 507 192 107 di cui:inventario vivofr.45 681 40 515 43 498 45 761 52 991 di cui:attivo immobilizzatofr.632 114 651 268 567 184 616 891 693 212 di cui:attivo aziendafr.788 164 785 474 708 718 773 552 885 193 Quota di capitale di terzi%41 42 40 39 43 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.14 015 13 864 12 644 14 314 15 245 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.240 927 184 477 207 598 237 821 334 248 di cui:pagamenti direttifr.39 818 32 689 35 645 39 108 51 889 Spese materialifr.143 117 130 309 126 626 136 065 179 607 Reddito aziendalefr.97 810 54 167 80 972 101 756 154 641 Costo della manodopera salariatafr.17 351 15 436 13 920 14 141 25 942 Interessi passivifr.9 567 10 425 8 053 8 658 11 130 Canoni d'affittofr.7 564 4 765 6 632 7 286 11 593 Costi di terzifr.177 599 160 934 155 231 166 150 228 272 Reddito agricolofr.63 328 23 542 52 367 71 671 105 976 Reddito accessoriofr.18 142 28 012 16 732 15 576 12 194 Reddito totalefr.81 471 51 554 69 098 87 247 118 170 Consumo della famigliafr.71 028 63 925 64 954 72 736 82 540 Formazione del capitale propriofr.10 443 -12 371 4 145 14 511 35 629 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.51 471 47 870 40 402 54 354 63 318 Cash flow 3 fr.47 951 26 243 37 649 51 012 77 050 Rapporto cash flow-investimenti 4 %93 56 93 95 123 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %65 53 67 65 74 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %42 22 42 50 55 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %18 9 14 21 30 Aziende con reddito insufficiente 8 %21 37 23 17 8 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %18 32 21 12 8 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA 56 079 32 406 47 025 59 404 82 618 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 859 3 324 4 417 5 142 5 940 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%12.4 6.9 11.4 13.2 17.5 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-1.2 -6.0 -3.8 -0.5 4.6 Redditività del capitale proprio 11 %-4.2 -12.9 -8.6 -2.7 6.0
Risultati d’esercizio per quartili:regione collinare* – 2001/03
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF298284268216733422959828 (Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF27747 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione collinare:zona collinare e zona di montagna I
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
A24 ALLEGATO
Tabella 24
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero783 155 197 212 219 Aziende rappresentateNumero14 117 3 546 3 530 3 522 3 518 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha18.17 13.81 16.12 18.86 23.94 Superficie coltiva apertaha2.90 1.84 2.26 3.25 4.27 Manodopera aziendaleULA 1.57 1.48 1.56 1.57 1.69 di cui:manodopera familiareULAF1.26 1.20 1.32 1.29 1.21 Totale vaccheNumero15.6 12.4 14.5 16.4 19.1 Totale animaliUBG26.8 20.5 24.2 27.3 35.4 Strutturadelcapitale Totale attivifr.696 014 639 299 648 722 689 509 807 086 di cui:attivo circolantefr.116 902 102 528 103 053 117 817 144 309 di cui:inventario vivofr.49 182 39 174 44 603 50 428 62 611 di cui:attivo immobilizzatofr.529 930 497 597 501 067 521 264 600 165 di cui:attivo aziendafr.651 213 595 189 608 242 640 732 761 221 Quota di capitale di terzi%44 44 44 43 46 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.10 950 10 141 10 344 11 004 12 320 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.181 576 128 133 158 881 184 347 255 441 di cui:pagamenti direttifr.44 020 35 325 39 190 45 582 56 064 Spese materialifr.111 104 94 371 101 759 108 429 140 021 Reddito aziendalefr.70 472 33 762 57 122 75 918 115 420 Costo della manodopera salariatafr.9 196 7 884 6 876 8 111 13 935 Interessi passivifr.7 810 7 223 7 570 7 384 9 071 Canoni d'affittofr.5 068 3 331 3 639 5 354 7 965 Costi di terzifr.133 178 112 810 119 844 129 278 170 992 Reddito agricolofr.48 399 15 324 39 037 55 069 84 449 Reddito accessoriofr.20 532 33 217 19 180 15 482 14 159 Reddito totalefr.68 931 48 541 58 217 70 551 98 607 Consumo della famigliafr.60 331 51 857 57 042 61 425 71 076 Formazione del capitale propriofr.8 600 -3 316 1 174 9 127 27 531 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.47 374 49 424 38 882 38 550 62 666 Cash flow 3 fr.40 052 26 734 30 936 38 971 63 697 Rapporto cash flow-investimenti 4 %85 56 81 104 104 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %65 55 63 69 72 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %41 31 37 46 51 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %22 12 15 24 36 Aziende con reddito insufficiente 8 %18 29 25 15 4 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %18 29 22 14 9 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA 44 817 22 837 36 655 48 412 68 485 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha3 878 2 446 3 544 4 025 4 822 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%10.8 5.7 9.4 11.9 15.2 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-3.3 -8.7 -5.8 -2.7 2.5 Redditività del capitale proprio 11 %-8.2 -18.0 -12.7 -6.8 2.5
Tabella 25
Risultati d’esercizio per quartili:regione di montagna* – 2001/03
(Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF20556 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990:6.40%;1991:6.23%;1992:6.42%;2000:3.95%; 2001:3.36%;2002:3.22%;2003:2.63%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotte le sovvenzioni e i disinvestimenti
3Formazione del capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow dell'azienda e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio positiva
7Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio positiva
8Quota del capitale di terzi <50% e formazione del capitale proprio negativa
9Quota del capitale di terzi >50% e formazione del capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione di montagna:zone di montagna II a IV
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
ALLEGATO A25
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero719 157 171 196 196 Aziende rappresentateNumero14 089 3 528 3 537 3 515 3 509 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha18.67 13.36 16.10 19.42 25.84 Superficie coltiva apertaha0.25 0.07 0.18 0.34 0.41 Manodopera aziendaleULA 1.57 1.50 1.63 1.63 1.51 di cui:manodopera familiareULAF1.35 1.29 1.46 1.39 1.24 Totale vaccheNumero12.0 9.2 10.7 12.8 15.4 Totale animaliUBG20.5 16.2 18.2 21.6 26.1 Strutturadelcapitale Totale attivifr.606 749 555 007 564 086 604 446 703 975 di cui:attivo circolantefr.102 872 74 338 97 832 111 933 127 575 di cui:inventario vivofr.39 659 31 737 35 271 41 701 49 997 di cui:attivo immobilizzatofr.464 218 448 932 430 983 450 812 526 403 di cui:attivo aziendafr.574 307 532 804 531 392 572 956 660 544 Quota di capitale di terzi%40 41 37 40 42 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.10 429 9 569 10 128 10 417 11 608 Contoperditeeprofitti Totale reddito lordofr.139 508 101 312 119 194 147 885 189 980 di cui:pagamenti direttifr.55 533 43 269 51 148 58 982 68 820 Spese materialifr.84 464 77 256 74 805 85 489 100 413 Reddito aziendalefr.55 044 24 056 44 389 62 396 89 567 Costo della manodopera salariatafr.5 653 4 835 3 943 6 279 7 573 Interessi passivifr.5 867 6 284 4 958 5 723 6 508 Canoni d'affittofr.3 001 2 222 2 009 3 323 4 463 Costi di terzifr.98 986 90 596 85 715 100 813 118 956 Reddito agricolofr.40 523 10 716 33 480 47 072 71 024 Reddito accessoriofr.20 608 31 342 17 698 17 226 16 140 Reddito totalefr.61 131 42 058 51 177 64 298 87 164 Consumo della famigliafr.53 548 46 691 50 030 53 654 63 877 Formazione del capitale propriofr.7 582 -4 633 1 147 10 644 23 287 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.36 449 30 312 32 475 38 699 44 381 Cash flow 3 fr.33 948 22 561 25 442 36 453 51 460 Rapporto cash flow-investimenti 4 %94 75 80 94 117 Aziende con eccedenza di investimenti 5 %66 59 62 68 74 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %44 28 37 54 57 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %18 10 15 19 29 Aziende con reddito insufficiente 8 %21 35 29 13 7 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %17 27 19 14 7 Rapportoredditoaziendale/impiegodifattori Reddito aziendale per manodoperafr./ULA 35 118 16 020 27 275 38 304 59 257 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha2 949 1 797 2 756 3 217 3 465 Rapporto reddito aziendale/attivi azienda%9.6 4.5 8.4 10.9 13.6 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-5.1 -10.4 -8.2 -4.4 1.2 Redditività del capitale proprio 11 %-10.3 -20.0 -14.7 -9.1 0.4 Profittodellavorodellamanodoperafamigliare12fr./ULAF22419897160102641948099
UnitàAziendecombinate:Aziendecombinate:Aziendecombinate:Aziendecombinate: lattecommerciale/vacchemadritrasformazionealtre campicoltura
A26 ALLEGATO
26 Risultati d'esercizio per regione,tipo di azienda e quartile:1990/92–2001/03 UnitàTutteleaziendeRegionedipianuraRegionecollinareRegionedimontagna Redditoperregione1990/922001/031990/922001/031990/922001/031990/922001/03 Superficie agricola utileha16.06 19.19 16.66 20.13 15.30 18.17 15.76 18.67 Manodopera familiareULAF1.39 1.27 1.36 1.23 1.40 1.26 1.42 1.35 Reddito agricolofr.62 822 52 988 73 794 63 328 59 838 48 399 45 541 40 523 Reddito accessoriofr.16 264 19 473 16 429 18 142 14 544 20 532 17 853 20 608 Reddito totalefr.79 086 72 461 90 223 81 471 74 382 68 931 63 394 61 131 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF3102532168369244007730335298282120122419 UnitàCampicolturaColturespecialiLattecommercialeVacchemadri Redditopertipodiazienda1990/922001/031990/922001/031990/922001/031990/922001/03 Superficie agricola utileha21.23 23.89 8.92 12.72 15.30 18.86 15.32 17.62 Manodopera familiareULAF1.08 1.09 1.29 1.29 1.42 1.33 1.20 1.09 Reddito agricolofr.60 284 66 511 67 184 63 898 53 923 48 466 36 627 38 740 Reddito accessoriofr.26 928 21 974 21 555 18 874 16 044 18 224 33 558 31 455 Reddito totalefr.87 212 88 485 88 739 82 773 69 967 66 690 70 185 70 194 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF3437548845303343885726471281701734825486 UnitàAltriboviniEquini/ovini/capriniTrasformazione Redditopertipodiazienda1990/922001/031990/922001/031990/922001/03 Superficie agricola utileha14.20 16.17 Solo sette12.61 9.34 11.74 Manodopera familiareULAF1.37 1.25 aziende1.22 1.35 1.18 Reddito agricolofr.38 407 32 290 disponibili22 256 86 288 66 949 Reddito accessoriofr.20 570 21 886 32 671 14 614 17 106 Reddito totalefr.58 977 54 176 54 926 100 902 84 055 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF1679318561113254818244405
Tabella
Redditopertipodiazienda1990/922001/031990/922001/031990/922001/031990/922001/03 Superficie agricola utileha20.37 25.39 17.93 21.81 15.59 19.43 17.24 20.50 Manodopera familiareULAF1.45 1.31 1.24 1.13 1.40 1.28 1.43 1.25 Reddito agricolofr.75 368 65 351 51 161 51 146 84 363 67 135 66 705 52 759 Reddito accessoriofr.11 802 14 398 20 475 29 095 12 032 16 411 15 000 19 995 Reddito totalefr.87 170 79 749 71 636 80 241 96 395 83 546 81 705 72 754 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF3642038570274563331142927413213273232296 UnitàIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Redditoperquartile(profittodellavoro)1990/922001/031990/922001/031990/922001/031990/922001/03 Superficie agricola utileha14.68 14.69 15.30 17.10 15.78 20.03 18.47 24.95 Manodopera familiareULAF1.36 1.25 1.49 1.35 1.42 1.30 1.27 1.17 Reddito agricolofr.26 883 16 354 52 294 41 750 69 198 60 629 102 975 93 253 Reddito accessoriofr.27 789 30 211 14 629 18 279 12 064 15 931 10 557 13 465 Reddito totalefr.54 672 46 565 66 923 60 029 81 262 76 560 113 532 106 718 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF43674134235922271036016370506266567634 Fonte:Agroscope FAT Tänikon
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Uscite della Confederazione
Uscite per produzione e smercio Tabella 27
Fonte:UFAG
ALLEGATO A27
Promozione
fr.fr.fr. Produzionelattiera336820243581796134643330 Formaggio,estero19 825 65230 459 24018 500 000 Formaggio,Svizzera3 705 3721 418 3214 626 080 Latte10 151 0003 940 40011 517 250 Produzioneanimale293124528900195361250 Carne1 796 0001 660 0504 031 000 Uova626 000618 519740 000 Pesce16 50008 250 Animali vivi472 745611 450572 000 Miele20 000010 000 Produzionevegetale6751833735481912153008 Verdura1 692 7471 919 6772 473 050 Frutta2 381 7112 607 7392 552 458 Cereali885 503530 536340 000 Patate705 0001 180 890737 500 Semi oleosi286 872315 978350 000 Piante ornamentali800 000800 000700 000 Vino 4 --5 000 000 Provvedimenticollettivi513714658524712548133 Provvedimentisovrasettoriali(Bio,PI)217354227502883327164 Pubblicherelazioni1003107750 Conteggi finali e impegni a lungo termine, piccoli progetti e sponsorizzazione4 826 324906 211 Nazionale555021145557176961140635 Regionale2329636225860652532065 Totale587984765906404563672700
dello smercio:mezzi stanziati Settori/SettoridiprodottidimercatoConto2002Conto20033Mezzistanziati2004
nel
collettivi
1 Fino al 2003
conto dei provvedimenti
2 Preventivo,pianificazione continua
3 Secondo il conteggio provvisorio
4 Fino al 2003 nel fondo per la viticoltura
Tabella 28
Uscite nel settore dell’economia lattiera
A28 ALLEGATO
DenominazioneConto2002Conto2003Preventivo20041 fr.fr.fr. Sostegnodelmercato(supplementieaiuti) Supplemento per il latte trasformato in formaggio318 644 295306 348 248308 667 996 Supplemento per il foraggiamento senza insilati44 808 18042 956 25443 670 000 Aiuti all'interno del Paese a favore del burro92 936 17693 119 64071 460 000 Aiuti all'interno del Paese a favore del latte scremato e del latte in polvere59 235 68346 542 31043 670 000 Aiuti all'interno del Paese a favore del formaggio1 404 78400 Aiuti all'esportazione a favore del formaggio45 264 64829 090 87615 880 000 Aiuti all'esportazione a favore di altri latticini31 356 23134 801 67213 797 735 593649997552859000497145731 Sostegnodelmercato(amministrazione) Commissioni di ricorso in materia di contingentamento lattiero66 05243 04997 960 Amministrazione del contingentamento lattiero e della valorizzazione del latte6 933 5157 076 4926 269 424 699956771195416367384 Totale600649564559978541503513115
Considerato il
Fonti:Conto dello Stato,UFAG
1
blocco dei crediti
Tabella 29
Uscite nel settore della produzione animale
DenominazioneConto2002Conto2003Preventivo20041 fr.fr.fr.
Fondoperlacarne
Indennità ad organizzazioni private per il bestiame da macello e la carne7 596 2627 448 000
Acquisto di carne bovina a fini umanitari177 8020
Contributi alle azioni d'immagazzinamento di carne di vitello3 963 5673 801 575
Contributi alle azioni d'immagazzinamento di carne bovina di animali da banco (torelli,manze,buoi)1 734 7690
Contributi alle azioni d'immagazzinamento di carne bovina di animali da salumeria (vacche)20 911801 132
Contributi alle azioni di vendita a prezzo ridotto di muscoli di manzo256 1730
Cassadicompensazionedeiprezzidelleuovaedeiprodottidiuova
Contributi di riconversione per la detenzione di ovaiole particolarmente rispettosa degli animali342 39853 850
Contributi ai costi di raccolta e di cernita378 8800
Azioni di spezzatura1 671 5241 525 082
Azioni di vendita a prezzo ridotto627 618593 203 Esperimenti sul pollame conformi alla pratica319 314204 848
Contributi d'investimento per la costruzione di pollai247 964597 678
Contributiperl'esportazionedibestiamedaallevamentoedareddito2200000923155013207495
Contributiperlavalorizzazionedellalanadipecora800000594000800000
Totale203371822485091840229994
1 Considerato il blocco dei crediti Fonti:Conto dello Stato,UFAG
ALLEGATO A29
137494841205070715781940
3587698297466110440559
Tabella 30
Uscite nel settore della produzione vegetale
1 Nel preventivo 2004 nella rubrica «Altre spese per beni e servizi» (3190.000)
2 Ex promozione della viticoltura
3 Promozione dello smercio di vino all'estero / Nel conto 2003 sono contenuti i contributi di riconversione per il vino / Nel preventivo 2004 la promozione dello smercio è contenuta nella rubrica 3601.200
4 Considerato il blocco dei crediti
dello Stato,UFAG
A30 ALLEGATO
DenominazioneConto2002Conto2003Preventivo20044 fr.fr.fr. Contributidicoltivazione390225154357392645698450 Contributi di superficie per semi oleosi32 176 19235 178 96737 698 450 Contributi di superficie per leguminose a granelli6 378 0517 905 3927 500 000 Contributi di superficie per piante da fibra468 272489 567500 000 Contributiditrasformazioneedivalorizzazione945819969405592090981702 Trasformazione di barbabietole da zucchero45 000 00045 000 00039 203 750 Trasformazione di semi oleosi8 509 0008 500 0008 436 250 Trasformazione di patate18 972 11718 851 41218 857 500 Produzione di sementi3 867 5843 889 3443 870 750 Valorizzazione della frutta18 217 44517 815 16420 368 085 Trasformazione di MPR15 8500245 367 Promozionedellavitivinicoltura12296573163344607053697 Spese per beni e servizi 1 83 02482 934Controllo della vendemmia 2 869 2251 066 2981 091 750 Provvedimenti di valorizzazione 3 4 387 8149 951 554Trasformazione dell'uva in prodotti analcolici6 956 5105 233 674Contributi di riconversione in vitivinicoltura--5 961 947 Totale145901084153964306143733849
Fonti:Conto
Uscite nel settore dei pagamenti diretti
Tabella 31
Evoluzione dei pagamenti diretti
i dati del Conto dello Stato.I valori relativi ai pagamenti diretti si riferiscono all'intero anno di contribuzione, mentre il Conto dello Stato riporta le spese sostenute durante un anno civile.Le riduzioni indicano le deduzioni in ragione delle limitazioni e delle sanzioni giuridiche e amministrative.
Fonte:UFAG
ALLEGATO A31
2000200120022003 Tipodicontributo 1000fr.1000fr.1000fr.1000fr. Pagamentidirettigenerali1803658192909419948381999091 Contributi di superficie1 186 7701 303 8811 316 1831 317 956 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo258 505268 272283 221287 692 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione251 593250 255289 572287 289 Contributi di declività generali96 71496 64395 81195 630 Contributi di declività per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate10 07610 04310 05110 524 Pagamentidirettiecologici361309412664452448476724 Contributi ecologici278 981329 886359 387381 319 Contributi per la compensazione ecologica108 130118 417122 347124 927 Contributi giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE)--8 93414 638 Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza33 39832 52631 93831 255 Contributi per prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la gestione (disposizioni transitorie fino a fine 2000)17 150-Contributi per l'agricoltura biologica12 18523 48825 48427 135 Contributi per la detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze108 118155 455170 684183 363 Contributid'estivazione81238805248956191381 Contributiperlaprotezionedelleacque1090225435004024 Riduzioni22542167632114317138 Totalepagamentidiretti2142425232499524261432458677 Avvertenza:non è possibile fare un paragone diretto
con
Tabella 32a
Pagamenti diretti generali – 2003
ContributidisuperficieContributiperanimalidaredditocheconsumanoforaggiogrezzo AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeUBGFGTotalecontributi
A32 ALLEGATO
Numerohafr.NumeroNumerofr. Cantone ZH3 63169 71093 458 6431 81915 54613 259 231 BE12 627187 995243 499 2368 75363 24055 792 728 LU5 12677 12497 125 1213 13322 86520 374 967 UR6656 6888 027 4576265 3774 545 467 SZ1 69523 93928 702 8491 47913 97211 847 790 OW7037 9039 493 9656183 9933 518 144 NW4996 0857 304 4344022 4942 141 433 GL4167 2348 681 4013953 7023 215 616 ZG57010 62013 066 8023953 0162 615 564 FR3 22974 84397 501 9552 06517 58515 504 536 SO1 42331 40440 949 0289658 8907 642 040 BL95721 45827 322 2516616 1175 289 973 SH58114 13619 619 6152382 4692 153 976 AR77312 13114 493 1636274 8624 233 041 AI5747 3328 781 8843902 4422 262 427 SG4 35271 57687 016 5873 24928 58224 375 101 GR2 74052 29962 736 7042 63136 44529 834 828 AG3 08657 81778 626 7831 55314 00612 022 764 TG2 69349 27165 477 3069326 6265 447 797 TI90912 99115 736 8227027 1705 446 656 VD4 020105 881144 239 4992 00521 81819 039 863 VS3 78136 47445 903 4512 32319 43414 021 389 NE94333 07538 830 6387098 5447 575 871 GE30910 46514 150 174951 3671 145 927 JU1 09538 87047 210 38493216 32714 385 106 Svizzera573971027321131795615237697336891287692235 Zona1 Pianura24 232477 077650 200 78710 69891 34278 587 586 Collina8 091142 765181 861 0205 26041 59635 657 497 ZM I7 453119 285145 190 8355 87844 25438 212 696 ZM II9 111155 748183 274 9067 55871 04862 117 860 ZM III5 62186 330102 659 8865 46258 82149 110 877 ZM IV2 88946 11754 768 7182 84129 83024 005 719 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
Tabella 32b
Pagamenti diretti generali – 2003
DetenzionedianimaliinContributidideclivitàgeneraliContributidideclivitàpervigneti condizionidifficilidiproduzioneinzoneinfortependenzaeterrazzate
ALLEGATO A33
TotaleTotaleTotale AziendeUBGFGcontributiAziendeSuperficiecontributiAziendeSuperficiecontributi NumeroNumerofr.Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH78112 6943 994 0007715 1142 103 680187170320 245 BE8 975131 08472 296 1068 33847 44419 902 4676595330 744 LU3 15048 46121 180 8073 30721 7769 084 800101325 770 UR6598 0666 978 3026184 7432 249 990111 245 SZ1 52622 70613 070 5781 48910 1544 340 840141123 385 OW67110 2615 911 0376464 7232 175 062112 500 NW4667 1513 775 0994483 8611 726 5450 GL3715 7804 322 0163713 4141 548 127127 950 ZG3766 2082 902 5583682 8331 187 62920615 FR1 85434 63612 725 5561 5397 2292 855 580161218 834 SO6079 9963 795 2305794 8711 867 0930 BL69211 0903 123 2816785 9822 303 185413663 150 SH1221 893320 669142834312 68312196158 790 AR76912 3297 107 2167666 6582 802 48041030 955 AI5658 7135 798 3865483 3971 415 6920 SG3 01349 11422 404 5582 92925 28810 539 1337097287 545 GR2 63540 25438 667 1052 56832 06014 000 833271940 890 AG1 12517 4433 527 4071 1187 2132 776 215118159272 760 TG1783 092960 7971481 144502 49980100151 500 TI6788 0896 593 3725663 1601 393 947182157312 810 VD1 29722 5429 694 5569875 7582 284 8434336662 377 630 VS2 31423 38821 243 2132 18312 3445 532 9391 3741 6585 879 878 NE79815 2729 116 1715883 5451 331 0504870141 265 GE000000434772 510 JU77714 9007 780 7295913 6111 392 410322 895 Svizzera3439952516328728874932286227154956297222841342310523866 Zona1 Pianura2 64946 9514 156 4512 0555 6042 255 2531 7762 3167 091 297 Collina7 551120 96531 054 1237 02537 51114 681 089193262666 645 ZM I7 208112 62449 832 3046 83147 16119 269 212176210596 139 ZM II8 560132 04790 139 6938 03761 36525 918 9035395751 967 895 ZM III5 56275 69370 015 1945 48448 40021 275 75711248162 700 ZM IV2 86936 88342 090 9842 85427 11312 229 508451139 190 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
A34 ALLEGATO
Tabella 33a
AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH3 6249 01112 749 7263536 7492 092 912 BE12 36818 73518 010 4281 40620 4224 918 767 LU5 1088 3609 500 4162944 4731 121 663 UR6631 204620 21054694139 456 SZ1 6693 2462 871 4121552 405487 482 OW7001 109908 9052012 492499 997 NW496937732 46866902183 380 GL4111 104677 013921 652329 353 ZG5701 6291 766 425801 431312 837 FR3 1646 6117 287 7461032 056700 637 SO1 4204 2495 321 8001112 908738 842 BL9573 4354 554 0751292 914770 985 SH5611 6512 522 53417402166 652 AR711846684 5631402 435488 173 AI481549390 4023348496 621 SG4 3188 2198 750 3684978 4931 836 631 GR2 71214 5775 947 4671 38828 6175 893 005 AG3 0757 53110 252 6312113 8251 334 660 TG2 6605 1337 224 7372314 0001 451 069 TI8311 6281 200 7141001 558379 429 VD3 8109 86612 932 3511242 726954 842 VS2 1625 1553 006 8072644 2651 161 954 NE7271 8711 636 648451 250314 359 GE3051 1892 035 95955854 742 JU1 0613 1683 341 346832 920706 291 Svizzera54564121010124927147618211013427134739 Zona2 Pianura23 24250 23672 128 1781 16720 6238 160 675 Collina8 00517 68121 223 88459510 2892 771 261 ZM I7 19511 71510 410 70580212 6682 809 413 ZM II8 12614 97410 469 0031 31422 6714 576 949 ZM III5 24014 2406 223 6721 37525 4885 165 257 ZM IV2 75612 1654 471 70592918 3953 651 184 1 Alberi da frutto ad alto fusto convertiti in are 2 Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
Contributi ecologici – 2003 Compensazioneecologica1Agricolturabiologica
Contributi ecologici – 2003
ProduzioneestensivaDetenzionedianimalidaredditoparticolarmente dicerealiecolzarispettosadelleloroesigenze
ALLEGATO A35
Tabella 33b
AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeUBGTotalecontributi Numerohafr.NumeroNumerofr. Cantone ZH1 6036 3952 546 7742 07967 51510 203 405 BE5 28315 9306 371 6279 251224 02236 151 541 LU1 2643 2661 306 4763 903154 73023 270 559 UR0004066 0981 008 313 SZ182610 5681 01023 2503 779 034 OW241 56845711 0221 771 302 NW0002667 2251 152 193 GL231 1003017 3131 217 188 ZG8318071 86840414 6842 211 947 FR1 2976 1312 452 5572 560100 68315 841 135 SO7733 8101 519 4401 09733 8135 176 752 BL6573 1561 253 88556320 7393 149 250 SH3382 420951 79726311 0311 552 823 AR00062015 5482 606 184 AI00043812 0712 120 745 SG323729286 6012 81793 32314 997 674 GR271798319 0482 35157 7939 170 282 AG1 6896 9882 792 7521 82162 8889 543 344 TG8122 7491 097 0901 74968 22410 249 574 TI68299119 60868513 7852 163 781 VD2 00315 3996 149 8412 14681 36912 195 667 VS112321126 8071 17616 0532 664 479 NE3982 8061 121 39464726 3204 047 711 GE2223 2041 238 171682 351338 273 JU5663 8111 516 26291446 6396 780 239 Svizzera177847842531255234379921178486183363395 Zona1 Pianura10 58954 06421 520 01914 423558 82184 087 078 Collina4 17415 2696 098 4945 787194 62530 348 022 ZM I2 1476 9922 796 0225 377154 30724 605 131 ZM II7141 901760 5676 298157 67025 724 203 ZM III13518373 3404 04377 12912 655 359 ZM IV25176 7922 06435 9345 943 602 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
Contributi per la compensazione ecologica – 2003
PratisfruttatiinmodoestensivoPratisfruttatiinmodopocointensivo
A36 ALLEGATO
Tabella 34a
AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH3 1234 4936 352 9071 040939596 126 BE7 2306 7266 726 9437 5846 4303 100 921 LU4 0423 5433 886 3732 0561 471752 584 UR379448216 729480585184 859 SZ980847625 086584488205 164 OW583649403 12421312552 343 NW369469293 52221018477 943 GL375801471 30615918971 640 ZG354336400 32724518498 767 FR1 9202 4443 181 1872 0302 7301 595 922 SO1 1712 1352 679 288604776447 348 BL7521 1931 421 433441541331 087 SH5279931 391 71215314997 019 AR358194141 250412264119 990 AI287190133 31116011350 839 SG2 7802 4252 584 7842 0621 475800 605 GR2 0415 4642 676 6822 3678 7022 679 563 AG2 5323 7785 119 3921 2071 023659 189 TG1 8571 6762 459 8531 068739477 778 TI507650545 611418728252 669 VD3 1005 0466 829 4281 3182 2931 200 908 VS8921 319869 3211 5683 1231 052 894 NE485805866 250383855396 920 GE2968441 265 715132113 659 JU7251 2291 469 2876421 134596 599 Svizzera376654869553010818274173526315913336 Zona1 Pianura18 59124 11035 313 6178 5697 5834 861 514 Collina5 3616 2067 273 3054 3594 1562 612 312 ZM I3 9183 5232 585 7294 1363 5631 645 963 ZM II4 5944 7313 199 4014 5465 5022 412 151 ZM III3 3075 9332 739 2903 5006 8702 096 284 ZM IV1 8944 1921 899 4762 3077 5882 285 113 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
Contributi per la compensazione ecologica – 2003
ALLEGATO A37
Tabella 34b
TerrenidastrameSiepi,boschetticampestrierivieraschi AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH1 1631 3351 823 358955187270 070 BE752568355 7801 964414439 400 LU448322288 075506102135 492 UR575646 61621421 SZ8901 181945 35571942 OW1518579 0971311 066 NW1189883 1951311 209 GL604633 2151221 133 ZG311535419 3632726665 988 FR874645 738769234311 581 SO111 80030589110 475 BL027383100 462 SH1068 7602286590 093 AR265190133 3845296 514 AI206193134 86262128 120 SG1 7271 7661 506 8943215865 625 GR734020 8211132521 687 AG11487128 2171 036293384 303 TG16589128 76747097144 184 TI273946 2521756 150 VD12811285 3631 052354478 932 VS34118 1751313930 872 NE442 5481164139 260 GE468 4601103045 705 JU281410 624334127127 334 Svizzera682368286344715913323362887015 Zona1 Pianura1 8011 8312 695 3125 3911 3261 961 489 Collina813651780 9421 737452540 558 ZM I1 068814640 209963265191 005 ZM II2 0802 5611 769 556779235166 186 ZM III788704336 7922154823 517 ZM IV273268121 9064894 262 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona
Fonte:UFAG
Contributi per la compensazione ecologica – 2003
A38 ALLEGATO
Tabella 34c
MaggesifioritiMaggesidarotazione AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH397305916 230140163407 625 BE331251752 260108120297 375 LU402575 240111638 750 UR000000 SZ113 000000 OW000000 NW000000 GL000000 ZG101339 390000 FR200226679 4155277192 578 SO7096289 3204367168 175 BL150123369 6606589222 025 SH165150450 3604155136 375 AR000000 AI000000 SG373295 250338 050 GR131441 46041025 350 AG397186558 720150158395 700 TG135113338 7003748120 675 TI91545 66091947 725 VD4356461 938 450175277691 775 VS332678 63071128 275 NE4143129 27091743 550 GE6185253 83064144360 150 JU6971212 671283791 650 Svizzera25942423726751694613113275803 Zona1 Pianura2 1682 0706 208 5238001 1212 799 488 Collina4063381 015 576140185461 717 ZM I151338 197338 748 ZM II424 830224 825 ZM III10390101 025 ZM IV000000 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
Contributi per la compensazione ecologica – 2003
ALLEGATO A39
Tabella 34d
FascedicoltureestensiveincampicolturaAlberidafruttoadaltofustoneicampi AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeAlberiTotalecontributi Numerohafr.NumeroNumerofr. Cantone ZH811 2452 559158 8112 382 165 BE2757 3858 444422 2016 330 365 LU912 2054 327288 1134 321 697 UR00024611 439171 585 SZ101501 04172 7811 091 715 OW00046624 885373 275 NW00035018 440276 600 GL0001446 64899 720 ZG00051049 506742 590 FR823 7001 99485 1751 277 625 SO1535 1241 165108 0181 620 270 BL1023 270911140 4092 106 138 SH3156038623 177347 655 AR00034218 895283 425 AI000784 21863 270 SG822 2653 072245 7933 686 895 GR00058532 127481 905 AG1123 4202 629200 2463 003 690 TG811 4102 216236 9323 553 370 TI00022817 107256 648 VD221015 0602 112112 8291 692 435 VS1015083362 566938 490 NE104519410 587158 805 GE302101145 88288 230 JU106067355 548833 121 Svizzera136314625935619241233336181684 Zona1 Pianura1062537 72217 2241 216 92518 250 514 Collina2868 4027 037568 7388 531 073 ZM I201355 835353 3815 300 719 ZM II0003 985194 1372 912 055 ZM III0001 30768 4241 026 374 ZM IV00023110 728160 949
1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona
Fonte:UFAG
Tabella 35
Contributi per la qualità biologica e l'interconnessione – 2003
Soltantoqualitàbiologica1Soltantointerconnessione1QualitàbiologicaeContributifederali interconnessione1
AziendeSuperficieAziendeSuperficieAziendeSuperficieAziendeTotalecontributi NumerohaNumerohaNumerohaNumerofr.
A40 ALLEGATO
Cantone ZH7788584446661634631 140835 426 BE2 0182 16500002 0181 386 941 LU1 8801 058549711101 9131 785 472 UR2463540000246 142 164 SZ1 0271 5327346642211 088934 255 OW280376222761162328259 144 NW2332433945127566326305 796 GL19942117291850218201 528 ZG4035980000403 422 387 FR2282041502334551375285 429 SO3135300000313 293 736 BL9554233542502833627957 968 SH1221544123712485 892 AR1921034231106270274177 928 AI233220101323392 452 SG1 9382 16293200822602 0131 436 348 GR 1 2923 1961532211446211 3401 267 810 AG2272034035104312 9696601 728 532 TG3898900370246664620 056 TI153326182945171146 640 VD1 0481 15100001 048 558 601 VS38868194400393326 664 NE2422647713600287176 050 GE16130000164 382 JU2163740000216 207 203 Svizzera141561732718322867213267371643414638800 Zona Pianura3 9982 6788681 1957961 8365 0494 440 317 Collina1 8631 2744075545902 3232 4742 864 460 ZM I1 7951 6971533152086401 9971 584 068 ZM II2 9264 0962284453108933 1902 390 675 ZM III2 1964 298962191516192 3101 926 493 ZM IV1 3783 28580140774261 4141 432 787 1Alberi ad alto fusto convertiti in are Fonte:UFAG
Tabella 36
Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza – 2003
ALLEGATO A41
CerealipanificabiliCerealidaforaggioColzaTotale AziendeSuperficieAziendeSuperficieAziendeSuperficieTotalecontributi NumerohaNumerohaNumerohafr. Cantone ZH1 2134 0251 0671 9462244242 546 774 BE3 0857 1004 3798 4042594266 371 627 LU7801 4489631 6251051931 306 476 UR0000000 SZ3317231110 568 OW231101 568 NW0000000 GL0023001 100 ZG31656210071471 868 FR7893 0151 0452 7301373872 452 557 SO5291 7696561 847881941 519 440 BL4871 5175771 506531321 253 885 SH3201 86116444758113951 797 AR0000000 AI0000000 SG1382812304082140286 601 GR1383702283832244319 048 AG1 4044 1061 2792 6261492552 792 752 TG6621 803489797831491 097 090 TI331195117713119 608 VD1 1677 5211 5375 5068272 3736 149 841 VS83229618715126 807 NE1768313711 765722101 121 394 GE1831 935181883853871 238 171 JU3091 6024721 912752971 516 262 Svizzera115323960413832331772268564431255234 Zona1 Pianura7 93431 2847 39718 0821 8444 69821 520 019 Collina2 6026 3583 6258 1533547586 098 494 ZM I8371 7301 9975 078671832 796 022 ZM II1161916671 70436760 567 ZM III36391221440073 340 ZM IV732414006 792 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
Contributi per la detenzione di animali particolarmente rispettosa delle loro esigenze – 2003 SistemidistabulazioneparticolarmenteUscitaregolareall'aperto
A42 ALLEGATO
Tabella 37
rispettosideglianimali AziendeUBGTotalecontributiAziendeUBGTotalecontributi NumeroNumerofr.NumeroNumerofr. Cantone ZH1 16624 8552 616 4911 95642 6607 586 914 BE3 97760 5057 189 9098 963163 51728 961 632 LU2 63962 1817 570 8153 73592 54915 699 744 UR1031 048102 4734035 050905 840 SZ3555 508603 68599217 7423 175 349 OW2043 167360 3004457 8551 411 002 NW1402 429301 9902564 796850 203 GL761 285133 5953016 0281 083 593 ZG2265 374568 2473879 3091 643 700 FR1 56932 3863 655 6392 43868 29712 185 496 SO64711 2621 208 6121 03822 5503 968 140 BL3327 731828 53054613 0082 320 720 SH1925 787659 3262185 244893 497 AR1832 801328 12861712 7462 278 056 AI1562 958482 6144339 1131 638 131 SG1 17126 6963 145 8092 75866 62611 851 865 GR74614 0931 330 8122 35043 6997 839 470 AG1 10825 7472 953 9211 68337 1416 589 423 TG98026 8532 986 9911 64541 3727 262 583 TI2083 398313 54768110 3871 850 234 VD1 22230 0143 087 8642 00851 3559 107 803 VS1832 368225 1811 16713 6852 439 298 NE3007 947796 20363918 3733 251 508 GE2989989 339671 452248 934 JU56517 6741 717 00889228 9655 063 231 Svizzera184773849694325702936618793517140106366 Zona1 Pianura8 734219 83224 912 55113 529338 98959 174 527 Collina3 30467 4727 887 1525 560127 15422 460 870 ZM I2 49842 5204 728 8115 280111 78719 876 320 ZM II2 35134 9273 823 8736 191122 74221 900 330 ZM III1 11914 2451 353 1594 00862 88411 302 200 ZM IV4715 973551 4832 05029 9625 392 119 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte:UFAG
Tabella 38
Partecipazione al programma SSRA – 2003
ALLEGATO A43
Base1PartecipazioneSSRA CategoriedianimaliUBGAziendeUBGAziendeUBGAziende NumeroNumeroNumeroNumero%% Allevamentoereddito: Vacche lattifere620 17838 405131 8605 45621.314.2 Manze di oltre 1 anno146 86436 80838 0937 45725.920.3 Tori di oltre 1 anno5 0757 6701 3911 81227.423.6 Bestiame giovane,da 4 a 12 mesi,femmine31 75728 7668 3215 94426.220.7 Bestiame giovane,da 4 a 12 mesi,maschi1 8683 71420636111.09.7 Vitelli da allevamento fino a 4 mesi23 81025 4078 8497 57137.229.8 Vacchemadrienutrici: Vacche madri e nutrici con vitelli59 0805 59145 4143 31176.959.2 Ingrasso: Manze,tori,buoi di oltre 4 mesi37 4647 14321 1152 51956.435.3 Vitelli fino a 4 mesi4 1216 4812 3131 83256.128.3 Vitelli da ingrasso11 11117 9905 3114 42247.824.6 Totalebestiamebovino941329455182628741569227.934.5 Caprini8 2426 2072 14771526.111.5 Conigli4 4203 79990415320.54.0 Totalealtrianimalicheconsumanoforaggiogrezzo126629157305183024.19.1 Suini da allevamento di oltre 6 mesi e suinetti57 8155 12429 5041 72651.033.7 Rimonte fino a 6 mesi e suini da ingrasso97 32010 18659 8593 79961.537.3 Totalesuini1551351225889363459057.637.4 Galline e galli da allevamento9732 0521537115.73.5 Ovaiole16 93114 47412 7431 81375.312.5 Pulcini,galletti e pollastrelle2 0015131 30210265.019.9 Polli da ingrasso18 2051 04715 22974283.770.9 Tacchini2 0952981 95310193.233.9 Totalepollame402051621731379264778.016.3 Totalecategoriedianimali1149331488423866671845733.637.8 1 Aziende aventi diritto ai
Fonte:UFAG
contributi (aziende che hanno ottenuto pagamenti diretti)
Tabella 39
Partecipazione al programma URA – 2003
A44 ALLEGATO
Base1PartecipazioneURA CategoriedianimaliUBGAziendeUBGAziendeUBGAziende NumeroNumeroNumeroNumero%% Allevamentoereddito: Vacche lattifere620 17838 405437 13824 78370.564.5 Manze di oltre 1 anno146 86436 80895 78522 08365.260.0 Tori di oltre 1 anno5 0757 6702 4463 76148.249.0 Bestiame giovane,da 4 a 12 mesi,femmine31 75728 76617 99716 23056.756.4 Bestiame giovane,da 4 a 12 mesi,maschi1 8683 7144911 13226.330.5 Vitelli da allevamento fino a 4 mesi23 81025 4076 2296 25526.224.6 Vacchemadrienutrici: Vacche madri e nutrici con vitelli59 0805 59153 6884 47890.980.1 Ingrasso: Manze,tori,buoi di oltre 4 mesi37 4647 14315 8692 94542.441.2 Vitelli fino a 4 mesi4 1216 4819931 37524.121.2 Vitelli da ingrasso11 11117 9901 0141 6449.19.1 Totalebestiamebovino941329455186316493093667.168.0 Animali della specie equina32 25211 44026 2198 03181.370.2 Ovini38 3059 93329 9606 67478.267.2 Caprini8 2426 2075 7032 98369.248.1 Daini e cervi58517347012480.471.7 Bisonti181121781198.791.7 Conigli4 4203 7992413005.57.9 Totalealtrianimalicheconsumanoforaggiogrezzo8398523511627711448174.761.6 Suini da allevamento di oltre 6 mesi e suinetti57 8155 12428 7291 83149.735.7 Rimonte fino a 6 mesi e suini da ingrasso97 32010 18655 7923 78057.337.1 Totalesuini1551351225884521469254.538.3 Galline e galli da allevamento9732 052572875.814.0 Ovaiole16 93114 47410 5363 69462.225.5 Pulcini,galletti e pollastrelle2 00151327511813.723.0 Polli da ingrasso18 2051 0472 11221111.620.2 Tacchini2 0952981 93712692.542.3 Totalepollame402051621714917406537.125.1 Totalecategoriedianimali1220654520717938583659965.070.3 1 Aziende aventi diritto ai contributi (aziende che hanno ottenuto pagamenti diretti) Fonte:UFAG
Tabella 40
Contributi d'estivazione – 2003
CantonePecoreVacchemunte,pecoreAltrianimalicheconsumanoAziendeecontributi
1 Carico usuale per animali munti con una durata d'estivazione di 56-100 giorni
ALLEGATO A45
(escl.pecorelattifere)lattifereecaprelattifere1foraggiogrezzoTotale AziendeCaricousualeAziendeCaricousualeAziendeCaricousualeAziendeContributi NumeroCariconormaleNumeroUBGNumeroCariconormaleNumerofr. ZH00001048610 145 683 BE1832 34953713 4461 59448 2981 69218 891 018 LU44383562922506 1802551 987 373 UR811 5322273 8522413 1243522 362 301 SZ496302722 8094309 8064593 907 063 OW24249587862478 2402672 737 458 NW14144121171203 9991351 256 641 GL1760061481136 6601222 159 107 ZG0013102311070 158 FR606381422 07959921 5586357 218 832 SO36212572 49157751 630 BL00001038910 116 754 SH00001100129 889 AR11272911162 460117821 272 AI9951051 4861401 8771461 020 182 SG421 1781434 45344116 7064536 585 803 GR2008 40640514 64889432 4791 05415 597 640 AG42800840511 126 519 TG0000280223 901 TI881 882884 4071994 1912682 942 149 VD329031940064432 1486719 969 990 VS1756 2701345 83344216 3395287 701 138 NE3795991494 3511531 357 461 GE1850015227 096 JU2123178311 804833 574 240 Totale1032255802240551676801234409749391381298
Fonte:UFAG
Pagamenti diretti a livello aziendale1:per zone e classi di dimensione – 2003
1I risultati si basano sui dati della Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon 2 Contributi d'estivazione,contributi di coltivazione,altri contributi
A46 ALLEGATO
Tabella 41a
ZonadipianuraZC CaratteristicaUnità10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Aziende di riferimentoNumero60941213620611527 Aziende rappresentateNumero10 1075 8613 1113 4881 591605 Superficie agricola utileha 15.3123.9835.5614.9924.3536.97 Pagamenti diretti in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) Pagamentidirettigenerali,totalefr.237403648551780286024443264500 Contributi di superficiefr.20 88032 75247 54019 12131 33046 169 Contributi per animali da reddito che consumano foraggio grezzofr.2 3002 9273 7823 2995 4739 261 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.3234492654 2904 7345 094 Contributi di declivitàfr.2373571941 8932 8963 976 Contributiecologiciedetologici,totalefr.67499597138127841986814582 Compensazione ecologicafr.2 3683 2295 5052 3263 3434 682 Produzione estensivafr.6529671 3646391 0271 669 Agricoltura biologicafr.3674128644537561 019 Contributi etologicifr.3 3614 9896 0804 4234 7427 211 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.30 48946 08165 59336 44454 30179 082 Reddito lordofr.201 829289 321378 927179 398235 553310 963 Quota di PD giusta l'OPD sul reddito lordo%15.115.917.320.323.125.4 Altri pagamenti diretti 2 fr.1 6262 2114 8321 5322 9344 705 Totale pagamenti direttifr.32 11548 29270 42537 97657 23583 787 Quota totale di PD sul reddito lordo%15.916.718.621.224.326.9
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
Tabella 41b
Pagamenti diretti a livello aziendale1:per zone e classi di dimensione – 2003
1I risultati si basano sui dati della Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon 2 Contributi d'estivazione,contributi di coltivazione,altri contributi
ALLEGATO A47
ZMIZMII CaratteristicaUnità10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Aziende di riferimentoNumero1841073719210148 Aziende rappresentateNumero3 1471 2828443 0281 510982 Superficie agricola utileha 15.1324.0836.3915.0924.2736.61 Pagamenti diretti
Pagamentidirettigenerali,totalefr.343334856165543395215623471846 Contributi di superficiefr.18 34329 37544 14817 81029 07442 083 Contributi per animali da reddito che consumano foraggio grezzofr.4 5935 8327 6055 7868 89511 764 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.7 8989 1799 14011 92413 45413 692 Contributi di declivitàfr.3 4984 1754 6514 0014 8104 307 Contributiecologiciedetologici,totalefr.61009980135495699824610557 Compensazione ecologicafr.1 3622 0673 0651 2491 5631 677 Produzione estensivafr.2023751 8022186389 Agricoltura biologicafr.7181 2027109551 3952 552 Contributi etologicifr.3 8186 3367 9723 4745 2025 939 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.40 43258 54279 09245 21964 48082 403 Reddito lordofr.159 386232 925280 304153 095202 263231 483 Quota di PD giusta l'OPD sul reddito lordo%25.425.128.229.531.935.6 Altri pagamenti diretti 2 fr.1 4182 2914 8723 4144 7604 366 Totale pagamenti direttifr.41 85160 83383 96448 63369 23986 769 Quota totale di PD sul reddito lordo%26.326.130.031.834.237.5
in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
Fonte:Agroscope
FAT Tänikon
3
Tabella 41c
Pagamenti diretti a livello aziendale1:per zone e classi di dimensioni – 2003 ZMIIIZMIV CaratteristicaUnità10–2020–3030–5010–2020–3030–503 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU
Pagamenti diretti in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
1I
si basano sui dati della Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon
2 Contributi d'estivazione,contributi di coltivazione,altri contributi
non presentati a causa di una campionatura troppo ridotta Fonte:Agroscope
A48 ALLEGATO
Aziende di riferimentoNumero89582369235 Aziende rappresentateNumero1 6421 0074611 567395 Superficie agricola utileha 14.3223.9835.7814.0823.84
Pagamentidirettigenerali,totalefr.4628066732844154930668911 Contributi di superficiefr.17 12328 81041 21316 89128 226 Contributi per animali da reddito che consumano foraggio grezzofr.10 14413 13615 46410 28411 640 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.14 32118 12919 52617 11621 585 Contributi di declivitàfr.4 6926 6578 2125 0157 460 Contributiecologiciedetologici,totalefr.413779791353637158420 Compensazione ecologicafr.1 1691 5774 5921 0822 494 Produzione estensivafr.0184600 Agricoltura biologicafr.7642 1553 1057152 477 Contributi etologicifr.2 2044 2295 7931 9183 449 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.50 41774 71197 95153 02177 332 Reddito lordofr.114 516169 633225 104110 088171 097 Quota di PD giusta l'OPD sul reddito lordo%44.044.043.548.245.2 Altri pagamenti diretti 2 fr.3 5813 1417 7683 7415 668 Totale pagamenti direttifr.53 99877 852105 71956 76183 000 Quota totale di PD sul reddito lordo%47.245.947.051.648.5
risultati
Risultati
FAT Tänikon
Tabella 42
Pagamenti diretti a livello aziendale1:per regioni – 2003
in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
di coltivazione,altri contributi
ALLEGATO A49
CaratteristicaUnitàTutteleRegioneRegioneRegione aziendedipianuracollinaredimontagna Aziende di riferimentoNumero2 6631 219745699 Aziende rappresentateNumero50 51622 53314 06213 921 Superficie agricola utileha 19.1019.7918.4818.60 Pagamenti diretti
Pagamentidirettigenerali,totalefr.36936298433651348846 Contributi di superficiefr.24 27126 64922 70722 002 Contributi per animali da reddito che consumano foraggio grezzofr.4 8842 5354 8538 716 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.5 6323576 13213 665 Contributi di declivitàfr.2 1503022 8214 464 Contributiecologiciedetologici,totalefr.7474822178565878 Compensazione ecologicafr.2 2512 8622 1711 342 Produzione estensivafr.54779961372 Agricoltura biologicafr.6694136291 125 Contributi etologicifr.4 0074 1474 4423 339 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.44 41038 06444 36854 725 Reddito lordofr.203 189247 188186 427148 901 Quota di PD giusta l'OPD sul reddito lordo%21.915.423.836.8 Pagamenti diretti per ettarofr./ha2 3261 9232 4012 942 Altri pagamenti diretti 2 fr.2 6362 2012 1263 856 Totale pagamenti direttifr.47 04640 26546 49458 581 Quota totale di PD sul reddito lordo%23.216.324.939.3 1 I risultati si basano
2 Contributi d'estivazione,contributi
Fonte:Agroscope FAT Tänikon
sui dati della Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon
A50 ALLEGATO
NumeroNumero%Numero%NumeroNumero ZH3 6583 6571.001 61244085000270000112 BE12 74612 6551.0112 7461009139145897451451324589 LU5 2795 1331.034 4658503115658133216217220419 UR6656651.00610921160 211000021 SZ1 7321 6951.029265355314 020000377 OW7047041.00484690335513 7801116134 NW4994991.00258520382927 2200211111 GL4214161.01253600510 8010013459 ZG5865721.02263450411 102000119 FR3 3803 2341.051 179351187756341031830355 SO1 4361 4301.001 436100n.d.468544 39513021244 BL9689651.00968100253812 13103469 SH5885821.0149684021700612131363 AR7767731.004856303216 0000004694 AI5715740.9927248034238 90000588 SG4 4034 3651.011 59536493129931110131264 GR2 7262 7460.991 98073345929111613273255 AG3 2383 0971.051 58449126661020182040445385 TG2 7872 7071.031 89368354716828028891068401 TI9339161.0234737014659 13000048257 VD4 1284 0301.021 7434213917732671423282540410 VS3 7983 7871.002 284604261 420010038 NE9469461.0041244002212 081412371 GE3153101.02273871100 0121002035 JU1 1081 1081.0043539323024 02442071 CH58391575661.0138999672171245132341718424794793095264641 n.d.= non disponibile Fonte:rapporti cantonali concernenti i controlli e le sanzioni Cantone Aziende notificate Aziende aventi diritto a PD Aziende notif./aziende aventi diritto a PD Aziende controllate Aziende controllate in % delle aziende notificate Notifica tardiva Detenz.anim.da reddito rispettosa delle esigenze Registrazioni Bilancio di concimazione equilibrato Quota adeguata di sup.di compensazione ecologica Fasce tampone e di superficie inerbita Avvicendamento discipl.delle colture Protezione adeguata del suolo Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante Altro Totale contestazioni
Tabella
43a Controlli PER – 2003 Contestazioni
n.d.=
Fonte:rapporti
ALLEGATO A51
%Numero%fr.fr. ZH7112781190 874 BE523721 009239 230 LU911731 152134 824 UR321357412 057 SZ84751 74381 914 OW282651 29533 671 NW43932 32020 881 GL231048858 852 ZG7523 91619 578 FR30252211 900478 905 SO177151 517107 712 BL72532 18454 598 SH133372 48581 994 AR19721526419 024 AI32936195 567 SG1726417992261 802 GR13196101 475289 148 AG2410572 190229 934 TG219151 01992 715 TI74122351 384168 863 VD24209122 773579 494 VS23822 59698 647 NE17927646 875 GE13931 74415 700 JU1670161 640114 787 CH122159615043247646
Tabella 43b Controlli PER – 2003
non disponibile
cantonali concernenti i controlli e le sanzioni Cantone Contestazioni per 100 aziende controllate Aziende con sanzioni Aziende con sanzioni per 100 aziende controllate Sanzione in fr.per azienda sanzionata Totale sanzioni
Uscite nel settore del miglioramento delle basi
Tabella 44
Contributi versati ai Cantoni – 2003
A52 ALLEGATO
CantoneBonifichefondiarieEdificiagricoliTotalecontributi fr.fr.fr. ZH1 555 443539 2002 094 643 BE7 468 4247 096 20014 564 624 LU3 093 8271 216 8004 310 627 UR854 800570 0001 424 800 SZ1 502 2411 011 5002 513 741 OW361 800699 5001 061 300 NW428 756281 695710 451 GL562 989371 400934 389 ZG16 900345 500362 400 FR3 953 5183 514 0007 467 518 SO1 533 967298 6001 832 567 BL252 134565 000817 134 SH11 25019 60030 850 AR2 323 406868 3003 191 706 AI458 163590 1151 048 278 SG3 889 5082 540 6006 430 108 GR20 899 0537 016 98027 916 033 AG1 042 641574 5001 617 141 TG923 05425 000948 054 TI1 373 5531 423 7802 797 333 VD7 406 937738 4008 145 337 VS4 182 0791 272 3005 454 379 NE676 1421 734 7002 410 842 GE87 00087 000 JU2 320 3031 470 8503 791 153 Diversi37 67237 672 Totale6721556034784520102000080 Fonte:UFAG
Tabella 45
Contributi a progetti approvati,secondo i provvedimenti e le regioni – 2003
ALLEGATO A53
ProvvedimentoContributiCosti complessivi RegioneRegioneRegioneTotaleTotale dipianuracollinaredimontagna 1000fr. Bonifichefondiarie Ricomposizioni particellari (compr.infrastrutt.)13 6081 3727 01121 99067 255 Costruzione di strade agricole1 1102 92011 02015 05149 801 Altri impianti di trasporto 4994991'572 Provvedimenti volti a conservare e migliorare il bilancio idrico del suolo9462699742 1898 091 Acquedotti1 7567 3379 09242 610 Approvvigionamento elettrico207484006552 497 Rispristino e protezione361 73725 74927 52254 729 Acquisto dei dati di base782317119454 Totale1598481255300777116227009 Edificiagricoli Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo10 37915 33625 715159 629 Edifici alpestri302 0112 04115 592 Edifici collettivi per lavorazione e stoccaggio1 0541 0547 735 Totaleintermedio104091840128810182956 Totale159841853471407105926409965 Fonte:UFAG
Crediti d'investimento accordati dai Cantoni – 2003
A54 ALLEGATO
Tabella 46
CantoneProvvedimentiProvvedimentiTotale collettiviindividuali CreditidicostruzioneCreditid'investimentoCreditid'investimento Numero1000fr.Numero1000fr.Numero1000fr.Numero1000fr. ZH441410013 23410413 648 BE122 412121 40437342 89839746 714 LU42 360585223325 77424228 986 UR 252 165252 165 SZ111 1548403465 578657 135 OW2102273 004293 106 NW2202212 288232 490 GL 111 146111 146 ZG 223 117223 117 FR770817724 93618425 644 SO21 0752230586 502627 807 BL258424 554444 612 SH 263 277263 277 AR 353 194353 194 AI264373 763393 828 SG35751093121825 50223127 008 GR53 58071 058829 3409413 978 AG447011011 50311411 973 TG 718 922718 922 TI51 4743466242 867324 807 VD221 63215318 18117519 812 VS62 153181 543242 509486 205 NE3788354 449385 237 GE5508131 424181 932 JU3161617 389647 550 Totale48147831211199420242375162193264292 Fonte:UFAG
Tabella 47
Crediti d'investimento secondo le categorie di provvedimenti – 2003 (senza crediti di costruzione)
ALLEGATO A55
CantoneAiutoAcquistoEdificioEdificioAcquistoLavorazioneBonificheTotale inizialedell'aziendad'abitazioneruraleincomuneestoccaggiofondiarie dapartedell'inventariodiprodotti dell'affittuarioagricoli 1000fr. ZH3 6752902 5266 74311015415013 648 BE19 5101 3707 34014 6781 3545044 302 LU8 0351505 99911 59070814426 626 UR6251 0904502 165 SZ1 7702 8629461003035 981 OW9908131 20150523 106 NW9909243742022 490 GL6602302561 146 ZG1 0802101 8273 117 FR8 4009882 25513 2936010654225 644 SO2 9707402 7912306 732 BL2 0555301 969584 612 SH1 6503001 3273 277 AR6603291 1221 0833 194 AI6906122 461643 828 SG7 8305143 51113 64793126 433 GR2 4622 2314 6471 05810 398 AG5 6401 6854 17811414621011 973 TG3 9404634 5198 922 TI3004922 0754663 333 VD7 6658472 3877 28265158140019 812 VS2608191 430241 1154044 052 NE1 7405306681 511183704005 237 GE6008243082001 932 JU2 6108623 91799627 550 Totale86807501840670105020144276952857249509 Fonte:UFAG
Tabella 48
Mutui accordati dai Cantoni nel quadro dell'aiuto alla conduzione aziendale – 2003 (quote federali e cantonali)
A56 ALLEGATO
CantoneNumeroImportoPersingolocasoDurataammortamento 1000fr.1000fr.anni ZH7 1 14716416 BE25 3 68614715 LU42 6 07714518 UR1 10010016 SZ2 1708515 OW2 33016517 NW5 4969914 GL ZG FR14 1 5661129 SO11 8397610 BL6 4507510 SH1 10010014 AR4 2807010 AI SG18 1 7709813 GR8 6077615 AG7 5958511 TG3 50016712 TI6 66411116 VD43 6 98416213 VS9 1 35015015 NE4 46011510 GE1 45045012 JU30 1 194405 Totale24929815Ø:120Ø:13 Fonte:UFAG
dei crediti d'investimento e dei mutui per l'aiuto alla conduzione aziendale
ALLEGATO A57 Tabella 49a Ricapitolazione dei
ProvvedimentoProgettiapprovatiin1000fr. 200120022003 Contributi9569077214105926 Ricomposizioni particellari comprese le infrastrutture27 41622 68721 990 Costruzione di strade agricole12 0539 24315 051 Acquedotti 5 9685 5669 092 Altri provvedimenti del genio civile19 2855 68430 983 Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo28 48331 41025 715 Altri provvedimenti nel settore delle costruzioni rurali2 4852 6243 095 Fonte:UFAG Tabella 49b Ricapitolazione
ProvvedimentoCreditiaccordatiin1000fr. 200120022003 Creditid'investimento1265105283412249509 Aiuto iniziale 69 98489 52086 807 Acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario5 1735 5355 018 Edifici d'abitazione 44 36044 86640 670 Edifici rurali 132 921128 221105 020 Acquisto in comune dell'inventario,lavorazione e stoccaggio di prodotti agricoli11 52610 5839 137 Bonifiche fondiarie 1 1414 6872 857 Mutuiperl'aiutoallaconduzioneaziendale1344133516429815 1Accordati dal Cantone Fonte:UFAG Tabella 50 Aiuti finanziari all'allevamento di animali – 2003 SpecieanimaleeprovvedimentiImportoAnimaliLGOrganizzazioni d'allevamento fr.Numero Bovini138430005472498 Tenuta del libro genealogico2 736 000 Esami funzionali per la produzione di latte e carne10 439 000 Apprezzamento della conformazione668 000 Equini11210004640122 Suini1715000161061 Ovini1098000900142 Capriniepecorelattifere812000291504 Tenuta del libro genealogico583 000 Esami funzionali per la produzione di latte e carne 229 000 Razzeminacciate7740005 Totale19363000 1 Puledri identificati Fonti:Conto dello Stato / Organizzazioni d'allevamento
contributi
Conto dello Stato 1999 rappresenta la base per la ripartizione dei mezzi finanziari fra i singoli settori. Le uscite per la valorizzazione delle patate o della frutta o quelle dell'Amministrazione dei cereali 1990/92,ad esempio, figurano come uscite dell'UFAG.All'epoca esistevano ancora conti separati.Per tale motivo le cifre relative al 1990/92 non sono identiche a quelle figuranti nel Conto dello Stato.L'aumento delle spese d'amministrazione è riconducibile in primo luogo al fatto che alcune prestazioni,come ad esempio quelle per le Casse pensioni, non sono più riportate come un'unica rubrica nel Conto dello Stato,bensì ripartite fra i singoli Uffici.
1 Le uscite straordinarie nel settore lattiero sono comprese nel presente importo.Ciò è andato a carico di altri settori, come p.es.miglioramento delle strutture e produzione animale.
Fonti:Conto dello Stato,UFAG
A58 ALLEGATO Tabella 51
della Confederazione per agricoltura e alimentazione,in 1000 fr. Ambitodispesa1990/922001200220031990/92–2001/03 % UsciteUFAG269944235657763683702352573333.1 Produzioneesmercio16849949015579786191798028-47.0 Promozione dello smercio59 99858 79859 234 Economia lattiera1 127 273666 149753 583559 979-41.5 Produzione animale133 90246 37020 33724 851-77.2 Produzione vegetale423 819129 040145 901153 964-66.3 Pagamentidiretti772258233357524286732435000210.7 Pagamenti diretti generali758 3321 916 5801 981 4321 980 000158.4 Pagamenti diretti ecologici13 926416 995447 241455 0003 057.7 Miglioramentodellebasi20876127658822282024235318.4 Miglioramenti strutturali133 879102 05890 000102 000-26.8 Crediti d'investimento27 13698 18070 00079 418204.1 Aiuti per la conduzione aziendale95230 0009 00011 7201 675.9 Consulenza e contributi per la ricerca21 47623 03923 73723 7369.4 Lotta alle malattie delle piante e ai fitofagi1 4492 1198 9963 641239.5 Produzione vegetale e animale23 86921 19221 08721 838-10.5 Amministrazione3342954056535905032257.5 Altreuscite34816339644638349738150211.2 Contributi d'esportazione per prodotti agricoli trasformati93 86798 355114 900114 90016.5 Assegni familiari nell'agricoltura77 99691 44780 40081 2008.1 Stazioni di ricerche agronomiche96 431122 127118 297121 68525.2 Istituto nazionale d'allevamento equino6 8437 0087 1967 6406.4 Altre73 02677 50962 70456 077-10.4 Totaleagricolturaealimentazione304760539622224067199390723530.6 Osservazione:il
Uscite
■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Aspetti internazionali
UE-4:si riferisce a:Germania (D),Francia (F),Italia (I) e Austria (A)
UE-5:UE-4 più Paesi Bassi (NL) o Belgio (B)
UE-6:UE-4 più Paesi Bassi (NL) e Belgio (B)
D:Repubblica federale di Germania (compr.ex DDR dal 1991)
Avvertenza:le cifre in corsivo sono calcolate sulla base di indici (Eurostat)
Fonti:UFAG,UST,USC,Banca Nazionale Svizzera,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ALLEGATO A59
Tabella 52
ProdottoPaeseUnità1990/922001200220031990/92–2001/03 % LatteCHct./kg104.9779.9078.3975.54-26 UE-5ct./kg56.5550.7146.8747.07-15 - Dct./kg 57.28 52.1746.2145.16-16 - Fct./kg48.6747.5344.9546.08-5 - Ict./kg68.76 53.1051.9453.96 -23 - Act./kg66.6449.9546.2745.14-29 - NLct./kg57.9351.8848.0147.95-15 USA ct./kg40.5755.8141.5537.1010 TorelliCHfr./kgPM9.286.857.238.19-20 UE-4fr./kg PM5.593.544.014.18-30 - Dfr./kg PM5.223.203.673.79-32 - Ffr./kg PM5.563.484.014.13-30 - Ifr./kg PM5.833.874.334.58-27 - Afr./kg PM6.493.703.934.09-40 USAfr./kg PM4.355.114.384.588 VitelliCHfr./kgPM14.3912.0311.7712.15-17 UE-5fr./kg PM8.657.387.137.95-13 - Dfr./kg PM8.988.198.509.68-2 - Ffr./kg PM8.948.428.038.76-6 - Ifr./kg PM8.816.786.407.05-23 - A (dal 92)fr./kg PM9.606.386.227.03-32 - NLfr./kg PM7.836.136.006.97-19 USAfr./kg PM5.056.835.715.3218 SuiniCHfr./kgPM5.834.544.474.69-22 UE-6fr./kg PM2.932.471.931.88-28 - Dfr./kg PM2.882.521.981.91-26 - Ffr./kg PM2.842.491.901.87-27 - Ifr./kg PM3.48 2.992.402.48 -25 - Afr./kg PM 3.18 2.151.661.54-44 - NLfr./kg PM2.642.001.611.54-35 - Bfr./kg PM3.012.551.961.84-30 USAfr./kg PM1.882.081.441.41-12 PolliCHfr./kgPV3.722.762.722.72-27 UE-5fr./kg PV1.491.171.071.14-24 - Dfr./kg PV1.431.171.051.10-23 - Ffr./kg PV1.301.071.001.02-21 - Ifr./kg PV1.891.421.281.50-26 - Afr./kg PV2.291.231.181.22-47 - NLfr./kg PV1.361.090.930.96-27 USAfr./kg PV0.981.471.071.0522 UovaCHfr./100pz.33.2923.1223.4423.44-30 UE-5fr./100 pz.10.678.688.4810.52-14 - Dfr./100 pz. 13.12 9.719.6411.91-21 - Ffr./100 pz.8.606.756.188.05-19 - Ifr./100 pz.12.86 11.5411.6213.19 -6 - Afr./100 pz.12.6713.5013.3616.6715 - NLfr./100 pz.7.946.526.418.77-9 USAfr./100 pz.7.558.667.828.4310
Prezzi alla produzione di prodotti di origine animale Svizzera – diversi Paesi
Prezzi alla produzione di prodotti di origine vegetaleSvizzera – diversi Paesi
UE-4:si riferisce a:Germania (D),Francia (F),Italia (I) e Austria (A)
UE-5:UE-4 più Paesi Bassi (NL) o Belgio (B)
UE-6:UE-4 più Paesi Bassi (NL) e Belgio (B)
D:Repubblica federale di Germania (compr.ex DDR dal 1991)
1 Media di 4 anni (alternanza) 1990/93 e variazione 1990/93–2000/03
Avvertenza:le cifre in corsivo sono calcolate sulla base di indici (Eurostat)
Fonti:UFAG,UST,USC,Banca Nazionale Svizzera,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
A60 ALLEGATO
Tabella 53a
ProdottoPaeseUnità1990/922001200220031990/92–2000/02 % FrumentoCHfr./100kg99.3455.6556.6361.13-42 UE-4fr./100 kg28.5917.4915.6517.78-41 - Dfr./100 kg26.8116.8514.8816.78-40 - Ffr./100 kg28.3717.3415.6418.05-40 - Ifr./100 kg35.92 23.4220.9822.11 -38 - Afr./100 kg43.3015.9014.3315.30-65 USA fr./100 kg15.3217.5519.2516.9817 OrzoCHfr./100kg70.2445.0844.8845.82-36 UE-4fr./100 kg25.9715.7313.5715.37-43 - Dfr./100 kg24.4714.8912.7214.45-43 - Ffr./100 kg25.6716.1613.9216.03-40 - Ifr./100 kg34.52 21.8619.8821.38 -39 - Afr./100 kg36.0514.4212.8913.29-62 USAfr./100 kg12.3013.6413.9814.0013 MaisdagranellaCHfr./100kg73.5443.3345.1746.31-39 UE-4fr./100 kg33.7219.0318.0820.36-43 - Dfr./100 kg30.4417.5515.8618.95-43 - Ffr./100 kg29.6318.2716.7818.87-39 - Ifr./100 kg40.80 21.2621.3923.32 -46 - Afr./100 kg36.3715.4214.6719.47-55 USAfr./100 kg12.7612.5313.1012.01-2 PatateCHfr./100kg38.5535.1534.9436.21-8 UE-6fr./100 kg16.9914.3415.1816.86-9 - Dfr./100 kg13.699.8512.4114.11-11 - Ffr./100 kg15.5013.3515.1012.86-11 - Ifr./100 kg43.79 49.2849.0953.49 16 - Afr./100 kg30.3613.8012.6322.78-46 - NLfr./100 kg16.3113.2912.6913.51-19 - Bfr./100 kg12.4912.268.5817.673 USAfr./100 kg18.0822.5227.5818.3226 BarbabietoledazuccheroCHfr./100kg14.8413.3011.6411.87-17 UE-4fr./100 kg7.376.645.946.15-15 - Dfr./100 kg7.896.716.526.76-16 - Ffr./100 kg5.845.944.915.09-9 - Ifr./100 kg9.59 8.107.057.25 -22 - A (dal 92)fr./100 kg9.217.066.857.11-24 USAfr./100 kg----ColzaCHfr./100kg203.6779.5778.5681.69-61 UE-4fr./100 kg48.7133.7033.1636.04-30 - Dfr./100 kg55.4532.9432.2634.91-40 - Ffr./100 kg41.7734.8634.4637.64-15 - Ifr./100 kg52.5323.2323.8625.48-54 - A (dal 92)fr./100 kg53.6928.9828.0629.87-46 USAfr./100 kg----Mele:GoldenDelicious1CHfr./kg1.121.040.821.21-12 UE-5fr./kg0.790.530.580.63-30 - Dfr./kg 1.07 0.550.610.70-45 - Ffr./kg0.68 0.510.560.57 -22 - Ifr./kg0.75 0.580.630.69 -21 - A (div.)fr./kg1.020.490.500.65-50 - Bfr./kg0.800.440.420.54-43 USA (div.)fr./kg0.660.660.820.7311
Prezzi alla produzione di prodotti di origine vegetale Svizzera – diversi Paesi
UE-4:si riferisce a:Germania (D),Francia (F),Italia (I) e Austria (A)
UE-5:UE-4 più Paesi Bassi (NL) o Belgio (B)
UE-6:UE-4 più Paesi Bassi (NL) e Belgio (B)
UE-4/6:Stati membri dell'UE confinanti con la Svizzera (D,F,I,A) nonché Belgio (B) e/o Paesi Bassi (NL) per prodotti dai volumi di produzione ragguardevoli
D:Repubblica federale di Germania (compr.ex DDR dal 1991)
1 Media di 4 anni (alternanza) 1990/93 e variazione 1990/93–2000/03
2 Il paniere standard è composto a grandi linee dalla produzione media (1998–2000) svizzera di 15 dei 17 prodotti agricoli oggetto del presente confronto internazionale dei prezzi (tabelle 52 e 53).Le statistiche sui prezzi delle barbabietole da zucchero e della colza praticati negli USA non erano disponibili e pertanto questi prodotti sono stati esclusi dal paniere standard.Esso comporta 3,2 milioni di tonnellate di latte,2,7 milioni di suini,35,5 milioni di polli,674,3 milioni di uova,0,52 milioni di tonnellate di frumento,0,14 milioni di tonnellate di mele,eccetera.
Avvertenza:le cifre in corsivo sono calcolate sulla base di indici (Eurostat)
Fonti:UFAG,UST,USC,Banca Nazionale Svizzera,Eurostat,ZMP,Agreste,U.S.Department of Agriculture
ALLEGATO A61
Tabella 53b
ProdottoPaeseUnità1990/922001200220031990/92–2001/03 % PereI1CHfr./kg1.331.170.921.24-21 UE-5fr./kg0.960.770.770.83-20 - Dfr./kg 1.10 0.740.610.75-40 - Ffr./kg1.090.981.001.15-6 - Ifr./kg0.90 0.690.660.69 -26 - A (dal 92)fr./kg1.200.680.911.00-34 - Bfr./kg0.950.880.970.94-6 USAfr./kg0.570.710.610.6210 CaroteCHfr./kg1.091.201.281.3417 UE-6fr./kg0.520.640.620.6019 - Dfr./kg 0.48 0.480.440.37-9 - Ffr./kg0.440.680.520.6339 - Ifr./kg0.83 1.021.111.06 28 - Afr./kg0.420.320.290.26-31 - NLfr./kg0.390.400.460.365 - Bfr./kg0.360.290.310.26-20 USAfr./kg0.410.660.680.6058 CipolleCHfr./kg0.891.191.211.2537 UE-5fr./kg0.540.570.460.54-3 - Dfr./kg 0.30 0.280.250.30-8 - Ffr./kg0.60 1.060.720.86 47 - Ifr./kg0.700.410.420.48-38 - Afr./kg0.250.220.230.24-8 - Bfr./kg0.210.290.370.3152 USAfr./kg0.400.520.460.5831 PomodoriCHfr./kg2.421.902.322.69-5 UE-6fr./kg0.980.730.790.90-17 - Dfr./kg 0.89 0.971.171.3129 - Ffr./kg1.31 1.111.351.46 0 - Ifr./kg0.900.650.650.76-24 - A (dal 92)fr./kg0.390.830.991.18153 - NLfr./kg1.250.911.211.650 - Bfr./kg1.221.121.280.89-10 USAfr./kg1.001.161.121.1113 Panierestandard2CHmio.difr./anno7268552554515579-24 UE-4/6mio.di fr./anno3 7153 1102 8622 948-20 - Dmio.di fr./anno3 7423 1622 8752 931-20 - Fmio.di fr./anno3 4133 0562 8332 933-14 - Imio.di fr./anno4 4493 5113 3323 511-22 - Amio.di fr./anno4 3792 9762 7422 815-35 USAmio.di fr./anno2 5793 3032 6382 4268
Tabella 54
Prezzi al consumo di prodotti di origine animale Svizzera – diversi Paesi
UE-4:si riferisce a:Germania (D),Francia (F),Italia (I) e Austria (A)
Osservazione in merito al Paese:(min) e (max) -> prezzo più basso,rispettivamente più alto registrato in un anno nel Paese in questione
Avvertenza:la quota «label» (Bio,M-7,Coop Natura Plan) riscontrabile nei negozi,segnatamente per il settore della carne,è più elevata in Svizzera che all'estero
Fonti:UFAG,UST,ZMP,Uffici nazionali di statistica di F,B,A,USA,Ufficio di statistica della città di Torino (I)
A62 ALLEGATO
ProdottoPaeseUnità1990/922001200220031990/92–2001/03 % LattediconsumoCHfr./l1.851.551.561.53-16 UE-4fr./l1.301.131.131.16-12 - min (D:90/92,00,01,02)fr./l1.070.910.890.88-16 - max (I:90/92,00,01,02)fr./l1.821.821.831.963 USAfr./l1.041.291.130.989 FormaggioCH-Emmentalerfr./kg20.1520.5920.3320.892 UE-4 (UE-4 con B,senza F)fr./kg15.9812.5412.3812.82-21 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg13.5210.069.909.87-26 - max (I:90/92,B:00,01,02)fr./kg20.6817.1317.0018.25-16 USA (Cheddar)fr./kg11.1414.9714.4711.7123 BurroCHfr./kg13.7612.1212.2411.97-12 UE-4fr./kg9.048.077.647.94-13 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg6.815.925.165.23-20 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg12.9011.6611.4011.88-10 USAfr./kg5.9612.2710.548.3474 PannaCHfr./1⁄4l3.582.792.792.91-21 UE-3 (UE-4 con B,senza F e I)fr./ 1⁄4 l1.250.980.950.95-23 - min (D:90/92,00,01,02)fr./ 1⁄4 l1.130.910.860.86-23 - max (A:90/92,B:00,01,02)fr./ 1⁄4 l2.531.621.591.69-35 USAfr./ 1⁄4 l ArrostodimanzoCHfr./kg26.3425.9626.3527.161 UE-4fr./kg16.0014.8414.4015.37-7 - min (F:90/92,00,01,02)fr./kg11.8511.7811.6912.491 - max (A:90/92,00,01,02)fr./kg24.3223.1022.6824.20-4 USAfr./kg9.2611.9411.9410.9425 ArrostodimaialeCHfr./kg18.4319.3119.3519.906 UE-4fr./kg11.8012.0211.2011.44-2 - min (A:90/92,01;D:00,02)fr./kg10.0010.439.599.43-2 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg13.6713.7013.2514.050 USAfr./kg CotolettedimaialeCHfr./kg19.8820.7420.4021.325 UE-4fr./kg10.6210.189.399.65-8 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg9.719.538.548.55-9 - max (I:90/92,01;A:00,02)fr./kg12.4311.0610.3610.88-13 USAfr./kg10.0213.0911.679.2713 ProsciuttoCHfr./kg25.5628.4930.2429.9916 UE-4fr./kg22.1320.9920.2021.01-6 - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg20.3819.8018.6518.69-7 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg27.1523.4923.9926.30-9 USAfr./kg8.8510.199.678.577 PollifreschiCHfr./kg8.419.139.358.909 UE-4fr./kg5.725.395.055.20-9 - min (F:90/92,00,01,02)fr./kg4.844.134.074.23-14 - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg6.176.315.906.652 USAfr./kg2.744.113.683.0732 UovaCHfr./pz.0.570.600.610.617 UE-4 (UE-4 con B,senza F)fr./pz.0.250.250.240.261 - min (B:90/92,00,01,02)fr./pz.0.220.220.220.251 - max
USAfr./pz.0.100.160.140.1232
(A:90/92,00,01,02)fr./pz.0.330.350.340.376
Tabella 55
Prezzi al consumo di prodotti di origine vegetale e del paniere standard Svizzera – diversi Paesi
UE-4/5fr./paniere1 5731 4111 3751 433-11%
Media inferiore UEfr./paniere1 3141 1811 1421 167-11%
Media superiore UEfr./paniere2 1021 8851 8732 001-9% USA 2 fr./paniere1 1081 5471 4651 23828%
UE-4:si riferisce a:Germania (D),Francia (F),Italia (I) e Austria (A)
Osservazione in merito al Paese:(min) e (max) -> prezzo più basso,rispettivamente più alto registrato in un anno nel Paese in questione
1 Media di 4 anni (alternanza) 1990/93 e variazione 1990/93–2000/03
2 In mancanza di statistiche sui prezzi di panna (32,27 confezioni da 1/4 di l),arrosto di maiale (8,43 kg),cipolle (4,53 kg) e carote (8,84 kg),il paniere standard degli USA non è identico a quello di Svizzera e UE.Per questi quattro prodotti mancanti nel paniere standard sono stati aggiunti 8,07 kg di burro,8,43 kg di cotolette di maiale,4,53 kg di pomodori e 8,84 kg di patate.
3 Il paniere standard corrisponde a grandi linee al consumo annuo medio di un abitante della Svizzera (tabella 10) delle 21 derrate alimentari oggetto del presente confronto internazionale dei prezzi (tabelle 54 e 55).Si sottolinea a grandi linee in quanto,ad esempio,la categoria della carne di manzo è rappresentata soltanto dall'arrosto di manzo. Il paniere rappresenta 380 kg ossia il 91 per cento dei 417 kg di derrate alimentari (vino escluso) consumati annualmente da un abitante della Svizzera.È composto da 83,03 litri di latte,19,80 kg di formaggio,5,77 kg di burro,32,27 confezioni da 1/4 di litro di panna,10,17 kg di arrosto di manzo,8,43 kg di arrosto di maiale,8,43 kg di cotolette di maiale,8,43 kg di prosciutto,9,81 kg di pollo fresco,187 uova,25,25 kg di farina bianca,50,50 pagnotte di pane bianco da 500 gr,43,29 kg di patate, 47,71 kg di zucchero,17,09 litri d'olio vegetale,14,39 kg di mele Golden,3,33 kg di pere,10,15 kg di banane,8,84 kg di carote,4,53 kg di cipolle e 9,89 kg di pomodori. Fonti:UFAG,UST,ZMP,Uffici nazionali di statistica di F,B,A,USA,Ufficio di statistica della città di Torino (I)
ALLEGATO A63
ProdottoPaeseUnità1990/922001200220031990/92–2001/03 % FarinabiancaCHfr./kg2.051.671.601.71-19% UE-4 (UE-4 con B,senza F)fr./kg1.100.930.920.94-15% - min (D:90/92;B:00,01,02)fr./kg0.790.780.770.820% - max (A:90/92,00,01,02)fr./kg1.671.101.101.17-33% USAfr./kg0.751.121.070.9238% PanebiancoCHfr./1⁄2kg2.091.751.741.80-16% UE-4fr./ 1⁄2 kg1.491.481.471.561% - min (D:90/92,00,01,02)fr./ 1⁄2 kg1.160.970.940.97-17% - max (A:90/92,00,01,02)fr./ 1⁄2 kg2.982.962.903.120% USAfr./ 1⁄2 kg1.121.861.741.4852% PatateCHfr./kg1.432.032.082.1646% UE-5 (UE-4 con B)fr./kg0.921.101.061.1620% - min (B:90/92;D:00,01,02)fr./kg0.560.790.770.8343% - max (A:90/92;F:00,01,02)fr./kg1.271.621.581.6627% USAfr./kg1.041.451.691.3644% ZuccheroCHfr./kg1.651.421.471.59-9% UE-3 (UE-4 con B,senza D,F)fr./kg1.751.491.441.51-15% - min (B:90/92,00,01,02)fr./kg1.671.411.381.46-15% - max (A:90/92,00,01,02)fr./kg1.891.661.601.66-13% USAfr./kg1.221.561.441.2516% OliovegetaleCH-Girasolefr./l5.053.753.884.30-21% UE-4 (UE-4 con B,senza D)fr./l2.812.262.322.48-16% - min (I:90/92,00,01,02)fr./l1.942.012.022.197% - max (F:90/92;F:00,01,02)fr./l3.562.452.572.71-28% USA - olio per insalatafr./l2.263.293.703.3753% MeleGoldenDelicious1CHfr./kg3.153.413.813.6713% UE-4 (F e A:div.varietà)fr./kg3.162.502.592.76-19% - min (A:90/92;I:00,01,02)fr./kg2.942.122.192.33-27% - max (D:90/92;F:00,01,02)fr./kg3.252.792.993.25-10% USAfr./kg2.583.233.252.9124% Pere1CHfr./kg3.253.463.603.699% UE-4fr./kg3.432.752.872.97-17% - min (D:90/92,02;I:00,01)fr./kg3.322.482.642.68-23% - max (F:90/92,00,01,02)fr./kg3.623.073.363.53-9% USAfr./kg2.523.593.422.9434% BananeCHfr./kg2.522.863.063.0619% UE-4fr./kg2.612.332.142.15-15% - min (D:90/92,00,01,02)fr./kg1.892.161.911.865% - max (I:90/92;A:00,01,02)fr./kg3.562.582.512.49-29% USAfr./kg1.451.881.741.5118% CaroteCHfr./kg1.912.112.092.2612% UE-5 (UE-4 con B)fr./kg1.711.521.431.44-15% - min (B:90/92,00,01,02)fr./kg1.061.161.101.126% - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg2.321.671.751.78-25% USAfr./kg1.35 CipolleCHfr./kg1.862.292.562.3930% UE-5 (UE-4 con B)fr./kg1.541.671.651.709% - min (B:90/92,00,01,02)fr./kg0.920.991.071.0914% - max (I:90/92;F:00,01,02)fr./kg1.752.082.272.4229% USAfr./kg1.29 PomodoriCHfr./kg3.733.213.753.67-5% UE-5 (UE-4 con B)fr./kg3.603.103.583.60-5% - min (F:90/92;D:01,02;A:00)fr./kg3.332.692.982.80-15% - max (I:90/92,00,01,02)fr./kg4.413.734.454.72-3% USA (in pieno campo)fr./kg3.294.914.544.4841% Panierestandard (prod.anim.eveg.)3fr./paniere22712241227723210%
Leggi
–LF del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura,LAgr,RS 910.1)
–LF del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR,RS 211.412.11)
–LF del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (LAAgr,RS 221.213.2)
–LF dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese,LAP,RS 531)
–LF del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72)
–Legge sulla tariffa delle dogane (LTD,RS 632.10)
–LF del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali (RS 232.16)
–LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF,RS 836.1)
–LF del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio,LPT,RS 700)
–LF del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari,LDerr,RS 817.0)
–LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc,RS 814.20)
–LF del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA,RS 455)
–LF del 1°luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN,RS 451)
–LF del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente,LPAmb,RS 814.01)
Ordinanze
Aspetti generali
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola,OTerm,RS 910.91)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli,RS 919.117.71)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (Ordinanza sulle zone agricole,RS 912.1)
Produzione e smercio
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori (RS 919.117.72)
–Ordinanza del 30 ottobre 2002 concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori; OOCOP,RS 919.117.72)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio,RS 916.010)
–Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (ODOP/IGP,RS 910.12)
–Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica,RS 910.18)
–Ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.181)
–Ordinanza del 3 novembre 1999 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole,ODAgr,RS 916.51)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr,RS 916.01)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero,OCL,RS 916.350.1)
ALLEGATO A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Atti legislativi
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte,OSL,RS 916.350.2)
–Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all'importazione di latte intero in polvere (RS 916.350.21)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte,OQL,RS 916.351.0)
–Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1)
–Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte (RS 916.351.021.2)
–Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.021.3)
–Ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio (RS 916.351.021.4)
–Ordinanza dell' 8 marzo 2002 concernente l’importazione e l’esportazione di formaggio tra la Svizzera e la Comunità europea (Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE,RS 632.110.411)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'importazione di latte e latticini,di oli e grassi commestibili,nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull'importazione di latte e oli commestibili,OILOC,RS 916.355.1)
–Ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 1999 concernente l'importazione di burro (RS 916.357.1)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di animali della specie equina (Ordinanza sull'importazione di equini,OIEq,RS 916.322.1)
–Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello,OBM,RS 916.341)
–Ordinanza dell’UFAG del 23 settembre 1999 concernente la valutazione di animali da macello della specie suina e l’impiego di apparecchi tecnici di classificazione della qualità (RS 916.341.21)
–Ordinanza dell’UFAG del 23 settembre 1999 concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina,equina, ovina e caprina (RS 916.341.22)
–Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 sul pollame (RS 916.341.61)
–Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi,OEMax,RS 916.344)
–Ordinanza del 26 novembre 2003 sull'utilizzazione della lana di pecora indigena (RS 916.361)
–Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova,OU,RS 916.371)
–Ordinanza del DFE del 18 giugno 1996 sulle uova (RS 916.371.1)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura,OCCamp,RS 910.17)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali,alimenti per animali,paglia,strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali,RS 916.112.211)
–Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi (RS 916.112.231)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la valorizzazione,l'importazione e l'esportazione di patate (Ordinanza sulle patate,RS 916.113.11)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero,RS 916.114.11)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura,frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF,RS 916.121.10)
–Ordinanza dell’UFAG del 12 gennaio 2000 concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF,RS 916.121.100)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura,RS 916.131.11)
A2 ALLEGATO
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino,RS 916.140)
–Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle varietà (RS 916.143.5)
–Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il controllo dei mosti d’uva,dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione (RS 916.145.211)
–Ordinanza del 28 maggio 1997 sul controllo del commercio dei vini (RS 916.146)
Pagamenti diretti
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti,OPD,RS 910.13)
–Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA,RS 910.132.4)
–Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA,RS 910.132.5)
–Ordinanza del 29 marzo 2000 concernente i contributi d'estivazione (OCEst,RS 910.133)
–Ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica dell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica,OQE,RS 910.14)
Miglioramento delle basi
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali,OMSt,RS 913.1)
–Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti (RS 913.211)
–Ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 2003 concernente gli aiuti investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC,RS 913.211)
–Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC,RS 914.11)
–Ordinanza dell'8 novembre 1995 concernente la ricerca agronomica (ORA,RS 426.10)
–Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola,RS 915.1)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali (RS 916.310)
–Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi,RS 916.151)
–Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme,RS 916.151.1)
–Ordinanza del DFE del 11 giugno 1999 sulla produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto e di vite certificati (RS 916.151.2)
–Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali,patate,piante foraggere,piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (Ordinanza sul catalogo delle varietà,RS 916.151.6)
–Ordinanza del 23 giugno 1999 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari,RS 916.161)
–Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (OCon,RS 916.171)
–Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (OPV,RS 916.20)
–Ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali,RS 916.307)
–Ordinanza del DFE del 10 giugno 1999 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali,additivi per l'alimentazione animale,coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali,OLAIA,RS 916.307.1)
–Ordinanza dell'UFAG del 16 giugno 1999 concernente la lista degli alimenti OMG per animali (RS 916.307.11)
Tali documenti possono venir consultati o ordinati:
–Accesso via Internethttp://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html
–Ordinazioni presso UFCL,Distribuzione pubblicazioni
– via Internethttp://www.bundespublikationen.ch
– per fax031 325 50 58
ALLEGATO A3
Terminologia e metodi
Terminologia
Beni pubblici: i beni pubblici si distinguono in base a due caratteristiche:mancanza di rivalità e assenza del principio di esclusione.Vi è mancanza di rivalità se il consumo di un determinato bene non pregiudica altri consumatori.L’assenza del principio di esclusione implica che non è possibile escludere singoli fruitori dal consumo di beni pubblici.Tra i beni pubblici rientrano ad esempio la difesa del Paese,il riposo nei boschi,l’apprezzamento di un paesaggio incontaminato.Per i beni pubblici non esiste alcun mercato e di conseguenza neppure un prezzo di mercato.Essi devono quindi venir approntati dallo Stato o,su suo incarico,da terzi.
Effetti esterni: Gli effetti esterni,o esternalità,sono effetti secondari positivi o negativi su terzi o sulla società,riconducibili al comportamento in materia di consumi o ai processi di produzione di singoli attori.Siccome non vengono immediatamente recepiti a livello di mercato,rispettivamente di prezzo di mercato,provocano distorsioni dello stesso e disfunzioni nel collocamento di beni e fattori di produzione.L’obiettivo di una politica economica razionale consiste nell’internalizzazione degli effetti esterni.
Esempi di effetti esterni:
Effettiesterninegativi(costisociali)
Effettiesternipositivi(vantaggisociali)
ProduzioneConsumo
Conseguenze negative per l’acqua potabile,Incremento dei costi della salute a causa le acque sotterranee o superficiali dell’abuso di alcol e tabacco a seguito di una concimazione inadeguata
Conservazione e cura del paesaggio Riduzione dei costi della salute grazie colturale attraverso la produzione agricolaallo sport di massa praticato nel tempo libero
Equivalente latte: un equivalente latte corrisponde al tenore medio in grasso e proteine di un chilogrammo di latte crudo (73 g) e consente di calcolare la quantità di latte trasformato in latticini.
Indicatore ambientale per l’agricoltura: rilevazione rappresentativa che raggruppa i dati su una causa,uno stato di cose,un cambiamento o un rischio ambientale in relazione alle attività agricole e che riveste notevole importanza per i responsabili dei processi decisionali (ad es.grado d’erosione del suolo;definizione dell’OCSE).
Legge sul cioccolato: legge federale su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72):applicazione del Protocollo 2 dell’accordo di libero scambio concluso fra Svizzera e CE nel 1972.Compensazione della differenza del prezzo delle materie prime fra il prezzo sul piano indigeno e quello praticato sul mercato mondiale per le materie prime agricole (esportazione:contributi all’esportazione / importazione:elementi mobili).
Margine: differenza tra prezzo al consumo e prezzo alla produzione (valore assoluto),rispettivamente quota che per ogni franco speso dal consumatore ricade sugli addetti alla trasformazione e sui commercianti (valore relativo).
Mediano: valore mediano (in ambito statistico):il valore centrale di una seriazione (ad es.serie di misurazioni).
Monitoraggio: osservazione costante,sulla scorta di indicatori,per un periodo determinato senza tenere conto,con un modello orientato ai problemi,delle relazioni causali.Il monitoraggio consente di mostrare le tendenze in atto.Esempi:evoluzione della superficie agricola utile,delle popolazioni di uccelli,eccetera.
ALLEGATO A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Multifunzionalità dell’agricoltura: il concetto di agricoltura multifunzionale definisce i molteplici compiti svolti dall’agricoltura. Comprende le prestazioni che vanno ben oltre la mera produzione agricola.Tra queste rientrano la sicurezza dell’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari,la cura del paesaggio colturale,la conservazione delle basi naturali di produzione e della biodiversità nonché il contributo volto a mantenere le aree rurali vitali dal profilo economico e sociale.Un’agricoltura multifunzionale contribuisce considerevolmente allo sviluppo sostenibile.I compiti multifunzionali dell’agricoltura sono ancorati nella Costituzione federale (art.104).
Prezzo d’obiettivo: valore indicativo fissato dal Consiglio federale per ogni chilogrammo di latte commercializzato con un tenore complessivo di 73 grammi di grasso e proteine.Il prezzo d’obiettivo può venir raggiunto per il latte trasformato in prodotti con un valore aggiunto elevato e facilmente commerciabili.L’ammontare del prezzo d’obiettivo dipende soprattutto dalla valutazione della situazione del mercato e dai mezzi a disposizione nell’ambito del sostegno al mercato.Il supplemento per il foraggiamento senza insilati non viene tenuto in considerazione.
Proprietà abiotiche: caratteristiche chimiche o fisiche di un’area,come fattori climatici (luce,temperatura ecc.),proprietà del suolo, condizioni idrologiche e conformazione del terreno.
Proprietà biotiche: caratteristiche di un’area derivanti dalla sua flora e fauna.
Quartile: quarto (in ambito statistico):ripartizione di un valore in quattro sottoinsiemi successivi.
Traffico di perfezionamento: nell’ambito del traffico di perfezionamento le merci importate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate beneficiano,a determinate condizioni,di una riduzione del dazio o dell’esenzione.Per i prodotti agricoli e le materie prime agricole il traffico di perfezionamento è consentito soltanto nel caso in cui non siano disponibili in quantità sufficiente prodotti indigeni simili oppure se per tali prodotti lo svantaggio a livello di prezzo della materia prima per l’industria alimentare svizzera non possa venir compensato con altri provvedimenti adeguati.
Valore medio: media (in ambito statistico):somma delle cifre di una serie divisa per il numero delle cifre.
Valutazione: sinonimo di controllo del successo dei provvedimenti.Si tratta di un metodo per la rilevazione e l’apprezzamento dell’effettività (livello di raggiungimento degli obiettivi),dell’efficacia (relazione di causa ed effetto) e dell’efficienza (economicità) di provvedimenti o strumenti.La valutazione presuppone l’esistenza di obiettivi prestabiliti e consente soprattutto di effettuare paragoni:confronto tra gruppi di controllo,confronto prima/dopo,confronto trasversale.
Varianza: indice di variabilità (in ambito statistico):media del quadrato degli scarti dalla media delle singole osservazioni di una popolazione statistica.
Per ulteriori definizioni si rinvia a:
–«Terminologia economico-aziendale in ambito agricolo» (disponibile presso:Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale,Länggasse 79,3052 Zollikofen).
–Ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91).
A2 ALLEGATO
Metodi
Rilevazione del prezzo del latte
L’UFAG rileva mensilmente i prezzi alla produzione e informa sui risultati nella pubblicazione «Rapporto sul latte».Si distingue tra le seguenti quattro categorie di prezzo:prezzo del latte considerato globalmente,prezzo del latte per l’industria,prezzo del latte trasformato in formaggio e prezzo del latte biologico.I prezzi del latte vengono rilevati sia su base nazionale sia su base locale,secondo una ripartizione in cinque regioni: Regione I: Ginevra,Vaud,Neuchâtel,Giura e parti della regione francofona del Canton Berna (distretti di La Neuveville,Courtelary e Moutier). Regione II: Berna (tranne i distretti della regione I),Lucerna,Unterwaldo (Obwaldo,Nidwaldo),Uri, Zugo e una parte del Canton Svitto (distretti di Schwytz e di Küssnacht). Regione III: Basilea Campagna e Basilea Città,Argovia e Soletta. Regione IV: Zurigo,Sciaffusa,Turgovia,Appenzello Interno ed Appenzello Esterno,S.Gallo,una parte del Canton Svitto (distretti di Einsiedeln,March e Höfe),Glarona e Grigioni. Regione V: Vallese e Ticino.
Le cinque regioni della rilevazione dei prezzi
Fonte: UFAG
Alla rilevazione dei prezzi del latte,che secondo l’ordinanza di transizione nel settore del latte va eseguita presso gli addetti alla valorizzazione del latte,prendono parte tutti i principali responsabili della trasformazione industriale del latte nonché un novero rappresentativo di caseifici.In tal modo è possibile rilevare i dati riguardanti oltre il 60 per cento del latte prodotto.Secondo l’ordinanza di transizione nel settore del latte,per prezzo pagato s’intende il prezzo versato per il latte sul luogo di rilevazione (presso l’azienda o il centro di raccolta), compresi i supplementi concessi abitualmente in loco e le detrazioni.Il supplemento per il foraggiamento senza insilati,i contributi volontari delle associazioni nonché le detrazioni per il siero non sono contemplati nel prezzo del latte oggetto della rilevazione.
ALLEGATO A3
I II III IV V
Calcolo dei margini lordi Latte e latticini
In una prima fase,il margine lordo del latte e dei latticini è il risultato di un calcolo teorico del valore aggiunto nei segmenti «latte di consumo», «formaggio», «burro», «panna di consumo» e «yogurt».Il valore aggiunto calcolato per i singoli prodotti è espresso in franchi per chilogrammo di latte crudo utilizzato.Il margine lordo del latte e dei latticini è quindi la differenza fra il prezzo spuntato dai produttori lattieri e il prezzo al consumo del prodotto finito.
In una seconda fase,il valore aggiunto viene corretto in funzione delle caratteristiche specifiche dei prodotti.Nel calcolo dei singoli margini lordi sono ad esempio contemplati i contributi della Confederazione,le deduzioni e i supplementi vincolati ai prodotti nonché il valore dei sottoprodotti.Il margine lordo del latte e dei latticini risulta dal valore aggiunto e dalle caratteristiche specifiche dei prodotti. Il margine lordo totale del latte e dei latticini ingloba tutti i margini lordi dei segmenti «latte di consumo», «formaggio», «burro», «panna di consumo» e «yogurt»,i quali risultano dai calcoli concernenti i prodotti indicatori osservati.
Il quantitativo di latte crudo valorizzato annualmente in Svizzera costituisce la base per il calcolo del margine lordo totale del latte e dei latticini nonché dei margini lordi dei segmenti «latte di consumo», «formaggio», «burro», «panna» e «yogurt».Il singolo tipo di valorizzazione è ponderato in funzione della quota del prodotto rispetto al quantitativo di latte crudo.
Il calcolo del margine lordo riguarda unicamente il valore aggiunto dei latticini prodotti e consumati in Svizzera.Dal quantitativo di latte trasformato dev’essere pertanto dedotta la quota esportata.
Per la rilevazione dei prezzi al consumo si distinguono tre canali di vendita:grande distribuzione,discounter e commercio specializzato. I canali di vendita sono ponderati in base alle quote di mercato conformemente ai dati forniti dall’Istituto di analisi del mercato di Hergiswil (IHA GfM).
Resa: 8%Aiuti, tasse, valore dei
A4 ALLEGATO
PV1/kg
Margine lordo del formaggio Emmentaler (Ottobre 2000) PV1/kg
Emmentaler
Latte crudo Prezzo del latte
Margine lordo Emmentaler
fr. / kg 1 PV = prezzo di vendita Fonte: UFAG 0 20.44 1.64 0.81
sottoprodotti, ecc.
Carne
Il margine lordo di trasformazione-distribuzione della carne fresca destinata al consumo rilevato nella vendita al minuto è un valore reale (a prezzi del gennaio 1999),IVA esclusa (IVAe).Esso è espresso in franchi per chilogrammo di peso morto (PM).Il margine lordo è la differenza tra il rendimento lordo e i costi variabili totali,ma anche la differenza fra l‘entrata netta e il prezzo di costo.
Il rendimento lordo equivale alla cifra d‘affari del settore della trasformazione-distribuzione o alle uscite del consumatore (economie domestiche e grossisti).Comprende la carne venduta fresca al consumo e la valorizzazione della carne per salsicce,della pelle e degli scarti a livello di grossisti.
I costi variabili totali comprendono il prezzo di costo corretto del bestiame.Si tratta di un prezzo medio ponderato (convenzionale, label),franco macello,che di conseguenza comprende un eventuale margine del negoziante o costi di trasporto,ma dal quale è dedotto il profitto riconducibile a importazioni effettuate nel quadro dei contingenti doganali.I costi variabili comprendono pure le spese d’eliminazione degli scarti di macellazione,della testa e dei piedi,la tassa sul traffico pesante (TTPCP) e la quota di partecipazione al marketing di base di Proviande.
Avvertenza: le proporzioni del grafico non sono reali. I prezzi indicati fungono da esempio per il calcolo del margine lordo sulla carne fresca bovina nel 2000. Trattasi di franchi il chilogrammo di peso morto (PM), prezzo costante (valore reale in data 1.1999), IVA esclusa. Fonte: UFAG
Per la definizione dettagliata del margine lordo di trasformazione-distribuzione si rinvia alle edizioni speciali del Rapporto sul mercato della carne,gennaio 2001 e aprile 2002 (numeri 140 e 155) pubblicati dalla Sezione Osservazione del mercato dell’UFAG.Tali rapporti sono disponibili su richiesta.
ALLEGATO A5
Rendimento lordo (= franco del consumatore):
Costi variabili
16.74 fr./kg PM
totali: 8.46 fr./kg PM
Carni fresche da banco (prezzo al dettaglio) 15.54 fr./kg PM Entrata netta (POC) 16.62 fr./kg PM Prezzo di costo osservato corretto (PCC) 8.34 fr./kg PM Imp. (TVI) 0.77 fr./kg PM Margine lordo (ML2) 8.28 fr./kg PM Carne per salsicce (prezzo grossista) 0.56 fr./kg PM Scarti vendibili (prezzo al dettaglio) 0.64 fr./kg PM Scarti e ossi da incenerire, tassa TPCP, marketing, 0.12 fr./kg PM Prezzo di costo osservato (PCO) 9.11 fr./kg PM
Frutta e verdura
Il margine lordo della frutta e della verdura è la differenza fra il prezzo di costo di un prodotto al primo livello commerciale – eccettuati i costi d’imballaggio – e il prezzo di vendita (compr.eventuali costi d’imballaggio).Nel calcolo dei margini lordi vengono tenuti in considerazione sia i dati del mercato indigeno sia quelli del mercato d’importazione.I dati del mercato d’importazione comprendono l’imposizione doganale.Vengono considerati sette tipi di frutta e di verdura che rivestono un significato particolare dal profilo della cifra d’affari. Per la frutta trattasi di:mele (valori delle Golden Delicious e delle principali varietà destinate all’immagazzinamento nonché delle importazioni di Granny Smith,ponderati in funzione dei quantitativi),pere (valori delle pere indigene e di quelle importate,escluse le pere Abate e Nashi,ponderati in funzione dei quantitativi),fragole,nettarine,ciliegie,albicocche e arance.Per la verdura trattasi di:pomodori (pomodori carnosi,pomodori tondi,entrambi con quota ponderata in funzione dei quantitativi),cavolfiori,cipolle gialle,carote,cicoria Witloof (di coltura forzata),cetrioli e patate.La ponderazione in funzione dei quantitativi viene effettuata sulla base delle cifre dell’IHA GfM,della Centrale svizzera dell’orticoltura (CSO),dell’Associazione svizzera frutta (ASF),dell’Ufficio federale di statistica (UST) e della Direzione generale delle dogane (DGD).
Margine lordo della verdura
Il prezzo di costo dei singoli prodotti è,per la merce indigena,il prezzo franco caricatore (per la merce destinata all’immagazzinamento vengono tenuti in considerazione i costi di stoccaggio) e,per la merce importata,il valore all’importazione franco frontiera,dopo lo sdoganamento,entrambi ponderati in funzione dei quantitativi.Per la rilevazione dei prezzi al consumo vengono utilizzati i dati delle vendite dei principali grandi distributori e dei mercati settimanali.I canali di vendita sono ponderati in base alle quote di mercato conformemente ai dati forniti dall’IHA GfM.I margini dei singoli prodotti vengono raggruppati nel margine della verdura.
Margine lordo della frutta
Una particolarità del margine totale è data dalla presenza e dall’assenza di frutta riscontrabile per brevi periodi dell’anno.Nonostante ciò, i dati considerati globalmente forniscono indicazioni preziose soprattutto in vista di un confronto su diversi anni.
Il prezzo di costo è,per la merce indigena,il prezzo alla produzione franco centro di raccolta e per la merce importata il valore all’importazione franco frontiera,dopo lo sdoganamento,entrambi ponderati in funzione dei quantitativi.Sono tenuti in considerazione anche i costi di stoccaggio e gli interessi.Per la rilevazione dei prezzi al consumo vengono utilizzati i dati delle vendite dei principali grandi distributori e dei mercati settimanali.I canali di vendita sono ponderati in base alle quote di mercato conformemente ai dati forniti dall’IHA GfM).I margini dei singoli prodotti vengono raggruppati nel margine della frutta.
A6 ALLEGATO
P import P di costo P Svizzera P di vendita
Margine lordo della frutta e della verdura
Fonte: UFAG
Margine lordo
Conto economico dell’agricoltura – nuova metodologia
Il conto economico dell’agricoltura è allestito dall’UST in collaborazione con il Segretariato dell’USC,applicando il sistema europeo dei conti economici (Eurostat).La nuova metodologia introdotta si basa sulla nomenclatura CEA97 di Eurostat (preced.CEA89).Grazie a questa revisione è possibile effettuare un diretto confronto tra i risultati svizzeri e quelli dell’UE.
Di seguito vengono illustrati gli adeguamenti metodologici.Sulla scorta di un esempio viene mostrato come queste modifiche possano incidere quantitativamente.Siccome la revisione è stata integrale,i risultati non possono essere confrontati con quelli degli anni precedenti pubblicati nei Rapporti agricoli 2000–2002.
Si può fare una distinzione tra due gruppi di adeguamenti:adeguamenti metodologici e adeguamenti relativi all’insieme di riferimento,ai prodotti e alle prestazioni di servizio in esame.
Modifiche metodologiche
Abbandono del concetto aziendale nazionale
Nel vecchio sistema l’agricoltura veniva considerata quale «Black Box».Nel CEA venivano presi in considerazione soltanto i flussi di beni e di servizi tra l’agricoltura e gli altri settori economici.Con il nuovo sistema vengono presi in esame anche i flussi intraaziendali e interaziendali.Questi ultimi soltanto laddove siano coinvolti due diversi rami di produzione (p.es.produzione di alimenti per animali quale input per la produzione di latte o di carne).
Nuova definizione dei prezzi
I «prezzi di fabbricazione» sostituiscono i vecchi «prezzi presso l’azienda».La differenza sta nel fatto che con il nuovo sistema vengono tenute in considerazione anche le sovvenzioni direttamente vincolate ai prodotti (p.es.indennizzo per il divieto d’insilati,contributi all’esportazione per animali,sostegno alla valorizzazione delle patate).Anche i prezzi dei beni d’acquisto («prezzi di acquisto») vengono corretti (p.es.viene tenuto conto delle restituzioni dei tributi doganali per il carburante).
ALLEGATO A7
Unità agricola
CEA89 (metodo vecchio)
CEA97 (metodo nuovo) Agricoltura
Prezzo alla produzione
Prezzo presso l'azienda
+ imposte sui beni
Prezzo alla produzione + sovvenzioni di beni
Prezzo di fabbricazione – imposte sui beni
Impianti
I nuovi impianti e l’aumento del rispettivo valore fino alla maturazione vengono presi in considerazione nell’ambito della produzione come pure degli investimenti fissi lordi.A maturazione completa vengono contabilizzati anche gli ammortamenti in base al valore.Secondo il vecchio metodo,venivano prese in considerazione soltanto le variazioni delle scorte complessive (l’aumento o la diminuzione delle scorte complessive,senza tener conto degli impianti sostitutivi).
Superficie viticola 2001
Superficie viticola 2002 Aumento
Produzione = IFL
IFL: Investimenti fissi lordi
IFN: Investimenti fissi netti
Superficie viticola 2001
Superficie viticola 2002 Rinnovo
Produzione = IFL
IFN Ammortamenti
A8 ALLEGATO
CEA89, vecchio metodoCEA97, nuovo metodo
CEA89, metodo vecchioLGR97, metodo nuovo
Aumento
Adeguamenti dell’insieme di riferimento,dei prodotti e delle prestazioni di servizio in esame
In base al nuovo sistema il CEA comprende:
colture di piante ornamentali (piante e fiori,prodotti da vivaio);
– prestazioni di servizio offerte da aziende specializzate (p.es.lavori a pagamento,inseminazione artificiale) o da agricoltori (p.es.lavori a pagamento);
– attività accessorie non agricole – tuttavia direttamente legate all’attività primaria – (attività non agricole non separabili),quali la trasformazione di materie prime agricole,da un lato,e,dall’altro,l’impiego di fattori di produzione agricoli per altri scopi (p.es. sgombero dalla neve,servizio di pensione per animali);
– vino:la valutazione dell’uva è effettuata in base allo scopo della trasformazione (vino da tavola,vino di qualità,uva da tavola,mosto) (CEA89:valutazione di tutta l’uva vendemmiata secondo i prezzi per il mosto d’uva).
Dall’insieme di riferimento sono stati eliminati i piccoli produttori al disotto di determinati valori soglia.In particolare trattasi di una parte dei viticoltori,di apicoltori e di allevatori di conigli.
–Piccoli produttori
Produzione agricola delle aziende coperte dal CEA89
+ coltivazione di piante ornamentali
+ prestazioni di servizio delle aziende specializzate
Quantificazione degli adeguamenti
+ valutazione del vino di propria produzione
+ prestazioni di servizio agricole (attività accessorie)
+ attività non agricole non separabili
Nella tabella di seguito sono messi a confronto i risultati del vecchio (CEA89) e del nuovo (CEA97) metodo di allestimento del conto economico dell’agricoltura per la media degli anni 1999/2001.A tutti i livelli del CEA le differenze constatate vengono classificate in base a tre motivi: «adeguamenti metodologici», «influsso floricoltura» e «altri influssi».Nel complesso le modifiche hanno portato ad un incremento dei valori relativi a tutti i livelli del CEA.
A livello del valore della produzione totale e delle prestazioni preliminari,le variazioni intervenute sono da attribuire essenzialmente all’abbandono del concetto aziendale nazionale (rispetto a determinati flussi intraaziendali e interaziendali).Anche floricoltura e prestazioni di servizio hanno avuto un certo impatto su entrambi i livelli.Prendendo in considerazione la floricoltura,si sono modificati in modo particolarmente forte anche i valori relativi al costo della manodopera.Le attività accessorie non agricole sono state inserite nel valore della produzione totale e hanno influito anche sull’importo del costo della manodopera complessivo,ma non sulle prestazioni preliminari. Relativamente forti sono stati pure gli influssi del passaggio ai nuovi prezzi di fabbricazione.Siccome le sovvenzioni vincolate ai prodotti sono state prese in esame nell’ambito dei prezzi,esse non sono state più registrate nella rubrica «sovvenzioni»
Complessivamente gli adeguamenti hanno comportato un aumento del reddito settoriale del 30 per cento circa.
ALLEGATO A9
–
Nuovo CEA97
CEACEAInflussomodificheInflussoAltriImpatto
A10 ALLEGATO
8997metodologichefloricolturainflussitotale mio.fr.mio.fr.mio.fr.%mio.fr.%mio.fr.%mio.fr.% (ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–(ø1999–2001)2001)2001)2001)2001)2001) Valoredellaproduzionetotale738110483197663,778625,3341113102100 Consumo interaziendale, vendite e acquisti intraaziendali (alimenti per animali,paglia)01 2681 26810000001 268 40,9 Colture piante ornamentali,vivai0786007861000078625,3 Prestazioni di servizio agricole05415411000000541 17,4 Impianti realizzati autonomamente100116161000000160,5 Attività accessorie non agricole (non separabili)03503501000000350 11,3 Prezzo di fabbricazione: con sovvenzioni di beni010710710000001073,5 Prezzo di fabbricazione: senza sovvenzioni di beni1500-1501000000-150-4,8 Valutazione del vino022900002291002297,4 Piccoli produttori,economie domestiche non agricole1560-1561000000-156-5,0 Altri influssi netti della revisione011100001111001113,6 Prestazionipreliminari38645733174193,129115,6-163-8,71870100 Consumo interaziendale, vendite e acquisti intraaziendali (alimenti per animali,paglia)01 2681 26810000001 268 67,8 Prestazioni di servizio agricole05415411000000541 28,9 Colture piante ornamentali,vivai0291002911000029115,6 Torchiatura065000065100653,5 Prezzo d’acquisto:paglia / restit.tributi dog.per carburanti670-671000000-67-3,6 Manutenzione e riparazioni di macchine e installazioni8695160000-354100-354 -18,9 Altri influssi netti della revisione012600001261001266,7 Valoreaggiuntolordo351747502351949440,150340,91232100 Ammortamenti1 8651 982120102,23328,4-36-30,6117100 Valoreaggiuntonetto1653276711510,346141,353948,41115100 Costodellamanodopera72111496114,331072,45713,3428100 Impostesullaproduzione1851211-1,92-2,8-67104,7-64100 Imposte sulla produzione (senza sottocompensazione IVA)85541-45-17,6-37121,6-3147,7 Sottocompensazione IVA netta1006700-410,8-3089,2-3452,3 Sovvenzioni24962352-175120,80030-20,8-145100 Sovvenzioni di beni1070-1071000000-107 74,3 Restituzioni di tributi doganali per carburanti670-671000000-67 46,5 Sovvenzioni2 3222 35200003010030 -20,8 Eccedenzaaziendalenetta/ redditoindipendente32423849-123-20,215024,658095,6607100 Canoni d’affitto2252080000-17100-17100 Interessi pagati50436523-16,521-15-182131,5-138100 Redditosettorialenetto25133276-145-19,112916,9779102,2762100
Schema del conto economico dell’agricoltura
Composizione del valore della produzione totale
Consumo interaziendale
Trasformazione da parte dei produttori
Produzione finale dell’agricoltura
Consumo delle economie domestiche agricole
Vendite a altre unità agricole
Vendite al di fuori del primario, all’interno del Paese e all’estero
Impianti realizzati autonomamente
Variazioni delle scorte
Sovvenzioni
Sovvenzioni di beni
Produzione finale dell’agricoltura
Valore aggiunto lordo ai prezzi di fabbricazione
Valore aggiunto netto ai prezzi di fabbricazione
Reddito dei fattori
Eccedenza aziendale netta / reddito indipendente
Reddito settoriale netto 1
Affitti e interessi passivi
Costo della manodopera Imposte sulla produzione AmmortamentiPrestazioni preliminari
1 Nella bibliografia e nel metodo Eurostat viene indicato come utile aziendale netto Fonte: UST
ALLEGATO A11
Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon
Nuova metodologia d’analisi
A partire dalla chiusura contabile 1999 la Centrale analisi ha applicato una metodologia completamente nuova.In passato per la rilevazione del reddito si faceva capo ad aziende pilota scelte in base a criteri restrittivi (p.es.limitazione del guadagno accessorio,formazione presso una scuola specializzata).Visto che era stata consapevolmente operata una selezione positiva delle aziende pilota,potevano venir espresse considerazioni soltanto in merito a tali aziende.Nel nuovo sistema le cosiddette «aziende di riferimento» consentono di esprimere considerazioni rappresentative per l’intero settore agricolo.
Ricapitolazione dei cambiamenti metodologici intervenuti presso la Centrale analisi
– Per insieme si intendono le aziende svizzere che,per principio,entrano in linea di conto come aziende di riferimento per la Centrale analisi.A tal fine devono raggiungere soglie fisiche minime.Nell’insieme rientrano,ad esempio,le aziende che gestiscono una superficie di almeno 10 ettari o detengono almeno 6 vacche.L’insieme comprende circa 57’000 aziende;ciò corrisponde al 90 per cento circa della superficie gestita e al 90 per cento circa della produzione.
Dall’insieme vengono scelte circa 3'500 aziende di riferimento.
Dato che le strutture delle aziende di riferimento della Centrale analisi divergono dalle strutture dell’agricoltura considerata nel suo insieme,i risultati contabili vengono ponderati.A tal fine viene ripresa la ripartizione delle aziende in base alle dimensioni, al tipo e alla zona in cui sono ubicate di cui alla rilevazione della struttura aziendale.Questo modo di procedere garantisce,ad esempio, che i risultati contabili di aziende di minori dimensioni,sottorappresentate nella scelta delle aziende di riferimento,abbiano il rispettivo peso nell’analisi.
– Grazie a una nuova tipologia aziendale è possibile distinguere meglio i tipi di azienda significativi dal profilo della politica agricola. Due terzi circa delle aziende sono classificabili in sette tipi specializzati,che presentano una concentrazione in determinati rami aziendali della produzione vegetale o della detenzione di animali.Il terzo rimanente è classificabile in quattro tipi di azienda combinata (cfr.paragrafi seguenti).
L’ampiezza dell’insieme e la ponderazione accrescono sensibilmente la significatività dei risultati della Centrale analisi per l’intero settore agricolo.Anche la comparabilità dei dati contabili sul piano internazionale risulta più semplice.I cambiamenti intervenuti nel quadro della metodologia sono tali da non più consentire un confronto con vecchi rapporti della Centrale analisi.Affinché sia possibile,nonostante ciò, fare un parallelo sull’arco di diversi anni i risultati contabili degli anni scorsi sono stati adeguati applicando la nuova metodologia.
La nuova tipologia aziendale FAT99
Nel quadro delle modifiche di carattere metodologico della Centrale analisi di Agroscope FAT Tänikon si è proceduto alla sostituzione della vecchia tipologia aziendale secondo la Commissione verde (1996) mediante una nuova denominata FAT99.Oltre che per la rappresentazione dei risultati,questa nuova tipologia aziendale viene impiegata per il piano di selezione delle aziende della Centrale analisi e per la ponderazione dei risultati delle singole aziende.
La classificazione delle aziende secondo la nuova tipologia viene effettuata applicando esclusivamente criteri di natura fisica,segnatamente:superficie e UBG di diverse categorie di animali.Sulla base di dieci indicatori,rispettivamente otto quozienti per azienda, è possibile giungere a una classificazione differenziata e chiara.
A12 ALLEGATO
–
–
Definizione della nuova tipologia aziendale FAT99
SettoreTipodiaziendaUBG/SCA/CS/UBGb/VLC/VMN/EOC/SP/Altre SAUSAUSAUUBGUBGbUBGbUBGUBGcondizioni
Tutti i criteri riportati su una riga vanno rispettati contemporaneamente
Abbreviazioni:
UBGUnità di bestiame grosso
SAUSuperficie agricola utile in ettari (ha)
UBG/SAUDensità di animali per ha di SAU
SCA/SAUQuota di superficie coltiva aperta rispetto alla SAU
CS/SAUQuota di colture speciali rispetto alla SAU
UBGb/UBGQuota di UBG bovine rispetto all effettivo totale di bestiame
VLC/UBGbQuota di vacche con produzione di latte commerciale rispetto all’effettivo bovino
VMN/UBGbQuota di vacche madri e nutrici rispetto all effettivo bovino
EOC/UBGQuota di UBG equine,ovine e caprine rispetto all’effettivo totale di bestiame
SP/UBGQuota di UBG suine e di pollame rispetto all effettivo totale di bestiame
Fonte:Agroscope FAT Tänikon Si distingue fra sette tipi di aziende specializzate e quattro tipi di aziende combinate.Le aziende specializzate nel settore della produzione vegetale (11 e 12) presentano una densità di animali inferiore a una UBG per ettaro di SAU.Nelle aziende dedite alla campicoltura la quota di superficie coltiva aperta è superiore al 70 per cento della SAU.Le aziende con colture speciali presentano una quota di colture speciali superiore al 10 per cento della SAU.Le aziende specializzate nella detenzione di animali (21 a 41) dispongono del 25 per cento al massimo di superficie coltiva aperta e del 10 per cento al massimo di superficie riservata alle colture speciali.Nelle aziende con produzione di latte commerciale oltre il 25 per cento dell’effettivo bovino è costituito da vacche lattifere il cui latte viene commercializzato. Una quota analoga si riscontra anche per le aziende orientate sulla detenzione di vacche madri.Nel gruppo «Altri bovini» rientrano soprattutto aziende con vacche lattifere senza contingente (ingrassatori specializzati di vitelli o aziende d’allevamento nella regione di montagna).Nelle aziende dedite alla trasformazione le UBG suine e di pollame costituiscono oltre la metà dell’effettivo di bestiame. Le aziende che non possono venir classificate in nessuno dei sette tipi di aziende specializzate,sono considerate aziende combinate (51 a 54).
ALLEGATO A13
110%
oltre max. 25%10%75%25%25% 22Vacche
max.oltre 25%10%75%25%25% 23Altri bovinimax.max.oltrenon 21 25%10%75%oppure 22 31Equini/ovini/max.max.oltre caprini25%10%50% 41Trasformazionemax.max.oltre 25%10%50% 51Prod.combinataLatte comm./oltreoltreoltremax.non campicoltura40%75%25%25%11– 41 52Vacche madrioltremax.oltrenon 75%25%25%11– 41 53Trasformazione oltrenon 25%11– 41 54Altra non 11– 53
11Prod.vegetaleCampicolturamax.oltremax. 170%10% 12Colture specialimax.oltre
21Prod.animaleLatte commercialemax.max.oltre
madrimax.max.oltre
Aspetti della rappresentazione
Conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura,la situazione economica dell’agricoltura dev’essere analizzata anche regionalmente.In base all’ordinanza sulle zone agricole vengono pertanto definite tre regioni:
la regione di pianura:zona campicola,zone intermedie; – la regione collinare:zona collinare,zona di montagna I; – la regione di montagna:zone di montagna II a IV
Delimitazione della regione di pianura, collinare e di montagna (Classificazione dei Comuni in base alla quota maggiore di territorio nella rispettiva regione)
Regione di pianura
Regione collinare
Regione di montagna
Affinché sia possibile valutare in modo differenziato la varianza di determinati indici,le aziende sono state classificate in quartili. Il profitto del lavoro per unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF) costituisce il criterio di classificazione.In ogni quartile (0–25% / 25–50% / 50–75% / 75–100%) si riscontra un quarto delle aziende dell’insieme.
La rappresentazione in quartili consente una valutazione differenziata dal profilo economico.Si è deciso di non operare una differenziazione sul piano ecologico in quanto la quota di aziende di riferimento che non forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate risulta inferiore al 3 per cento e la differenza tra i profitti del lavoro è minima.
In virtù dell’articolo 5 LAgr,la situazione economica dev’essere valutata «sulla media di vari anni».Per illustrare gli sviluppi vengono pertanto considerati vari anni,mentre le considerazioni di carattere statico si fondano sulla più recente media triennale disponibile (1998/2000).
A14 ALLEGATO
–
UFAG
Fonte: dati AGIS/SIPA 1998
Confini comunali: © UST GEOSTAT
Confronto dei redditi
Affinché sia possibile effettuare un confronto tra i redditi del lavoro vengono rilevati il profitto del lavoro per il settore agricolo e il salario lordo annuale per la rimanente popolazione attiva negli altri settori.La situazione salariale della popolazione non agricola viene accertata dall’UST a scadenza biennale con l’ausilio di rilevazioni della struttura dei salari.Negli anni intermedi i valori vengono aggiornati sulla base dell’evoluzione dell’indice dei salari.La rilevazione della struttura dei salari offre una panoramica rappresentativa della situazione salariale delle persone occupate nell’industria (secondario) e nel settore dei servizi (terziario).
Componenti salariali rilevate (giusta la rilevazione della struttura dei salari dell’UST)
Salario lordo versato per il mese di ottobre (compr.l’ammontare dei contributi del lavoratore alle assicurazioni sociali,le prestazioni in natura,i pagamenti regolari di premi,di partecipazioni alla cifra d’affari o di provvigioni),indennità per il lavoro a squadre,domenicale e notturno, 1⁄12 della tredicesima mensilità e 1⁄12 dei pagamenti speciali annuali.
Standardizzazione: Conversione dei contributi prelevati (comprese le tasse sociali) in un orario di lavoro uniforme di 4,33 settimane di 40 ore.
I valori della rilevazione della struttura dei salari sono convertiti in salari lordi annuali.Successivamente,per ogni regione viene stabilito il valore mediano di tutti coloro che sono occupati nei settori secondario e terziario.
In ambito agricolo quale corrispettivo del salario lordo annuale viene calcolato il profitto del lavoro per ULAF.La base di una ULAF è costituita da 280 giorni di lavoro,laddove una persona corrisponde al massimo a 1,0 ULAF.
Calcolo del profitto del lavoro nell‘agricoltura
Reddito agricolo
-interesse del capitale proprio investito nell’azienda
(tasso d’interesse medio delle obbligazioni della Confederazione)
=profitto del lavoro della famiglia del capoazienda
:numero di unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
(base:280 giorni di lavoro)
=profitto del lavoro per ULAF
ALLEGATO A15
Esigenze poste per l’ottenimento di pagamenti diretti (stato agosto 2004)
Requisiti generali
Hanno diritto ai pagamenti diretti i contadini che gestiscono un’azienda agricola a proprio rischio e pericolo e hanno il domicilio civile in Svizzera.Non vengono concessi pagamenti diretti alle aziende della Confederazione,dei Cantoni e dei Comuni nonché ai gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell’ordinanza sugli effettivi massimi.Sono escluse anche le persone giuridiche,salvo se si tratta di aziende a conduzione famigliare (articolo 2 dell’ordinanza sui pagamenti diretti).
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)
I gestori che richiedono pagamenti diretti devono dimostrare alle autorità cantonali di gestire l’intera azienda attenendosi ai principi della PER o alle norme riconosciute dal Consiglio federale (cfr.considerazioni espresse più avanti).
Ulteriori condizioni
Per avere diritto ai contributi è presupposto l’adempimento di altri criteri strutturali e sociali.Nella tavola sinottica sono riportate,in breve, le condizioni per il versamento dei pagamenti diretti.
Condizioni per il versamento di pagamenti diretti
Dimensioniminimedell’azienda
Volumedilavorominimo
Manodoperadell’azienda
Etàdelgestore
Limitazionideicontributi
1 ha Colture speciali:50 are Vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate:30 are
0,3 unità standard di manodopera (USM)
Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda dev’essere svolto da manodopera propria dell’azienda (famigliari e impiegati)
Al massimo 65 anni
– GraduazioneSuperficie haAnimali UBGAliquota % fino a3045100
30–6045–9075
60–9090–13550 oltre901350
– Contributo massimo per USM 55 000 fr.
Reddito determinante (reddito imponibile meno 30 000 fr.Oltre 80 000 franchi di reddito determinante l’importo dei per gestori coniugati)pagamenti diretti viene ridotto
Sostanza determinante (sostanza imponibile,Oltre 800 000 franchi di sostanza determinante l’importo dei pagamenti meno 200 000 fr.per USM e 200 000 fr.diretti viene ridotto.Se la sostanza determinante è superiore a 1 milione di per gestori coniugati) franchi non vengono concessi pagamenti diretti.
Fonte:Ordinanza sui pagamenti diretti
A16 ALLEGATO
–
–
Supplementi per le zone declive nella regione di montagna e nella zona collinare0,02 USM per ha per l’agricoltura biologica come per SAU più 20 % per alberi da frutto ad alto fusto nei campi 0,01 USM/10 alberi
Fonte:Ordinanza sulla terminologia agricola
Il calcolo delle USM viene effettuato applicando coefficienti di conversione per la SAU e gli animali da reddito.Per determinate forme di gestione,come ad esempio l’agricoltura biologica che comporta un maggiore dispendio di lavoro,vengono concessi supplementi.I coefficienti scaturiscono dalla rilevazione standard dei processi di lavoro.Per l’esecuzione dei pagamenti diretti e dei provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali essi sono stati semplificati.Tali coefficienti non possono venir applicati per il calcolo del volume effettivo di lavoro in quanto quest’ultimo dipende dalle caratteristiche specifiche della singola azienda,dalla conformazione del terreno,dal grado di raggruppamento delle particelle,dalle condizioni degli edifici o dall’intensità della meccanizzazione.
Graduazione dei contributi giusta l'articolo 20 dell'ordinanza sui pagamenti diretti
La graduazione,espressa in per cento, è applicabile a tutti i tipi di contributo tranne i contributi d’estivazione e quelli per la protezione delle acque.
ALLEGATO A17 SuperficieagricolautileUSM/ha SAU escluse le colture speciali 0,035 Colture speciali 0,400 Vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate 1,000 AnimalidaredditoUSM/UBG Vacche,pecore e capre lattifere 0,05 Suini da ingrasso 0,01 Suini da allevamento 0,02 Altri animali da reddito 0,04
Superfici 1–30 ha>30–60 ha>60–90 ha>90 ha % dell'aliquota di contributo Effettivo di animali / animali da reddito 1–45 UBGFG>45–90 UBGFG>90–135 UBGBFG>135 UBGFG % dell'aliquota di contributo 0 100 75 50 0 100 75 50
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)
Mediante la PER s’intende considerare globalmente i sistemi agroecologici e le aziende agricole.A tal fine è stato ripreso il principio elaborato a suo tempo per la produzione integrata (PI).La PER viene quindi concretizzata sulla base delle condizioni poste alla produzione integrata (stato 1996).In via suppletiva,i gestori sono tenuti a dimostrare che adempiono le prescrizioni della legge sulla protezione degli animali.La PI,unitamente alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali, è quindi assurta a standard per l’agricoltura svizzera.I pagamenti diretti vengono concessi soltanto ai gestori che adempiono i principi della PER.Le aziende senza PER hanno beneficiato di pagamenti diretti ridotti fino al 31 dicembre 2001.Le condizioni applicate nel campo della PER rispecchiano quelle poste alla produzione integrata (PI,stato 1996).L’introduzione dei pagamenti diretti ha esercitato un notevole influsso sui metodi di gestione e di riflesso sull’ecologia.Lo dimostra il notevole incremento delle superfici gestite in conformità della PER e delle direttive concernenti l’agricoltura biologica.Nelle prime fasi della riforma agraria,nel 1993,tale quota ammontava a poco meno del 20 per cento della SAU.Oggi corrisponde a oltre il 99 per cento della SAU.La massiccia partecipazione delle aziende è il risultato dell’impiego mirato degli incentivi finanziari.In questo contesto è doveroso osservare che determinate aziende,come ad esempio quelle gestite dallo Stato o le persone giuridiche,non vengono rilevate nel sistema dei pagamenti diretti nonostante adempiano le esigenze della PER o dell’agricoltura biologica.
La PER comprende i seguenti punti:
Obbligo di registrazione e di prova:chiunque chiede pagamenti diretti è tenuto a dimostrare all’autorità cantonale che fornisce le prestazioni ecologiche nell’intera azienda.L’attestazione di un’organizzazione di controllo designata dal Cantone vale come prova. Per ottenere tale attestazione,il richiedente tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda.
Congrua detenzione di animali da reddito agricoli:vanno rispettate le disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali. A seguito del trasferimento dell’onere della prova il gestore è tenuto a dimostrare che nella sua azienda viene rispettata la legge sulla protezione degli animali.
Bilancio di concimazione equilibrato:onde ridurre le perdite di sostanze nutritive nell’ambiente e creare cicli di sostanze nutritive possibilmente completi,l’apporto di azoto e di fosforo dev’essere calcolato in funzione del fabbisogno delle piante e del potenziale produttivo dell’azienda.Nel quadro del bilancio di concimazione la priorità è data ai concimi aziendali.I concimi minerali e quelli a base di scarti vengono impiegati soltanto in caso di necessità.Vige un limite di tolleranza di +10 per cento.
Almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo al fine di rilevare le riserve di sostanze nutritive presenti nel terreno e adeguare l’apporto di concimi onde conservare la fertilità del suolo.
Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica (SCE):le SCE devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della SAU messa a colture speciali e il 7 per cento della rimanente SAU.Lungo i sentieri devono essere mantenute strisce inerbite di almeno 0,5 metri di larghezza,mentre lungo le acque superficiali,i bordi del bosco,le siepi,i boschetti campestri e rivieraschi esse devono essere larghe almeno 3 metri.
Avvicendamento disciplinato delle colture:per conservare la fertilità del suolo e la salute delle piante,nelle aziende con oltre 3 ettari di terre aperte l’avvicendamento delle colture deve annoverare almeno quattro colture all’anno.Vanno inoltre prescritte quote massime delle colture principali rispetto alla superficie coltiva o pause.
A18 ALLEGATO
–
–
–
–
–
–
Protezione adeguata del suolo:per ogni coltura è stato fissato un indice di protezione del suolo.Onde ridurre l’erosione,le perdite di sostanze nutritive e i residui di prodotti per il trattamento delle piante,ogni azienda con oltre 3 ettari di terre aperte deve raggiungere un indice medio minimo di protezione del suolo.Esso ammonta a 50 punti nella campicoltura e a 30 punti nell’orticoltura.I giorni di riferimento sono il 15 novembre e il 15 febbraio.
Selezione e utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante:i prodotti per il trattamento delle piante possono disperdersi nell’aria,nel suolo e nelle acque e provocare effetti spiacevoli su taluni organismi.Dev’essere quindi data la preferenza a meccanismi di regolazione naturali e a processi biologici.In campicoltura e foraggicoltura sono vietati determinati trattamenti (p.es.il trattamento in preemergenza con erbicidi nelle coltivazioni di frumento).I prodotti autorizzati a determinate condizioni nella coltivazione di colture speciali sono riportati in elenchi costantemente aggiornati.
ALLEGATO A19 Esempidiquotemassimein%dellasuperficiecoltiva – Cereali (esclusi granturco e avena) 66 – Frumento e spelta 50 – Granturco 40 – Avena 25 – Barbabietola 25 – Patata 25 –
EsempidiindicidiprotezionedelsuolonellacampicolturaPunti – Colza 80 – Orzo autunnale,triticale,segale,avena autunnale 50 – Frumento autunnale,spelta 40 – Prati artificiali fino al 15 novembre 80 – Prati artificiali fino al 15 febbraio 100 –
Osservanza delle leggi
In caso d’infrazione delle prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque,dalla legge sulla protezione dell’ambiente e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio,oltre alla multa i pagamenti diretti vengono ridotti o addirittura negati.
Di seguito sono riportate alcune prescrizioni la cui violazione può comportare sanzioni:
– Osservanza del dovere di diligenza per evitare effetti pregiudizievoli alle acque (articolo 3 della legge sulla protezione delle acque).
Divieto di introdurre direttamente o indirettamente o di lasciar infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinarle.Divieto di depositare o spandere tali sostanze,se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l’acqua (articolo 6 della legge sulla protezione delle acque).
– Inosservanza del numero di UBGFG ammesse giusta l’articolo 14 della legge sulla protezione delle acque (commisurato alla SAU fertilizzabile).
– Capacità di deposito dei concimi aziendali non conforme all’articolo 14 della legge sulla protezione delle acque.
– Distruzione o danneggiamento di un biotopo protetto dalla Confederazione o dal Cantone – in particolare cariceti e paludi,siepi, boschetti campestri e siti secchi – nonché di rarità naturali o monumenti protetti,di un luogo storico protetto o di un paesaggio naturale protetto (comprese le zone palustri),se ciò è da ricondurre alla gestione agricola (articolo 24 capoverso 1 lettera a congiuntamente all’articolo 18 capoverso 1bis della legge sulla protezione della natura e del paesaggio);
– Infrazioni del divieto di incenerire i rifiuti (articolo 26 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico).
Le infrazioni delle prescrizioni citate sono trattate singolarmente in funzione dei fatti antecedenti e in considerazione delle conseguenze che hanno provocato.Vengono attribuite a una delle tre seguenti categorie:
– infrazione unica senza effetto duraturo.Esempio:un gestore ha proceduto un’unica volta allo spandimento di colaticcio contravvenendo alla legislazione sulla protezione delle acque (riduzione del 5 fino al 25%,al massimo 2'500 fr.);
– infrazione unica con effetto duraturo;le azioni o le omissioni hanno conseguenze su diversi giorni,settimane o mesi.Esempio:cumulo di letame non consolidato.Un gestore ha proceduto per diversi giorni allo spandimento ripetuto di colaticcio contravvenendo alla legislazione sulla protezione delle acque (riduzione del 10 fino al 50%,al massimo 10'000 fr.);
infrazioni ripetute;sull’arco di tre anni il gestore ha infranto più volte le stesse disposizioni rilevanti per l’agricoltura.Sono determinanti i fatti a partire dal 1999 (riduzione del 20 fino al 100%).
A20 ALLEGATO
–
–
Organizzazioni/Istituzioni
AFDAmministrazione federale delle dogane,Berna
DFEDipartimento federale dell’economia,Berna
DGDDirezione generale delle dogane,Berna
FALStazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura,Zurigo-Reckenholz
FAMStazione federale di ricerche lattiere,Berna-Liebefeld
FAOOrganizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura,Roma
FATStazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole,Tänikon
FAWStazione federale di ricerche in frutticoltura,viticoltura e orticoltura,Wädenswil
IEAIstituto di economia agraria,Zurigo
IRABIstituto di ricerche dell’agricoltura biologica,Frick
LBLCentrale di consulenza agricola,Lindau
OCSEOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,Parigi
OMCOrganizzazione mondiale del commercio,Ginevra
PFZPolitecnico federale,Zurigo
PSLProduttori svizzeri di latte,Berna
RACStazione federale di ricerche per la produzione vegetale,Changins
RAPStazione federale di ricerche per la produzione animale,Posieux secoSegretariato di Stato all’economia,Berna
SRVAServizio romando di consulenza agricola,Losanna
TSMFiduciaria Latte,Berna
UEUnione europea
UFAEUfficio federale per l’approvvigionamento economico del paese,Berna
UFAGUfficio federale dell’agricoltura,Berna
UFAFPUfficio federale dell’ambiente,delle foreste e del paesaggio,Berna
UFASUfficio federale delle assicurazioni sociali,Berna
UFFTUfficio federale della formazione professionale e della tecnologia,Berna
UFSPUfficio federale della sanità pubblica,Berna
UFVUfficio federale di veterinaria,Berna
USCUnione svizzera dei contadini,Brugg
USTUfficio federale di statistica,Neuchâtel
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-,Forst- und Ernährungswirtschaft Sagl,Bonn Unità di misura
haettaro = 10'000 m2
ALLEGATO A65 ■■■■■■■■■■■■■■■■
Abbreviazioni
cts.centesimo fr.franco
hora hlettolitro kcalchilocalorie kgchilogrammo kmchilometro llitro mmetro m2 metro quadrato m3 metro cubo
mia.miliardo
mio.milione
pz.pezzi
qquintale = 100 kg
ttonnellata
%per cento
Ømedia
Terminologia/Denominazioni
ADCAliquota di dazio del contingente
ADFCAliquota di dazio fuori contingente
AGIS/SIPAServizio d’informazione sulla politica agricola
AIAssicurazione invalidità
AVSAssicurazione vecchiaia e superstiti
ca.circa
cfr.confronta
CO2 Anidride carbonica
compr.compreso
DOPDenominazioni di origine protette
ESBEncefalopatia spongiforme dei bovini («Malattia della mucca pazza»)
IGPIndicazioni geografiche protette
IPGIndennità per la perdita di guadagno
IVAImposta sul valore aggiunto
LAgrLegge sull’agricoltura
MPRMaterie prime rinnovabili
NAzoto
OGMOrganismi geneticamente modificati
PFosforo
PACPolitica agricola comune dell’UE
PERProva che le esigenze ecologiche sono rispettate
p.es.per esempio
PIProduzione integrata
PMPeso alla macellazione
PTPProdotti per il trattamento delle piante
PVPeso vivo
risp.rispettivamente
SAUSuperficie agricola utile
SCESuperficie di compensazione ecologica
SSRASistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
UBGUnità di bestiame grosso
UBGFGUnità di bestiame grosso foraggio grezzo
ULAUnità di lavoro annuale
ULAFUnità di lavoro annuale della famiglia
UMUnità di manodopera
UMSUnità di manodopera standard
URAUscita regolare all’aperto
ZM I,II,..Zona di montagna
Rinvio all’allegato (p.es.tabelle)
A66 ALLEGATO
Barthelemy F.,Renault D.,Wallernder W.,1993. Water for a sustainable human nutrition:inputs and resources analysis for arid areas. UC Davis Internal report.
Chapagain A.K.,Hoekstra A.Y.,2003. Virtual water flows between nations in relation to trade in livestock and livestock products. UNESCO-IHE,Delft,Paesi Bassi.
FAO,1997.
Water Resources of the Near East Region:A Review. Roma.
Landwirtschaftliche Beratung St.Gallen,2004
Tätigkeitsbericht 2003.
Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),diverse edizioni. Rapporto agricolo 2000 / 2001 / 2002 / 2003.
Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),2003
Auswertung der Daten über die Milchkontingentierung;Milchjahr 2002/2003.
Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),2004
Pubblicazione delle attribuzioni dei contingenti doganali. Conformemente al punto 2 del Rapporto dell'11 febbraio 2004 del Consiglio federale concernente le misure tariffali,edizione separata.
Ufficio federale di statistica (UST),diverse edizioni. Einblicke in die schweizerische Landwirtschaft, Neuchâtel.
UNESCO-WWAP,2003.
Water for People – Water for Life.The United Nations World Water Development Report. http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/table_contents.shtml.
Unione svizzera dei contadini (USC),diverse edizioni. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg.
ALLEGATO A67 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Bibliografia








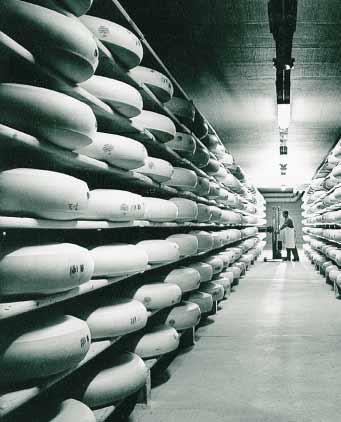

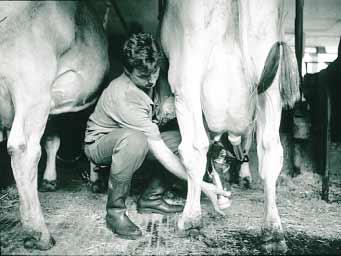

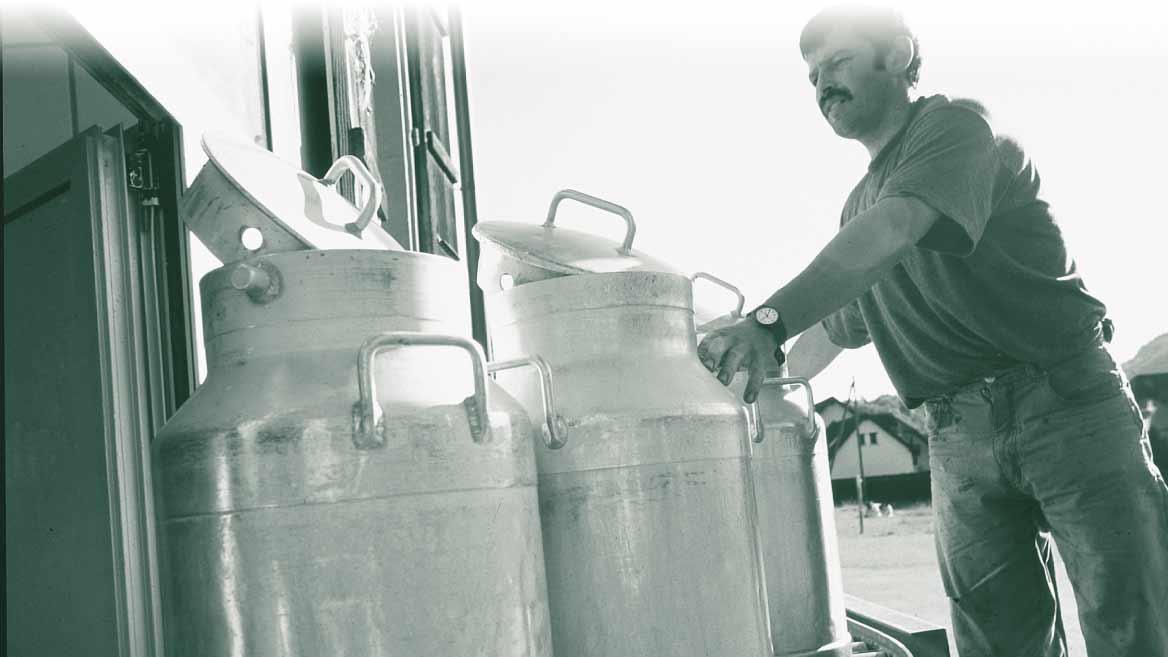

 ■ Margine lordo della carne
■ Margine lordo della carne

 Evoluzione del rendimento di prodotti scelti della campicoltura
Evoluzione del rendimento di prodotti scelti della campicoltura


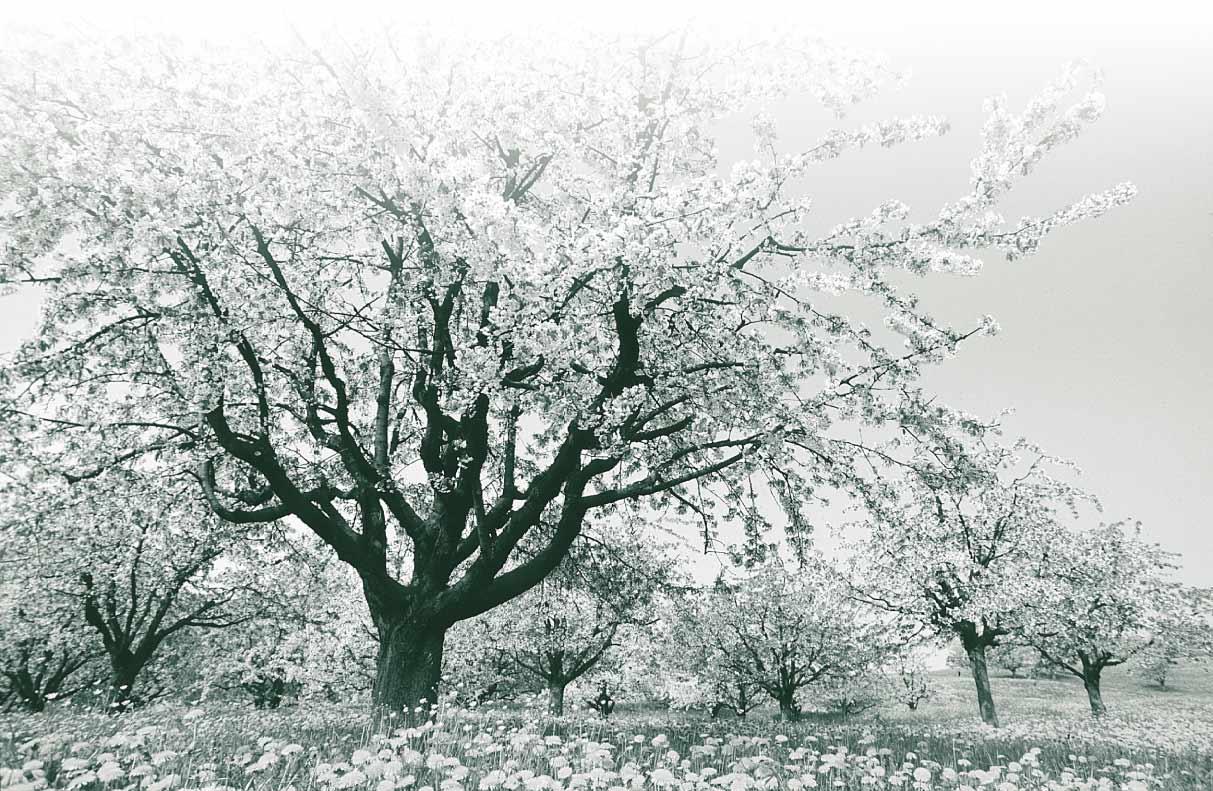




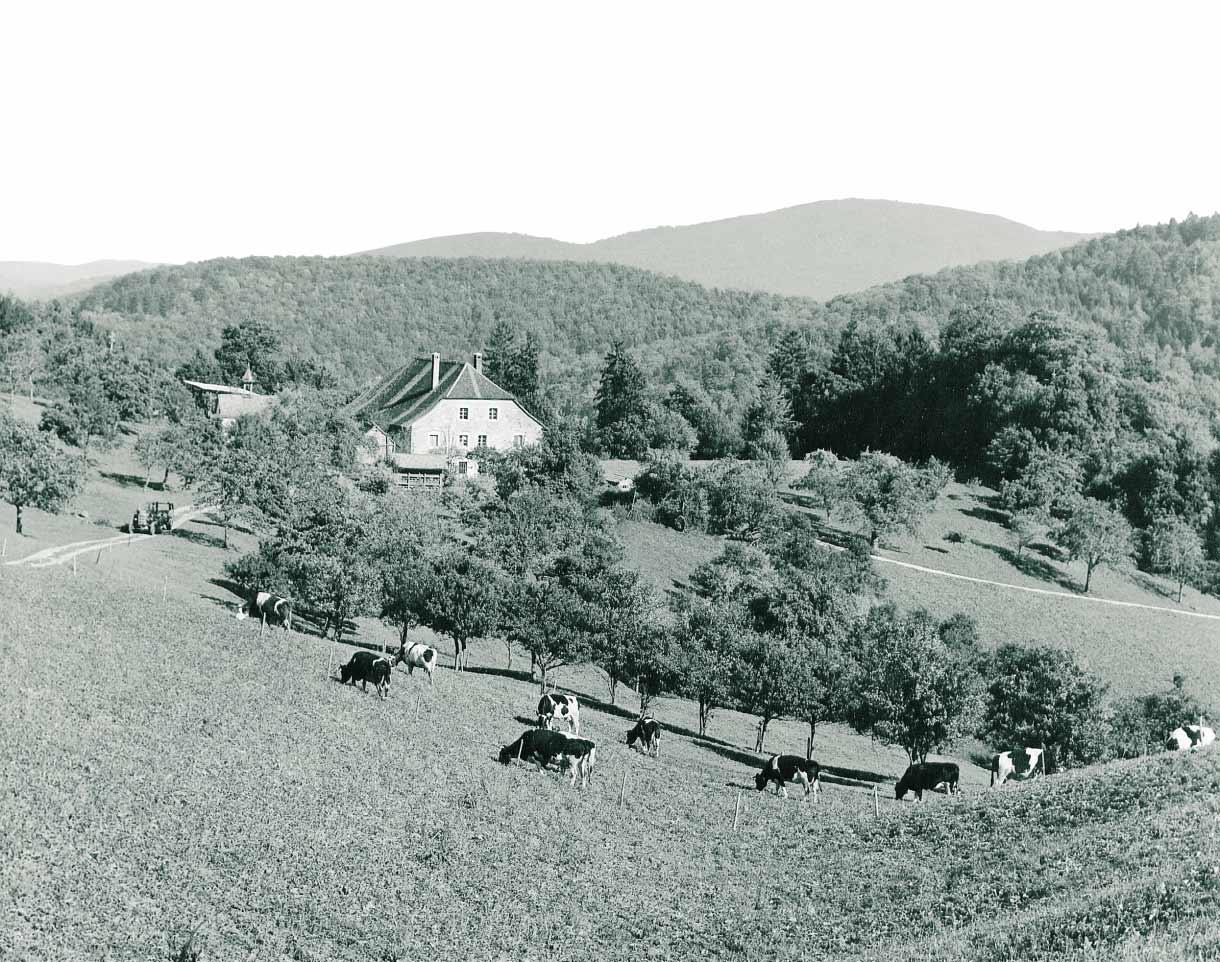





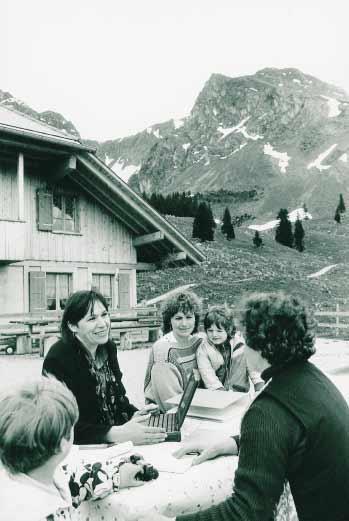
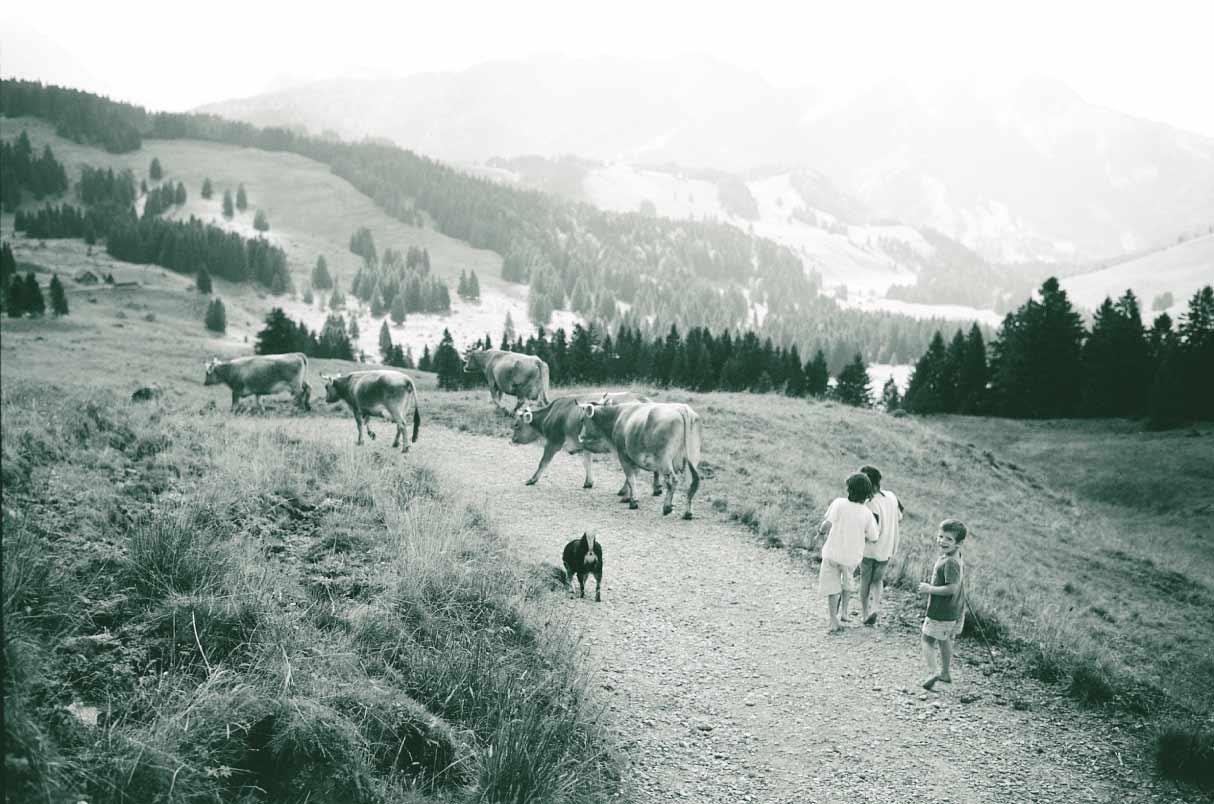
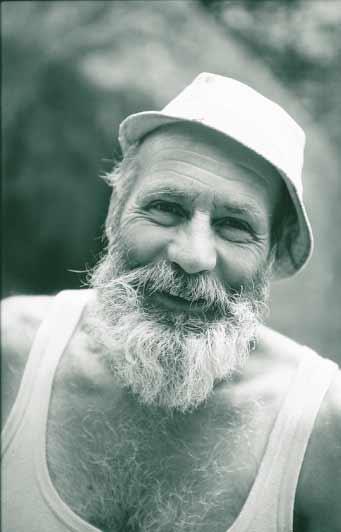





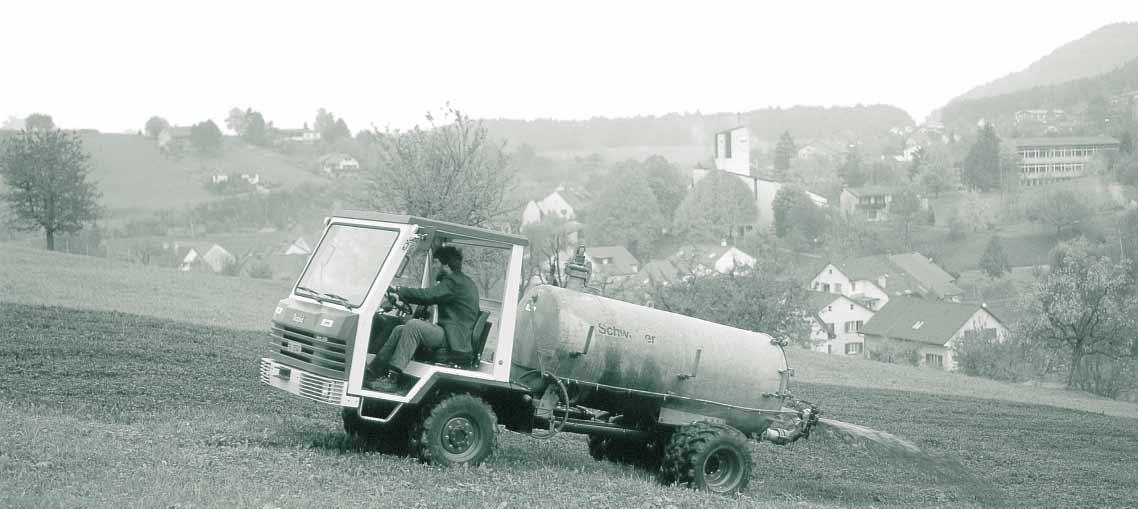 ■ Bilancio dell'azoto secondo il metodo dell'OSPAR
■ Bilancio dell'azoto secondo il metodo dell'OSPAR