Anno 157° - Fase. J/ 2007 gem1aio - marzo 2007


Anno 157° - Fase. J/ 2007 gem1aio - marzo 2007

Corso di Medicina Trasfusionale: Situazione Attuale e Prospettive della Medicina Trasfusionale
Workshop in Ematologia: Cosa c'è di nuovo?
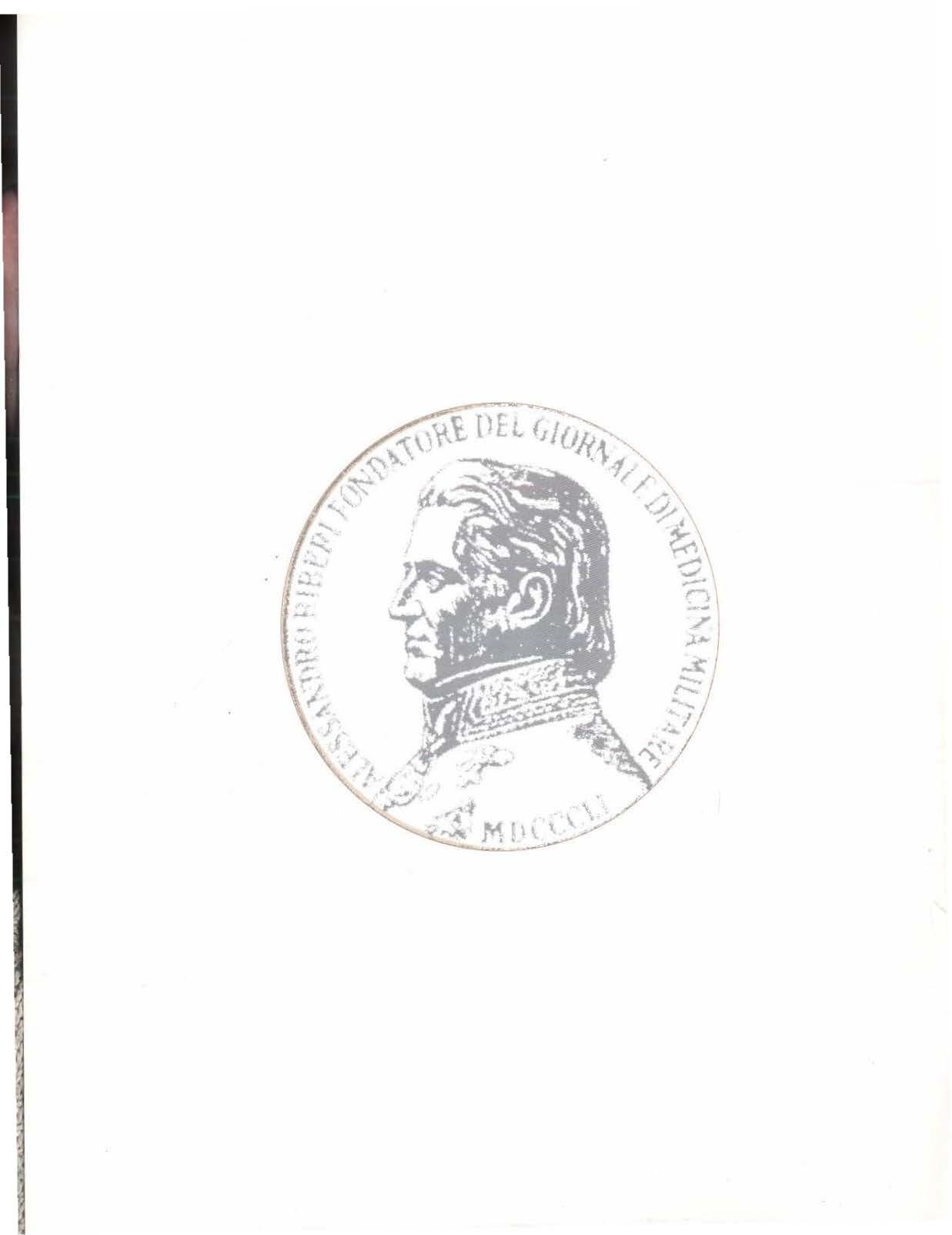
<d1nna ilit a re -----EMAJ.OL-DGIA DG

7 Saluto del Capo di Stato Maggiore Difesa Amm. Sq. Di Paola Giampaolo
WORKSHOP
11 Programma d e l Convegno
13 Nuove terapie della leucemia mi e loide acuta.
&\L\D0RI S
25 N ew insight into chronic Iymphocytic leuk e mia. *
MALR0 F. R., D EL GILTDICF L , F OÀ R.
29 Linfomi non Hodgkin a grandi ce lltù e B: c o s a c'è di nu ov o.
M. \RTEI.I .I M
33 Moschcowitz Syndrom e
MELONI G TRISOLIN I S. M., CAPRJA S
37 La Coagulazi one Intravascolare Disse minata.
A\'\1SAT1 G.
43 La biologia molecolare nelle malattie mi eloproliferative. *
OTTONE T. . Lo Coco F.
51 Nuovi farmaci per il controllo delle emorragie nei traumi di guerra. *
R OSSETTI R.
CORSO DI MEDICINA TRASFUSIONALE: Situazione attuale e prospettive della Medicina Trasfusionale
Programma deJ Corso
Presentazione: Intervento del Capo Dipartimento Immunoematologia.
J\IL.\L'RO E
La donazione di s angue
P A~O S
Le anemie n e l pazi e nte non ematologico.
MAFFEI L.
Larn r i tradotti imerameJJLe in inglese - Artide, e ntfrely t ran s latC' in engli sh
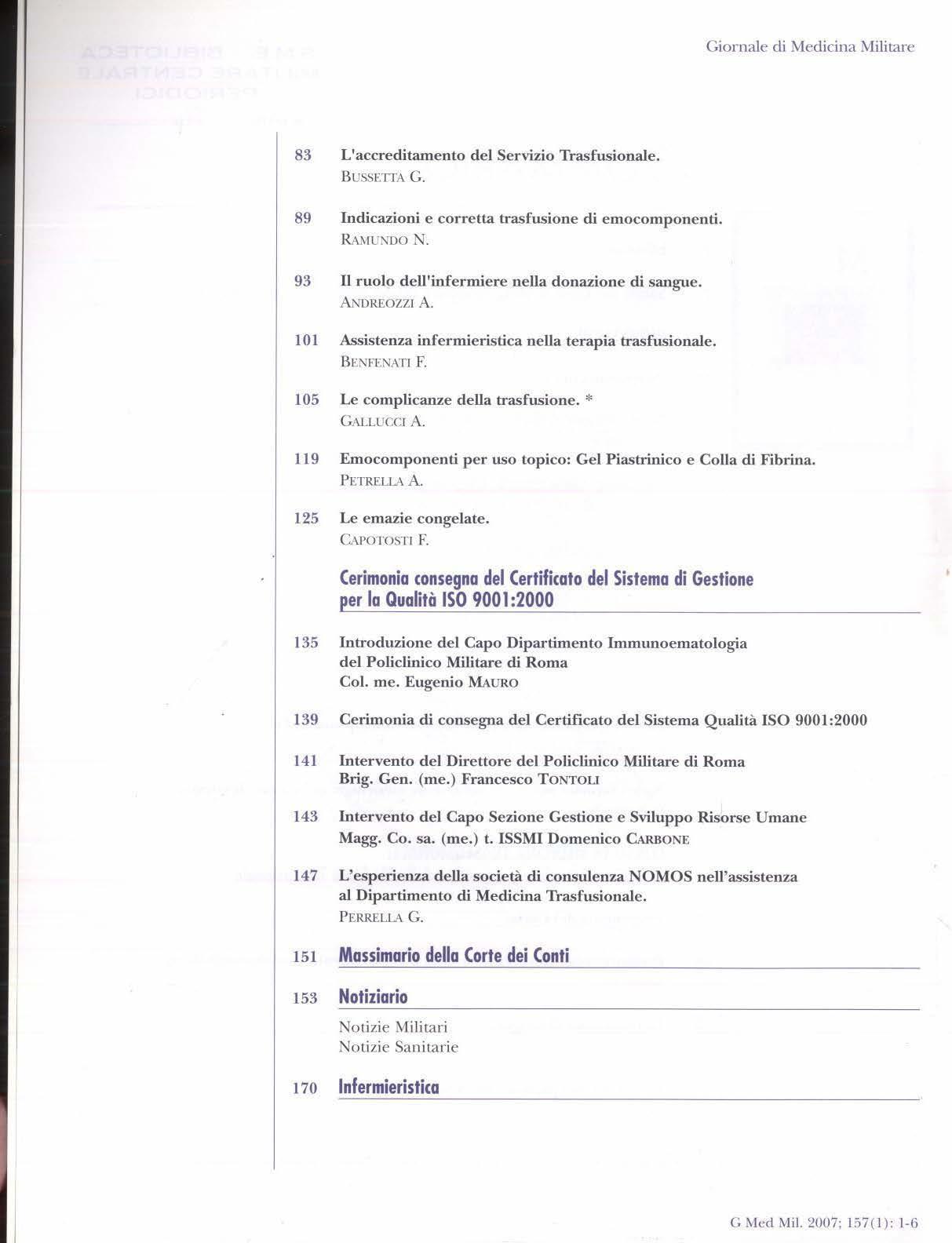
83 L'accreditamento del Servizio Trasfusionale.
BussETIA G.
89 Indicazioni e corretta trasfusione di emocomponenti.
R AMUNDON.
93 Il ruolo dell'infermiere nella donazione di sangue.
ANDREOZZI A.
1O1 Assistenza infermi eristica nella terapia trasfusionale.
BENFFNATI F.
105 Le comp licanze della trasfusione. *
GALLUCCI A.
119 Emocomponenti per uso topico: Gel Piastrinico e Colla di Fibrina.
P ETRELLA A.
125 Le emazie congelate.
C.,APOTOST I F.
Cerimonia consegna del Certificato del Sistema di Gestione er la Qualità ISO 9001 :2000
135 Introduzione del Capo Dipartimento Immunoematologia del Policlinico Militare di Roma
Col. me. Eugenio MAURO
I 39 Cerimonia di consegna del Certificato del Sistema Qualità ISO 9001 :2000
141 Intervento del Direttore del Policlinico Militare di Roma
Brig. Gen (me ) Francesco TONTOU
143 Intervento del Capo Sezione Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Magg. Co. sa. (me.) t. ISSMI Domenico CARBONE
J47 L'esperienza della società di consulenza NOMOS nell ' assistenza
aJ Dipartimento di Medicina Trasfusionale.
P ERRELU G.
151 Massimario della Corte dei Conti
153 Notiziario
Notizie Militari
Noti7.ie Sanitarie
I 70 Infermieristica
Periodico trimestrale
del Mini s tero della Difesa
a cura d11lla
Direziow Generale dAla Sanilà Militare
Direttore responsabile
Ten. Gen. J\,1ichde DMvito
Comitato Scientifico
Brig. Gen /i't,rlerico Aformo
Amm. lsp. Capo \!inumzo Mnrtines
Gen. lsp. Capo Manlio Carboni
Gen. B. CC RTL Domenico Ribalti
Referenti Scien ti fici di Forza Armata
Ten. Col. mP. Gltiuco Cali
C I'. (SAN) Ciusej>j1e Forare
Col. CSA m /'aofo 1òsro
'frn. Col. CC RTL (me.) Sergio \'mtum
Coordinatore e d itoriale
C,a/1. nw. Marro Cmmavitci
Consulenti
Ten. Gen. me. (c. a.) Domenico Mario Alonaco
Rn'g. c:m. me. (r) Cfrnui.io IJe SantiJ
Redazione e Segreteria
Fmnresca A malo
1'\',i{/er Dr Caro
Claudio Fan/tra
Stefano lvhtlargia
Alessandro Rerde
Collaboratori
Giovanni Fasria
J,uigi Usta
Francesco Boccucri
Direzione e Redazione
Via S. S1efmw Rolundo, 4 • 00184 Roma
Te{. e Fax: 06/47353327
Amm in i.stra:zi one
Ufficio A 1mni11iftr1aioni Speciali del Ministem Difesa
Via Mrmala, 104 - 00185 Roma
Stampa
Stilgrafim s.r.l. - Roma
Spedizi one in llliJ. Pilli. 70% - /ciliate di Roma
A u torizzazione del Tribunale d i Rom a o! n. 11687 del R,>gisliv delk1 ;tampa il 27- 7-67 (Mice ISSN {XJJ 7..()364
Fini to di stampare n e l novembre 2007
Garanzia di rise r vatezza
I da t i jll"rsonati forniti Jwr l'indirizzario vmgono utilizzati Psclusivamente per l'invio della pubblicazione e non vmgono rerlu ti o terzi per nes~wi motivo (D. Lgs. { 96/2003 - CodirP in ma/Pria rii protezione dr,i dati personali).

Italia:
AbbonamenLi militari e rivili
€ %,15
A.U.C (med ici, [armac isLi, oclomo iatri e veterinari),
A.S. infermieri professionali
€ 30.99
Fase. singolo (annata in corso)
€ 5,16
Fase. singo lo (annate arretrate)
€ 7,75
Estero
€ 86,00 - $ 89,10
Librerie
Sconto del 10% sull'imporro annuo
ILalia € 32,54
Estero€ 77.40 - $ 80 .1 9
Servirsi, per i versamenti, del e/ e postale n. 00610014 intestato a:
Miliistero Di fesa - Uff. Amministraz ioni Specia li Giornale di Medicina Militare
Via Marsala n 104 - 00185 Roma.
I Sigg. Abbonali sono pn;gati di segnalare Lempcstivamente e\ emuali cambiamenti cli i ndirizzo allo scopo cli evitare disguidi nella spcdi7,ione del Giornale.
L'IVA su ll 'abbonamento di questo trimestra le è cons id erata n e l prezzo cli vend ita ed è asso l ta dall'Editore ai sensi dell'art. 74, primo co mma letre ra C del DPR 26 / 10 / 1972 n. 633.
L'importo 11011 è d etra ibil e e pertanto non verrà rilasciata fattura.
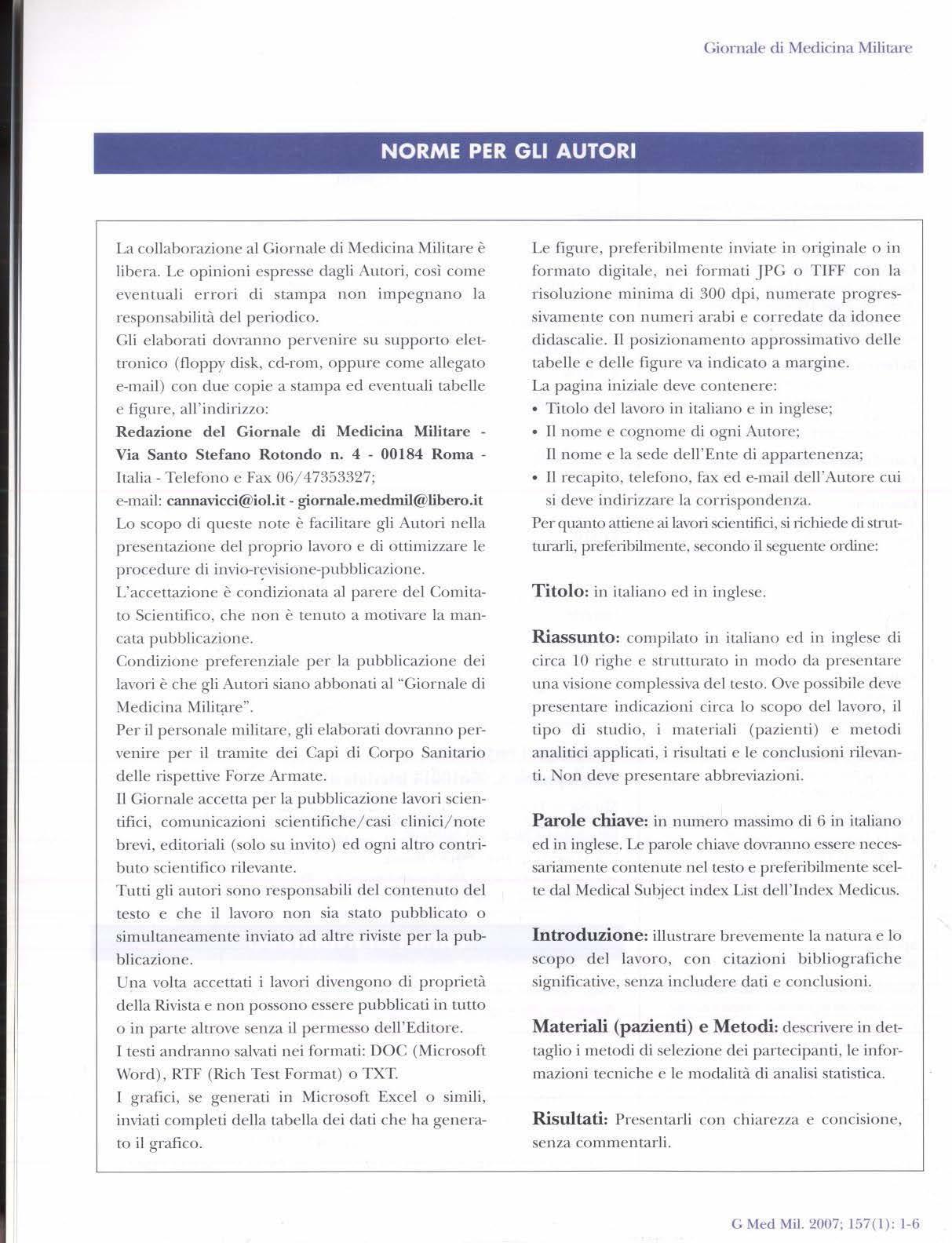
La collaborazione al Giornale di Medicina Militare è libera. Le opinioni espresse dagli Autori, così come eventuali errori di stampa non impegnano la responsabilità del periodico.
Gli elaborati dovranno pervenire su supporto elettronico (floppy disk, cd-rom, oppure come allegato e-mail ) con due copie ,L stampa ed eventua li tabelle e figure, a ll 'i ndiri zzo:
Redazione d e l Giornale di Medicina Militare -
Via Santo Stefano Rotondo n. 4 - 00184 RomaItalia - Telefono e Fax 06 /,17353327; e -mail: cannavicci @ iol.it - giornale.medmil@libero.it
Lo scopo di queste nore t'> facilitare gli Autori nella presentaàone del proprio lavoro e di ottimizzare le procedmc <li invio-r~·,·isione-pubblica1.ione.
L'accettazione è condizionata al parere del Comitato Scientifico, che non è tenuto a motivare la maucata pubblicazione.
Conclizione preferenziale per la pubblicazione dei lavori è che gli Autori siano abbonati al 'Giornale di Medicina Miliqire".
Per il personale militare, gli elaborati dovranno pervenire per il tramite dei Capi di Corpo San i tario delle rispettive Forze Armate.
LI Giornale accetta per la pubblicazione lavori scie11tifici, comunicazioni scient ifi che / casi clinici / nott> brevi, editoriali (solo su invito) ed ogn i altro contributo scientifico rilevante.
Tutti gli auto ri so n o responsabili de l contenuto del testo e che il lavoro non sia stato pubblicato o simu l taneamente imiato ad a lu·e riviste per la pubb l icazione.
Una vo lta accettati i la vori divengono di proprietà della Rivista e non possono essere pubblic ali in wtto o in pane altrove senza i l permesso dell'Editore.
I i·es ti andran n o salvali nei formati: DO C (Microsoft Word), RTF ( Ri ch Test Format) o TXT.
I grafici, se ge n erati in Microsoft Exccl o simili , inviati comp leti della tabella dei dati che h a generato il grafico.
Le figure, preferibilmente inviate in 0 1·iginale o in formato digitale. nei formali JPC o TlFF con la risoluzione minima di 300 dpi, numerate progress ivamente con numeri arabi e corredate da idonee didascalie. Il posizionamento approssimativo delle tabelle e delle figure va indicato a margine. La pagina iniziale deve contenere:
• Titolo del lavoro in italiano e i11 inglese:
• Il nome e cognome di ogni Autore; Il nome e la sede dell'Ente di appartenenza;
• Il recapito. te lefono, fax ed e-mail dell'Autore cui si deve indiriaare la corrispondenza.
Per quanto attiene ai lavori scientifici, si riclùecle cli strutnmrrli, preferibilmente. secondo il seguente ordine:
Titolo: in it al iano ed in inglese
Riassunto: compi la to in italiano ed in inglese cli circa 10 righe e stru1rurato in modo da presentare una vis ione comp lessiva del Lesto. Ove possibile deve presentare indicazioni circa l o scopo ciel lavoro, il tipo di stud io, i materiali (pazienti) e metodi ana liti c i app li cati, i risultati e le conclusion i rilevanti. on deve presemare abbreviaz ioni.
Parole chiave: i n nmnero massimo di 6 in italiano ed in inglese. Le parole c hi ave dovranno essere necessariamente contenute nel testo e preferibi l mente scelte dal Medica] Subject index List dell' l ndex Medicus
Introduzione: illustrare brevemente la natura e lo scopo del lavoro, con citaz ioni bibliografiche significative. senza includere dati e conclusioni.
Materiali (pazi e nti) e M e todi: descrivere in dettag li o i me todi di seleL.ione dei partecipanti, le in.formazioni tecniche e le m odal ità di a n a lis i statistica.
Risultati: Presentarli con chiarezza e conc ision e, senza commentarli.
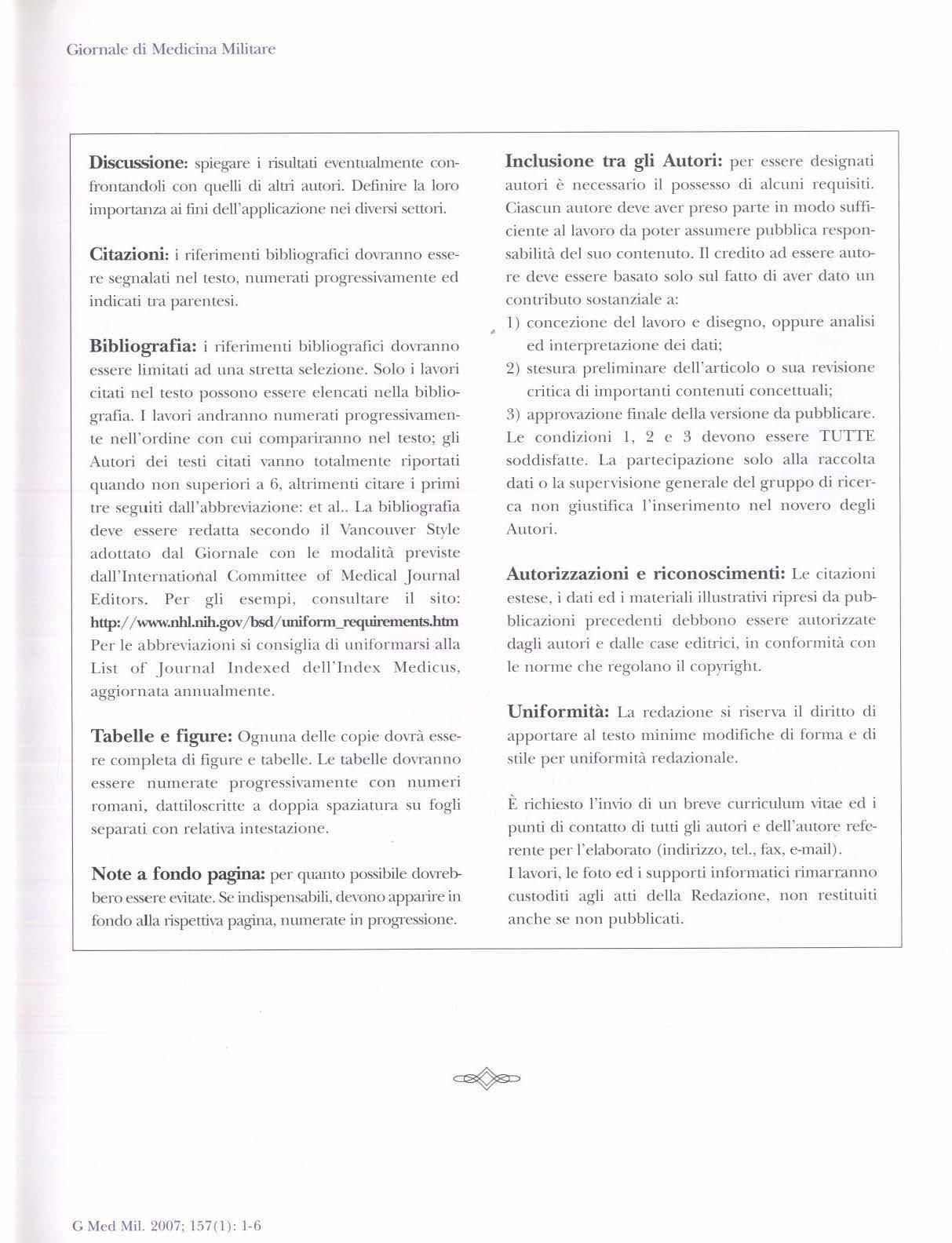
Discussione: spiegare i risult.aù eventualmente confron candoli con quelli cli alai autori. Definire la loro importanza ai fini dell'applicazione nei diversi scttoti.
Citazioni: i riferimenti bibliografici dovranno essere segnalati nel testo, numerati progressi\·amcnte ed indicaù u-a parentesi.
Bibliografia: i r iferimenti bibliografici dovranno essere I.imitati ad una stretta sel ezione. Solo i laYori ci tati nel testo possono essere elencati nella bibliografia. I lavoti aneli-anno numerati progressi,·amcnLe nell'ordine con cui compariranno nel testo; gli Autori dei testi citati vanno tota lmente 1iport.ati quando non superiori a 6. a luimcnti citare i prim i tre seg u iti dall 'abbrcviazione : et al.. La b i bliografia deve essere redatta secondo il Vancouver Style adottato dal Giornale con le modalità preYiste dall'Intcrnational Commitree of Medicai Journa l Eclit.ors. Per gli esempi, consultare il sito: http: //www.nhl.nih.gov/bsd/ uniform_requ:u-cm e ntsl1tm Per le abbreviazioni si consiglia di uniformarsi a ll a Lis t of Journal lndext>d dell"Inclex Meclicns, aggiornata annualrnenle.
Tabelle e figure: Ognuna delle copie dovrà t>ssere comµ leta cli figure e tabel le. Le tabelle dovranno essere numerate progressivamente con numeri romani, dattiloscritte a doppia spaziatnra su fogli separati con relativa in tcstazione.
Note a fondo pagina: per quanto possibile dovrel:>bero essere eYitat.e . Se indispensabil i, devono appaiire in fondo alla ,ispettiva pagina, numerate in progr essione.
Inclusion e tra gli Autori: per essere designati autori è necessario il possesso cli alcuni requisiti. Ciascun a11torc dcYc aver preso pane in modo sufficiente a l lavoro da poter assumere pubblica responsabilità del suo contenuto. TI credito ad essere antorc dc\"(' essere basato so lo sul fatto di aver dato un contributo sostanziale a: , l) concezione del lavoro e disegno, oppnre analisi ed interpretazione dei dati;
2) stesura preliminare dell"articolo o sua revisione critica di importanti contenuti concettuali;
3) approvazione finale della versione da pubblicare. Le condizioni 1, 2 e 3 devono essere TUTTE soddisfatte I.a partecipazione solo alla raccolra dati o la supervisione generale del gruppo di ricerca non giustifica l 'inserimen to nel novero degli Autori .
Autorizzazioni e ri c onoscime nti: Le citazioni t>srese, i dati cd i materiali il l ustrativi ripresi chi. pubblicazioni prcccrlenti debbono essere autorizzale <lagli autori e da ll e case t·ditrici, in conformità ron le norme che regolano il copyright.
Unifo rmità: La rcda,:ione si riserva il diritto di apportare a l resto minime modifiche di forma e di slik per uniformità redazionale.
È richiesto l'imio di un breve curriculmn vitae ed i pumi cli contatto cli tutti gli autori e dell"autorc referente per l'elaborato (indirizzo, tel.. fax, e-mail).
I lavo1i. le foto ed i supporti i nformat i ci 1.imarranno custoditi agli atti della Redaz,iont>, non restituiti anche ~e no n pubb li cati.
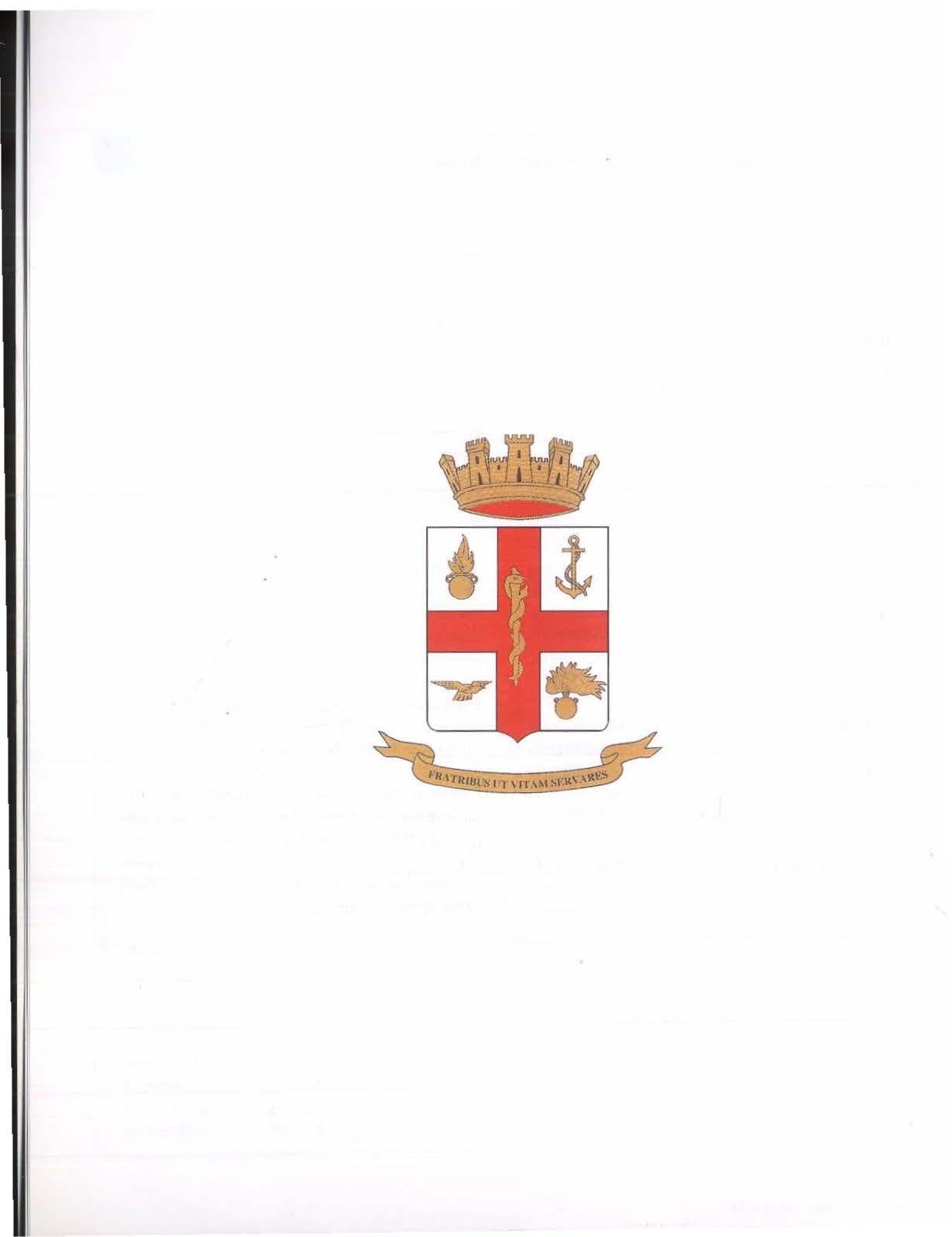
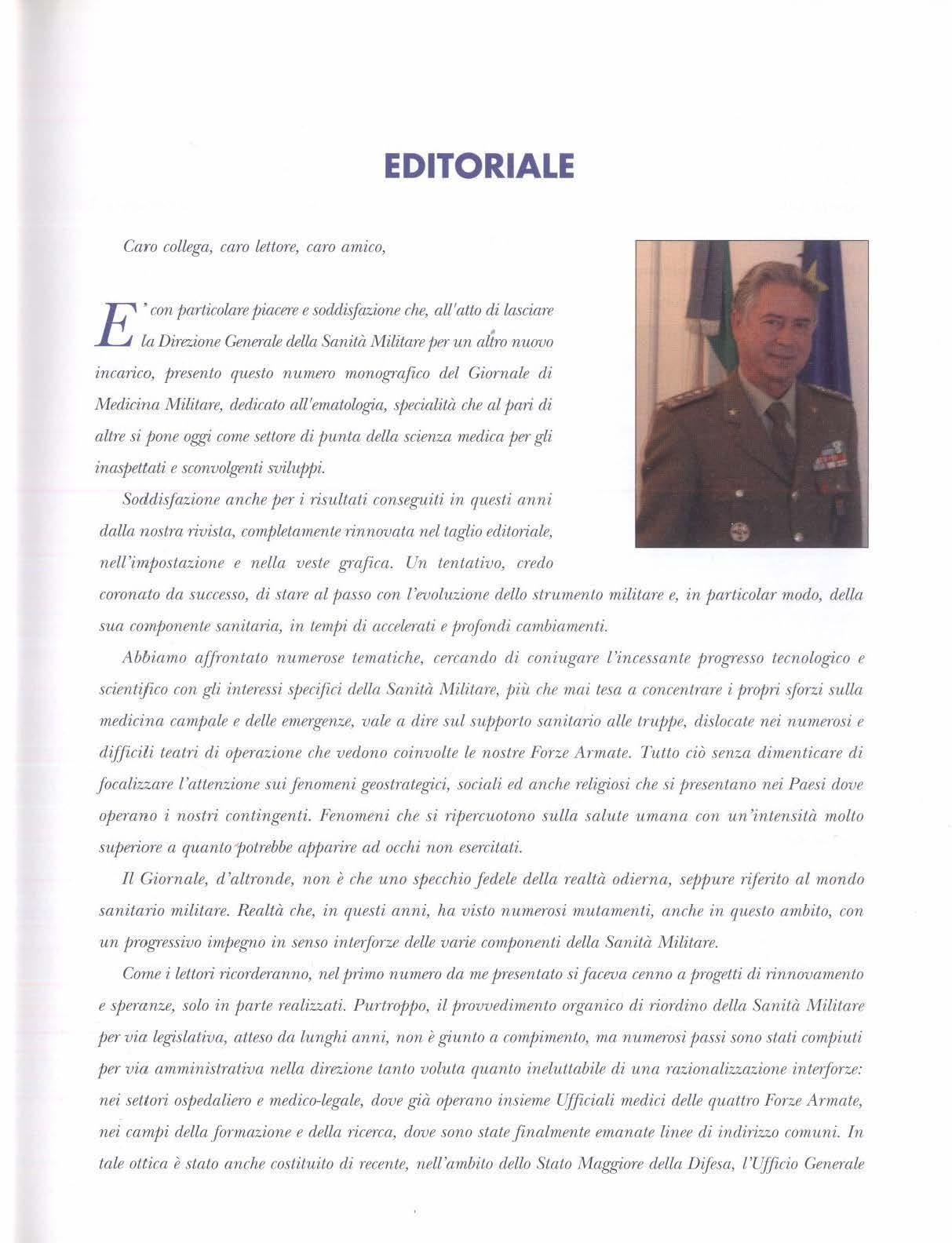
Caro collega, caro lettore, caro amico,
E'con parlicowre piacere e soddisfazione che, all'atto di lasciare
la Direzione Generare dell,a Sanità Militare /Jn- un altm nuovo incarico, presento questo numero monograjico del Giornale rii Merlirina Militare, dedicato all'ematologia, specialità che al pari di altre si pone oggi, come settore di punta della scienza medica per gli inaspettati e sconvolgenti sviluppi
Soddisfazione anchr jJPr insultati conseguiti in questi anni dalla nostra rivista, compktamente rinnovata nel taglio editorialR, nell'impostazione e nella veste grafica . Un tentativo, credo coronato da successo, di slarP al /Jasso mn l'evoluzionf dello strumfnto militare e, in particolar modo, della sua componentf sanitaria, in /empi di accelerati e /1rofondi cambiamenti. Abbiamo affrontalo n11merose tematiche, cercando di coniugare I 'incessanti' progresso lecnologico P scientifico con gli interessi specifici dflla Sanità JV[ifilare, più rhf mai tesa a concenlmre i propri sforzi sulla medicina cmnfmle f d.ellf pmergnne, vale a dire sul supporto sanitario allf truppe, dislocate nei numerosi f d{[(icili teatri di operazione che vedono coinvolte le nostre Forze Armate. Tutto ciò senza dimenticare di focalizzare l'attenzione sui fenomeni geostrategici, sociali ed anche religiosi che si presentano nei Paesi dove operano i nostri conti ngenti. Fenomeni che si ripercuotono sulla salute umana con un 'intensità mollo superiore a quanto potrebbe a/Jpmire ad occhi non esercitati.
ll Giornale, d'altronde, non è che uno specchio fedele rlella realtà odierna, sefJ/JUre riferito al mondo sanitario militare. R ealtà che, in questi anni, ha visto 11 1tmf?'rosi mutamenti, anche in questo ambito, con un progressivo imf>egno in senso interforze delle varie componenti della Sanità Militare.
Come i lettori ricorderanno, nel primo numero da me presen tato si faceva cenno a progetti di rinnovamento e speranze, solo in f1arte realizzati. Purtrof1po, il fJrovverlimento organico di riordino della Sanità MilitarP per via legi,slativa, atteso da lunghi anni, non ;, giunto n rompimento, ma numerosi passi sono stati compiuti /Jrr via amministrativa nella direzione tanto voluta quanto ineluttabile di una razionalizzazione interforze: nei setto ri ospedaliero e medico-/,egale, dove già operano insieme Ufficiali medici dflle quattro Forze Armate, nei campi della fonnazione e drlla ricerca, dove sono state finalmente emanale linee di indirizzo comuni. Tn tale ottica ;, stato anche costituito di recente, nell 'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, l'Ufficio Generale
della Sanità J.'v1ilitare, che ho avuto l'alto privilegio di dirigere sin dal suo nascere. 'Jàle nuovo elemento organizzativo fornirà un ultnim·p contributo al processo di intnforzizzazione in allo, /)Ur 11el doveroso rùpetto delle competenu P dPlle lradizioni delle singolP Forze Armate, in totale sinergia con le altre Pntità sanitarie militari, sia dell'area tecnico-oj1emtivn chp /ernico-mnminislrativa. L'Ufficio Generale dPl/.a Sanità Militare ha, tm gli altri nwnerosi compiti, queUo di verifirarP "la congruità dell'organizzazione della Sanità Militare territoriale inteiforu, propo11n1do soluzioni ordinativo-organiche alternative·· ed opererà in tal senso per introdurre migliorie in un ·area tanto complfssa.
Tutto ciò, mettendo in moto quelle sinergie tra le varie areP della Difesa che il Ca/10 di Stato Maggiore ha più volte fortenumle auspicato in svariati d,oru menti ed inlPrve11ti, allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare il funzionamento di tuf/e le romponenti rM sistema. È questa, infatti, l'unica via /Jercorribile se si vuole.far fronte nel modo migliore e più costo-pjfimce, nella inf'oitabile limilale-,.;w delle ,iwrse disponibili economiche ecl umane, tanto alle quotidiane d~fflcoltà dPlla gestione ordinaria, quanto al!P impegnative ~fide poste dn un mondo gl.obalizzato e caratterizzato da /micolose asimmetrie.
lVfi sento profonr(amente arricchito dall'espnimza effettuata rome Direttore del Giornale di Medicina Militare e j,enso rhe tu, runico e rollega, ajfezionrtlo ed attento nostro lettore di questi anni, avrai sicuramente colto quPslo progressivo incrm1ento di pr~frssionalità.
T11/lo questo j, staio gratijìcanle e j,roduttivo, Psaltante ed arricchente, tullavia è giunto il momento di salutarci.
Altre sfide. attualrnn1fp si parano all'orizzonte della Sanità Militare itClliana ed <incora una volta, di frontP alla sfida del nuovo e del rlifjìcile, il mio compito è di essere là, in prima linea, wn la tenacia ed il sudore di un veterano pioniere.
Consapevole del fatto rhP il Giornale debba continuare ad essere il testimone di qursti evmti e di questi sfarzi, oltrP rhe della professionalità dei nostri sanitari e dell'evoha.ione della scienza medica, colgo pertanto l'occasione per ringraziare tulfi i collaboratori rhe hanno contribuilo al successo di questa irnjJortanle pwblicnzione ed augurare al mi1J surcessore, Ammiraglio Ispettore Capo Martines un profic1w e soddiiacenle proseguimento dei lavmi
Insieme con loro, ringrazio anche i LPft01i che ci hanno fedelmente seguilo in questi anni e, nel fJorgervi il mio sahtto, formulo un sincero augurio per una buona e proficua lettura, adendo infine la parola al Capo di Stato Maggiorn della Difesa.
Buona lettura
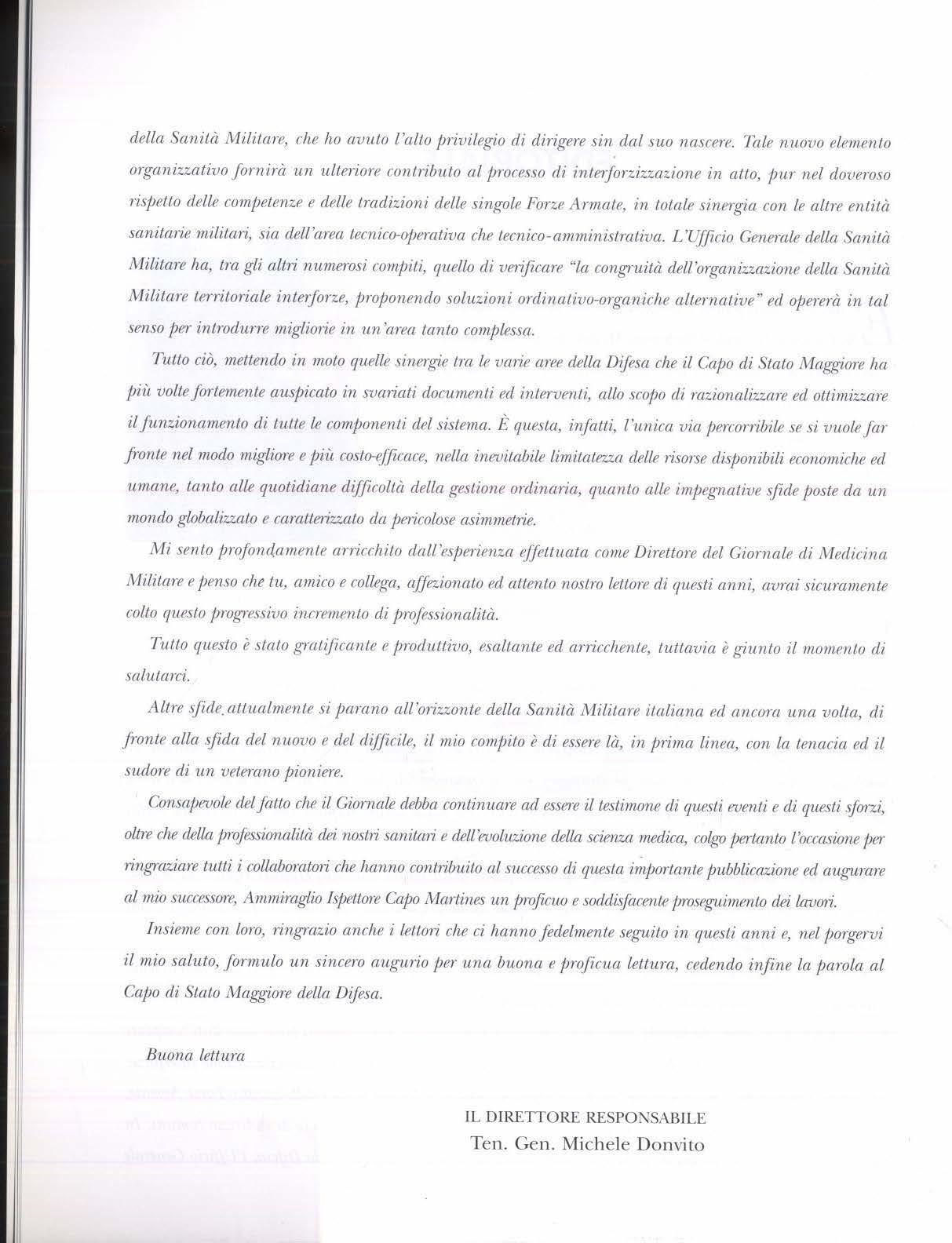
lL DIREn-oRE RESPONSABILE
Ten. Gcn. Mi chele D o n vito
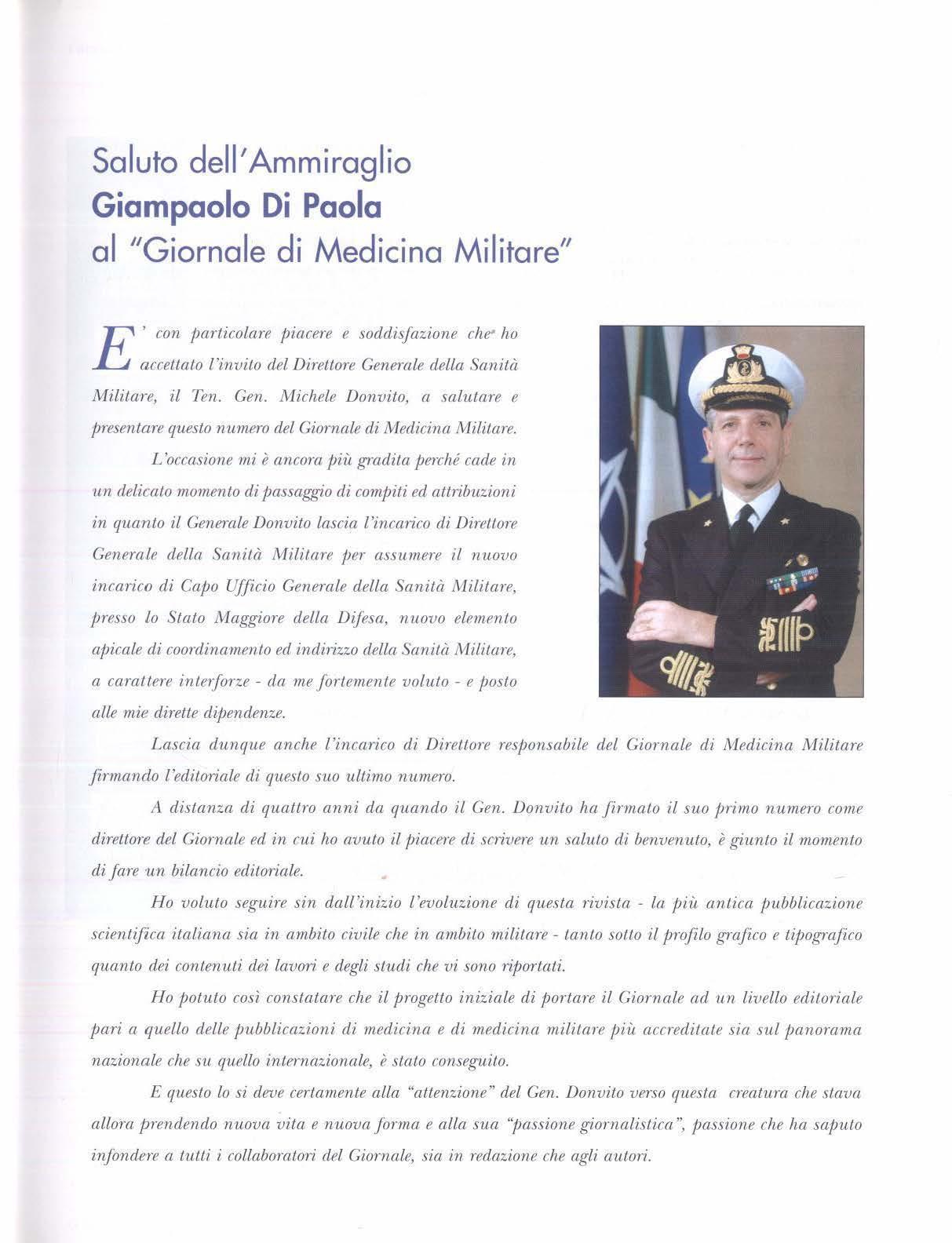
Econ /Jarticolare piacere e soddisfazione che- ho
affettalo l'invito del Direttore Generale della Sanità Milita-re, il Ten. Gen. Michele Donvito, a salutare e presentare questo numero del Giornale di Medicina Militare.
L'orrasione mi è ancora più gradita perché cade in 1tn delicato momento di passaggio di compiti ed attribuzioni in qucmto il Generale Donvito lasria l'incarico di Direlfore
Generale della Sanità Militare per assumere il nuovo inrariro di Capo Ufficio Gerierale della Sanità Militare, presso lo Stato Maggiore della D~/èsa, nuovo elemn1/o ajJicale di coordinamento ed indirizzo della Sanità Militare, a caral/ere intet:forze - da me fortemente voluto - e posto alle mie dirette dipendenze.
Lascia dunque anche l'incarico di Direttore responsabile del Giornali' di Medicina Militare firrnanrio l'editoriale di questo su.o ultimo numero.
A distanza di quattro anni da quando il Gen. Donvito ha firmato il suo primo numero come direttore del Giornale Pd in rui ho avuto -il piacere di scritlere un saluto di benvenuto, è giunto il momPnlo di fare t iri bilancio editoriale.
Ho voluto seguire sin dall'inizio l'evoluzione di questa rivista - la più antica pubblicazione scientifica italiana sia in ambito rivile chr in ambito militare - tanto sollo il profilo grafico e tipografico quanto dei contenuti dei lavori e degli studi che vi sono riportati.
Ho potuto così constatare che il progetto iniziale di portare il Giornale ad 1111 livello editoriale pari a quello delle Jmbblica zioni di medicina e di medicina militare /Jiù accreditale sia sul jJanorarna nazionale che su quello internazionale, è stato conseguito.
E questo lo si deve certamente alla "attenzione" del Gen. Donvito vn:so questa amtura clte stava allo1·a prendendo nuova vita e nuova forma e alla sua "passione giornalistica", passione che ha sajmlo infondere a tntti i collaboratori del Giornale, sia in redazione che agli autori.
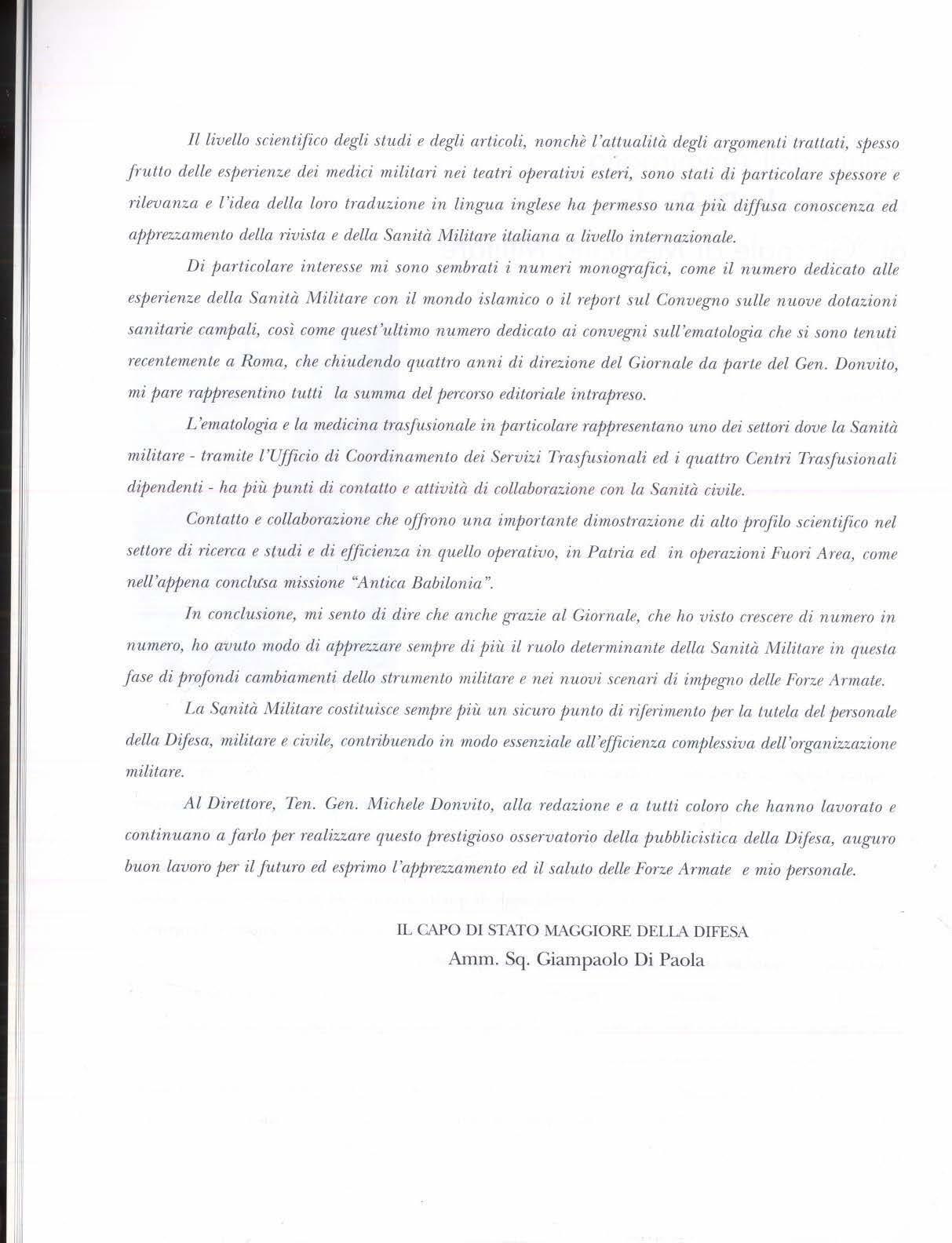
Il livello scientifico degli studi e degli articoli, nonchP l'alfualità degli argomenti trattati, spesso frutto delle es/Jeriem.e dei medici militari nei teatri opemtivi esteri, sono stati di particolare spessore e rilevanza f' l'idea della loro traduzionf' in lingua inglese ha j>ermesso una più dijfusa conoscenza ed apprez.z.amento della rivista e della Sanità Militare italiana a livello internazionale.
Di particolarf' interesse mi sono sembrati i numeri monografici, come il numero dedicato alle esperienze della Sanità Militare con il mondo islamico o il refJort sul Convegno sulle nuove dotazioni sanitarie campali, così come quest 'ttltimo numero dedicato ai convegni sull'ematologia che si sono tenuti recentemenl.e a Roma, che chiudendo quattro anni di direzione df'l Giornale da parie del Gen. Dorivito, mi pare rappresentino tutti la summa del perco1 so editoriale intrapreso.
L'ematologia e la medicina tra.ifusionale in jJartirolarr> rappresentano uno dei settori dove la Sanità militare - tramite l'Ufficio di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali ed i quattro Centri Trasfusionali dif;endenti - ha /1iù punti di contatto e attività di collaborazione ron la Sanità cir1ile.
Contatto e collaborazione che offrono una importante dimostrazione di alto profilo scientifico nel settore di ricl'rca e studi e cli efficienza in quello operativo, in Patria ed in operazioni .Fuori A rea, come nell'appena conclusa missione ''Antica Babilonia".
In conclusionf', mi sento di dire che anche grazif' al Giornale, che ho visto crescere di numero in numero, ho avuto modo di apprezzarP semj1re cli più il ruolo determinante della Sanità Militare in questa fase di pr~fondi cambiamenti dello strumento militare e nei nuovi scenari di impegno delle Forze Annate.
La S(lnità Militare costituisce sempre jJiù tm sicuro punto di riferimento fJer la tutela del personale delta Difesa, militare e civile, contribuendo in modo essenziale all'efficienza complessiva dell'organiz.z.azione militare.
Al Direttore, Ten . Gen. Michele Donvilo, alla redazionf' e a Lutti coloro che han no lavorato f' continuano a farlo fJer realizzare questo prestigioso osservatorio della pubblicistica della Difesa, auguro buon lavoro per il futuro ed esprimo l'a/Jprezzamento ed il sa lui o delle ròru Armate e mio f>f"rsonale.
IL CAPO DI STATO MAGGIORE D ELLA DfFESA
Amm. Sq. Giampaolo Di Paola
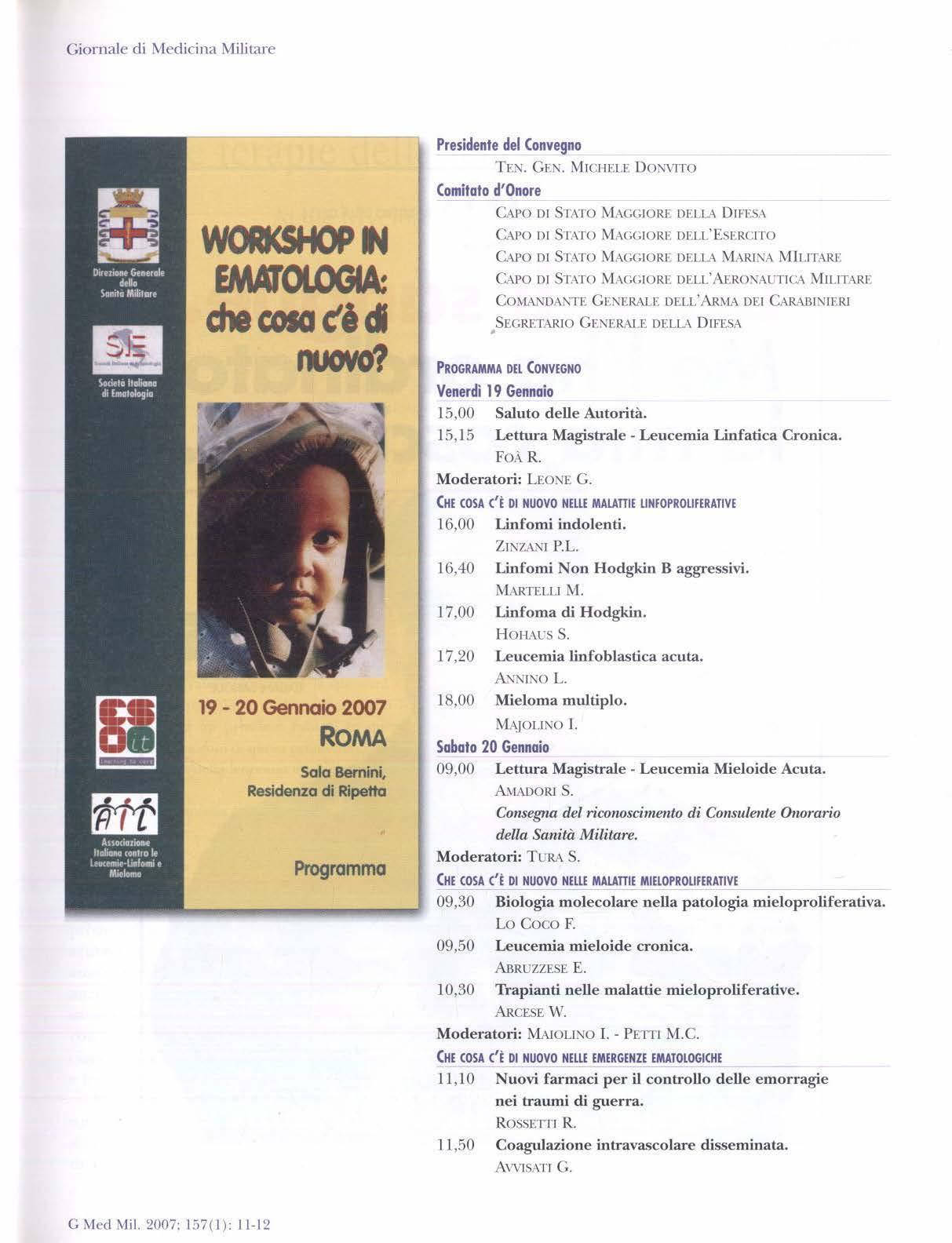
19 - 20 Gennaio 2007
Sala Bernini, Residenza dì Ripetta
Programma
Presidente del Convegno
TF.N. GF.1'. M1c11F.LF. Dol\,TIO
Comitato d'Onore
CAro 01 STATO MAcc~10RE DEtL\ 01n:s.,
CAro DI ST.\TO MAGGIORE DFLL'EsFRCITO
CAPO DI STATO MAGGIORF DELL\ lv1ARl~A MJI.ITAR.F.
C'.APO DI ST:\TO MAGGIOR.E DELL'AERO'\'AUTI CA MIUTARF
COt.lANDAJ\:TE GEJ\:ERALE DELL'ARMr\ DEI CARABI NIERJ
SEGRETARIO G F.J\:ERALE DELLA D IFESA
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Venerdì 19 Gennaio
15,00 Saluto d e lle Autori tà.
15,15 L ettura M agistrale - L eucemia Linfatica Cronica.
FoA R.
Mo deratori: L EONE G.
CHE COSA C'È DI NUOVO NEL.LE MALATTIE UNfOPROLJFERATIVE
16,00 Linfomi indolenti .
Z I N7,A.'IJ P.L.
16,40 Linfomi Non Hodgkin B aggressivi.
MARTELLI M.
l 7 ,00 Linfoma di Hodgkin.
H OJ-IAL"S S. 17 ,20 Leucemia linfob lastica ac u ta.
À'-INLNO L.
18,00 Mieloma multiplo.
M,\JOI.INO I. Sabato 20 Gennaio
09,00 L e ttura Magistrale - Leucemia Mieloid e Acu ta.
A\IIJ\DORJ S. Co11seg11a del rico 1wscime11 to di Consu lente Onorario della Sani tà M ilitare
M ode r ato ri : TURA S.
CHE COSA C'È DI NUOVO NELLE MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE
09,30 Biologia m ol ecolare n e lla p atol ogia miel opr ol iferaliva.
L o Coc:o F.
09 ,50 L e u cemia mie l o id e cr o nica.
ABRUZZESE E.
10,30 Trap ianti n e lle malattie mielop rolife r ative.
A.RCESE ',N.
Mo d e .-ato ri : MAIOLINO I. - P E1T I M.C.
CHE COSA C1 È DI NUOVO NELLE EMERGENZE EMATOLOGICHE
11 , 1O Nuovi far m aci per il con tro llo d e ll e emor ragie n ei traum i di guer ra.
RossETrl R.
11 ,50 Coagulazio n e in trava<;co lare di ssem ina ta.
A
\ '\1.S/ff f G.
MNSTERO DEUA DIFESA Dirmmé Generole dello Sor,iIO M~ìlore
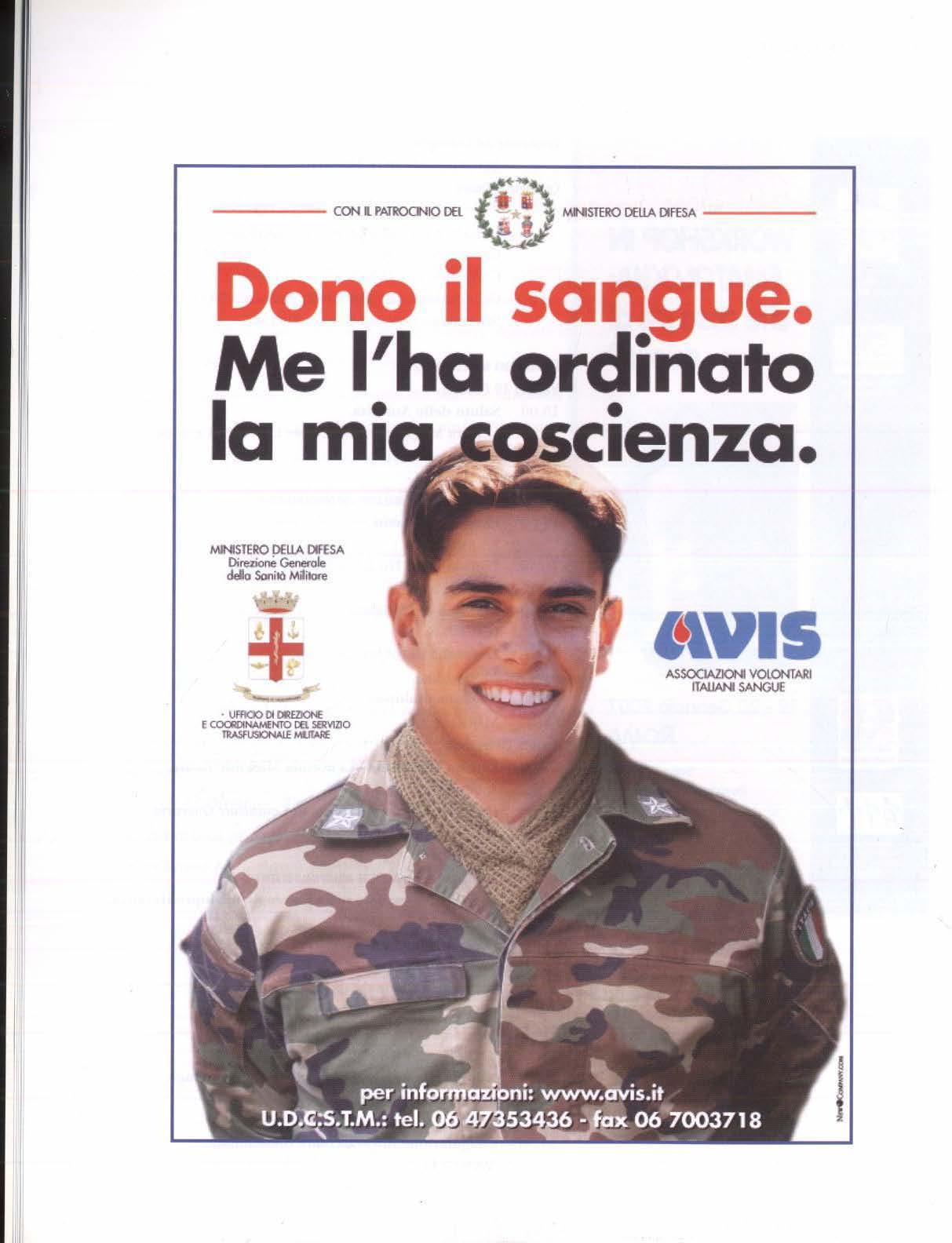
ASSOCIAZIONI VOI.ONTAIII ITAUANI SANGUE
UFAOOOIDIREZIOM: l COORDINAMENTO 00. :iEJMZJO TIWFIJSIONALE

* Prof <klla Srnou, di Spm11/ru:.azùme di Em11tolugia del/'Uniul'lsila rii Tor \lega/11 e P1immù1 del H.eparlo di Onwemalologia del Polìclinica di 7i,r 1Pt]!;llla - Roma.
Riassunto - Negli ultimi decenni non vi sono ~tali significaLi vi miglioramenti nella prognosi dei pazienti con leucemia rnieloic!e acuta ed ancora la maggioranza dei pa~Jenli muore per questa patologia. Negl i ulLimi anni c'è sLato un grande sforzo leso alla romprensione dei meccanismi molecolari di questa malattia che ha po1-1ato alla messa a punto di nuove terapie '·targcts" antilcuccmiche. Si va da agenti chemioterapici con nuovi meccanismi d'azione, come i modulatori dell'apoptosi o g l i agenti demetilanti. a meccani~mi cli rewrs ione della farmaco-resistenza, ad anticorpi monoclonali diretti verso spec i fici antigeni, a terapie m i rale che inibiscono la fÌ1117ione di molecole come le Lyrosi11 chinasi o Ras. La ricerca s11 mo l ti di questi agenti ì- ancora in fa_,e iniziale. ma qncsti nuovi trattamenti danno la speranza di rro1·arc una cura per la maggioranza dei paziemi con leucemia miel oide acuta in un pros,imo fmuro. Jn questo lavoro verranno desci-itli alcuni di questi promeuenli approcci Lerapeulici pc,- la cura de ll a leucemia mie loide acuta.
Parole c hiave: Leu c emia Mi e loide Acuta, Te rapia.
L a leucem i a m i e loide acuta è sopraL t uuo una mal atrja degli anziani, con una età mediana di presentazione cli circa 68 anni. L 'età avanzata è il fattore p r ogn ostico più imponante de ll a leucem ia mieloide acuta. Questo dato indubbiamente si correla con un aumento della co-morbosità nella popolazione a n zi ana, ma è a11che espressione della multiforme varietà bio l ogica del la malattia che spesso si presenta con un ins ieme di fattori di rischio. fra cui una associata mieloclisplasia, anorma l ità ci rogenetiche avverse e fenotipo "mullidrug resistance".
Molti paz ienti anLiani non vengono sotloposti ad un trat tamento chemioterapico intenso o per libera sce l ta personale o per le cattive condizioni genera l i d i sal ute. Tuttavia, anche per co l oro che ricevono il C Mcd Mii. '2007: 157(1): 1~24
S um m a ry - Abstr<1ct In 1hc l<1st f'ew dccadcs, rhc,-e has not been a significant improvemcnt in thc prognosis of' patients with anne myeloid leukemias. Stili, thc majority or pa t icnts ,uccumb lO Lhese disease~. In recent years there has been a greaL surge in the understanding of the molecular mechanisms of disease wh icl1 have prnvided us with new 1argets for anù-leukemia thernpy. These range from chenwtherapeutic agcnts ,,~th nove I mechanisms of' action, such as apoptosis modu lators. or dcmcthylaring agent~, to rt'versal of drugresistance mcchanisms, to monoclonal antibodics dirc·ctcd against specific a111igens, a.nel targetcd thcrapy thai inhibi1 the runctiou of molecules such as tyrosine kinascs or Ras. The research on many of I hese agen ts is stili in 1he early phases, hlll thest' new approaches offer the promise of linding a cnrt' for- 1hc m,~ority of patients with myeloid lcukcmia in the near finurc. I !ere we clescribe some of Lhe promising apprnachcs thai are currrntly hcing invcstigatcd in ù1c 1reatnwn 1 of ,1cute myeloid kukcmi,u,.
Key words: Ac ute Myelo id Lcuke mia , T h erap y.
trattamento convenzionale, la prognosi resra infausta con un'aspetlativa di vi ta a 5 an ni i n reriore a l 10% (Fig. 1). Alcune delle limitazioni della terapia convenzi ona le sono rappresentate dalla farmaco resis tenza e da ll a eccessiva tossic i tà . I poco confortanti "ou/come" ciel trattamento de ll a l eucem ia rnieloiclc acuta negli anziani hanno stimolaro, riuinrl i, g l i sforzi nella ricerca di nuovi rarmaci e strategie terapeutiche. Di recente, i progressi compiuti nella co n oscenza della biologia della leucemia mieloide acuta hanno prodotto l' identificazione di nuove potenziali terapie '·ta1gPfs" (m i rate) per una più efficace e meno tossica terapia anti leucemica. Questo l avoro fornisce una descriLione de ll e p iù recent i possib il ità terapeutiche della leucemia mieloide acuta negli anzian i.
(1986-90)
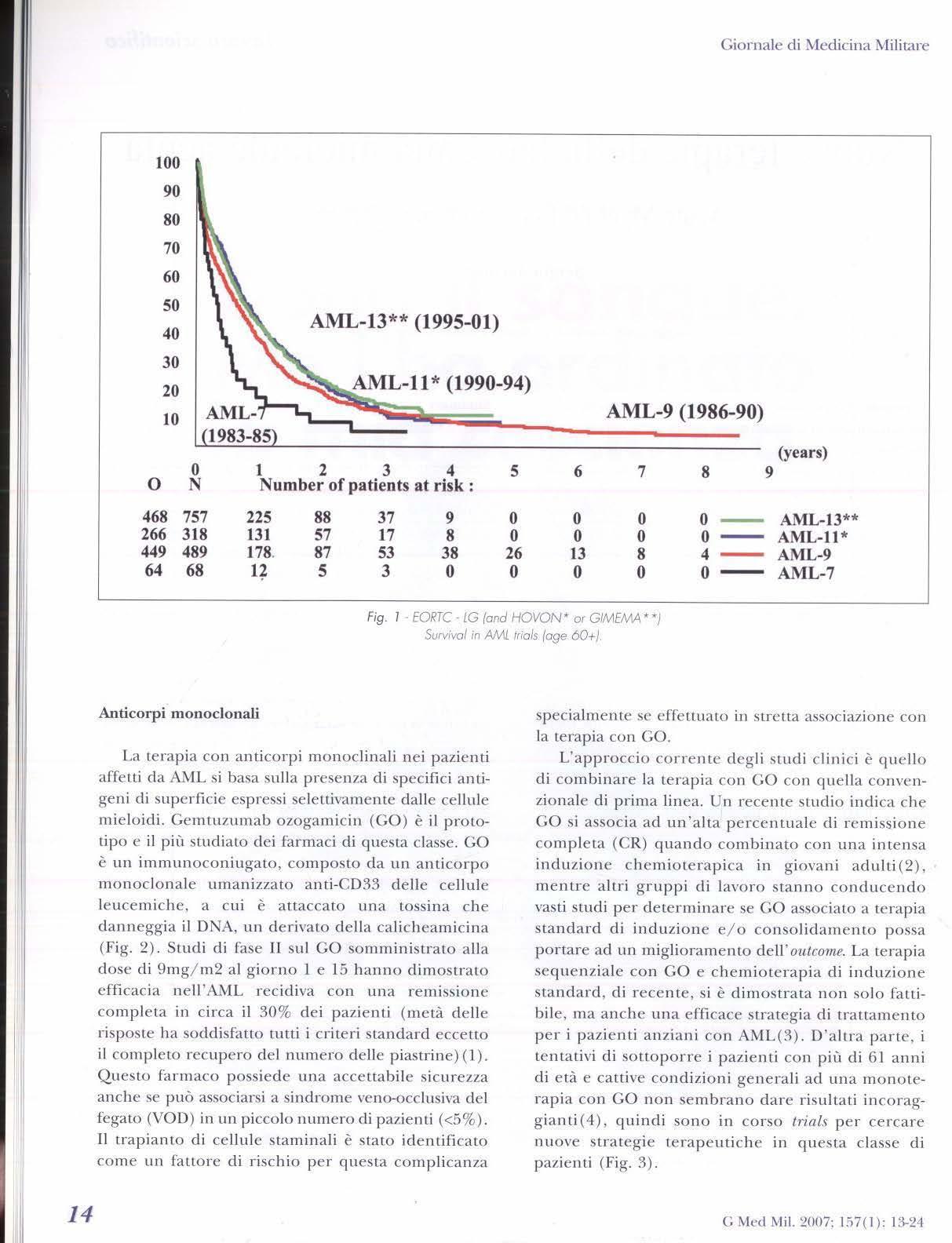
Anticorp i monoclon ali
La terapia con anticorpi monoclinali nei pazienti affetti eia A.ML si basa sulla presenza di spec ifici antigeni di superfic ie espressi se lettivamente dalle cellule mieloidi. Gerntuzumab ozogamicin (GO) è il prototipo e il più studiato dei farmaci di questa classe. GO è un imrnunoconiugato , composto da un anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD33 delle ce llul e leucemiche, a cui è attaccato una tossi na c he danneggia il DNA, un derivato della calichearnicina ( Fig. 2). Studi di fase JI su l GO somm ini strato alla dose d i 9mg / m2 al giorno 1 e 15 hann o dimostrato efficacia n e ll 'AM L recidiva con una remissione co mpl eta in circa il 30 % dei pazienù (metà delle i-isposte ha sodd isfauo mtti i criteri standard eccetto il completo recupero ciel numero delle piastrine) ( 1 ). Questo farmaco possiede una accettabil e sicurezza anche se può associarsi a sindrome veno-occlusiva del fegato (VOD) in un piccolo numero di paz.iemi (<5 % ).
11 trapianto di cellule stam ina li è stato identificato come un fa ttore di rischio per questa comp li ca n za
specia lm ente se effettuato in stretta associazione con la tera pia con GO.
L'approccio corrente degli studi c l inici è quello di comb inare la terapia con CO con quella convenziona le cli prima lillea. Un recente studio indica che GO si associa ad un'a l ta percentuale di remissione co mpleta (C R ) quando comb inato con una intensa induzione chemioterap i ca in g iovan i adu lti (2), mentre altri gruppi di lavoro sta nn o conduceudo vasti stud i per determinare se GO associato a terapia standard di induzion e e / o consolidamento possa portare ad un miglioramento dell ' outco1ne. La terapia sequenz iale co n GO e chemioterapia di induzi one sta nd ard , di recente, si è dimostrata non so lo fanibile, ma anche una efficace strategia di trattamento per i pazienti anz ian i con AML(3). D'altra parte, i tentativi di sottoporre i pazienti con più di 6 1 anni di età e cattive cond izioni genera li ad una monoter apia con GO non sembrano dare risultati incoraggianti( 4), quindi sono in corso trials per cercare nu ove strategie terapeutiche in questa classe di pazienti (Fig 3)
lgG4 anti-CD33
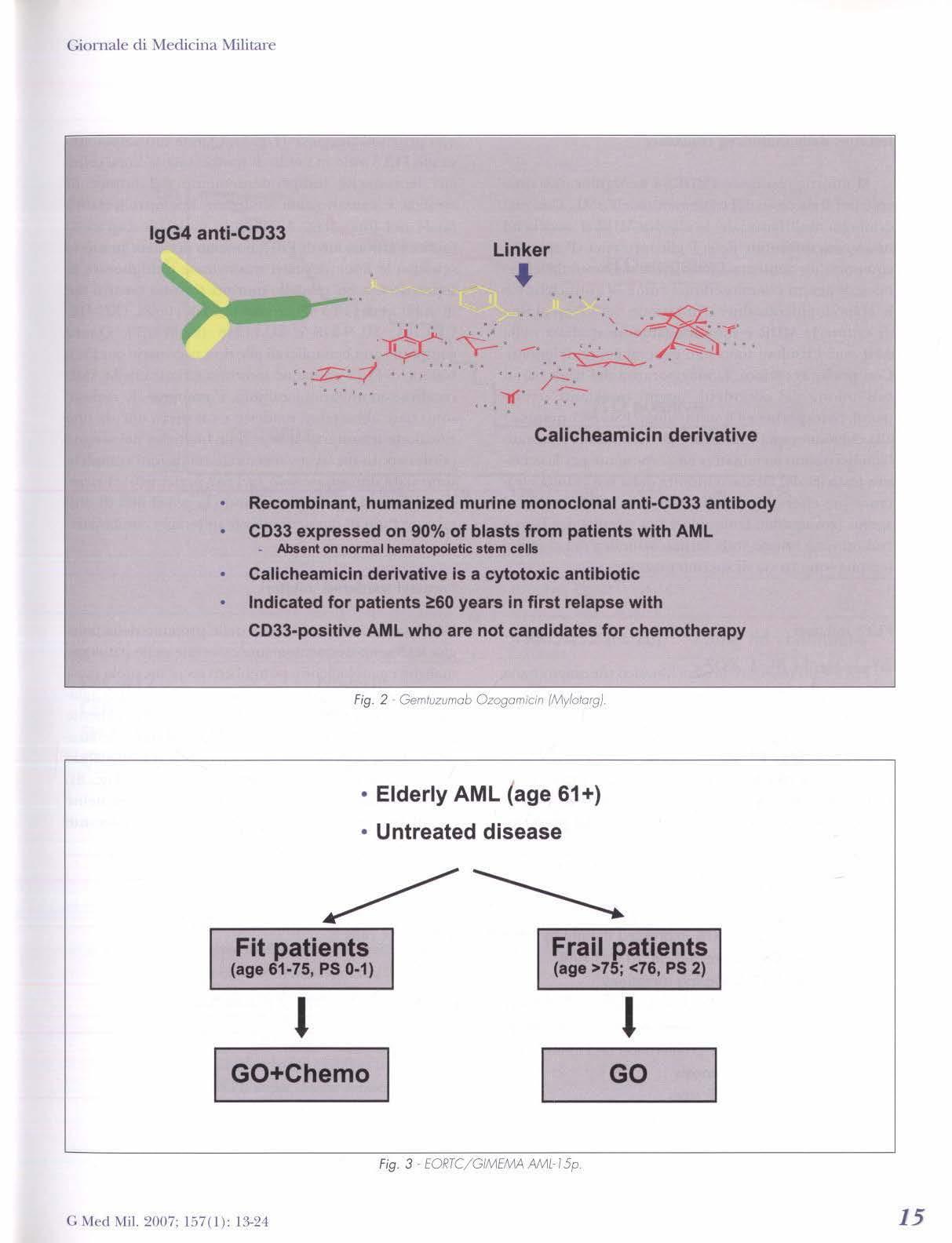
Callcheamicln derivative
• Recomblnant, humanlzed murtne monoclonal antl-CD33 antibody
• CD33 expressed on 90% of blasts from patlents wlth AML
- Absent on normai hematopoletlc stem cells
• Callcheamlcln derivative 1s a cytotoxlc antlblotlc
• lndicated for patlents ~60 years In flrst relapse wlth CD33-posltlve AML who are not candldates for chemotherapy
• Elderly AML (age 61+)
• Untreated disease
Fit patients (age 61-75, PS 0-1)
Frail patients (aga >75; <76, PS 2)
Fig. 3 - EOl?TC/GIMEN\A AML- 1Sp
Inib itori della muJ tid rug resistance
Mulliclrug resistance (IvIDR) è Lm significativo ostacolo per il successo del trattamento dell'ANIL. Con nna eziologia mu l tifattoriale , la classica MDR si associa ad una sovraespressione della P-glicoprotcina (P-gp), che comporta un aumentata fuoriuscita dalla cellula leucemica di agenti chemiorerapici come le antracicline e le epipodophillotossine. L'inibizione rlella P-gp a l fine di evitare la MDR è stata lungamente studiata nella A.ML, ma i ,-isultat.i sono stati generalmente deludenti. Con poche eccezioni. la maggioranza dei trials basati sull'unione dei cosiddetti "agenti revertanti" (verapaJTiil, ciclosporina ed il suo analogo PSC-833, quinine) alla chemioterapia convenzionale non hanno mosu-ato benefici o sono terminati prematuramente per la eccessiva tossicità del farmaco indotta dalla sua ridotta dearance per effetto dei modulatori della MDR(5). Nuovi agenti (zosuqnida,~ laniquidar) più selettivi per P-gp e con minima azione sulla farmacocinetica dei chemioterapici sono in via di sperimentazione.
FLT3 inibi tori
FLT3 è un recettore tirosinchinasico u-ansmembrana chè è espresso dal 70 % al 100% dei pazienti con ANIL. Approssimativan.ente 11d 25 % dei pazienti con AML vi è una duplicazione interna in tandem del dominio iuxtamembrana di FLT3. mentre in un altro 7% , i è una mutazione a nuico del loop intracitop lasmatico del recetwre; entrambe provocano l'attivazione costitutiva del recettore. Queste alterazioni sembrano far presagire

una prognosi peggiore (Fig. 5). Queste mut;uioni attivando FL1'3 sono in grado cli u-asformare le linee cellulari leucemiche indipendentemente dal fattore di crescita e causano una sindrome mieloproliferativa fatale nel topo (Fig. 4). Piccole molecole capaci di inibire l'attivazione di FLT3 possono uccidere in modo selettivo le linee cellulari trasformate e migliorare la soprawivenza nel modello murino. Ci sono quattro tipi di inibitori di FLT3 oggi testati in trials clinici: PKC-412, CEP-701 , MLN-518 e SU-11248 (Figg. 6,7). Questi composti sono ben tollerati alle dosi necessarie per l' inibizione di FLT3 ed hanno mostrato efficacia nella AML recidiva con mutazioni atlivanti. Comunque, le risposte sono state abbastanza modeste e caratterizzate da una riduzione u,msiwria delle cellule blastiche nel sangue periferico. In un lavoro recente le remissioni complete sono state dimostrate solo su 1/ 42 pazienti(6). J ,icercatori stanno ora spe1imentando la possibilità di ottimizzare l'uso di queste molecole in terapie combinate.
Mutazioni attivanti in una delle proteine della famiglia RAS sono frequentemente osservate nelle patologie maligne ematologiche e potrebbero avere un molo patogenetico nello sviluppo della leucemia mieloide. Cli inibiL01i di farnesyl transferasi (ITI.s) sono stati inizialmente S\'Ìluppati per interferire con il processamento e la localiz7azione di RAS nella membr,ma celltùare, impedendo quindi la trasduzione di segna li mitogeni (Fig. 8 ) . Tuttavia sembra probabile che l'inibizione cli proteine prenilate, oltre che RAS, possa essere più rilevante
• Class lii RTK expressed mainly by normai hematopoietic cells
• Overexpressed in 50% of AML
• FLTJ-activating mutations
- Internal tandem dupl ication (ITD) and point muta t ions occur in ~30% of patients with AM L
- Lead to constitutive activation of t he tyrosine kinase
- Stimulate proliferation and inhibi t apoptosi s of AML cells
• Poor prognosis
· Lower CR rates
- Hi gher risk of relapse
1.00
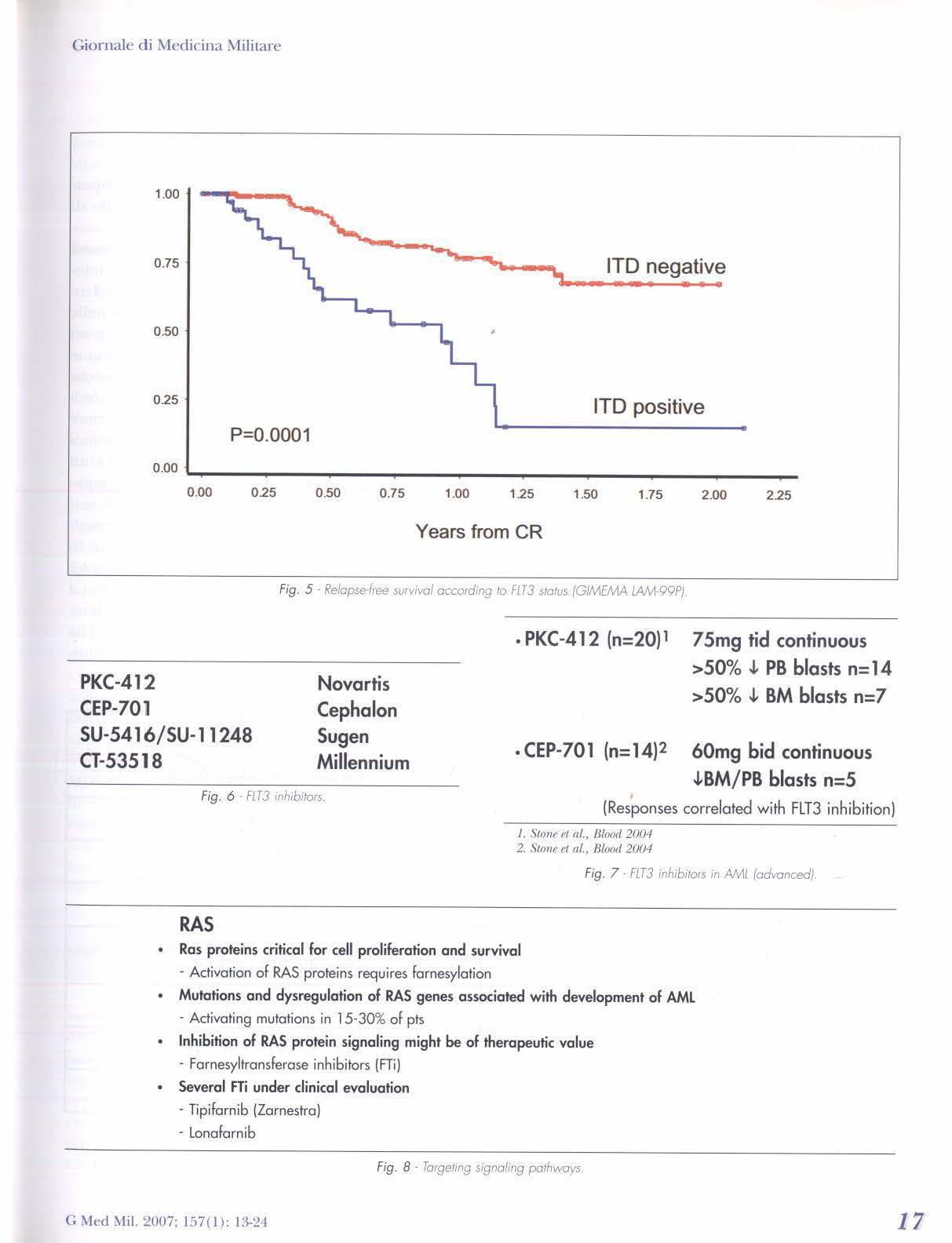
0.75 ITD negative
O SO
0.25 ITD positive P=0 .000 1
PKC-412
CEP-701
SU-5416/SU-11248
CT-53518
Novartis Cephalon Sugen Millennium
• Ras proteins criticai for cell proliferation and survival
. PKC-412 (n=20) 1 75mg tid continuous >50% J, PB blasts n= 14 >50% J, BM blasts n=7
CEP-701 (n= 14)2 60mg bid continuous J.BM/PB blasts n=5 (Responses correlated with FLT3 inhibition)
- Activation of RAS proteins requires farnesylation f ig 7 · FlT3 inhibi1ors ,n Ah1L /odvonced).
• Mutations ond dysregulation of RAS genes ossocioted with development of AML
· Activating mutations in 15-30% of pts
• lnhibition of RAS protein signoling might be of theropeutic value
- Farnesyltronsferase inhibitors (FTi)
• Several FTi under clinica! evoluation
- Tipifarnib (Zarnestra)
- Lonafarnib
nell'attività di FTis. In imo studio di fase I l di AìvlL ad alto 1ischio. tipifim1ib (Rl 15777) è stato studiato come unico agente terapeutico. Si definiscono A.\1L ad aJto 1·ischio i casi in cui l'età sia superiore a 65 anni, o l'età sia superiore a 18 anni ma con alLeraLioni citogenetiche sfavorevoli, o la AML secondaria. 111 un "report" ancora provvisorio, il tasso di remissione genera le (rem issione completa e parziale) co n la terapia è stato ciel 34% in tutta la popolazione sn 1ctiata e del 30% nei pazienti con oltre 75 anni (7). La mediana della durata della ,isposta nei pazienti con 1·emissione completa è stata di 6,4 mesi. In ola-e, i pazienti con remissione completa hanno avuto una mediana di sopraVYivenza cli 14,4 mesi con il o3% vivo a J 2 mesi. Effetti collatera li uon emato log ic i di grado 3 correlati ,lll"uso di tipifarnib si sono verificati nel 43% dei pazienti e per lo più sono state complica11ze cli tipo infettivo e gastrointestina li Sulla base di questi incoraggianti risultati, molti gruppi di ricerca hanno iniziato rri als comparalivi prospeuici per valutare tipifarnib come terapia cli prima linea negli adu lti più anziani con &\1.L che nc:Ìn sono idonei per una chemioterapia convcnzionalé. Qucsm agente è stato swcliato anche in pazienti più giovani in combinazione con una chemioterapia intensiva (Fig. 9). Per altri due FTis. lonafarnib e BMS-214662. sono ancora in corso trials clinici.
Agenti antiangiogenetici
L'angiogenesi è uu a ltro target terapeutico importante per la AML visto che un aumentato livello di fauori cli crescita angiogenetici ed un aumentata vascolariaazionc del midollo osseo si associano a prognosi peggiore. Per g iun ta, il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF) svolge un ruolo nello stimolare la cr<:'scita e la prolifrrazionc del clone maligno nelle sindromi mielodisplastichc e nella AML. Per tali ragioni g li inibitori del recettore tirosin-chinasiro cli VEGF sono sono al.lenta valutazioni:'. Dati preliminari indicano che SU-5416. una piccola molecola che inibisce la fosforilazione del rccetror<:' l e 2 di VEGF, di C-KIT, recettore cli "stem ccli factor", e di FLT3 ha attività sia biologica che clinica nella AML(8). Vatalanib (PTK-787) è un inibit ore orale cli un certo numero di chinasi compreso tutti i membri della famig li a dei recettori di VEGF, così come il recettore di PDGF (plate let-derived grm-vth faCLor). Questa molecola si è dimostrata efficace in monoterapia nei pazienti con malattia avanzata cd è ora studiata nei pazienti con AM L ad alto rischio e MDS. D'alu-a pane, la talidomide, un potenzia le fattore antiangiogenetico, unita con la chemio terapia non ha mosrato beneficio terapeutico nei pazienti con AML(9).
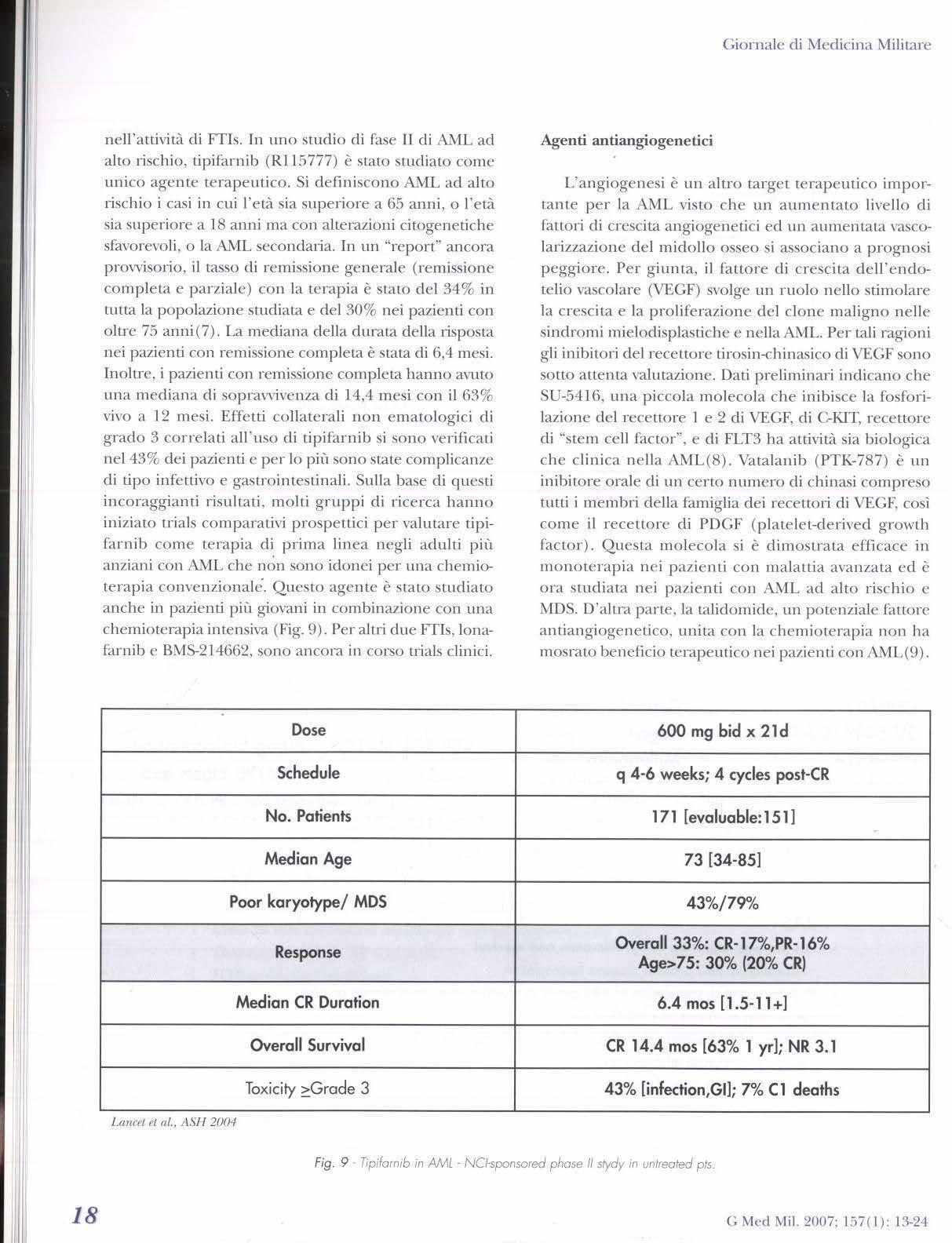
600 mg bid x 21d
q 4-6 week s; 4 cycl es post-CR
17 1 [evaluable: 151 ]
73 [34-85 ] 43%/79%
Overall 33%: CR-17%,PR-16%
Age>75: 30% (20% CR)
6 .4 mos [ 1.5- 11 +]
CR 14.4 mos [63 % 1 yr]; NR 3 . 1
43 % [infection ,GI ]; 7% C1 death s
9 T;pifarn,b in Nv'ìL · NC/·sponsored phose Il stydy in untreoted pls.
Bcvaciwmab, un anticorpo anti-VEGF, è stato dimostrato essere sicuro in AML ed è attualmente in uno studio di fase Il (IO).
Is ton e d eaceti lasi e d inibito ri d e i proteasomi
l stone-deacetilasi è una classe cli e117imi che rimuove un gruppo acetile dagli istoni, creando una forma di DNA "impacchettalo" che non è accessibile ai meccanismi trascrilionali. Il risultato finale è che molti geni che hanno un 'azione critica per la proliferazione e differenziazione cellulare non sono espressi. Per ta le ragione si stanno studiando molti inibitori dell'istone-deaceti lasi (fenilbutirrato, tricostatina A, SATI A [suberoylanilide hydroxamic add], acido valproico e dcpsipepricle). Uno studio cli fase 1 di dcpsipeptide dato alla dose di. 13mg/ rn 2 al giorno 1.8 e 15 ogni 28 giorni ha dimostrato una transitoria riduzione della conta dei blasti iu 9 pazienti ed una sindrome da lisi tumorale in tm pa7jenre; nessuno di questi pa7.ienti ha avuto. però, una risposta clinica ( 11).
TI proteasoma 20S è una proteasi multicatalitica ATP-dipendente. Un aumento della degradazione proteasoma -mediata di proteine come p53. p2lc p27 che conducono all'apoptosi e / o all'arresto elci ciclo cellulare è stato desc1itto nelle cellule leucemiche. Bortezomib, un inibitore del proteasoma 20s approvato per l'uso nel mieloma mul tiplo, è stato usato in monoterapia in 15 pazienti con leucemia acuta e MDS(12). Non è stata dimostrata un'attività clinica per lungo tempo, ma comunque è stata descritta una transitoria riduzione dei blasti nel sangue periferico e nel midollo osseo. L'atti,ità sinergica con mo l ti altri farmaci antileuc:cmici ha portalo a valutare questo agente in terapie combinate.
Modulatori de ll' apopto s i
Proteine anti-apoptotiche quali bcl-2, giocano un ruolo importante nella regolazione della via mitocondriale dell'apoptosi ed un'alta espressione di queste molecole in AML è associata con resistenza farmacologica e prognosi peggiore. Q u indi, attraverso la downregulation farmacologica cl i bcl-2 si può ristabil i re la chemiosensibilità alle cellule leucemiche. Un metodo diretto per inibire bcl-2 è con l'uso di bc l-2 o ligocleossinucleo tidi antisenso. Oblimersen (G3 I 39) è un 18-
mer phosphorothioate oligodeossinucleoticle antiscnso che è stato prodotto per avere come target l'mRNA di bcl-2. Un tria ) cli fase I con oblimersen in combinazioue con fluclarabina, Ara-C e granulocyte colonystimulating factor (FlAG) ha mostrato una 1-isposr.a in 9 su 20 pazienti cou leucemia acuta recidiva o refraLtaria (13). Una remissione completa è stata osservata in 6 casi mentre in 3 pazienLi, anche se in assenza di malattia, non vi è stato un recupero del numero dei neutrofili o delle piastrine o, comunque, la risposta è durata meno di Lrema giorni. In 1111 successivo tria] di fase l questo farmaco è stato somministrato ad anziani non trattati in combinazione con una chemioterapia cli indmione e consolidamenw(14). Dei 29 pazienti trattati, 14 hanno avuto una CR. Dopo una mediana di follow-up di 12.6 mesi , sette pazienti hanno avuto una recidiva. Gli effetti collaterali di questa combinazione sono stati sim i li a quelli previsti con la sola chemioterapia. E' ancora in corso uno sLUdio randomizzato in fase lll per valutare oblimerscn in aggiunta alla chemioterapia convenzionale di induzione e consolidamento.
Inibitori d e l ci cl o ce ll ulare
Il controllo del ciclo cellulare in caso di danno del DNA è gestito da una complessa rete d i segnali di trasduzione che integrano le risposte cellulari agli insulti genotossici. Da ciò consegue o l'arresto della progressione del ciclo cellulare durante la riparazione ciel DNA o l'induzione dell'apoptosi. L'integrità del processo cli controllo del ciclo cellulare è fondamentale per il mantenimento dell'integrità genomica e per il recupero cellulare da danni genotossici. UCN0 I (7-idrossistaurosporina) è un inibitore della protein chinasi C che b locca i sistemi di regolazione della fase S e G2 ciel ciclo cellu lare. La down-regulaUon o l 'inibizione della protein chinasi C da p,ute cli UCN -0 I è stata in grado di aggirare la resistenza all'Ara-C. L'impallo de lh1ti l izzo cli UCN-01 sull'efficac ia di Ara-e alle dosi clinicamente utilizzate è stato dimostraio in un tria! d i fase 1 (15). L'uso cli UCN-01 in combinazione con Ara-C, durante il corso della terapia, ha diminuito la fosfo 1ilazione cli Chkl (checkpoint Kinases I ), inibito il pathway cli sopravvivenza di AKT (protein chinasi B) ecl attivato JNK (Jun Ntcrm ina l Kinases). Analisi d i sopravvivenza clonale di campioni cli A,\1.L hanno dimostra l o che la capacità
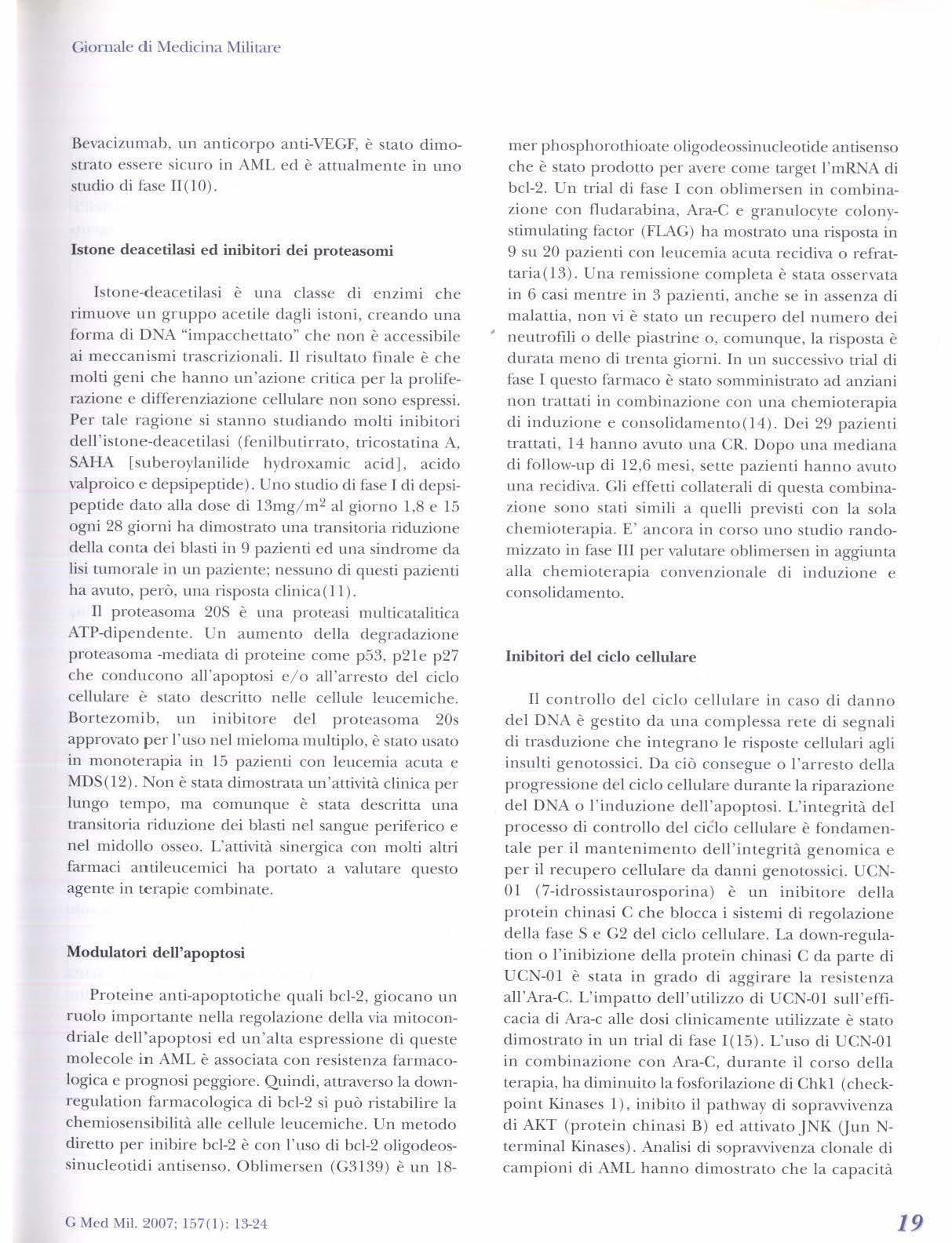
C
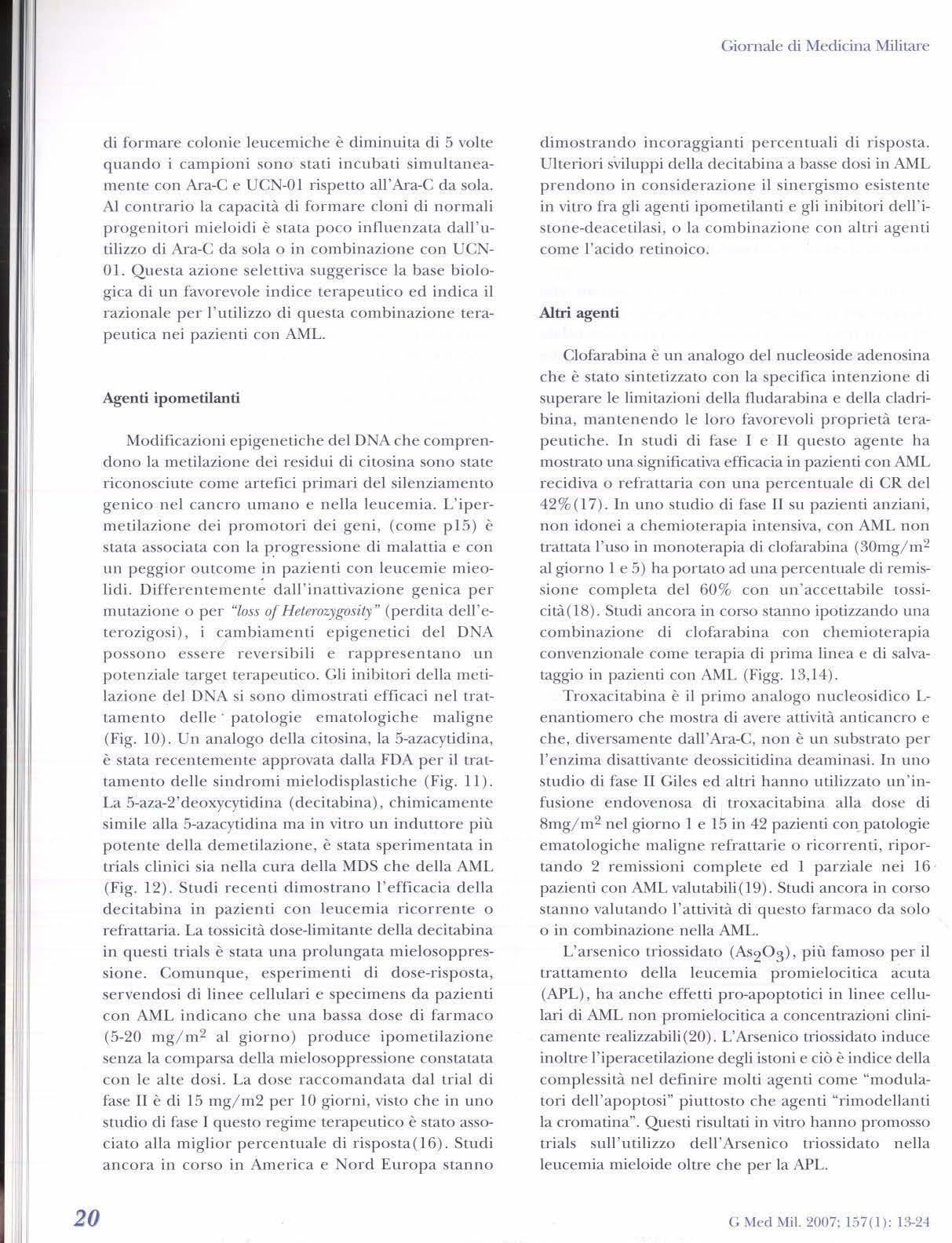
di formare colonie leucemiche è diminuiLa di 5 volle quando i camp ioni sono stati incubati simu ltaneamente con Ara-Ce UCN -01 rispeLto all'Ara-e da sola. Al contrario la capacità di formare cloni cli normali progeniLOri mieloidi è stata poco innnenzata dall'utiliLZo di Ara-C da sola o in combinazione con UCN0 1. QuesLa azione selettiva suggerisce la base biologica di un favorevole indice terapeutico ed indica il razionale per l'uùlizzo di questa combinazione terapeurica nei pazienti con A\1L.
Agenti ipometilanti
Modificazioni epigenetiche del DNA che comprendono la metilazione elci residui di ciLOsina sono state riconosciute come artefici p1ima1i del silenziamcnto genico nel cancro umano e nella leucemia. L'ipcrmetilazione dei promoto ri dei geni, (come pl:'5) è stata associata con la progressione di malattia e con un peggior outcome !n pazienti con le ucemie mieolidi. Differentemente dall'inatrivazione genica per mutazione o per "loss of Heterozygosity" (perdita dell'eterozigosi), i cambiamenti epigenetici de l DNA possono esse r e reversibili e rappresentano un porenziale target rerapeULico. Gli inibitori d e lla mctila7ione del DNA si sono dimostrati efficaci nel trattamemo de ll e · patologi e emato logiche maligne (Fig. 10). Un analogo della citosina, la 5-azacytidina, è stata recentemente approvata dalla FDA per il trattamento delle sindromi mielodisplastiche (Fig. 11).
La 5-aza-2'deoxycytidina (decitabina), chimicamente simile a ll a 5-azacyridina ma in vitro un induttore più potente della demeti lazione, è stata sper im entata in trials clinici sia nella cura della MDS che della AML (Fig. 12). Studi recenti dimostrano l 'efficacia della dccitabina in pazienti con leucemia ricorrente o refrattaria. La tossicità dose-limitante della decitabina in questi tr ial s è stata una prolungata mielosoppressione. Comunque, esperimenti di dose-risposta, servendosi di linee ce llu lari e specirnens da pazienti con AML indicano c he una bassa dose di farmaco (5-20 mg / m 2 al giorno) produce ipometilazione senza la comparsa della mielosoppressione constatala con le alte dosi. La dose raccomandata dal tria! di fase II è di 15 mg/ 1112 per 10 giorn i , visto che in uno studio di fase I questo reg im e terapeutico è stato associato a lla miglior percentuale di risposta(l6). Studi ancora in corso in America e Nord Europa stanno
dimostrando incoraggianti percentuali di risposta. Ulteriori sviluppi della decitabina a basse dosi in AML prendono in co nsidera zione il sinerbrismo esistenle in vitro fra gli agenti ipometìlanti e gli inibitori delristone-deace1 il asi, o la combinazione con altri agt>nri come l'acido retinoico.
Altri agenti
Clofarabina è un analogo del nucleoside adenosina che è stato sinteti zzato con la specifica intenz ione di superare le limitazioni della fludarabina e della cladribi11a, mantenendo le loro favorevoli proprietà terapeutiche. ln studi di fase I e Il questo agente ha mostrato una significativa efficacia in pazienti con AML recidiva o refrattaria con una percentuale di CR del 42% ( 17). lu uno studio di fase Il su pazienti anziani, non idonei a chem ioterapia intensiva, con AML non U"élttata l 'uso in monoterapia di clofarabina (30 mg/m2 al giorno 1 e 5) ha porta LO ad una percentuale di remissione completa del 60% con un 'acceuabile tossic ità(l8 ). Studi ancorn in corso stanno ipotiaando una combinazione di clofarabina con chemioterapia convenzional e come terapia di prima linea e· cli sa l vataggio in pazienti con AMI. (Figg. 13.14).
Troxacitabina è il primo analogo nuc leos idico Lenantiom ero che mostra di avere attività anticancro e che, diversamente dall'Ara-e, non è un substrato per l 'enzima disattivante dcossicitidina deaminasi. In uno studio di fase II Gi l es ed a ltri hanno utilizzato un'infusione endovenosa di rroxacitabina alla dose di 8mg/ m 2 nel giorno 1 e 15 in 42 pazienri con patologie e matologich e maligne refrattarie o ricorrenti, riportando 2 remissioni complete ed 1 parziale nei 16 pazienti con Ai\1L valutabili(l9). Studi ancora in corso stanno valutando l'attività di questo farmaco da solo o in combinazione nella AML.
L'arsenico triossidato (As 2 o 3 ), più famoso per il trattamento della leucemia promielocitica acuta (APL ), ha anche effetti pro-apoptotici in linee cell11lari di AML n on promielocitica a concentrazioni clinicamente realizzabili(20). L'Arsenico triossidato induce inoltre l'iperacetilazione degli istoni e ciò è indice della com ple ss ità nel definire molti agenti come "modulatori dell 'apop tosi" piuttosto che agenti "rimodclla11Li la cromatina·•. Questi risultati in ,~u-o hanno promosso trials sull'utilizzo dell'Arsenico triossidato nella lt>ucemia mieloide oltre che per la AJ'L.
• Azacitidine and decitabine first synthesized in 1964
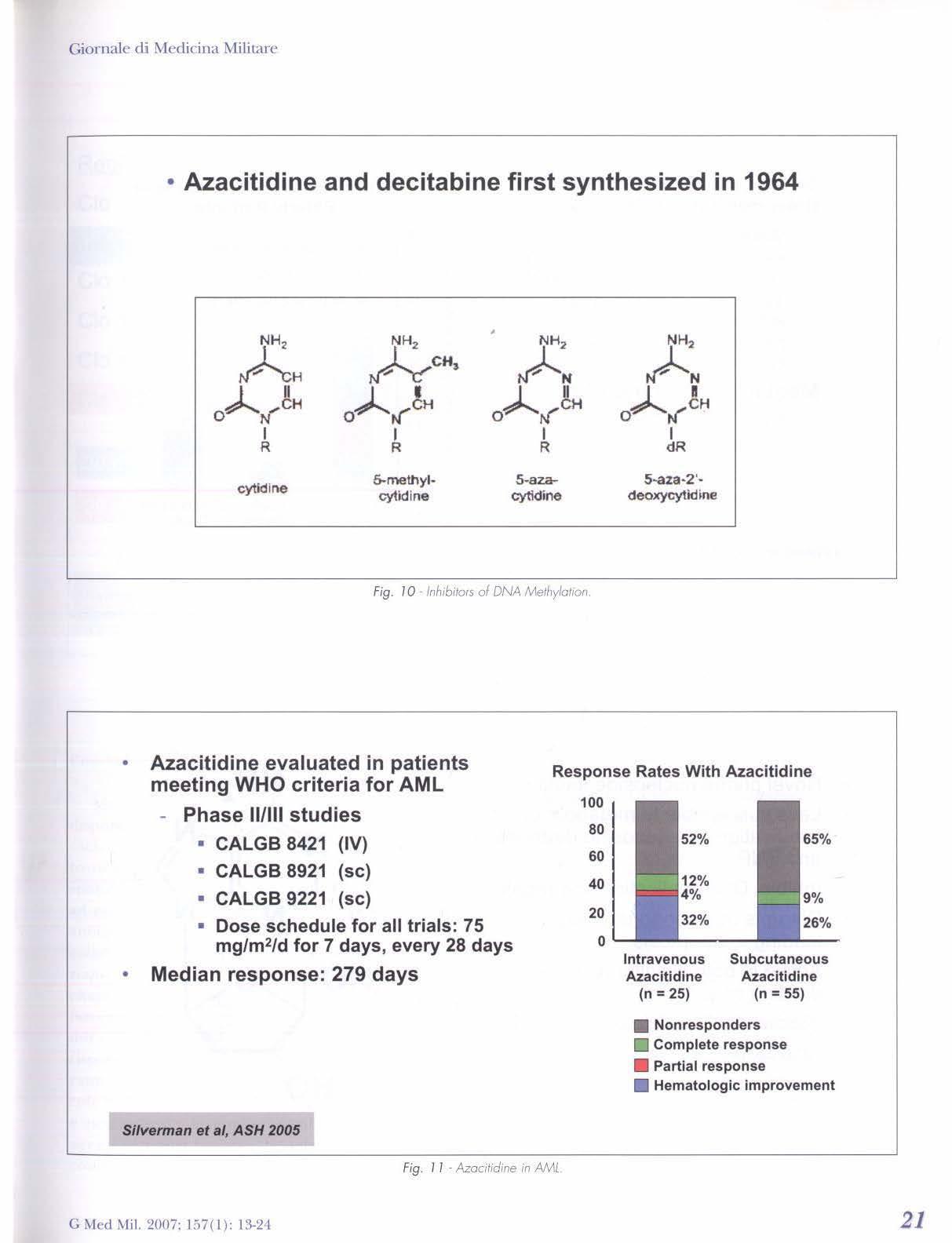
• Azacitidine evaluated in patients meeting WHO criteria for AML Response Rates With Azacitidine
- Phase 11/111 studies
• CALGB 8421 (IV)
• CALGB 8921 (se)
• CALGB 9221 (se)
• Dose schedule for all trials : 75 mg/m2 /d tor 7 days, every 28 days
• Median response: 279 days
Subc utaneous Azacitid i n e Azacitidin e (n = 25 ) (n = 55 )
Nonres ponders O Complete respons e Pa rtial r espon se Hematologic i mprov ement
• Short-course hydroxyurea, then decitabine (N = 66)
- Median age: 72 years
- 4 cycles of low-dose decitabìne {135 mg/m2 IV for 3 days every 6 wks)
- lf decitabine sensitive, ATRA adminìstered ìn cycle 2
- After 4 cycles, decitabìne maintenance every 8 wks
• Median OS: 7.5 months
- 1-year survival: 23%
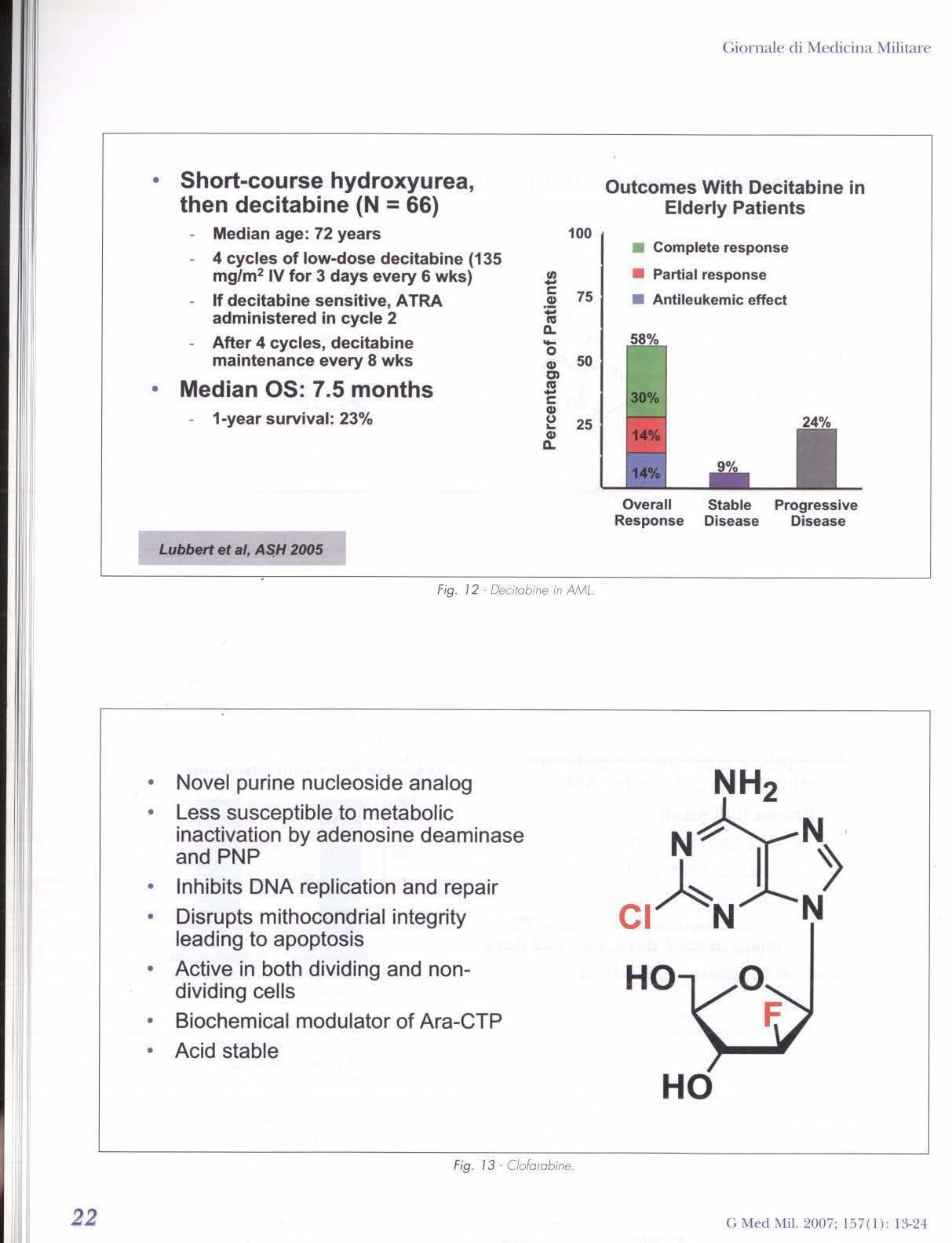
• Nove! purine nucleoside analog
• Less susceptible to metabolic inactivation by adenosine deaminase and PNP
• lnhibits DNA replication and repair
• Disrupts mithocondrial integrity leading to apoptosis
• Active in both dividing and nondividing cells
• Biochemical modulator of Ara-CTP
• Acid stable
Stable Progressive Response Disease Disease
1Kantarjian et al, Blood 2003; 2Burnett et al, ASH 2006; 3Faderl et al, Blood 2005; 4 Faderl et al, Blood 2006; 5Faderl et al, ASH 2005; 6Burnett et al, ASH 2006
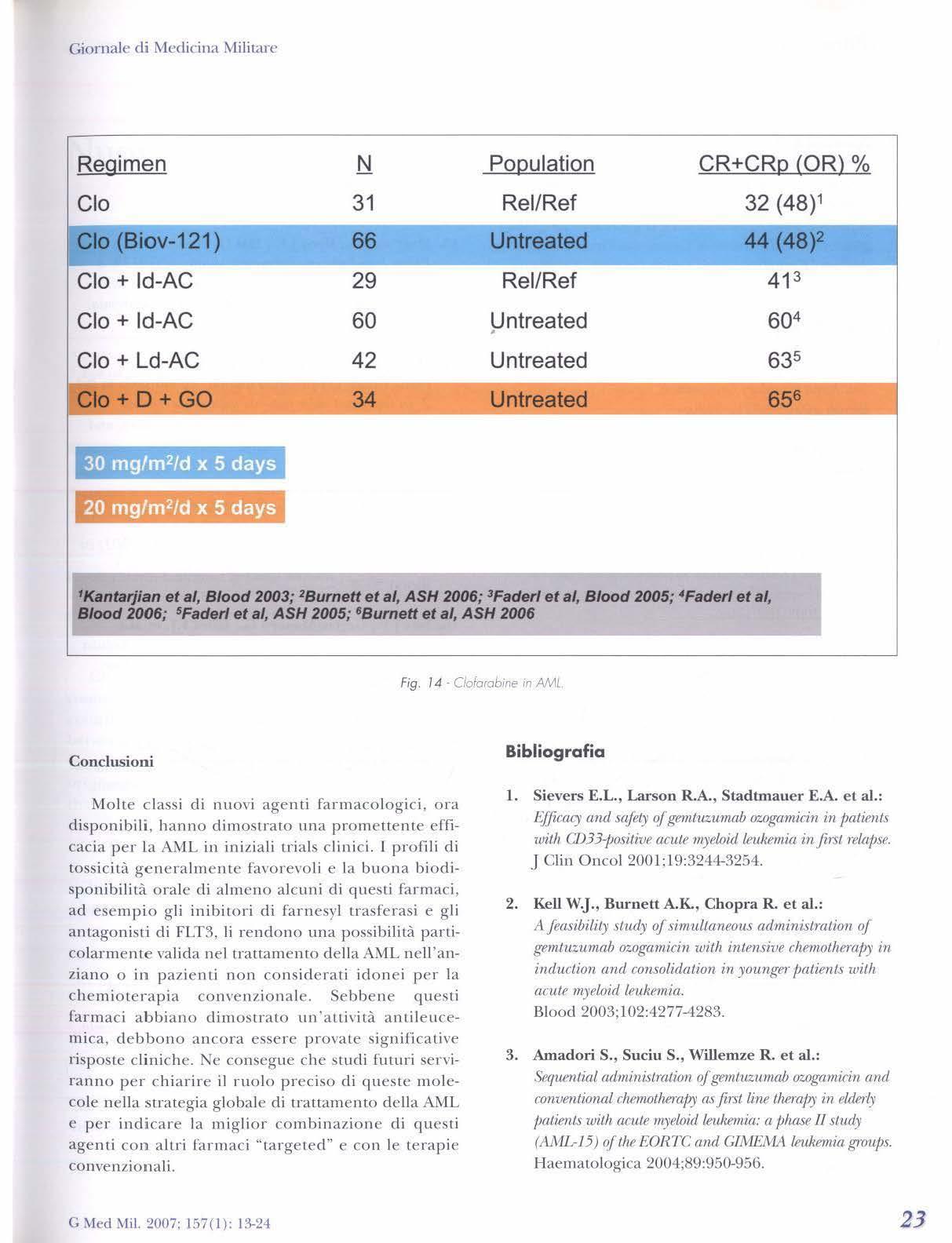
Conclusioni
Molte classi di nuovi agenti farmacologici. ora disponibili, hanno dimostrato nna promettente efficacia per la AML in iniliali trials clinici. I profili di tossicità generalmente favorevo l i e la buona biodisponibilità orale di almeno alcuni di questi farmaci, ad esempi.o gli inibitori di farncsyl trasferasi e gli antagonisti di FLT3, li rendono una possibilità particolarmente valida nel trattamento della AML nell'anziano o in pazienti non considerati idonei per la chemioterapia con\'enz.iona le. Sebbene questi farmaci abbiano dimostrato un 'auività antileucemica , debbono ancora essere provale significati\'e risposte cl i niche. Ne consegue che studi futu1i serviranno per chiarire i l ruolo preciso di queste molecole nella strategia globa le di trattamento della AML e per indicare la miglior comb i nazione di questi agenti con altri farmaci "targe1ed" e con le terapie convenzionali.
Bibliogr afia
I. Sievers E.L. , Larso n R.A ., Stadtma uer E.A . e l al .: Efficacy and sajety ofgemtuz.umab ozogamirin in /Jatienls with CD33~J1ositive acule myeloid leuhemia iu Jirsl re/(ipse. J Clin Onco] 2001: 19:324.4-3254.
2. Ke ll W.J. , Bw-nett A .K., C hopra R. e t al :
A feasibility stwly of:simultaneous administratio11 of gemtuz:umab ozogamicin with inlmsive rhemotheraf>y in induction and consolìdation in younger /mtients with acuti' m)'l'/.oid ln,hemin. Blood 2003;102:4277-1283.
3. Amadori S . , Suciu S., Wille m ze R. et al.:
Sequential ad111inistratio11 ofgemtuzumab owgamici11 and ronventional chemotherapy as first line theraP)· in eldedy fmtients with acute myeloìd lealiemia: a plwse Il study (AML-15) of the EORTC nnd GTMEMA leullemia groups. Haematologica 2004;89:950-956.
4. A.madori S. , Suciu S. , Stasi R. e t al.: Gnntuwmab ozogamicin (Mylotaq;) as singlP-agent l1'f'ahnen t forfmil patienls 61 years of agP and ol.der with acute myefoid leukemia: final results ofAML-15B, n jJ/wse 2 study of lhe European Organisation far Research and Trealmenl of Canrf'r and Gruppo Italiano Malattie Ematologichi' ddl'Adulto l ,et1kemia GroujJs. Leukemia 2005: 19 : 1768-1 773.
5. List A.F. , Kope cky K.J., Willmau C.L. et al.:
Benefit of ryclosporine modulalio'II of drug resis/ance in patients with pooHish arnlf' myeloid lnikPmia : fl Southwr;sl Oncology Group sludy. Bl ood 2001;98 :32 1 2-3220
6. Stone R.M. , O ' DonneU M.R. , Se kere s M.A.:
Acute myeloid leukemin. H ematology (Am Soc H ematol Educ P rogram) 2004:98- 11 7
7. Lancet J.E. , Gotlib J,, Gojo I. et al.: 1ìj)ijamib (lARNE~TRA) in /1reviously u.11treated poor· rish AML and NIDS: intnim rP.mlt.s of a /Jltase 2 trial.
Blood 2003: 102: I 76a.
8. F ie dler W., Mes ters R. , Tinn e feld H. et al.:
A p!rasP 2 rlinical study of SU54 J 6 in patients with refractory acuti' myeloid l.eukemia. Blood 2003; 102:2763-2767.
9. Cortes J ., Kantarjiau H. , Albitar M. e t al:
A mndomized lri.al of !iposomal dnunorubicin a7Ul cytarabine ver~ms liposomal daunornbici.n and lopotPcan wilh or withou/ thalidomide as initial lherapy far patienls with jJOor /Jrognosis acute myelogenous leuknnia or mJelodysplastic syndrome.
Ca11ce r 2003;97: 1 234-1241.
10. Karp J.E. , Gojo I. , Pili R. et al.:
Tcugeting vascular endothelial growth fartor /or relapsed (md refraclory aduli arute myelogenous leukemias : lhempy with sequential J-bela -darabinofuranosyl01tosine, mitoxan t rane, and bevarizumab.
C lin Ca n cer Res 2004;10:3577-3585.
11. Marcucci G. , Bruner R.J., Binkley P.F. et al.: Ph.ase I tria / of the histonr, dearPtylase inhibitor depsipeptide (FR90 1228) in aru t e myeloid u'ukemia (AJ.'vfL).
Blood 2002; 100:86a.
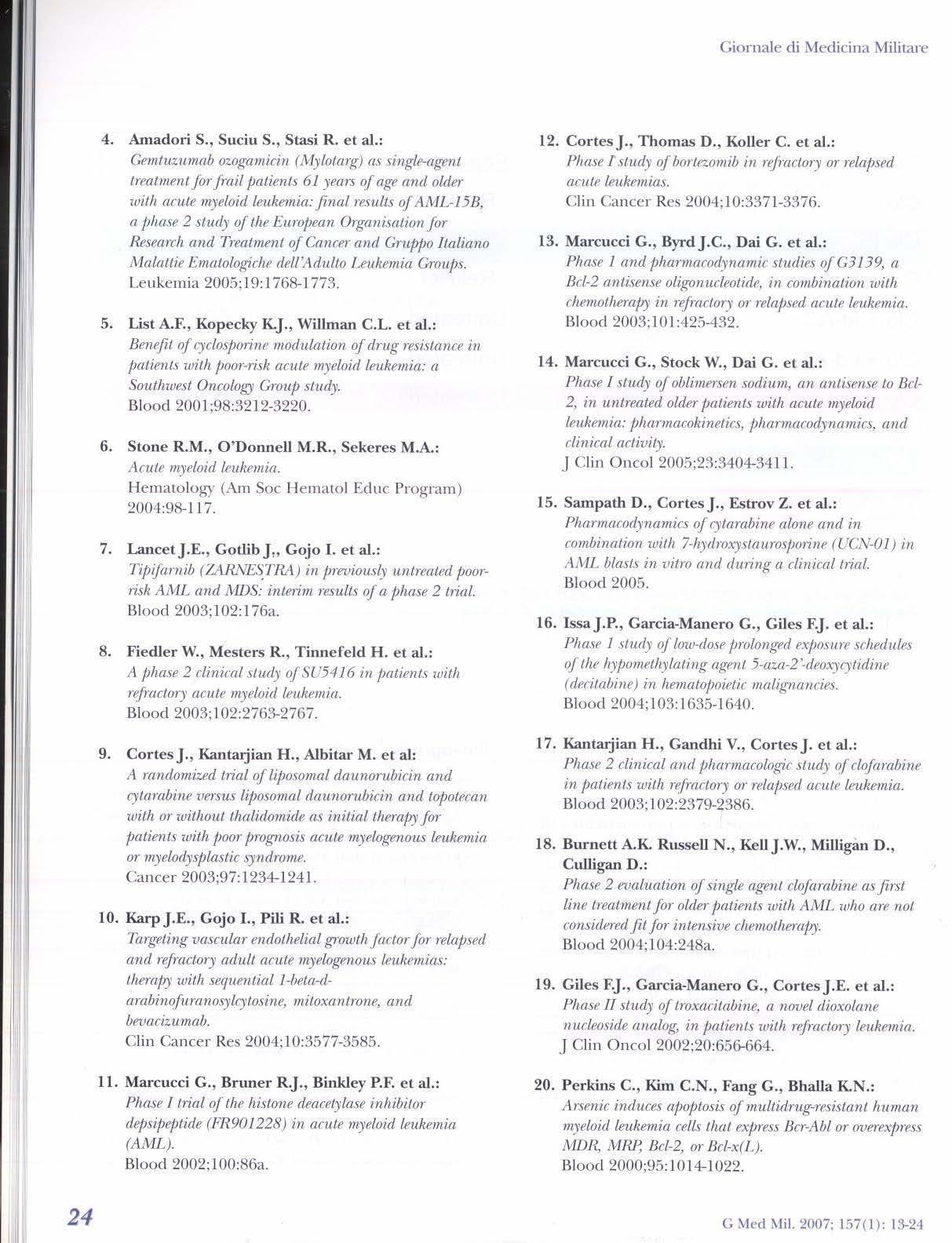
12. Corte s J. , Thomas D., Koller C. et al.: Plwse I study of borlezomib in rejratlrtry or relapsed amte leukemias.
Cl in Cancer Res 2004:10 :3371-3376.
13. Marcucci G. , ByrdJ.C. , Dai G. et al.: Phase J and pharmarodynarnic studies of GJ139, a Brl-2 antisense oligonurleolide, in co111bi11a/io11 with chemotherapy in refraclory or rela/1sed arnlP lnikemia. Blood 2003:101:42:J-432.
14. Marcucci G. , Stock W. , Dai G. e t al.: Phase I study vf oblimersen sodium, rm antisense lo Bc!2. in untrmted older palienls with acule mydoid ln1kemia: phannacokùwtirs, /Jh.armacodynamics, and dinical activity.
J C lin Onco! 2005;23:3404-3411.
15. Sampath D. , Cortes J ., Estrov Z. et al.: Phnrr11acodrwmin of rytarabine alone and in combination with 7-hydro:>-..ystaurosJJ01i11P (UCN-01) in AML blasts in vitro mul during a clinica[ tria/. Blood 2005.
16. lssaJ.P. , Garcia-Mane ro G., Gile s F.J. et al.: Phasf' 1 sludy o/ low-dosP pmlo11gpd expo.rnre stheduu'.J' vf the h)JJomethylati11g agenl 5-aza-2 ~deoxycytidinr ( deritobine) iu hematoj,oietic maligna1tcies.
B lood 2004; 103:1635-1640
17. Kantarjiau H. , Gandhi V. , Cortes J. et aJ.: Phase 2 diniral mul p!wnnacologic study of clofarabine in patients with refrartory or relapsed acute le-ukemia. Blood 200,3: I02:2379-2386.
18. Burne tt A.K. Russell N. , Kell J.W. , MiJJigan D., Culligan D.:
Phase 2 evaluation of single agenl clofarabine as.firsl line trea.tment Jòr older patimts with AMI. who a re 1w/ con.sidered Jit far i11tmsive chemotherapy.
Blood 2004; I04:248a.
19. Giles F.J. , Garcia-Mane ro G. , Cortes J.E. e t al.: Phase Il st11dy of l mxacitabine, a novel dioxolrine nurleoside analog, in /1atieuts with refmct01y leukernia. J C li n O n co! 2002;20:656-664.
20 . Pcrkins C. , Kim C.N., Fang G. , Bhalla K.N.: Ar.senic indttces apoptosis of rnultidrug-rrsistanl hwnan myeloid leukemia fflls t hai express Ber-Ab/ or overexpress lvIDR, MRJ~ Bc/-2, or Brl-x(L).
Bl ood 2000;95 : J01 4-J022.
* Doll.Jst, - Di11i.1ione di Ematof11gia, D,pnrtimPnto di Rl(itm10J,,gie r,/111/ari rd l.:.11wtolo1;ia, 01iver.1ità "La Sapieuw" J/oma.
Dau.ssa - lJiuiswn, d1 Emolo/nfsia, Di/Jflrtinu:nlo di Rinlmwl.ogw w/111/0,i ed brwtologia. Universila "La Sapienza" Roma. • Pro). - Dwiswne di Ematologia. Dipart,mento rfi Rint,010/,;,1;1e ffllu/m1 ed lim1110/01;ia, L'niversita "La Sa.pienw" · Ruma.
Riassunto - La leu cemia linfatica cronica è la forma più comune di leucemia 11egli adulti dei paesi occidentali. I.a decisione tt'rapeutica basata solo su parameu·i biologici può essere eseguita .mio nell'ambito di proLocolli cli ricerca.
Parole chiave: Leucemia linfatica c ronica.
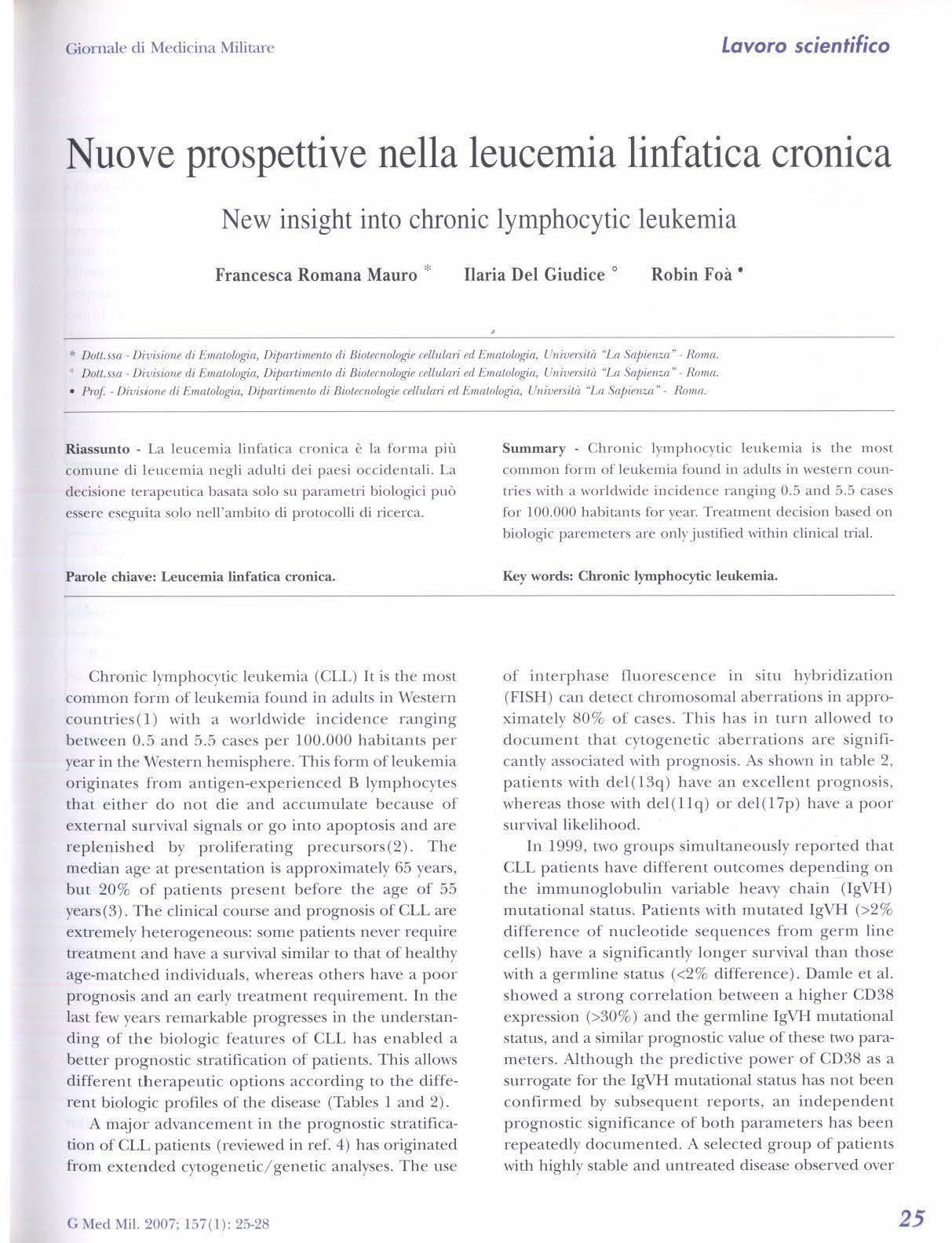
Chronic lymphocytic lenkemia (CLL) Il is the most common forni of leukemia founcl in adults in Western countries(l) with a worldwide inciclence ranging bctween 0 5 and 5.5 cases per 100.000 habitants per ycar in the Western hemisphere. This form of leukemia originates from antigen -experienccd B l ymµhocytes that either do not clie and accumulate becausc of external survival signa ls or go imo apoptosis and are replenishcd by pruliferating precursors(2). The median age at prcsentation is approximate ly 65 years, but 20% nf patients present before the age of 55 )'Cars(3), The clinica! course and prognosis of CLL are exa-emely heterogeneous: some patierns never reqnire u-eaunent a nd bave a survival s imiJar co that of healthy age-matched individuals, whereas orhers havc a poor prognosis and an carly u·eatment requirernent. In thc last few ycars rernarkable progresses in the unclerstanding of rhe biologie fcatures of CLL has enabled a better prognostic stratification of paticnts. This allows different therapeutic options accord in g to the clifferent bio logie profiles of th e disease (Tablcs 1 ancl i).
A major advancement i n the prognostic stratifi caticm of CLL patients (reviewed in ref. 4) h a5 origin ate<l from extended cytogcnetic/genelic analyses. The use
Summary - Chronic lymphocytic leukemia is thc mosr ,ornmon fonn of leukemia found in aclults in western countrics with a worldwide incidence ranging 0.5 and 5.5 cases for l 00.000 habitants for ycar. TreaUT1e11l decision based on biologie parcmetcrs are onl) jnstific<l 1,irhin clin ica! u·ial.
Key words: Chronic Jymphocytic leukemia. of interphase nuorescence in situ hybridizatio11 (FISH) can cletect chromosornal aberrations in approximately 80% of cases. This has in turn allowe<l to documcnl that cytogenetic aberrations are signifìcant ly associateci with prognosis. A,; shown in table 2. patients wiù1 del(l3q) havc an excellent prognosis, whereas those with del(llq) or dcl(l7p) bave a poor survi,·a l likelihoocl.
ln 1999, two gronps simultaneous ly reported that CLL patients have differern outcomes depending on the immunoglobulin variable heavy c h ain ( TgVlI) mutational status. Patients with mutateci lgVH (>2% clifference of nucleotide scquences from germ line ce ll s) bave a signifìcantly longer survi val than those with a gennline status (<2% difference). Danlle et al. showecl a strong correlation between a highcr C D38 cxpression (>30%) and the germ li ne TgVTI mutational status, aud a si.milar prognosùc value of rhese rwo parameters. Although thc prcdictive power of CD38 as a su r rogate for the I gVII mutational staLus has not been co nlìrm ed by subsequent rcports, an independem prognostic signifìcance of both pararnctcrs has been repeaLedly clocumented. A se lected group of patients wiù1 highly s ta.ble ancl untreated disease observed over
Single agents
Alkylating drugs
Chlorambucil
Cyclophoshomide (C)
Bendamustine
Purine onalogues
Fludarabine (F)
Pentostatin (P)
Cladribrine
Monoclonal Antibodies
Rituximob (R)
Campath- lH
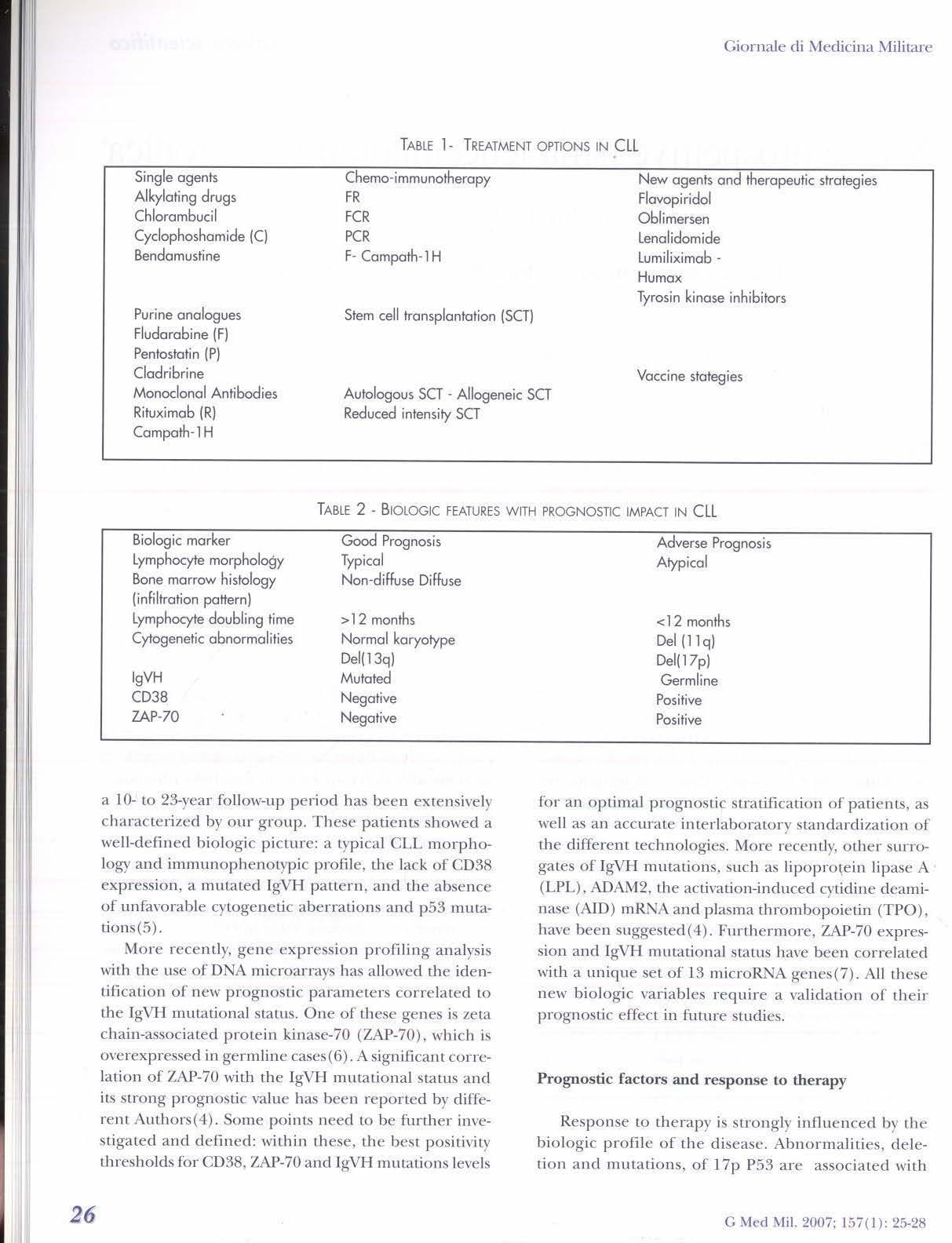
Biologie marker
Chemo-immunotherapy
FR
FCR
PCR f- Campath- 1H
Stem celi transplantation (SCT)
New agents ond therapeutic strategies
Flavopiridol
Oblimersen
lenalidomide
Lumiliximab -
Humax
Tyrosin kinose inhibitors
Vaccine stategies
Autologous SCT - Allogeneic SCT
Reduced intensity SCT
Good Prognosis
lymphocyte morphology Typical
Bone marrow histology Non-diffuse Diffuse
(infiltration pattern)
Lymphocyte doubling time >12 months
Cytogenetic abnormalities
Normai karyotype
Del(l 3q)
lgVH Mutated
CD38 Negative
ZAP-70 Negative
a 10- to 23-ycar follow-up period bas bcen extensivel)' characterizcd by onr group. These paticnts showed a well-defined biologie picture: a typical CLL morphology and immunophenotypic profile, the lack of CD38 expression, a mutai.ed l gVH pattern. and the absence of unfarnrable eytogenetie aberrations ancl p53 mutations(5).
More recently, gene expression profiling analysis with the use of DNA microarrays has allowed the idenlifieation of new prognostic parameters correlated LO the IgVH rnutational status. One of these genes is zeta chain-associated protein kinase-70 (ZAP-70), which is overexpressed in germline cases (6). A sign ilieaiu correlati on of ZAP-70 with the I gVIJ mutaLional status ancl iL~ strong prognostic value has been reported hy differelll Authors( 4) Some point5 need Lo be funher investiga Led and defined: wiLhin these, thc best positivity thresholds for CD38. ZAP-70 and l gVH mutations levels
Adverse Prognosis
Atypicol
<12 months
Del (l lq)
Del(l7p)
Germline
Positive
Positive for an op1jmaJ prognostic stratificacion of patients, as well as an accurate interlaboratory standardization of the differcnt technologies. More recently, other surro-gates of IgVH m11tations. such as lipoproçein lipase A (LPL), ADAM2, the activation -in duced eytidine dcaminase (AJD) mRNA and plasma thrombopoietin (TPO). havc been suggested ( 4). Furthermore, ZAP-70 expression and IgVH mutational status have been corre lateci with a unique set of 13 mieroR.l'-lA genes(7). Ali these new biologie variables require a validation of their prognostic effect in f-ucure studics.
Prognostic factors and response to therapy
Response Lo therapy is strongly influeneecl by the bio l ogie profilc of the diseasc. Abnorma liti es, cleletion and mulations, of l 7p P53 are associated with

an unsatisfactory response to alkylating agcnts, fluclarabin c and rimximab, whereas alerntuzumab may be effectivc(8). Palients wiù1 favorable cytogenetic abernnions show a good response to rituximab. J\t present, the impact oflgVH mutations. ZAP-70 ur CD38 expression on tbc rcsponse to therapy is less cleftned. H owever, there is some inclication that lhe OVC:'rall response rate and particularly the response duration could be worse in paLicms expressing th esc markers. Auwlogous stem -cell u-ansplantation (SCT) has been tested as a strategy lo improvc surviva l in patients with advanced CLL: however, the results have shown a constanl ralc of relapse over time, wilhout a suggestìon of c urc (9). Moreover, although this procedure may pro long survival in comparison with conventionaJ therapy, the unfavorable prognostic \'aluc of germi i ne I gVH status stili holds after autologous SCT(l O). AJso, a cytogenetic aberration such as del 1 lq has been associateci wiLh an adverse outcome after autologous SCT.
Allogeneic transplantation is being been increasingly utilized in patients \,~th lymphoid rnaligna.ncics, but is associateci with notable toxicit:y. There are suggestions that a graft-\'crsus-leukemia cffcct may erad ic ate Lhe leukemic clone cven in gerrnlinc patienLs(l 1).
Recently. rednce<l-imcnsity cond i tioniug regimens bave shown encouraging rcsuhs, attribllled to the graftvcrsus-lcukemia effect combincd wilh the reduction in toxicity( 12).
The response and Lhe quali I)' of the response aftcr therapy are impurtant prognostic parameters, with a higher degree of response associa teci with a longer survival. Patients who achieve a minimal residuai disease-neg.itive status, assessed by eitJ1er allele-specific polymerase chain reaction (PCR) or multi-color 0ow cytomctry, have a better response duration after chemo -i mmunotherapy and a trend to a better outcome than tho se with an inferior re sponse lo th erapy.
Advauces in the nn<lcrstanding of ù1e biology of CLL lymphocytes, the broadcning of the lherapeutic armamentarium, which include ncwer and potentiaUy more effective therapies and SCT proceclures potcntially capab le of erad ic a tin g the leukemic clone, havc challenged the conservative management that for many years has been thc norma i approach to CLL
patients. By imegrating ali a\'ailable biologie and clinica! parameters, a more accurate prognosùcation systern with a bctter risk-strarifìcation of CLL patients al diagnosis is today possible. 1-l owever. ù1e method5 tu determine biologie prognosric paramctcrs shou ld be fully ~tandardized ami their prognostic value validateci in large prospecti\'C clinica\ trials. Further studies are needed lo iclentify the markers with inclcpendent prognostic value. The definitio11 of a specilìc biologie ' profìle can guide the therapculic decision betwee11 different trcalment modalitics. Al! these issnes indicate rhat the scene is set for- ali CLL patienL5 to be offered a more targeted treatment (or uon-u·eatment) algorithm based on thc clinical ancl biologie characteristics of the diseasc. IL is toclay possiblc Lo idemify ca rly-stage disC:'ase with poor ot1tcome likelihood. Ongoing controlled studies will establish whether patients with adverse biologie feawres could have a benefit from early treatment intcrvenlion. Meanwhilc, t reatmcnt decisions based on biologie paramerers are only justified within cli nical rrials.
1. Redaelli A. , Laskin B.L., Stephens J.M. et al. : The clinica/ ami fj>idf'miolo{{ical burde11 of chronir lym/1hocytic leulwemia.
EurJ Cancer Care 2004; 13: 279-287.
2 . Ch iorazzi N . , R ai KR., Fe rrarini M. : Chronir lymphorylic /e-ukemia. N Engl .J Med 2005; 52: 804-815.
3 . Mauro F.R., Foa R. , Giannarelli D . et al.: (Jiniwl dtaructe1btirs and oulrome qj)vung tftr(J1Jic lymj>luxytic !PURnnia palit:llls: a !ingle insl,itutiun study of204 aM: Blood 1999; 94: 448-454.
4. Montserrat E.:
New prognostic marhers in CLL. H ematology Am Soc Hematol Educ Program. 2006; 279-284.
5 . Guarini A., Gaidan o G., Mauro F.R. et al.: Chronic lym.phocytir leuknnia patù:nts with highly stabf.e and indo/,en/ disease show distinctive j>ltenotypir n.nd genotypir Jeatures. Blood 2003; 102: 1035-1041.
6. Rosenwald A . , Alizadeh A.A. , Widhopf G. et al.:
RP!r1Lio11 o/gene expression plwnoty/JP lo ànmunoglobulin mulation genotype in B cdl chronir lympholylic leukemia.
J E xp M.ed 200 1; l 94: 1639- 1647.
7 . Calin G.A. , Fen·acin M. , Cimmino A. e t al.:
A i\Iicro R NA. signatttrP c1ssociated with /rrognosis and progrPssion in chronic lymphocytic leukemia
N Engl J .Med 2005; 353: 1793-80 1
8. Wierda W.G.:
Current and investigational th.empiPsforpatients with ClL
H ematology Am Soc Hemato l Ecl u c Prograrn. 2006; 285-294
9. Jabbour E. , Keating MJ., Champlin RE., Khouri I.F.:
Stem cell lrcmsplantat ion /or chronic lymf,lwrytir
feukPJnia: slwuld not morP palienls gel a transplrm t ?
Bo n e Marrow Transplant. 2004; 34: 289-297.
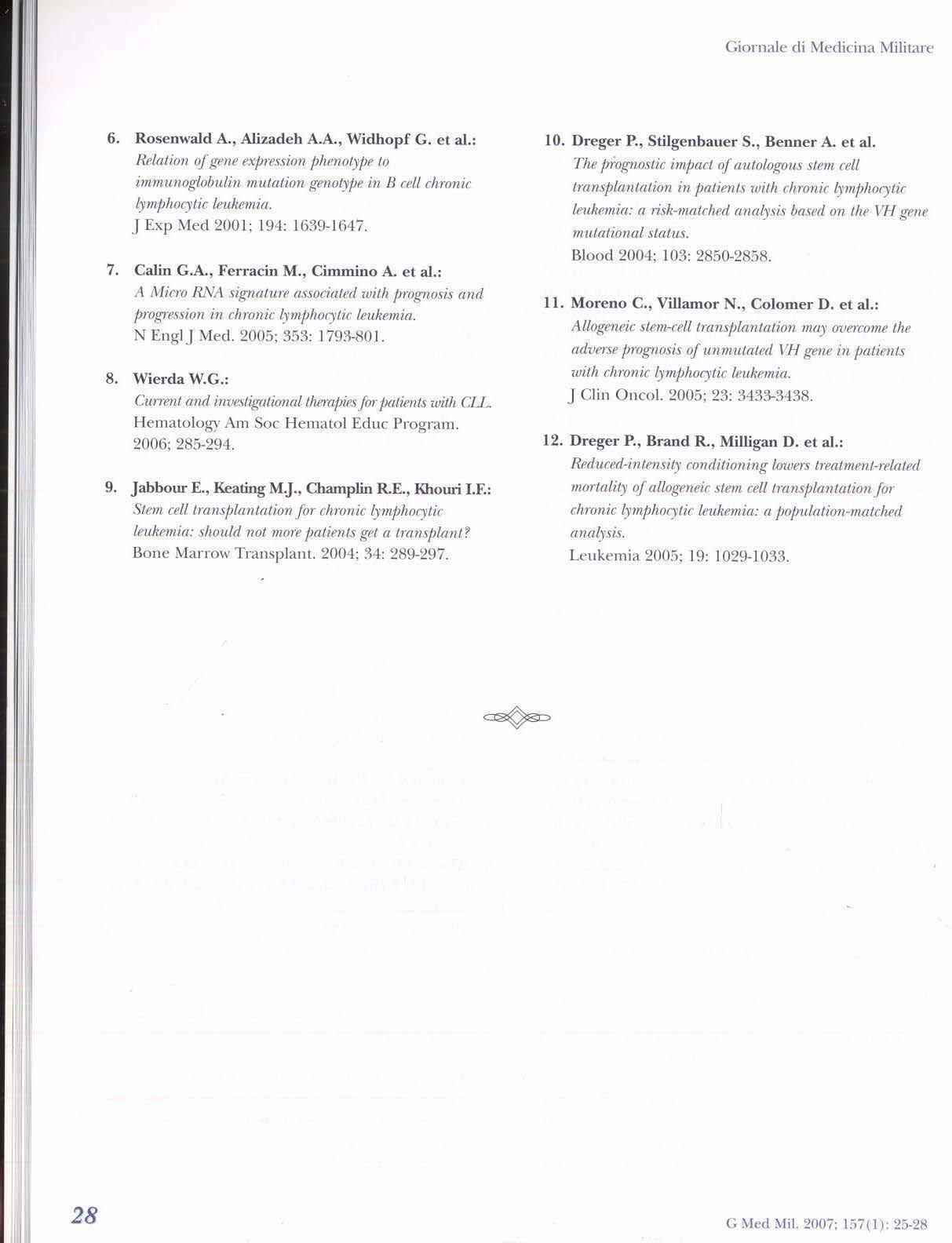
IO. Dreger P., Stilgenbauer S., Benner A. et al.
The prognostic impact o/ a11tologo11s slem cell lmnsplantatio11 in patien /s wilh chronic lymphorytir ll'll kemia: r; risll-malrhPd rmalysis baserl on the \IH gene mutational status.
BJ ood 2004; 103: 2850-2858.
11. Moreno C., Villamor N. , Colomer D . et al.:
Allogeneic stem-rell /ransplanlation mny overcome the adverse j,rognosis of unmu.tated VI-/ ge11e i11 patin1ts with rhronic lymphorytir leukrmia.
J Cl i n O nco!. 2005; 23: 3433-3438.
12. Dreger P. , Brand R., Milligan D. et al.:
Reduced-intensily ronditioning lowers lreatnwnt-reltited mortal ity o/ allogmeir stem cell lranspla11 tatio11 /or chronic lymphol)'lic leukemia: a /10/mlation-matdied ana!Jsis.
Leukemia 2005; 19: 1029-1033
co sa c ' è di nuo
* * Dou - f>i/1nrtimmto Biotfmol ogie Cdluluri fd Ematologia Unit,1•.-sità "l , n ~r,pimw" - Rnma
Ri ass u nto - I linfomi diffusi a grandi c ellule B (DLCBL) rappresentano circa il 35-40% di mtti i linfomi e son o considerati n e opla~ie molw ch e miosensibili. Nel prossimo futuro la valutazione di fattori biol o gici e molecolari correlari al fenotipo e al g e notipo del tessuto patologico potranno meglio definire la progn os i dei pazienti e cli conseguenza la migliore t e rapi a
Parole chiave: Linfoma diffuso a grand i cellule B.

Summary- Diffuse largc- lx:dl lyrnphoma ( DLBCL), th e most common sttl)ly p e of non llodgkin l)1111phoma ( 35--4.0 %) is clinicall y inte rogeneous. Some patients respond well lO current therapy ancl ba ve prol o ngcd survival whereas th e r c mander succ umb d e sea~e. Th e molccolar dassifi catiou o f lymphoma on the basis of gene e x pre ssi o n can identif)' signilìca nt subtypes of desease to u-eat.
Key words: Diffuse large B-cell lymphoma.
l linfomi diffusi a grandi cellule B (DLCRL) rappresenlano circa il 3!'>-40 % di tutti i linfomi e sono considerale neoplasie molto chcrniosensibile. 11 regime di chemioLerap i,1 conrenente ciclofosfamicle, doxorubicina , viucrislina. prednisone (CH OP). si è dimostrato in studi prospettici randomizzati negli anni 90 il trattamento conven z iona le standard per i pazienti affetti da DLBCL (Fisher 1993 , Gordon 1992, Montserrat 1997, Cooper 1994) (Fig. l). Tuttavia, ad un follow up mediano di 6 anni, con tale programma d i terapia solo il 40 % d e i pazienti u·attati poteva raggiungere la guarigione. Per t;ùe motivo, tutti gli studi successivi si ponevano quindi l'obiettivo di come increm e ntare l'efficacia terapeutica del regim e CHOP valutando la possibilità di intensificare la dose terapeutica dei farmaci (terapia dose-dense) , aggiungere nuovi farmaci (irnmnu<)terpia con anticorpi monoclonali) o impiegare alte dosi di chemioterapia con infusione di cellule staminali autologhe (trapianto autologo) precocemente durante la prima linea di terapia.
Queste strategie sono state divers,unente impiegate s uddividendo i pazien Li con DLBCL in tre principali categorie: pazienLi anziani (età > 60); pazienti giovani (età < 60) a prognosi favorevole (.IPl = 0-1 ); pazienti giovani a prognosi sfavorevole (lPl= 2-3 ).
Recenti stllrli randomizzati hanno clocumenrato un mig lioramento significativo delle percenwali di
remissione Completa ( RC ) della sopravvivcn;,a globa le (OS) e de ll a sop1anfren1a libera da malaltia ( EFS), st'n7a ulteriore incremento della tmsicità. con l'aggiu nt a cli Rituximab allo ~chema Cl IOP o C JIOP-lik e standard con infu<;ione ogni 21 giorni (Coifficr 2002. Sehn 2005, Feugier '.W05) (Fig. 2). l n ampio studio randomiaato dl'I gruppo tedesco sempre in paziemi con DLHCL dj età> 60 anni ha dimostrato come una chemioterapia Cl IOP abbrc\ iata con ,ommini,tralione ogni 1-1 giorni (C IIOP-1 +) poteva migliorare in maniera signifìcati\'a la percentuale di EFS e OS ri<;peuo al CHO P-21 ( Phreundschuh 2002). ' ulla ha~c di questi risu l tati è partito un succc~~ivo studio randomizzato, ~emprc in palicnri anziani affetti da DLBCL , che pone\'a a confronto un programma C H OP-14 +/Rituximab per 6 o 8 cicli (R-C HOP-1-1 x 6 \·s R-CHOP14 x 8 V<; C HOP-14 x 6 vs-CHOP-11 x 8). I ri~ultati di questo Muclio hanno dimostrato come il programma R-CHOP- 1 J x 6 cicli rappresenti il miglior rcgirnt" di terapia in termini di tossicità e di EFS, OS per i pazienti anziani affetti da DLBCL e pertanto da comiderare lo l\landard di riJcdmento per 'luesta ca1egoria di pazienti (Phrcund~chuh 2006) ( fi g. ~).
La 1,upc1iorità dello ~chema combinato R-CHOP i: ,tata dimostrala ,tnchc in pa1icnti giovani a prngno'>i f'avorevok ( IPI 0-1) in uno )>tudio prospettico internazionale rnndomi11ato di fa~e m ( ~llnT u-ial) condollo ,;empre dal gruppo cooperatore tedesco. I n questo swdio ~ono sta1i ,irruo lati 758 pa1ic11ti di età< di 60 anni con una diagnosi cli (D l.BCL ). Il Rituximab veniva associato alla chemioterapia C I IOP o ad altri programmi delìniti CHOP-like ( R-Chemo) e posto a

conl'ro11to con lo stesl>o regime di chemioterapia senta Riluximab (Chemo ) I pa1ienti che aH ' \,1110 ric e \l1to il trattamento combinaco (R-Chcmo) hanno pre,cnt.ato 1111 significativo miglioramento della percenwale di RC, della OS e cl< lla EFS ('d uguale efficacia di R-Cf !OP 1i~pct10 a regimi più in1cnsi\'i come R-Cl IOEP (Phreunclschnh 200:,). Quindi anche nel paziente gio\'ane a prognosi fa\Orcrnle R-CHOP-21 dcw t>,,ere con,iderata la terapia com·en11011ale standard.
La terapia com•c11ziona le C TJOP / C rIOPlik c..· ha prodotto ri~ultati ancora più i11,11ffìcien1i nei pa1ie11ti giornni a pro){ltosi starnrernle ( IPI= 2-3). L'aggiuma del Riu1ximab a.Ila chemioterapia ha migliorato comunque k percentuali di ri~pmta in questo gruppo di µa,ienù rispeno alla terapia comenziomtk, anche '>C questo dato non è mai ~tato ve1ificato in studi prospettici randomìtnli. L'intensificazione precoce con terapia ad alte dosi e trapianto autologo come terapia di prima linea ha port.ato a ri~ullati contrastanti in stndi di confronto con la terapia co11\'enzìo1tale (Gia1111i 1997, I faioun 2000, ~lat telli 2003, ~lilpied 2001. \'iwlo 2003 ). Cn 1-c..-n nce studio cli 11w1a-analisi di questi trials non ha documentalO una reale indica,ionc al mutamento intcnsifìcato con trap ianto autologo neanche nei pa1icnti a prognmi più ~fanirc Yole. Di c o11segue1va l'impiq{o di regimi do~c-clense con aggiunta cli Ri1uximab (R-CHOP-14) con o sen,a un 'intemilìcazionc con terapia ad alte dosi e tr.1pianto ancologo appare una logica ronsegucn1a in quesro grnppo di pa1icnti. Srucli preliminari di fase Il dimo~u-ano che l'associa,ione R-Dosc-Deme pù:'t terapia da alte dosi possono indurre una elenna percentuale di RC e di EFS, pur se con u11a rossicità s up eriore al
trattamento convenLionale, in questo gruppo di pazienLi a prognosi più sfa\'orevole (Vilolo 2006).
Pertanto solo ampi studi prospettici randomiuati dovranno valutare l 'associazione elci Rituximab a regim i dose dens e con o senza intensificazione con HDT nella terapia di prima linea dei pazienti giovani a prognosi sfavorevole (IP1=2-3).
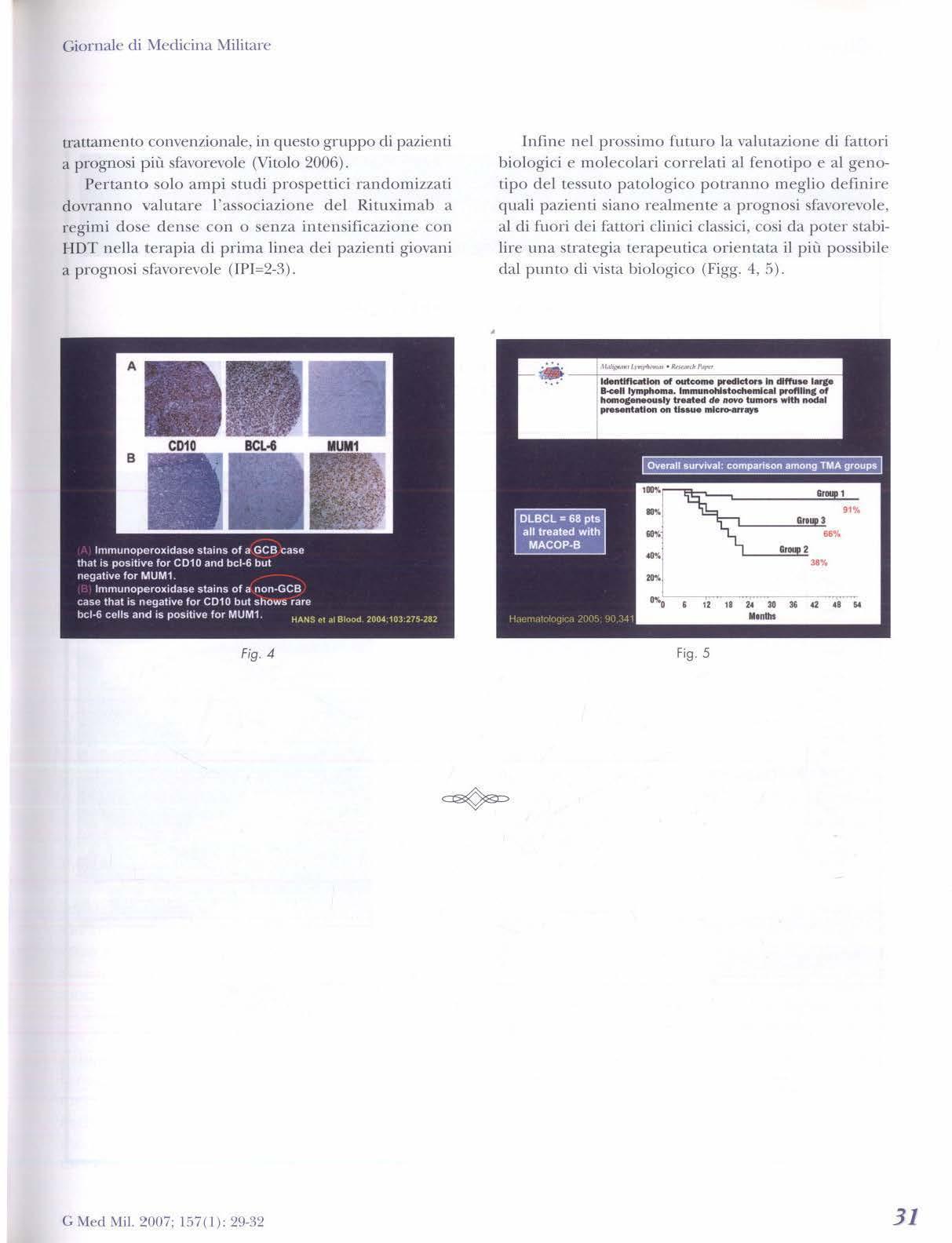
Inlìne nel prossimo futuro la valutazione cli fattori biologici e molecolari correlati al fenotipo e al genotipo del tessuto palologico potranno meglio definire quali pazienti siano realmente a prognosi sfavorevole, al cli fu01i dei fattori clinici cla~sici, cosi da poter stabilire una strategia terapeutica orientata il più possibile dal punto di vista biologico (Figg. 4, 5).
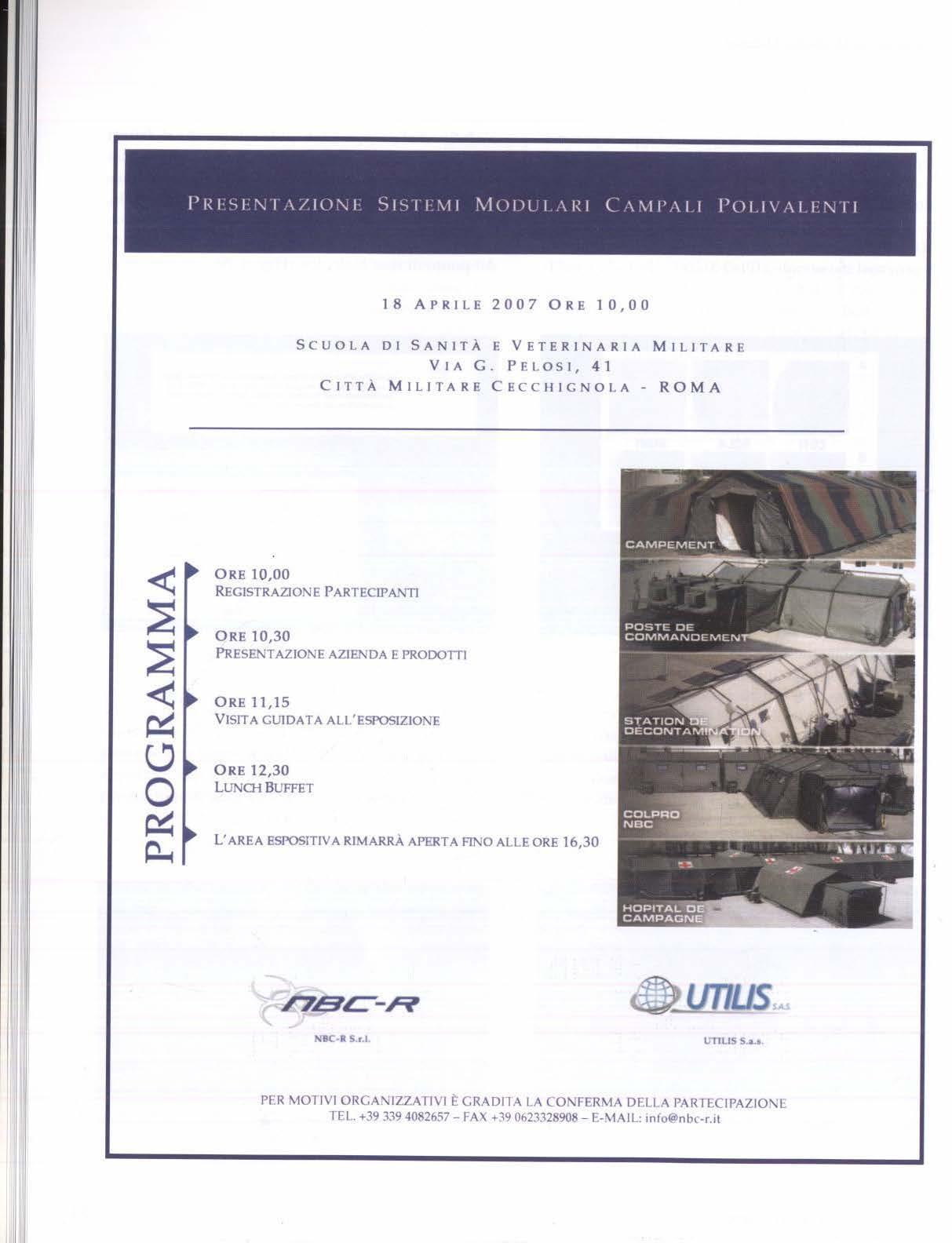
O RE 1 0 , 0 0 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ORE 1 0,3 0 PRESENTAZIONE AZIENDA E PROOOTTl
ORE 11, 15 VISITA GUIDATA ALL'ESPOSIZIONE
OR E 12,30 L UNOi BUFFET
L 'AREA ESPOSrTIVA RJMARRÀ APERTA FINO ALLE ORE 16,30

*
* Proj..,sa - Dipartimen to di Biolmww!(Ìe C,,lJulmi ed Emntolog;frz. I 'ni111'1:1i1/2 l n Snpirn~!l. R.oma. Dn/1.ssn - Dipartimm/o di Biolemologie Ce //11/nri ni Emn11,/,,gi(r. C:11hwrntiì l .n Sapimui Roma. • Doll.sm · Difiarli111,n/o di Biolemologie Cellulari ed E11wtol.ogia. U11i11Pnitiì La Sapif'llto - Roma.
Riassunto - La TIP è una grave malattia caraucrizzata da microangiopatiatrombatica occl u siva , profonda piastrinogemia, frammentazione degl i crirroc i ti, f'chbrc e in suflienza renale.
Parole chiave: Porpora trombotica, trom b ocitopenica (TIP ).
ThromboLic thrombocytopeni c purpura (TT P) is a severe micn)Vascular occlusive thrombotic microangiopathy c haracter ized by: syste mic plateleL aggrcgation, organ ischemia, profound thrombocytopenia au d fragmentation of erythrocyLcs. A "pc ntad " of si g n s a n d symptoms was l ong associateci wi eh TTP : thrombocytopen ia, microangiopathic hemol y ti c anemia , neurologie abnorma lities , renai failure and fe ver (Fig. l).
l n current clinica) practice thrornbocytopenia , sch.istocytosis and e le\'atecl se rum LDH va lue are sufliciem to s u ggest the diagnosis.
TTP is a very rare disease (inc id ence: l: 100.0001:500.000) , mos t patients are aged het:ween 30-40 ycars o ld al cliagnosis. with femalcs affec ted at !cast twice as often as males If untreated the mortal ity race is approximately 90% . plasma exchange th era p y reduced th e mortaJi ty rate ro approx imately 20 % (Fig. 2).
Th e majority of cases are considered to be idiopathic,( inclucling autoimmune di.sorders , prcgnancy a11d ticlopicline),while 15 % of cascs are secondary to cancer, transp lantation, infe ct io n , clrugs, a n d chemoth erapy; fam ili ar forms are ve r y rare. This clinica! h e l11 erogeneity poses a cha ll enge for understancling the pathogenesis of TIP and select i ug appropriate Lherapies.
Summary - TTP is a Se\·en: micro\'ascularorcl11sivc thrombotic microangiopaLlycharacterizcd by a sis rcmic platclct aggreg-d Lion , organ is c hema, profound thro111bocyiopena and fragmentarion of erythrncytcs.
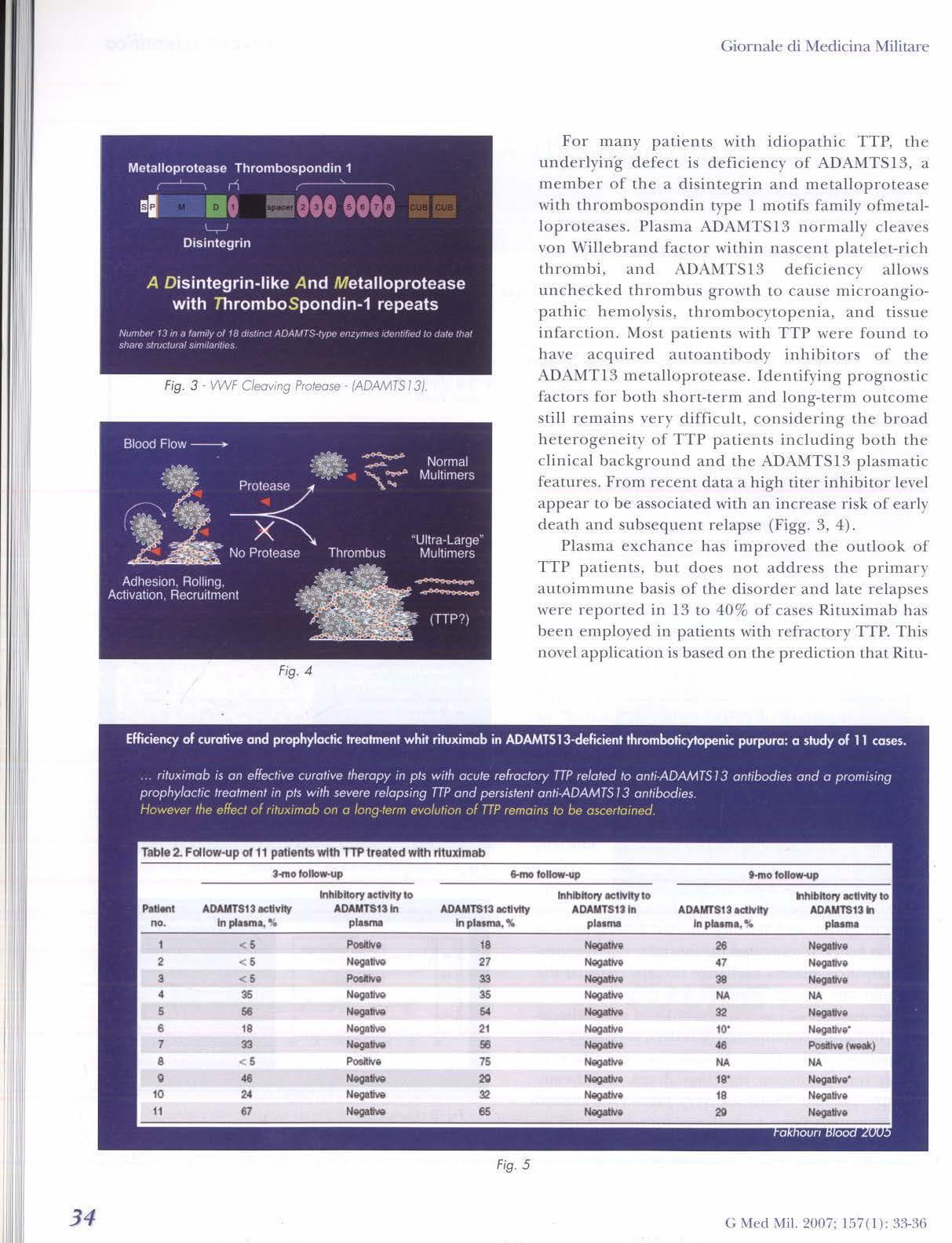
For rnany patien ts with idiopathic TTP, ù1 e underlyin g defect is deficiency of ADAMTS13, a member of the a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type l motifs family ofmetalloproteases. Plasma ADAMTSJ 3 normall y cleaves von Willebrand faccor within nascem platelet-rich thrombi , and ADAMTS13 deficienc y allows uncheckcd thrombus growth to cause microangiopathic hemol ysis , tbrombocytopenia, and tissue infarction. Most patients with TTP we r e found to have acquired autoantibody inhibitors of che ADAMTl 3 metalloprotease. Tdentify ing prognostic factors for both short-term and long-term outcome stili rernains ve rr difficult , con s idering the broad heterogeneity of TTP patients including both the clinica( background and th e ADAMTS13 pla s mati c featu1·es. From recent data a high titer inhibitor level appear lo be associate d with an increase risk of earl y death and s ubse quent re lapse ( Figg. 3 , 4).
Plasma ex c hanc e has improved the outlook of TTP patients, but does not address the prirnary autoimmune basis of th e disorder and late relapse s wer e reported in 13 to 40 % of cas e s Rituximab has been employed in patients with r efractor y TIP. Thi s nove! application is based on th e prediction that Ritu-
ximab clepletes the B-ccll clone producing ADAMTSJ 3 inhibitor y antibodies leading to a remission of the discase. So far - 60 patients have been u·eatécl documcn ting a 90 % CR rate and the effectiveness of this agen t i 11 terms of i ncreasing A.DAMTS13 activity and eradicaLing the ìnhibitor. Cu rrently a prospective randomited clìnìcal u;aJ in which Rit uximab therapy wi ll be added or not t0 plasma exchange in idiopathic TIP has been proposed hy ù1e Trasfusion Medicine Hemostatis C::linical Trials Network (Fig 5)
References
1. Rock G.A et al.: Comparison ofp!asnu, exrhange wilh plcmna infnsion in the lrealment of thrombotir thrombocytopenir purpura Canadian Apheresis Stmly Group NJM 1991.
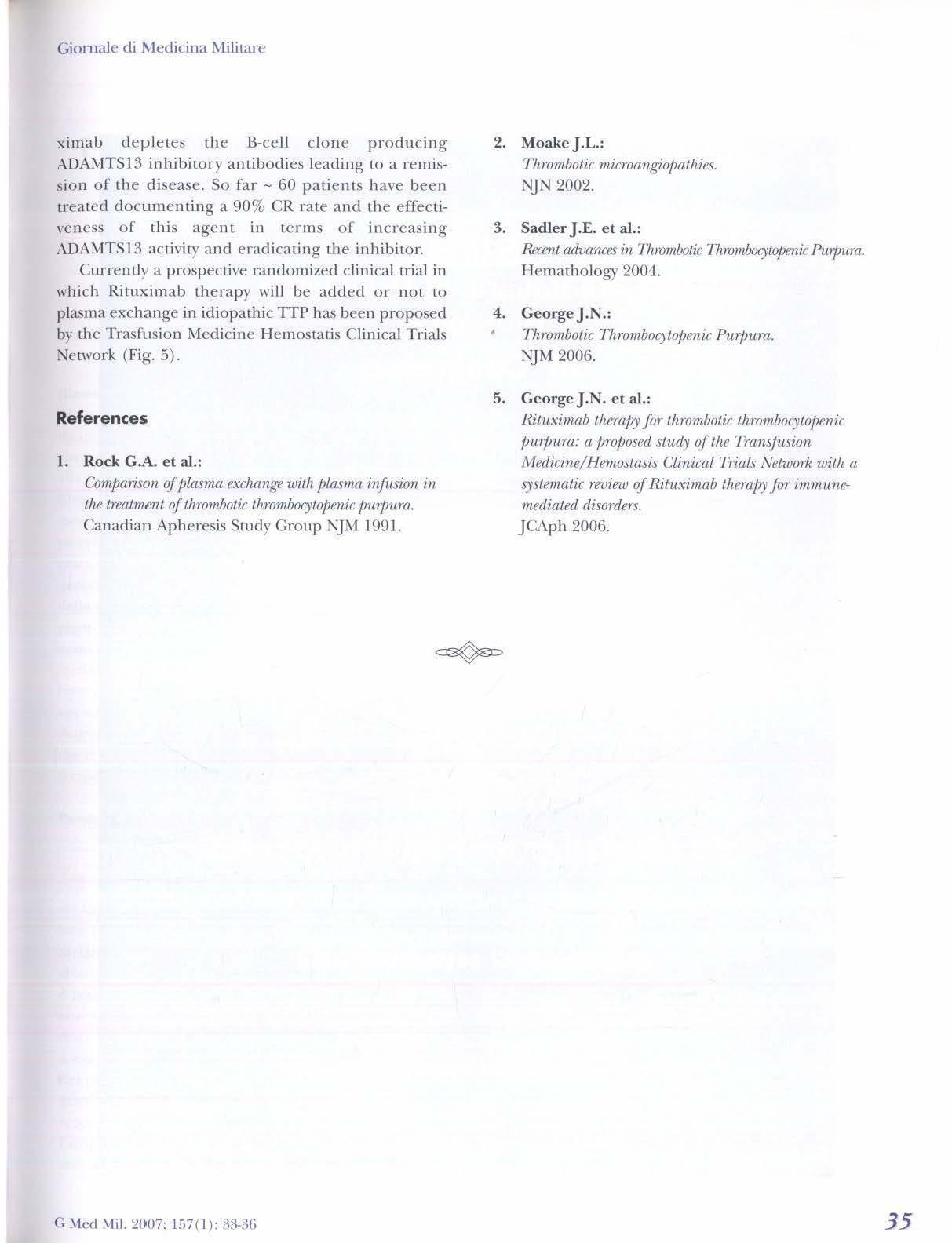
2 . Moake J.L.: Thrombotic microangio/>alhies. NJN 2002.
3. Sadler J.E. et al.: RPcent rlllvances in 17u-om/Jotic Thrmnbocylopenic Pu1pura. Hemathology 2004.
4. GeorgeJ.N.: Thrombolic Thrombocytopenir Pu1tmra. NJM 2006.
5. George J.N. et al.: Rit.uximab therapy Jor thrombotic Lhrombocylopenir /n.ajmra: a jJroposed study of the Transfusion Medicìne/ Hemostasis Clinica[ Trial~ Network with a systematic revi,{JU) of Rituximn.b therapy /or immuttemediated disorders. J CAph 2006.
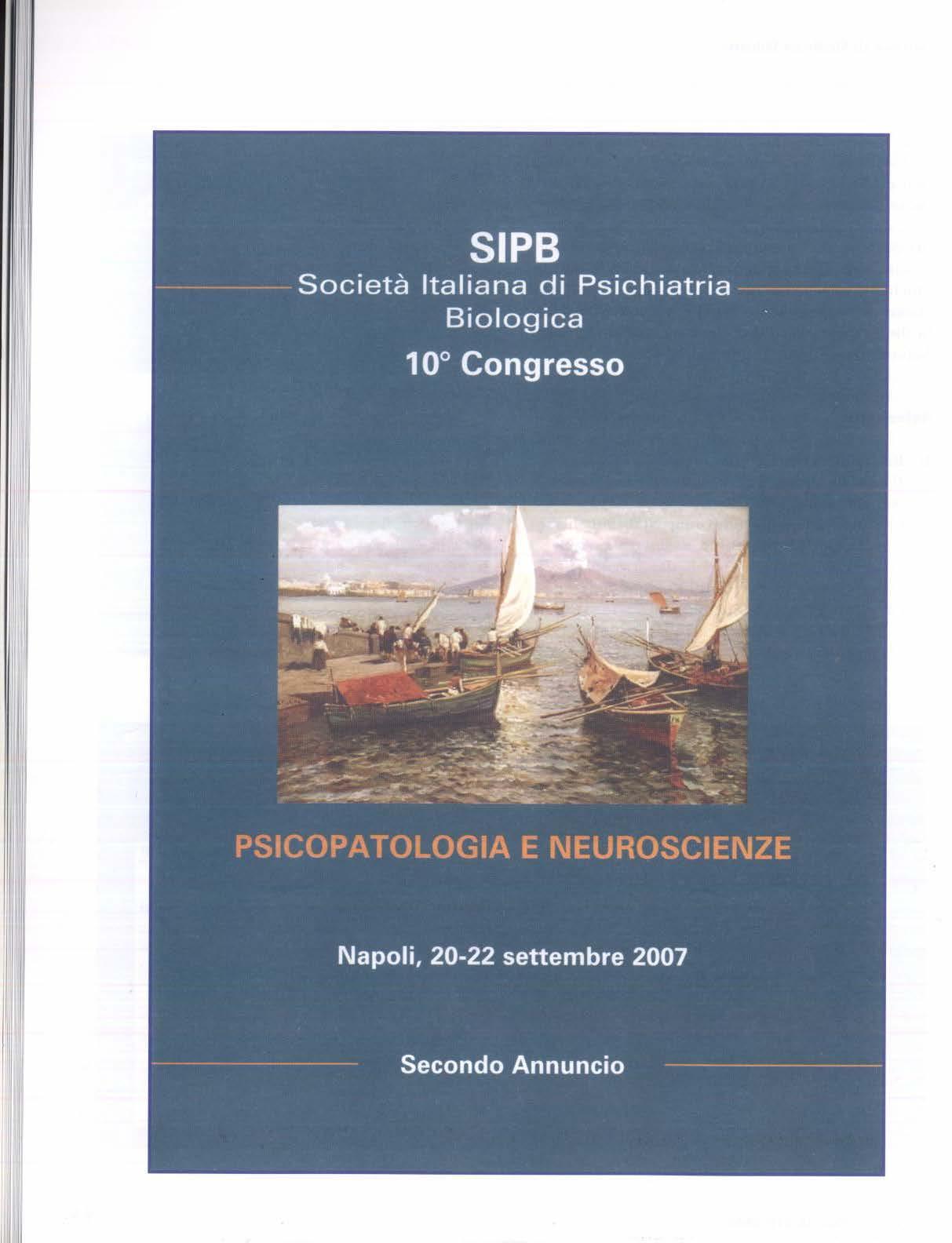
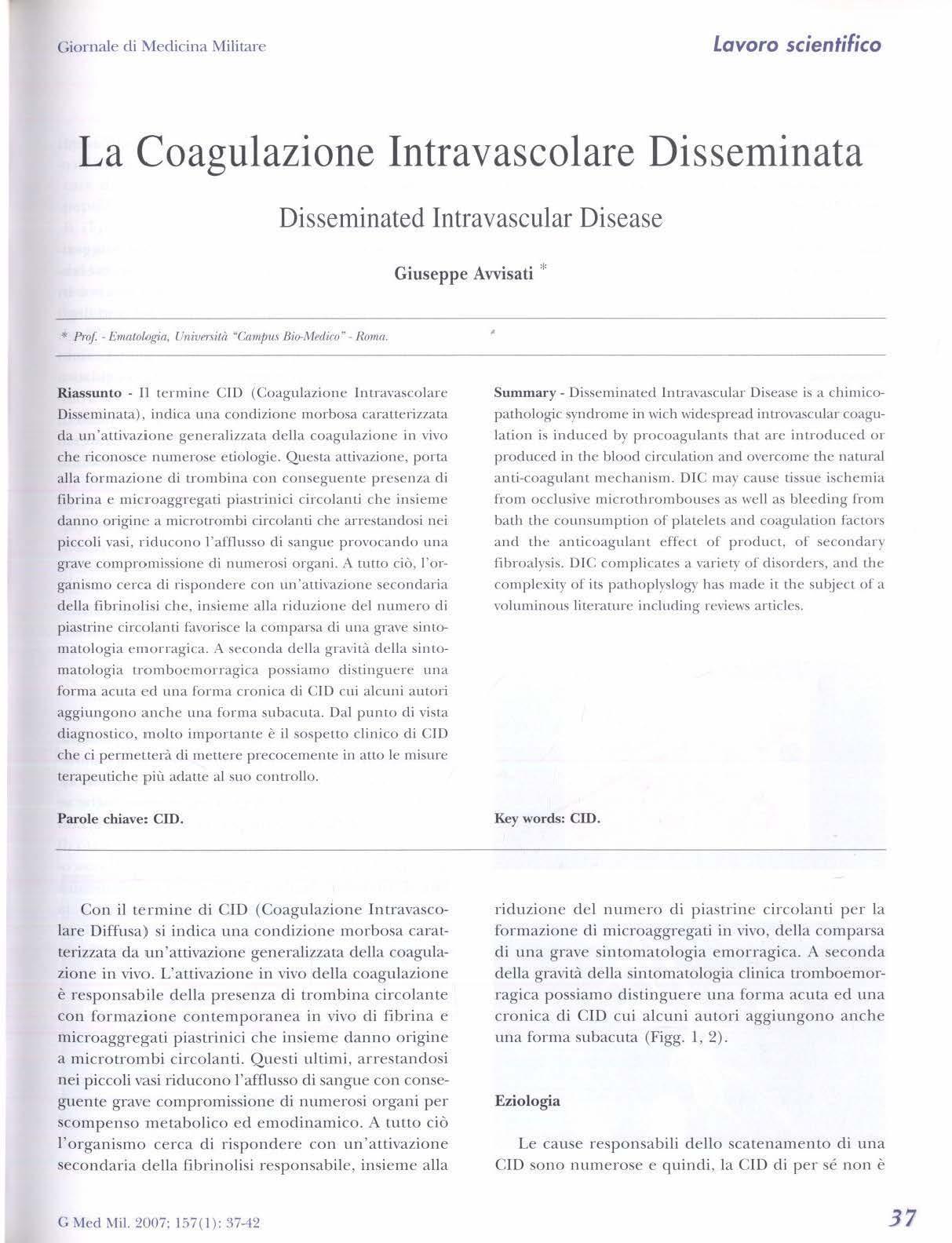
" Prof • t:mal/Jlògia, Univ mitlÌ ·ca111pw ./JiQ-J/Pdico • Homa.
Rfassunto - Il 1.crminc C I D (Coagu lazione lntra\'ascolare Disseminata), indica una con<lizionc mo,·bosa c.irattcdz,aca da un ' aLtivazione generalizzaca della coagu la1ionc in vivo che riconosce 11LU11ero,e eLiologie. Questa aLÙ\'az.ione, porta alla formazio11e <li trombina con corn,eguente pre,en.rn di lìbrina e minoaggregaù piastrinici circolauti che insieme danno orig in e a microtrombi circolanù che arrestandosi nei piccoli vasi, riducono l' anl11sso di sang11c provocancio una grave compromissione cli numerosi organi . A umo ciò, l ' organismo cerca di ri,pondere con un ·aui\ azionc secondaria della flb1 ino i isi che, insieme alla ridu.i:ione del numero cli piasu ine ciffolanti fa\'Orisce la comparsa di uua grave ~intu-matologia cmo1-ragica. A seconda <lella grn\·ità della si11tomatologia trombocmorragica possiamo dist inguert' una forma acuta ed una forma cronica di CID cui alcuni aut.Oli aggiungono anche una forma subacuta. Dal pun 10 cli vista diagnostico, molto importante è il so~petto clinico di CID che ci pennellerà di mettere precocemente i11 atto le misure terapeutiche p iù adatte a l suo co11trollu.
Paro le c bfave: CIO.
Con il termine cli CID (Coagu lazione In travascolare Diffusa) si indica una concli7 ione morbosa caratterizzata da un 'attivaz ione generalizzata della coagulazione in vivo. L'attivazione in vivo d e ll a coagu lazione è responsabile della presenza di trombina circolante con formazione contemporanea in vivo di fibrina e mi croaggregali piasLrinici che insieme danno origine a microtrombi circolanti. Questi ultimi, arrestandosi n e i picco li vasi riducono l'afflusso di sangue con conseguente grave compromissione di numerosi organi per scompenso metabolico ed emodinamico. A tutto ciò l 'organismo cerca di rispondere con un'attivazione seco nd aria del la fibrinolisi r esponsabi le, in sieme alla
Summary - Disseminateci ln trava.o,cular Di~ease is a ch imicopatholo~c sy11drome in wich "~dcspread i11Lr0\·ascular coagulation is ind1tcecl by procoag1tlants that are intsoduced or produccd in thc b lood circulaLion ancl m·crcomc rhc natur-d.! ant i-coagulant mechanism. DIC may cause tissuc ischemia from occlusive microthrombouses as well as bleccling rrom bath Lhe coun~urnpùo11 of plate leb ancl coagulation factor, and the anticoagulanL effrct of product, of secondaq· fihroalysis. DIC complicatcs a variet)' of disonlen, and Lhe rompl<'xi1y o[ its pathoplyslogy has marle it Lhe subjecL of a \'Olumino11s li tC'raturc including !TvÌ<'WS artir lcs.
Key words: CIO.
riduzione del numero di piastrine cii-colanù per la formazione cli microaggregati in vivo, della comparsa di nna grave sintomatologia emorragica. J\ seconda della gravità della sintomatologia clinica rromboemorragica possiamo distinguere una forma acuta ed una cronica di CID cu i alcuni autori aggiungono anche una forma subacuta (Figg. l, 2).
Le cause responsabili dello scatenamento di una CIO sono numerose e quindi , la CID di per sé non
una malattia ad eziologia unica, ma una sindrome dovuta a cause apparentemente differenti tra loro. Le forme morbose più frequentemente responsabili di una CID sono: alcune patologie ostetriche, le sepsi , alcune neoplasie maligne, soprattutto se rnetastalizzate, le emopatie acute, le condizioni morbose in cu i è presente un'iperemolisi acuta, la c irrosi epalica, gli interventi chirnrgici, i traumi e le ustioni gravi, gl i ernang iorni giganti.
Patogenes i
In condizioni fisiologiche, il sistema vascolare resta pervio cd il sangue non coagula grazi e al normale flusso ematico, alla presenza di inibitori naturali della coagulazione (come l 'antitrombina Hl e la proteina C) e a ll' au.ivazionc della fibrinolisi, con formazione di plasmina, in maniera bilanciata rispeuo a ll'attivazione della cascata coagulativa. Questo equilibrio fisiologico nella CIO viene alterato· perché si realizza lll10 stimo lo marcato o in senso coagulati\'o o in senso fìbrinoLitico o in ambedue i sensi. La ClD rappresenta comunque
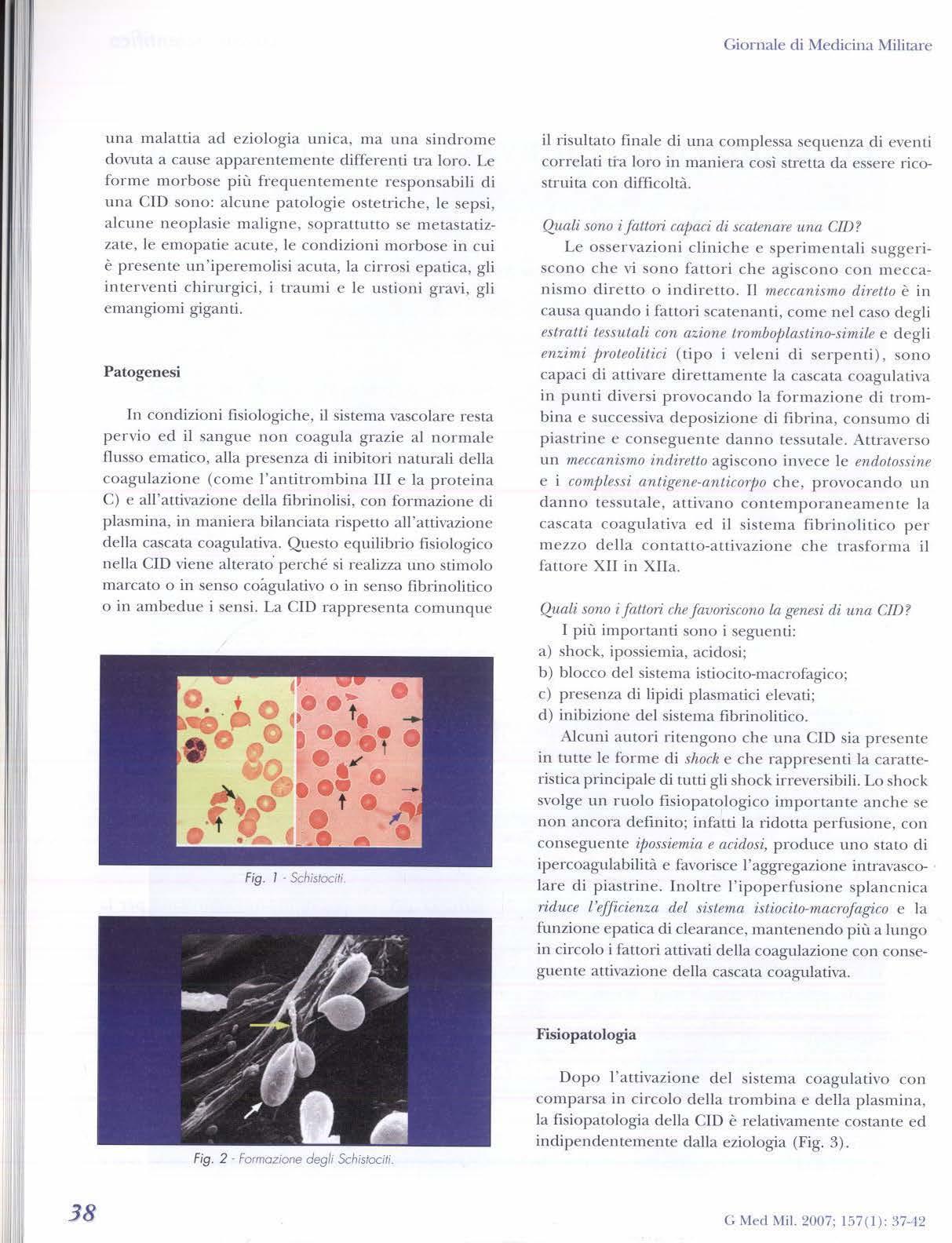
il risultato finale di una complessa sequenza di evemi correlati tra loro in maniera così stretta da essere ricostruita con difficoltà.
Quali sono i_fattori ca/Jaci di scatenare una CID?
Le osservazioni cliniche e sperimentali suggeriscono che vi sono fattori che agiscono con meccanismo diretto o indiretto. TI meccanismo diretto è in causa quando i fauo1i scatenanti, come nel caso degli estrali i tessutali con azione tromboplastino-simile e degli enzimi j1roteolitici (tipo i veleni di serpenti), sono capaci cli attivare direttameme la cascata coagulaliva in punti diversi provocando la formazione di trombina e success iva deposizione di fibrin a, consumo di piastrine e conseguente danno tessuta le. Attra\'erso un mPrranismo indiretto ag iscono invece le endotossinf e i comp!Pssi antigenP-antic011Jo che, provocando un danno tessutale, attivano contemporaneamente la cascata coagulat i va ed il sistema fibrinolitico per mezzo della contatto-attivazione che trasforma il fattore XII in XI la_
Quali sono i fattori che favoriscono la genesi di una CTD?
I più importanti sono i seguemi:
a) shock, ipossiemia, acidosi; b) b locco del sistema istiocito-macrofagico; e) presenza di lipidi plasmatici e levati; d) inibizione de l sistema fib1inolitico.
Alcuni autori ritengono che una C ID sia presente in llltte le forme di shock e che rappresenti la caratteristica principale di tutti g li sbock irreversibili. Lo sh ock svo lge un ruolo fisiopatologico importante anc h e se non ancora definito; infatù la r id otta perfusione, con conseguente ipossiemia e acidosi, produce uno stato di ipercoagulabilità e favorisce l' aggregazione inlravascolare di piastrine . Inoltre l'ipoperfusione sp lancnica riduce I 'pfjirienz.a del sistema istiocito-macrofa[!;ico e la funzione epat ica d.i dea.rance, mantenendo più a lun go in c ircolo i fattoti attiva ti della coagulazione con conseg u ente attivazione della cascata coagulativa.
D opo l'attivazione del s istema coagu lativo con comparsa in circolo della trombina e della plasmina, la fisiopatologia d e ll a ClD è relaùvamente costante ed indipendentemente dalla eziolo gia (Fig. 3).
Qual'è il ruo/,o delln trombina in una CJD?
Una volta formatasi, la trombina comincia a stacca.re dalla molecola di fibrinogeno prima il fibrinopcptide A (FpA) e successivamente il fibrinopepticle B (FpB). ln questo modo vengono lasciati liberi i monomeri di fibrina che successivamente sotto l'azione del fattore XIII, polimerizzano dando luogo aJJa formazione di microtrombi di fibrina, nei quali vengono catturate le piasu-ine con consequente piast1inopenia.
Altre azioni svo l te dalla trombina sono l'inizio dell'aggregazione piastrinica e il potenziamento della cascata coagulativa, arnnentando l'atti,irà coagulativa dei fattori V e Vll l ; LUttavia la sua azione continua conduce alfa clegradaL.ione di questi fattori per mezzo della proteina C. Quindi la trombina è responsabile della diminuzione del fibrinogeno, delle piastrine e dei fattori Il, V, VTIT, X III , ma alla diminuzione dj questi fattori concorre anche la pia.smina con la sua azione proteolitica. Tuttavia alcune volte le concentrazioni dei fattori V e Vll l in corso di CIO possono essere normali o addiriuura elevate; ciò si veriuca quando si ha una minore azione proteolitica della trombina, così che l'attivazione di questi fattori avviene senL.a che vi sia una COITispondente inattivazione.
Qual'j, il ruolo della jJlo.smina in una CID?
Anche la p lasmina circola \ibernmente e comincia a staccare dalla molecola del fibrinogeno i frammenti X , Y, D ed E, che danno luogo ai prodotti di degradazione del fibriuogeno (FDP). Inoltre la plasmina, prima ancora di staccare i frammenti X, Y. D ed E, rilascia dalla molecola ciel fibrinogeno anche peptidi specifici tra cui il peptide B-P 142 ed il frammento B-PJ5-42·
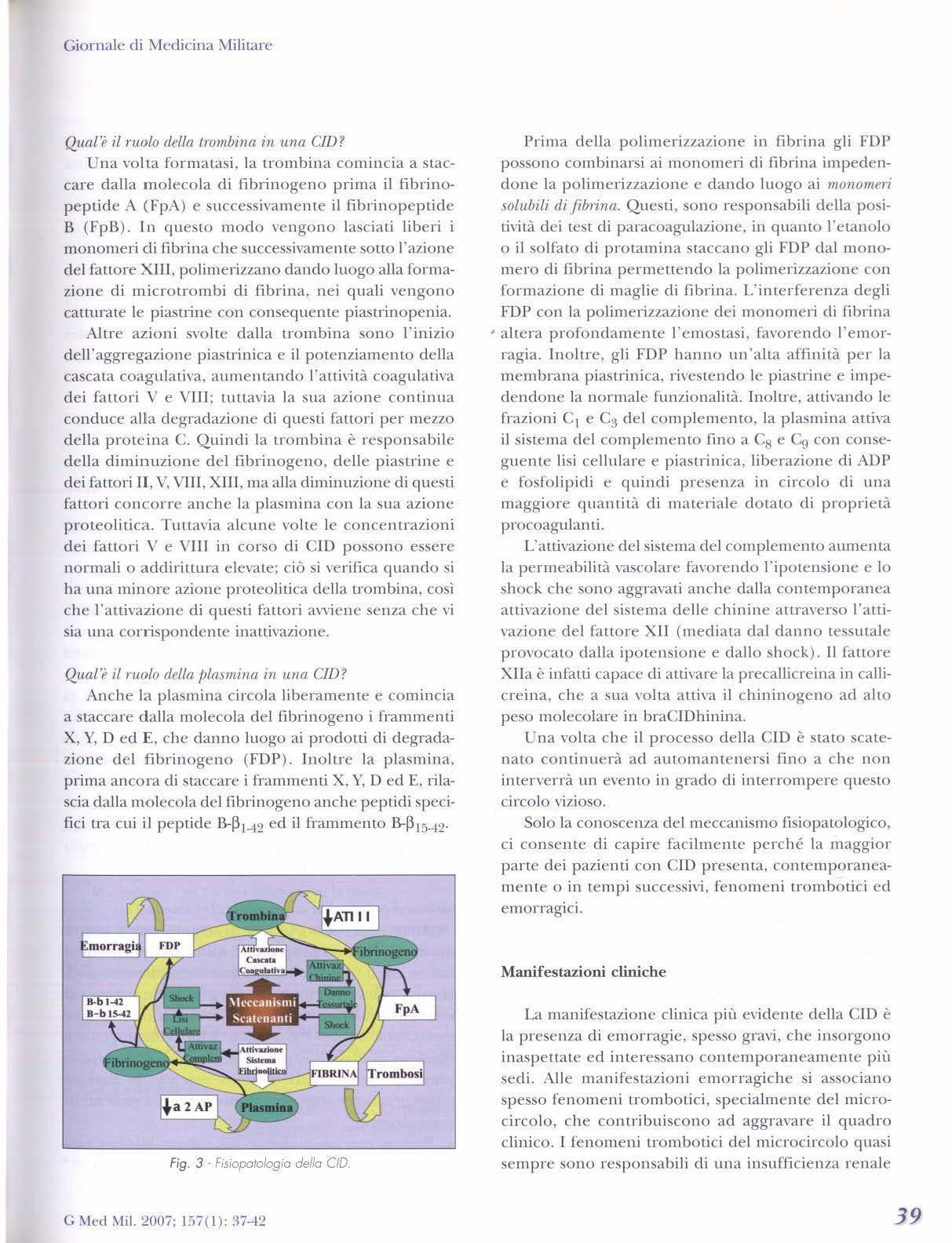
Prima della polimerizzazione in lìbrina gli FDP possono combinarsi ai monomeri di lìbrina impedendone la polimerizzazione e dando luogo ai monomeri solubili dì fibrina. Questi, sono responsabili della positività dei test di paracoagulazione. in quanto l'etanolo o il solfat0 di protamina staccano gli FDP dal monomero cli lìbrina permettendo la polimerizzazione con formazione di maglie di fibrina. l.'inrerferenza degli FDP con la polime1izzazione dei monomeri cli fibrina • altera profondamente l'emostasi, favorendo l'emorragia. lnollre, gli FDP hanno un'alta affinità per la membrana piasu-inica, rivestendo le piastrine e impedendone la normale funzionalità. Inolu·e, attivando le frazioni C 1 e C 3 del complemento, la plasmina attiva il sistema del complemento fino a C 8 e C 9 con conseguente lisi cellulare e piastrinica, liberazione di ADP e fosfolipidi e quindi presenza in circolo cli una maggiore quantità di materiale dotato di proprietà procoagulanti.
L'attiYazionc del sistema del complemento aumenta la permeabilità vascolare fayorendo l'ipote11sio11e e lo shock che sono aggravati anche dalla contemporanea auivazione del sistema delle chinine aru-averso l'arti\'aL.ione ciel fattore Xli (mediata dal danno tessutale provocato dalla ipotensione e dallo shock). Il fattore XIIa è infatti capace di attivare la precallicrei.na in callicreina, che a sua volta attiva il chininogeno ad alto peso molecolare in braCJDhinina.
Una volta che il processo della CID è stato scatenato continuerà ad automantenersi fino a che non interverrà 1111 evento in grado cli interrompere questo circolo ,izioso.
Solo la conoscenza del meccanismo fisiopatologico, ci conserne di capire facilmente perché la maggior parte dei pazienti con CID presenta. contemporaneamente o in tempi successivi, fenomeni trombotici cd emorragici.
La manifestazione clinica più evidente della C I O è la presenza di ernorra1:,ric, spesso gravi, che insorgono inaspettate ed interessano contemporanearnc11te più sedi. Alle manifestazioni emorragiche si associano spesso fenomeni trombotici, specia lm ente del microcircolo, che contribuiscono ad aggravare il quadro clinico. 1 fenomeni trombotici del microcircolo quasi sempre sono responsabili di una insufficienza renale
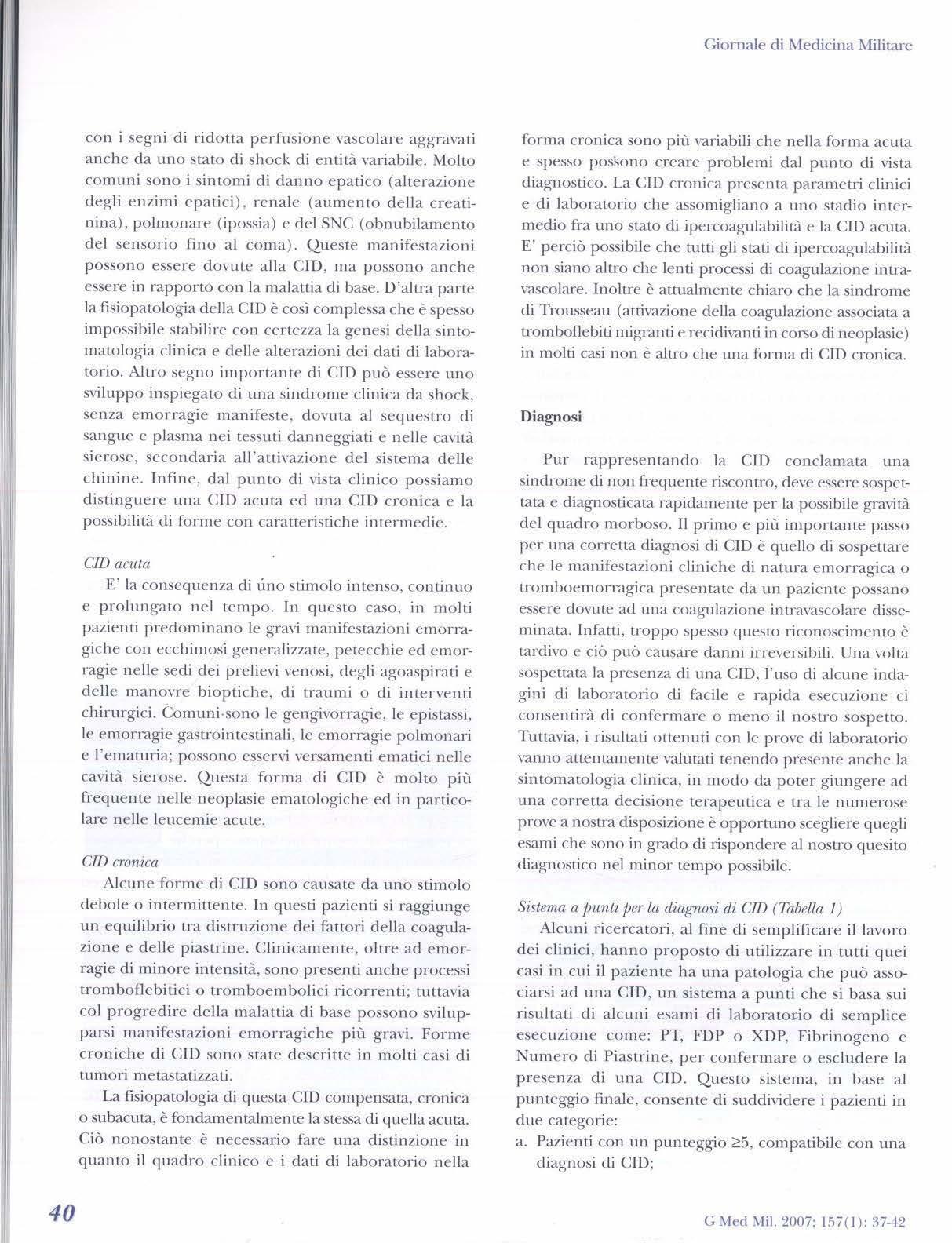
con i segni di ridotta perfusione va.scolare aggravali anche da uno stato di shock di enùtà variabi le. Molto comuni sono i sintomi d i danno epatico (alterazione degli enzimi epatici). renale (aumento della creatinina), polmonare (ipossia) e del SNC (obnubil amento del sensorio fìno al corna). Queste manifestazioni possono essere dovute alla CIO, ma possono anche essere in rapporto con la ma lauia di base. D'altra pane la fisiopatologia de ll a ClD è così complessa che è spesso impossibile stabilire con certezza la genesi della sintomatologia clinica e delle alterazion i dei dati di laboratorio. Altro segno importante di CID può essere nno sviluppo i nspiegato <li una sindrome clinica eia shock, seuza emorragie manifeste. dovuta al sequestro di sangue e plasma nei tessuti danneggiati e ne l le cavità sierose, secondaria all"auival'.ione del .sistema delle chinine. Infine, rial punto di vista clinico possiamo distinguere una C IO acuta ed una C IO cronica e la possibilità di forme con caratteristiche imerrnedie.
cm acuta
E' la consequcnza di uno stimolo intenso, cominuo e prolungaw ne l tempo. In questo caso, in molti pazienLi predominano le gravi manifestazioni ernorrngiche co11 ecchimosi genera lizzate, petecchie cd emorragie nelle sedi dei prelie,~ venosi, degli agoaspirati e delle manovre bioptiche, di traumi o di interventi chirurgici. Comuni-sono le gengivorragic. le epistassi, le emorragie gasu·ointestinali, le emorragie polmonari e l'ematuria; possono esservi versamenti ematici nelle cavità sierose. Questa forma di CTO è molto più frequente nelle neoplasie ematologiche ed i11 particolare nelle leucemie acnLe.
C/D cronica
Alcune forme cli CID sono causate da uno stimolo debole o intermittente. I n questi pazienti si raggiunge un equilibrio tra distruzione dei fattori della coai:,ru l azione e delle piasuine C l inicamente. oltre ad emorrabrie di minore intensità, sono presemi and1e processi tromboflebitici o tromboembolici ricorrenti; wltavia col progredire della malattia di base possono svi l upparsi manifestazioni emorrai:,riche più gravi. Forme croniche di C I O sono state descritte in molti casi di tu m ori metastatizzati.
La lìsiopatologia di questa ClD compensata, cronica o subacma, è fond,m1enralmenle la stessa di que ll a acuta. Ciò nonoslanre è necessario fare una distinzione in quamo il quadro clinico e i dati di laboratorio nella
forma cronica sono più variabili che nella forma acuta e spesso possono creare problemi dal punto di vista diagnostico. La ClD cronica presenta parametri clinici e di laboratorio che assomigliano a uno stadio intermedio fra uno stato di ipercoagulabilità e la CTD acuta. E' perciò possibile che tutti gli stati di ipercoagulabilità non siano alLro che lenti processi cli coagulazione imravascolare. Inoltre è attualmente chiaro che la sindrome di Trousseau (attivazione della coaguJazione associata a tromboflebiti migrami e reciclivarni in corso di neoplasie) in molti casi non è altro che una forma di CID cronica.
Pur rappresf'n tando la CTD conclamata una sindrome di non frequente riscontro, de\'c essere sospettala e diagnosticata rapidamenLe per la possibile gravità del quadro morboso. Il primo e più impanante passo per una correua diagnosi di CID è quello di sospeuare che le manifestazioni cliniche di natura emorragica o rromboemorragica presentate da 1111 paziente possano essere dovute ad una coai,rulazione intravascolare disseminata. Infatti, troppo spesso questo 1iconoscimento è tardivo f' ciò può causare danni irreversibili. Una volta sospettata la presenza di una CID, l'uso di alcnne indagini di laborato1io di facile e rapida esecuzione ci consentirà di confermare o mt'no il nostro sospetto. Tuttavia, i risu l tati ottenuti con le prove di laboratorio vanno attent.amenle valutati tenendo presente anche la simomatologia clinica, in modo da poter giungere ad una corretta decis ione terapeutica e tra le numerose prove a nostra disposizione è opportuno scegliere quegli esami che sono in grado di ri.spondere al nostro quesito diagnostico ne l minor tempo possibile.
Sistema a pnnti per la diagnosi di cm (Tabella 1) Alcuni ricercatori, al lìne di semplificare il lavoro dei c l inici , hanno proposto di utilizzare in tutti quei casi in cui il paziente ha una patologia che può associarsi ad una CID, un sistema a punti che si basa sui risultali di alcun i esami di laboratoi:io di semplice esecuzione come: PT, FDP o XDP, Fibrinogeno e Numero di Piastrine, per confermare o esc ludere la presenza di una CID. Quesro sistema, in base al punteggio finale. consemc di suddi,idere i pazienti in due categorie:
a. Pazienti con un punteggio :2'.5, compatibile con una diagnosi di CI D;
b. Palienti con u11 punteggio < 5, suggestivo ma non compatibile con una diagnosi di CID.
I pazien Li con punteggio~ 5 devono esser trattati secondo le l inee terapemiche consigliate per una Cl D; al contrario, nei pazienti con punteggio <5 è necessario controllare gli esami di laboratorio giornalmente ed attendere che il punteggio divemi 5 , p1;ma di iniziare il trattamento.
Bisogna 1icordarsi però che questo sistema a punti è valido solo per quei pazienti affetti da una patologia capace di scatenare una CID.
Nel caso si sospetti una CID , vi sono delle misure tcrapcmiche di carattere generale che vanno prontamente attuate senza attendere i risultai i cli laboratorio. Queste misure terapemiche genera l i sono:
a) tera/Jia della malallia di base (diversa a seconda della etiologia della CID);
b) eventuale terapia rontro lo Shock;
Inoltre, se il paziente presenta delle emorragie in atto, o deve essere ~ottoposto a manovre invasive e si ha il sospetto che ci si trovi in presenza di un pa;,iente con CIO. è necessaria:
c) La tras/i1sione di roncenlmti piastrinici (alla dose di 1 concemrato og11i 10 kg di peso corporeo);
d) La tmifusionp di plasmaJm~ro congelato in infusionf rontimia (alla dose di 15-20 ml/kg di peso corporeo).
Se invece il paziente non presenta una simomatologia emorragica o non deve essere sottoposto a manovre invasive, non è necessario utiliaare i concentrati piastrinici o il plasma fresco congelato.
Generalmente queste misure terapeutiche, se proutamcnte attuate, sono in grado di risolvere la maggior parte delle CJD. tuttavia. nei casi in cui prevalgono i fenomeni trombotici, è necessario auuare anche una terapia con farmaci anticoagulami.
T erapia con farmaci anticoagulan ti
Il farmaco anticoagulante più comunemente usato , anche se fino ad ora non è stato mai stato dimostrato un suo effetto benelìco in studi clinici controllati, è l'PJ1arina. Considerando la complessa fisiopatologia della CID è chiaro che la somministrazione di eparina è in grado di interrompere solo uno dei due momenti fisiopatologici. Tuttavia, quando necessaria la sommiuistra,1:ionc di eparina può esser fatta con modalità diverse ma sempre a dosaggi relativameme bassi. fn particolare. in presenza di insufficienza renale è inCfData la somministrazione di eparina in infusione continua con dosaggi variabili che dipendono dal peso ciel paziente. Invece, in asse1ua di insufficienza renale è utile la somministrazione sottocutanea di dosi terapeutiche di eparine a basso peso molecolare (EBPM) secondo gli schemi utilizzati per il trattamento della malattia tromboembolica per le diverse EBPM.

l Il paziente ha una patologia che può associars i ad una CIO?
SI = procedi ; NO = non usare questo sistema
2. Rich iedi Screening Coagu lativo ( PT, Fibrinogeno,FDP/XDP, Conio Piastrine)
3. Dai un punteggio ai risultati:
• Aumento del PT
• Fibrinogeno
• FDP/XDP•
• Piastrine x l 03/
4. Calco la il Punteggio
(<3 sec =O; >3 sec = l ; >6 sec = 2)
(>100mg/dL = O; <100 mg/dL =1)
(N = O; A=l; AAA= 2 )
L (> 100 = O; < I 00 = 1; <50 = 2)
2: 5 compatibi le con CIO, ripetere giornalmente o o o o < 5 suggest ivo, non affermativo di CIO, ripetere giornalmen te
• N = Normale; A = Aumentati; AAA = Molto aumentati
Terapia con Inibitori jisiologici della coagulazione
Poiché l'antitrombina III (ATITT ) è uno dei più potenti inibitori della coagu lazione, il suo uso nei pazienti con CID è stato oggetto di numerosi studi, anche se la maggior parte degli studi randomiZLati hanno riguardato paziemi con Sepsi o Shock seuico Al momento attua le, però, sulla base di numerosi studi clinici non,.; è inCIDaLione a ll 'utilizzo dei concentrati di ATI II in corso cli CIO con l'escl usione di quei pazienti in trattamento eparinico e gravi deficit di ATIII. Per quanto riguarda invece l'utiliao dei concentrali di proteina Cattivata è ancora u·oppo presto consig li arne l ' uso al di fuor i di studi clinici prospettici controllati.
Terapia con farmaci anlifibrinolitici
La somministrazione di questi farmaci in corso di C ID dovrebbe essere presà in consideraLione solo in quei pazienti nei quali è i:>resente un ·eccessiva risposta fibrinolitica secondaria all'attivazione della coagulazione oppure un ' iperfibrinolisi primaria. Anche questi farmaci vanno somministrati per infusion e continua alla dose di 40-100 mg / kg/d ie per l 'ac ido trancxamico.

Conclusione
I pazienti con C ID pr esentano problemi non solo diagnostici , ma anche terapeutici, per la possibile concomitante presenza cli complicanze emorragiche e trombotiche. Fo11damentale è comunque in questi casi identificare e trattare in modo corretto la condizione morbosa di base e l'evemuale condizione di shock che spesso si assoc ia alla CID. Inoltre , un ruolo di p1imaria importanza è svo lto anche da l corretto s upporto tra5fusionale Infine. deve essere tenuto ben presente che la somministrazione di eparina richiede nn 'attenta valutazione clinica e non può in alcun modo essere considerato, come avveniva una volta, runico trattamento specifico per questa patologia
1. Levi M., ten Cate H.: Dissemina/ed Intra vascular Coag;lllation. New EnglandJournaJ ofMeCIDine. 1999;341 :586-592
2. Levi M., deJonge E. , Meij ers J.: The Diagnosis ofDissemina/ed Intravasmlar Coagulation
Blood Reviews 2002; 16:217-223.
Molecular biology of myeloproliferative di sease
* D111t.ssa - Oipartimm/o di Biopatnlogia, l 'nivmità 1'01 \le,gata - Roma.
• Prof - Dipt1rfi11w11/o d, Biopalologia, U11ive1~ità Tar \ierga/(I - Roma.
Riassunto - I disordini mieloproliferativi sono un gruppo eLerogeneo di malattie ematologiche che includono fonn(' prevalentemenre associate a rlifc1ti della differ-cn7ia7.ionc (sindromi micloclisplastiche ). f"ormc caratteriZ7ate da iperprolifcrazionc cl.'l l ulare (sindrom i mieloproliferative croniche) e forme in cui :.i ha un difetto misw della proliferazione e della diffe,-enLiazione (leucemie acute mieloid.i).
Negli ultimi tempi. lo studio delle aberrazio11i molecolari delle malattie mieloprolifcratiYe ha acquisito una notevok valent:a clinico-Lerapeur ica. consentendo l a identificazione cli marcatori per una diagnosi più precisa, la dcfìni7ionl.' di gruppi prognostici per una classificazione più moderna, cosa ancora più rilevante. permettendo in alcuni casi di S\" il upparc armi terapemiche specifiche direue ,·erso i bersagli molecolari. I n que~ta rassegM1, ~aranno discusse le principali allerazioni geneLiche che sono aJla base della pawgenesi delle sindromi mieloproliferntive, con particolare riferimento a l s ign i ficato clinico delk stesse nella diagnosi. nella classificazione e nella tcrapi,1.
Parole chiave: Sindromi micloproliferative.
I disordini mieloproliferativi costitu iscono un gruppo di malattie ematologiche carat.rerizzate da un 'anomala pro liferaz ione di una o più li nee cellulari emopoietiche della serie mieloìde. La classificazione WHO ( World H ealth Organi:wlion) divide i disordini mieloproliferativi in leucemia micloidc acuta (LMA), sindromi micloclisp lastic h e (SM D ) e sindromi micioproliferative croniche (SMPC) in relazione alle cara tteristiche morfo logiche. immun ofenotipiche e c it ogenetiche delle cellu le coi nvo lte ( 1). Le LMA sono carat-
Summary • .\1ycloprolircrative cliseascs (M PD ) are a heterogencous group of hcmacologic disorders including for111s prcdominantly associateci witb a differentiation defen (mye loclvsplastic syndromes), forms cJ1aracterized by increasecl celi proliferatio11 (chronic myeloproliferative cliseases) and, f.ina lly, forrns featured by a mixed defect affecting both proliferation ,md differentiation (acute myeloid leukemias). 111 reccnt years, im·cstigarion on mo l ccular lesions of l'vlP D has led to important c l inico-thcrapcucìc ad\'anccs rhrough rhe idcntilìcatjon of markers fora more refìned cliagnosìs, b y allowing the definition of prognoslic groups for improved classifica t ion and. most imponantly, leading in some i11sLa11ces the development of specific therapeutic tools directed t0wards rnolecular target.~. In th is review, we will discu.~ the main gcnetic a!Lerations underlying the paLhogenesis of MPD , with partir11la1- cmphasis on 1.hcir c linica! impact 011 diagnos is, class iticarion and thcn1py.
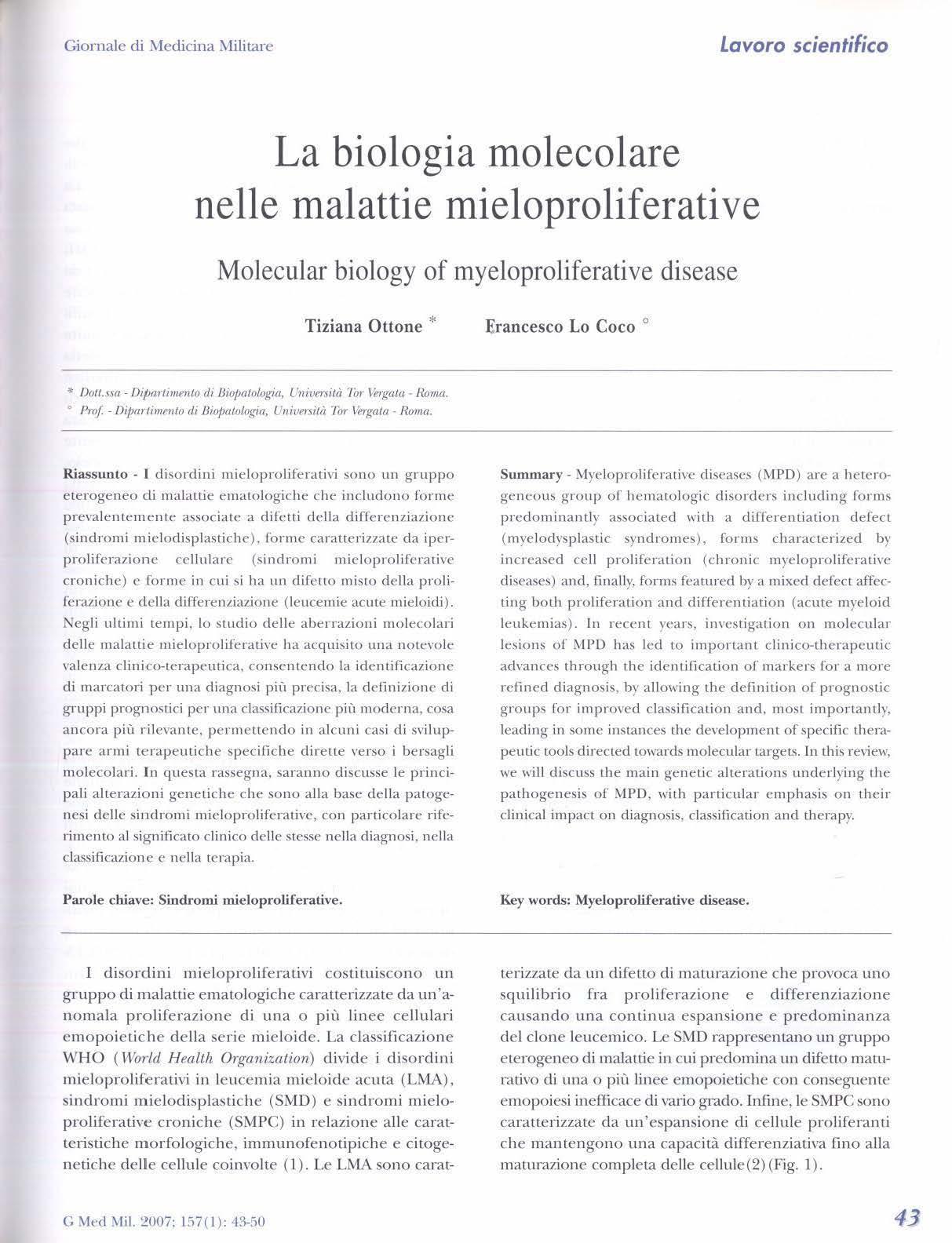
Key words: Myeloproliferative clisease.
tt."rizzate da un difetto di maturazione che provoca uno squilibrio fra proliferazione e differenziazione causando una continua espansione e predominanza ciel clone leucemico. Le SMD rappresentano un gruppo eterogeneo cli malattie in cui predomina un difetto maturativo cli Lma o più linee emopoietiche con conseguente emopoiesi inefficace cli vario grado. Infine, le SMPC sono caratterizzate da un'espansione di cellul e proliferanti che mantengono una capacità diffe rem:iativa fino alla maturazione comp leta delle ce llul e(2) (Fig. l).
Giornal e di \1e dici11a Militare
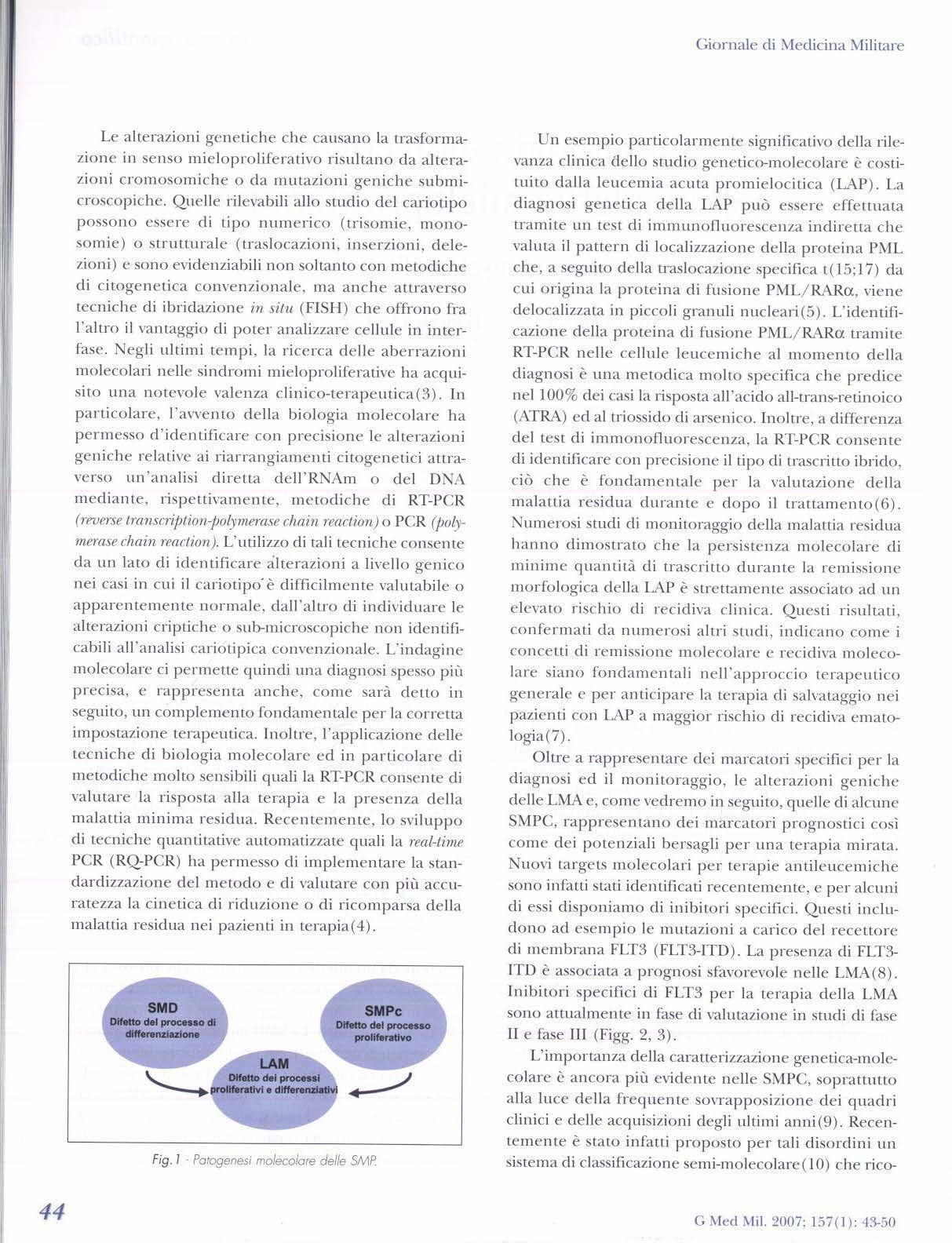
Le alterazioui genetiche che causano la trasformazione in senso mieloproliJerativo risultano da alterazioni cromosomiche o da mutazioni geniche submicroscopiche. Qnelle rilevabiJi allo studio del cariotipo possono essere di lipo numerico (trisomie, monosomie) o strutturale (tras locazioni. inserzioni. delezioni) e sono e\'ideuziabili non soltanto con metodiche di citogene tica convenzionale. ma anche attraverso tecnic h e di ib1idazion e in situ (FIS H ) che offrono fra l'altro il vamaggio di poter analizzare cellule in interfase. Negli ultimi tempi, la ricerca delle aberrazioni molecolari nelle sindromi mieloproliferaùve ha acquisit o una notevole valenza clinico-terapeutica(3). In particolare, l'avvento della biologia molrcolarc ha permesso d ' identificarr con precisione le alterazioni gen ich e relative ai riarrangiameuti citogenetici attraverso un'analisi diretta dell'RNAm o del DNA mediante, 1ispettivamenLe, metodiche cli RT-P C R (ffv Prse tra11srrijition -/Jo/ymerase rhoiu reartion) o PCR (jJolymera~e chain renrlion ). L'utilizzo di ral i tecniche con seme da un lato di identificare a lterazioni a li,·ello genico nei cas i in cu i il ca riotip o· è difficilmente valutabile o apparentemente 11ormale, dall'altro di incli\'icluare le alterazioni c1iptiche o sub-microscop iche non identificabi li all'ana li si cariotipica convenzionale. L'indagine molecolare c i permette quindi una diagnosi spesso più precisa, e rappresenta anche, come sarà detto i11 seguito, un compl emento fondamentale per la corretta impostazione terapeutica. Inoi tre , l'applicazione delle tecniche di biologia molecolare cd in particolare di merodiche molto sensibi li quali la RT-PCR consente di va lutare la risposta alla terapia e la presenza della malauia lllinima residua. Recentemen te , lo svi lupp o cli tecniche quantitative automatizzate quali la real-time PCR ( RQ-P C R ) ha permesso di implementare la standardizzazione del metodo e cli valutare con più acc11rarezza la cinetica di riduzione o di ricomparsa della malattia residua nei paziemi in terapia(4).
Un esempio particolarmeme significativo della 1ilevanza cl ini ca dello studio genetico-m o lecolare è costituito dalla leucemia acuta prnmielocitica (LAP). La diagnosi genetica della LAP può essere effettuata tramite un test di immunonuoresce11La indiretta che valuta il pattern di localizzazione della proteina PML che, a seguito della traslocazione specifica t( l.5;17) da cui origina la proteina di fusione P.vfL/ RARo:. viene dclocaliznta in piccoli granulj nucleari(S). L'identificazione della proteina di fusione PM L / RARo: tramite RT-PCR nelle cellule leucemiche al momento della diagnosi è una metodica molto specifica che predice nel 100 % dei casi la risposta all ' acido all-trans-reùnoico (ATRA) ccl al triossido di arsenico. Inol tre, a differenza del Lest di immonofluorescenza, la RT-PCR consente di identificare con prrcisio11c il tipo di Lra.sc1iuo ibrido , ciò che è fonclarnemale per la valutazione della rnalatlia residua durante e dopo il trattarnento(6). Numerosi studi di monitoraggio della malattia residua hanno dimostrato che la persistenza molecolare di minime quantità di trascritto durante la remissione morfo logica della LAP è strettamente associato ad un elevato rischio di recidiva clinica. Questi risultati , confermati da numerosi altri stud i , ind icano come i concetti cli remissione molecolare e recidiva molecolare siano fondamenta li nell'approccio terapeutico generale e per anticipare la terapia cli salvataggio nei pazienti con LAP a maggior rischio cli recidiva cmatologia(7).
Oltre a rappresentare dei marcatori spec ifì ci per la diagnosi ed il monitoraggio, le alterazioni geniche delle LMA e, come vedremo in seguito, quelle di alcune SMPC, rappresentano dei marcatori prognostici così come dei potenziali bersag li per una terapia mirata . Nuovi targets molecolari per terapie ant ilcucem iche sono infatti stati identificati recentemente, e prr alcuni cli essi disponiamo di inibitori specifici. Questi includono ad esemp io le mutazioni a ca1ico del recettore di membrana FLT3 (FLT 3-lTD). La presenza di FLT3ITD è associata a prognosi sfavorevo le nelle LMA(8). Inib itori spec ilì cì di FLT3 per la terapia della LMA s0110 attualmente in fase di valmazione in studi cli fase Il e fase llI (Figg 2, 3).
L'importanza della caratterizzazione ge n etica~mo lecolar e è ancora più e ,~d ente nelle SMPC, soprattutro alla lu ce della frequente so\'rnpposizione dei quadri clinici e delle acquisi1.ioni degli ultimi anni(9). Recentemente è stato infatri proposto per ta li disordini un sistema di classificazione semi-mo leco larc(l O) che rico-
noscc 3 vaste categorie: i disordini mieloproliferativi. classici, i disordini mieloproliferativi atipici f' le sindromi mielodosplastiche (MDS). I primi comprendono la policitemia vera (PV), la mieloJìbrosi idiopatica (MFI), la trornbocitemia essenziale (TE) e la leucemia mie Ioide cronica (LM.C). Le forme atipiche includono invece la leucemia mielorno11ocitica cronica (LMMoC), l a leucemia mielomonocitica g i owmile, la leucemia neutrofila cronica, la leucemia basofila cronica, la leucemia cronica eosinofìla/ sindrome ipereosinofila, la mastocitosi sistemica e le forme inclassificabili. Fino ad un anno fa circa, la classificazione iniziale della maggior pane delle SM PC, basata su caratteristiche cliniche e niteri morfologici, presentava foni limiti <liaguosticì pe1- la mancanza di marcatori genetico-moleco lari specifici e per i quad1i clinicolaboratoristici sovrapponibili che ne rendeYano difficile l'inquadramento diagnostico e terapeutico. Infarti , mentre la diagnosi della LMC è stata da tempo semplificata u-amiLe la idenùficazione del cromosoma Philadelphia o del suo corrispettivo molecolare (riarrangiamento BCR-ABL). fino a qualche a11no fa non erano note ,ùterazioni genetico-molecolari che fossero associate in modo consistente alle Sl'vIPC Philadelphianegative. Q1wsta mancanza di conosct"nza ha consf'gnentemente comportaw una scarsa accuratezza diagnostica. un 'incerteua circa la definizione prognostica ed un impiego cli approcci terapeutici non mirati. Negli ultimi 2-3 anni sono stati fatti in questo ambito enormi progressi che hanno aperto un nuovo scenario clinico-terapeutico. Così come la definizione della base molecolare della LMC ha consentito di sviluppare sia metodi diagnostici sofisticati sia farmaci molecolari specifici, quali l' imatinib mesilato, anche le num·e alterazioni sotto descritte delle SMPC Ph-negativc costituiscono già dei validi marcatori per la diagnosi più accurata e presumibilmente diventeranno presto targets per terapie mirate() I ). Un importante tassello per la comprensione dell'eziopatogenesi delle s indromi mieloproliferaLive croniche Philadelphia-negative è stata la scoperta nel 2005 , ad opera s imultan eamente di quattro gruppi di ricercatori, di una mutazione somatica puntiforme a livello del gene Janus Kinase 2 (JAK2). Tale mutazione , che determina ncJla cellula staminale emopoietica un 'ipersensibilità ai \'a1i fattori di cresc ita emopoieLici (stem celi factor, eriu-opoielina, trombopoietina, IL-3 , G-CSF, CM-CSF), con conseguente pro liferaLione trilineare ( eriLrociLi, piasrrine , leu cociti in , ·arie combinaLioni a seconda dei casi) ha
permesso di elaborare un n11ovo inquadramento delle sindromi mieloproliferative croniche secondo algoritmi diagnostico-terapeutici differemi. Utilizzando una PCR allele-specilìca(l 2) è possibile identificai-e la mutaLione JAK2 (V617F) nella PV ( >90 %) . nella TE (50 % ) e nella MF (30 % ) (12-15). La presenza della mutazione del gene JAK2 sembra rivestire 1111 significato particolare anche sotto il profilo prognostico-terapeutico. Per esempio, pazienti con trombocitemia • essenziale positivi per la muta7ione sembrano avere una miglior risposta clinica. anche in tennini cti ridotta incidenza di trombosi arteriose se trattali con idrossiurea piuuosto che con anagrelide ( 16). E. stata inoltre individuata una correlazione u a la mutazione genica V617F e la prognosi della policitemia vera( 17); nel corso di questo studio è stato osservato che un 'elf'vata carica dell'allele mutato è correlata ad alterazioni più
Ctualmulriora
RI.JNX•-<Em m-POGFRB Fl>Dt t-E.Vtl fl13 la-'U'«I RAS C8FB-,$1-
R'J'DtlPQWW mutllCll"I~-
FU3--- HOAC.....,._ F.,,....,.,~IMlb,1.,on
Fig.2
Remissione completa continua per FLT3 (studio GIME MA LAM-99 P)
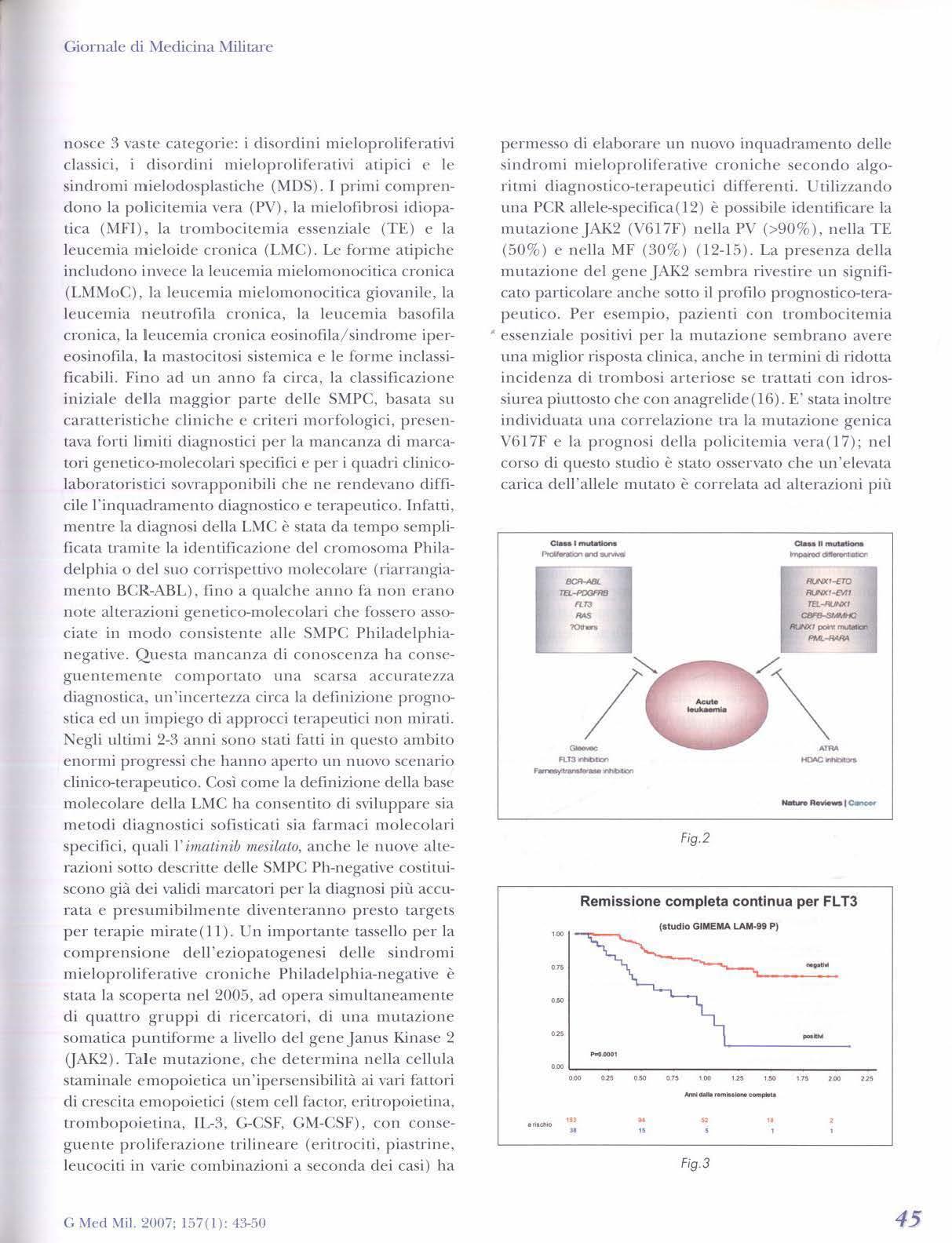
U IO
marcate dei parameu-i ematologici e ad alcuni sintomi, come ingrossamento della milza e prurito.
Un altro esempio cli come l'impiego di metodiche di biologia moleco lare offra un vantaggio addizionale circa la possibile identificazione di alterazione criptiche o sub-microscopiche, è rappresentato dalla scoperta di una alterazione che caratterizza la sindrome ipereosinofila consistente nel riarrangiamenLo FIP ! LI-PDGF Ra a sua volta derivato dalla del(4) (ql2q12), una delezione <li 800 Kb a livello del cromosoma 4ql2(18). La scoperta di questa delezione, non visibile utilizzando tecniche di bandeggio cromosomico. ha permesso di porre una corretta diagnosi avvalendosi cli tecniche di citogenetica molecolare (FISH) e cli b io logia molecolare (RT-PCR). E' importante osservare che in questi pazienti la terapia con imatinib mesi lato si è rivelata estremamente efficace poiché si possono infatLi ottenere remissioni molecolari con dosaggi ridotti rispetto a quelli arti\'i nella LMC(l9).
In conclusione, nel corso· degli ultimi anni la rapida evoluzione delle conoscenze sulla genetica-mo lecolare delle malattie mieloproliferative ha sostanzialmente modificato i criteri diagnostici e la classifìcazione di queste malattie, consemendo inolu·e di S\ilupparc in alcuui ca5i anni terapeutiche specifìc!Je e dunque più efficaci e meno tossiche (LMC, S. ipereosinofìle) (Fig. 4). Nel prossimo futuro, è auspicabile che 1111 ulteriore avanzamento delle acqujsizioni in campo genetico e biologico possa consentire di comprendere più a fondo la patogenesi delle altre sindromi mieloproliferative e il conseguente sviluppo di Lerapie mirate.
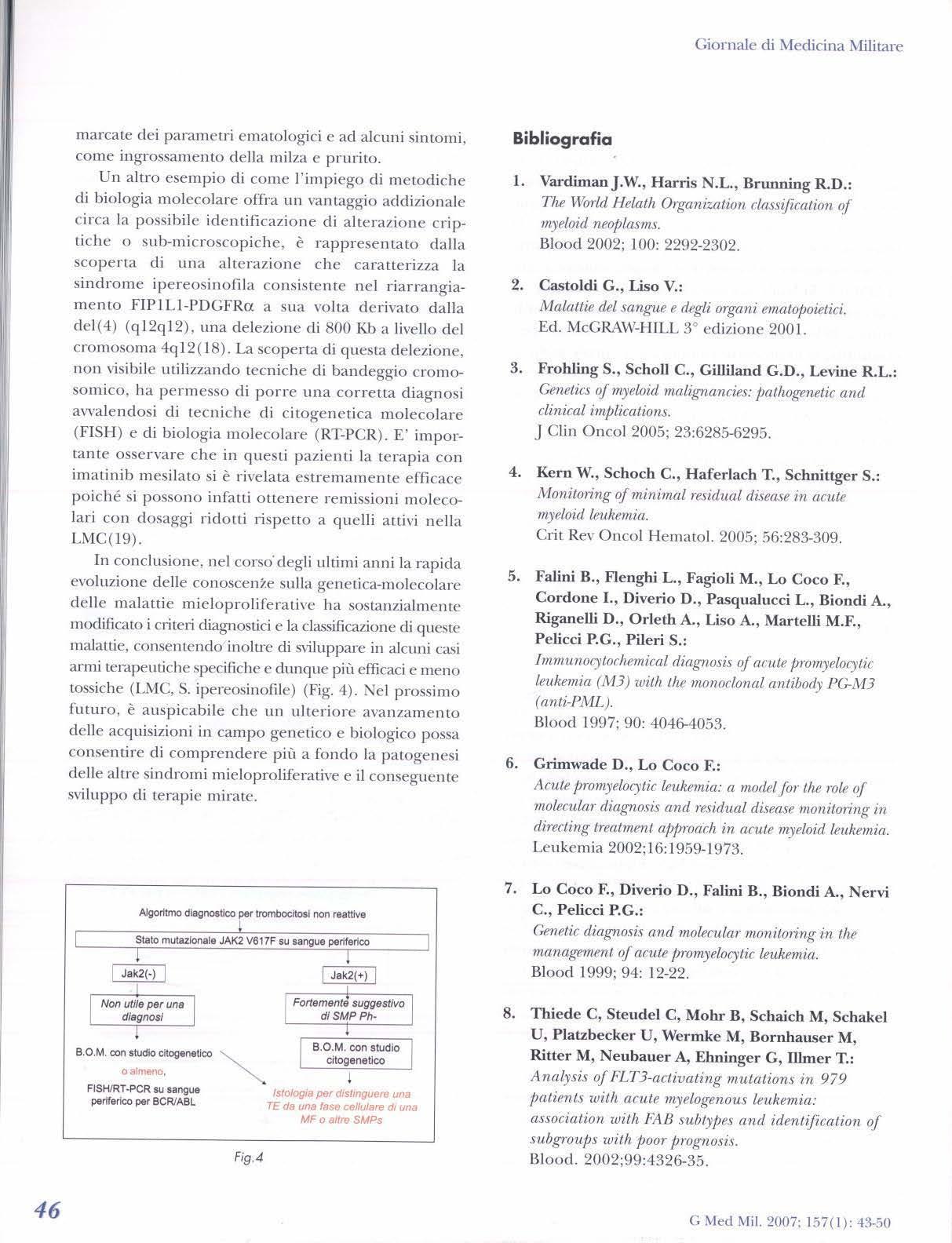
Algoritmo dlagnosUco per trombocltosl non reattive
Stato mutazionale JAK2 V617F su sangue periferico
I Jak2(-) I
Non utile per una diagnosi
B.O.M. con studio citogenetico
Odlmoa-'10, FISH/RT-PCR su sangue periferico per BCR/ABL
I Jak2(+) I
Fortemente suggestivo d/SMPPh·
B.O.M. con studio citogenetico j
lstolog,a por d1stmgume una TE da una /11se ce/1,1/aro <11 una MF o a11ro SMPs
Fig 4
1. VardimanJ. W. , Harris N.L. , Brunning RD. : 17ie World He/ath Organization classifiration of mydoid neoplasm, Blood 2002; 100: 2292-2302.
2 . Castolcli G. , Liso V.: Malattie del sangue e degli organi emalopoietiri. Ed McGRAW-HfLL 3 ° edizione 200 I.
3 . Frohlin g S., SchoJJ C ., GiJJiland G .D. , Levine R. L.: Cenelics of myeloùl maligncmcies: pathogenetir and clinica[ implications. J Clin Onco! 2005; 23:6285-6295.
4 . Kern W. , Scho ch C . , H aferlac h T. , Sc hnittger S.: Monitoring of minimal residuai dùease in acute myeloid leukemia.
Crit Rev Onco! Hematol. 2005; 56:283-309.
5 . F alini B. , Flen g hi L. , Fagio li M ., Lo Coco F. , Co rdone I. , Dive rio D ., P asqualucci L. , B io ndi A., Rig an e lli D ., O rle th A., Liso A ., Mar te lli M .F. , P elicci P.G . , Pileri S . : hnmunocytorlumiical diagnosis of arult' fJromyPlorytic leukemia (MJ) with lhe monoclonal antibody PG-M3 (rmti-P1'v1L).
Blood 1997; 90: 4046-4053.
6. Grimw ade D ., L o C o co F.:
Acute promyelocytic le11kemia: a model Jor lhe rote of molRculrir diagnosis and residuai diseasP tnonitoring in directing trentment approach in acute myeloid /euliemia. Leukemia 2002; 16: 1959-1973.
7. L o Co co F. , Diveri.o D. , Falini B. , Biondi A ., N ervi C., Peli cci P. G .:
Genetic diagnosis ancl molernlar monitoring in the management of aculP fmJmyelocytic /eukemia.
Blood 1999; 94: 12-22.
8. Thie d e C, Ste ude l C, Mo br B , Schai ch M , Schake l U , P latzbec ke r U, Werm.ke M, Bornhauser M, Ritte r M, Neubauer A , Ehninge r G, Illme r T.:
Analysis of FLTJ-act.ivating mutations in 979 jJatienls wilh acu/.e myelogenous leukemia: association with FA.B subtypPs ancl identification of subgroups with poor prognosis. Blood. 2002;99:4326-35.
9. Michiels J.J.: Clinica[, fmlhologiral and mo/ecularfeatures of the chronic myefo/1rolifnative disorders: A1PD 2005 and beyond.
H emaco l ogy. 200:'i: I O Suppl 1:215-223.
10. Tefferi A. , Gilliland G.: Classifìcation of r!tronir myeloid disorders: /rom Darneshek lowards a semi-mol,ecular .systnn.
Bcst Pract Rcs Clin H aematol. 2006; 19: 365-38:'i.
ll. CampbeU P.J., Green A.R.: The mye!oprolifrroti11e disordns.
N Engl J Med. 2006;355 :2452-2466.
12. Baxter E.J., Scott L.M., Campbell P.J., East C., Fourouclas N., Swanton S., Vassiliou G.S., Bench A.J., Boyd E.M., Curtin N., Scott M.A. , Erber W.N., Green A.R.:
Acquired mutation of /fu, tyrosine kinase.fAK.2 in lwman myr!oprolifemtive disorders.
Lancet. 2005;365: 10!54-106 L
13.James C., Ugo V. , Le CouedicJ.P., StaerkJ., Delhommeau F., Lacout C. et al. ( 2005):
A unique clonai JAK2 mutation leading lo costitutive signalling causes polycy th aemia vera. Nat:ure 434:ll44-l l48.
14. Kralovics R. , Passamonti F. , Buser A.S., Teo S.S., Tiedt R., PasswegJ.R. et al . (2005): A gain -ofjunction mula lion ofJAK2 in myelo/Jroliferativr' disorders.
N EnglJ Med 352 :l 7i9-1790.

15. Levine R.L. , Wadleigh M., Coolsj., Ebert B .L. , Wernig G . , Huntly B.J. et al. (2005):
Aclivating mulalion in lhe tyrosine kinase JAK2 in po(vcylhemia vn-a, essmtial thrombocythemia, and myeloid metaplasia wilh myelofibrosis.
Cancer Ce li 7:387- 397.
16. Campbell P.J., Scott L.M., Buck G. , Wheatley K, East C.L., MarsdenJ.T., Duffy A. , Boyd E .M. , Bench A.J., Scott M.A., Vassiliou G.S . , Milligan D.W., Smith S .R., Erber W.N. , Bareford D., Willtins B.S., Reilly J.T., Harrison C.N., Green A .R.: Unitfd Kingdom lHye!,opmliferative Disorders Sl.ully GrrtujJ; iHedical Research Council Adult IRukaemia Working Party; Australnsian Le11kaemia and Lymphoma Oroup Definition of subtypes of essentiaf lhrombocythaemia and rel,atio11 to poZ.'icythaemia vera basecl onJAK.2 V617F mutation slatus: a prosj1eclive study.
L ancet. 200.~ D ee ~;%6: 1945- 1953.
17. Vannucchi A.M., Ba.rosi G., Rambaldi A., Marchioli R. , Barbui T.: Clinical si6rniji.crmce ojJA K2 V617F homozygosily in the rhronir myeloproliferative disorders, A study 011 1306 /Jati en ls.
Blood 2006; I 08: l 99a.
18. CoolsJ., Stover E.H., Gilliland D.G.: DetPction o/FlPlLJ-PDGFRA in idiojJathic l~~pereosinophilic sindrome and e/ironie eosinophilit l,eucemia
Methods Mol Med 206; 125 : 177-1 87.
19. Gotlib J., Cross N.C. , Gilliland D.G.: Fosinoj1hilir disorders: mo/.ecular f1atlwgenesis, new rlassification, and modern therapy.
Besl Pract R es Clin Ha e matol 2006:19:535-569
Myeloproliferative disea~es (MPD) includ e a group of hematologic diseascs characte1izecl by anomalou~ prolifcration of onc or more myeloid lineages of the hematopoietic system. T11e WHO (World Hcalth Organization) classification systcrn includes among Lhe MPD the acute ffi}'Cloid leukemias (AM I. ). myelodysplastic syndromes (MDS) and chronic myeloproliferativc syndromcs (GMPD) accorcling to morphologic , im munophenotypic and cytogenetic ce l i characteristics(l) AMLs are character i zed by a maturation defect which results in impairment of eithcr proliferation and differemiation leading to the expansion of the leukemic clone. MDS are a heterogcneous group of diseases mainly featurecl by a maltlration impairment of one or more hematopoietic lineages with co n seq ucnr ineffi cie nt hematopoie sis of variable degree. Finally, CMPD are c h aracterizcd by expansion of h ypep r oliferating cclls maintaining their differentiative potential (2).
The genetic a lterations causing the transformation of m ye loid c<> ll s resulr from c h romosomc aberrations or s u btle gene mutations; those identifiablc by karyotypic anal ysis may be numerica! (e.g. trisomies, monosomies) or st.rnctural (e.g. translocaLions. insertions) lesions and are detec table not only by conve nti onal cytogenetics but also rhrough in situ hybridi zation Lechniques (FI SH ) offer in g the advantage of analyz in g interphase cc ll s . In the past years. investigatio11 on gene tic abcrrat ions of MPD has hacl r emarkab l e imp act in th c clinics(3). I n particular, the adve nt of molccu lar biology techniques has a ll owcd to precisely identify the genctic alterations underl y i ng cytogcnet ic aberra ti o 11s, th rou gh dire et analysis of mRNA or D NA using RT- PCR and PCR respectivel y. The use of thcsc techniques pcrmits on the one hanrl rhe identification of gene al t erations in cases where cycoge ncrics fai ls or revea ls apparently normai karyotype; on che other hand the y allow to cletcct c r y ptic or subm icroscopic a l terations which a r e not id e ntificd upon convcntiona l karyoryping.
Francesco Lo Coco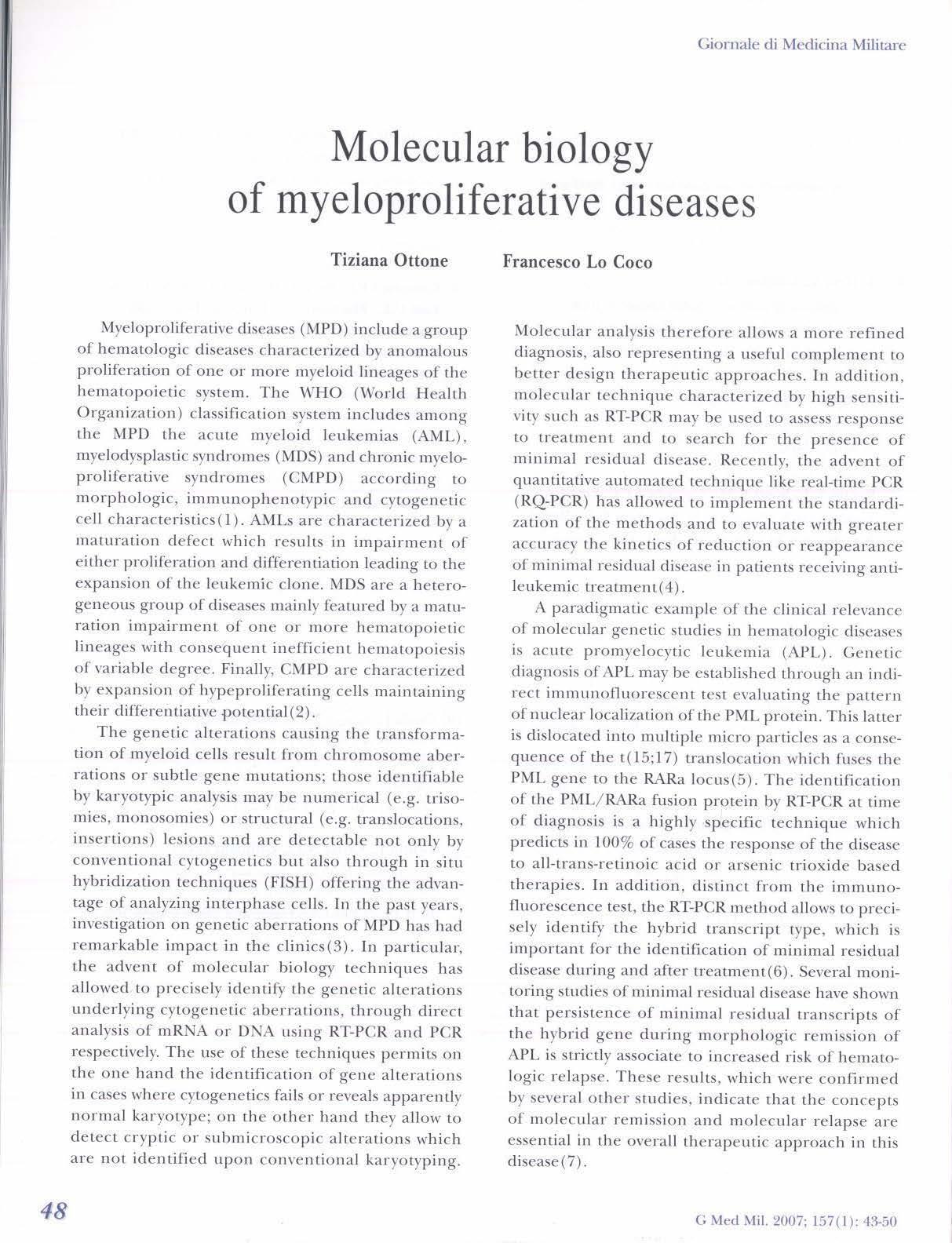
Molecular analysis therefore allows a more refined diagnos is. also representing a useful complemern LO beuer design therapeutic approaches. In adcl iti on, rnolecular tec hnique characterized by high sensitivity such as RT-P C R may be nsecl to assess response to treatmcnt and LO search for the presence of minimal residuai disease. Rece11tly, the advent of quantitative automated fechnique li k<> real-time PCR ( RQ-PCR) has allowerl lo implement the standard italion of the methods and to evaluate with greater accuracy the kine ri cs of recluct ion or rcappearance ofm ini mal residua i disease in patients receiving antilcukemic treannent(4) .
A paradigmatic example of the clinica! releva11ce of molccu lar genetic stuclies in hematologi c discases is acute promyelocytic leukemia (AYL). Genetic diagnosis of APL may be established through an indirect immunofluor escent test evalua ting the pattern of n uclear localization of th e P\1 L protein. This laller is dislocated into mllltiple micro particles as a consequence of the L(15;17) translocation which fuscs the P\.1.L gene to the RARa locus(5). The identification of the PML/ RA Ra fusion protein by RT-P C R a r time of diagnosis is a highl y specific techniqu e which predicts in 100% of cases th e respons e of the clisease ro a ll- trans-rctinoic acid or arsenic trioxide based cherapies. In aclditio n , rlistinct from the im muuon uorescence test, the RT-PCR mcthod al lows LO prccise ly identify the hybrid transcript ty pe , wh i ch is impo rtant for th e id enr ifì ca tion of minimal residua i disease during and after treatment(6). Seve r a ! monito1ing studies of minimal residuai clisease have s h own that persistencc of minimal residua} transc ripts of th e h ybricl gene during morphologic remission of AP L is st.rictly associate to incr ease d risk of h em aLOlogic relapse. These results, which were co nfirm e d b y seve ra! other studies, indi ca re that the concepts of molecul ar rern ission ancl molecu lar relapse are cssen ti al i11 the overa ll th erapeutic approac h i 11 this di sease(7).

Beside representing specific markcrs for disease diagnosis and moniw1-ing, genetic alrcrations of A\1L and those of some CMPD reprcsent imponanl progno-sLic inclicators as wcll as potential targets for tailored therapy. Nove! molecnlar target.~ for anLileukemic trealment havc been recently iclenrilìed and, in some instan ccs, there are already available spccific inhibitors. These inclncle, for example, ù1c mutaLions affecLing the membrane receptor FLT3 (FLT3-ITD). The presence of thi s lcsion is associateci wit h unfavorable outcome in AM L (8). Specific FLT3 inhibiwrs far the treatrnenl of AML are currently being evaluatecl in phase il and phase 111 stndies.
Thc importance ofgene tic characteliLation is becorning even more evident in CM.PD, particularly in light of the frequent overlapping of clinica! picturcs ancl consideri ng the discoverics of most recen t years (9). Recently, a semi-molecu lar classification of these clisorders has been proposed(JO) which identilìes 3 large groups: classic C'vl PD , atyp ical CMPD and MDS. Classic CMPD cornprise P olycythemia Vera (PV) Jdiopathic Myelofìbrosis (IMF) Essential Thromb ocyLhcmia (ET) and Chronic Myeloid Leukcmia (CML). Atypical forms include Cronìc Myelomonocytic Leukemia (CMMoL ) .Juvenile Myelomonocytic L eukemia (JCML), Chronic Neutrophilic Leukemia, Chronic Basophilic Leukemia, Chronic Eosinophilic Leukcmia/ Hypereosinophilic Syndrome (CEL/HES). Systernic \1 astocytosis and unclassified fo rrn s Unti! 2005, the inicial classification of most CMPD was based on c linica! ancl morphologi c fcatures thus preseming .severa! Jimits due to thc lac k of specilìc geneti, markers and in li g ht of che overlapping clinica! featurcs. In fact, while CML diagnosis was long since exemplified throngh the identification of Philadelphia chromosome or its rnolecnlar counterpart BCRABL, up LO few )'Car ago no other molecular lcsion cons istently associateci to the Ph-ncgativc CMPD were known. This lack of knowlcdge has inevitably led Lo inaccuracy iu diagnosis, uncertainly in prognostic assessmcnt and to th e nse or non tailored therapies. The past 2 years have witnessed enormous progress in ùiis filed which has opened a new scenario both in the classification and in the therapeutic area Like it has occurred in th e case of CML, where tbc defi11ition of its molecular basis has allowed to dcvelop specific molccular rJierapies such imatinib mesylate, the newly identified a lterations of Ph-n egative C MPD alrcady represent important diagnostic markers and
will likely becornc in the near fut11re the targets of specific treaunent( 11). An important advance in our understanding of the pathogenesis of Ph-negative CMPD has been the discovery in 2005 of a somatic mutation of in thejanus Kinase 2 (JAh.2). Such mutation, which ,-esults in the affected cell in hypersensitivity to hematopoietic growth factors (stcm celi fac:t01~ erythropoietin, thrombopoictin, TL-3, G-CSF, GMCSF) with consequcnt trilineage proliferation. has àllowed LO elaborate a new c lassifìcation of CMPD following differe111 diagnostic-therapeutic algorithms. Csing an allele-specifì, PCR it is possible to promptly identify rhe V617F mutation in theJAK.2 gene in >90 % of PV. 50 % of ET ancl 30 % of IMF approxirnatelr( 12l :5). The p1·esence of thc .JAK2 mutatio11 also appcars to have a clinico-prognostic significance. For example, patients with .JAK2 positive ET ~eem to haw a better clinica! response with rerluce thrombotic episodes after treatment wiLh hydroxyHrea( 16). l n addition, a correlation has been rlesc:ribecl between the V617F mutation and the prognosis of PV(l 7); in Lhis study. an elemterl load or the V617F mutated ailele was correlar ed to more severe clinica! altcrations such as splenoniegal}' and pruritus.
Another exampk 011 how the use of molecular techniques pro\"ides the identifìcation or c-rypt.ic or submicroscop ic a l terations is represen ceci by the discovery of the FIP IL 1-POGFRA clerived from an 800kb imersti ri a l chromosome 4q de letion which is associateti to hypeosinophilic syndrome(l8). The discovery of this dele1 ion wh icb is noL dctcctable using conventional karyot)tping has allowcd to diaE:,TJ1ose ùiis a lteration by FlSH and RT-PCR techniques. lt is remarkable that in thcsc patients the use of im atin ib mesylate shows high efficacy a ll m1•ing to obtain clinica! and molecular response with lower doses as compared to ù1ose used for CML(l9).
In conclusion, aver ù1c past few years, tl1c advance in our knowleclge of molccular pathogenesis of myeloproliferative diseases has substantia ll y modified the diagnostic criteria and the classi.ficatio11 of rh ese clisordcrs. This has allowed in some instances the de\'elopment of specific therapies which are at ùie same time more effic icnt and less toxic (CML, H.ES). In tbc ncar future, it is foresee11 that additional progress in the genetics ami biology of these disease wi ll lead ro better understanding or the paù1ogencsis of the other myeloproliferative syndromcs and to th e consequent developrnent of tailored treatments.
Centro Internazionale
Studi Medicina Oloenergetica®
Repubblica di San Marino
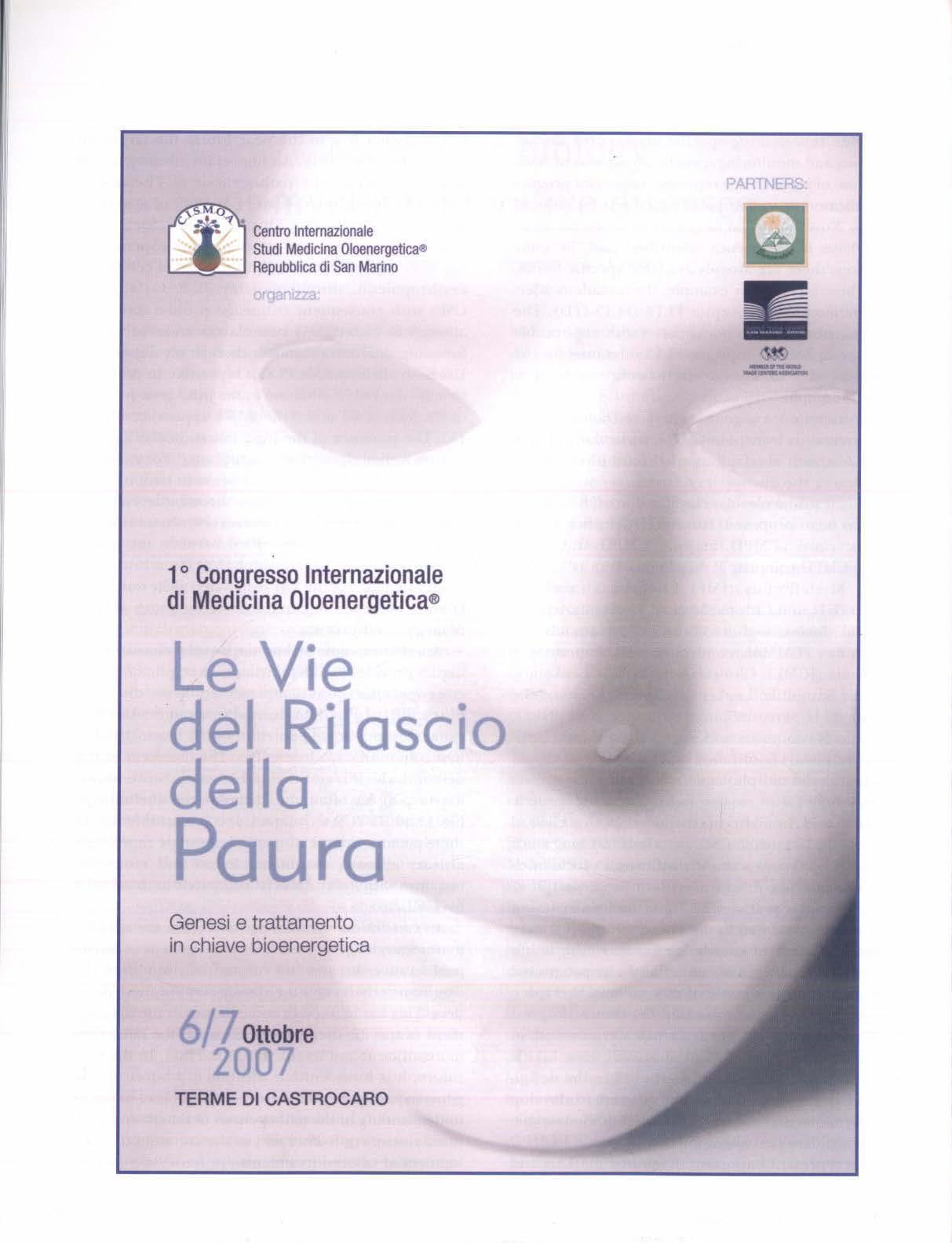
1° Congresso Internazionale di Medicina Oloenergetica®
Genesi e trattamento in chiave bioenergetica 6/7 Ottobre 2
TERME DI CASTROCARO
PARTNE:RS
*
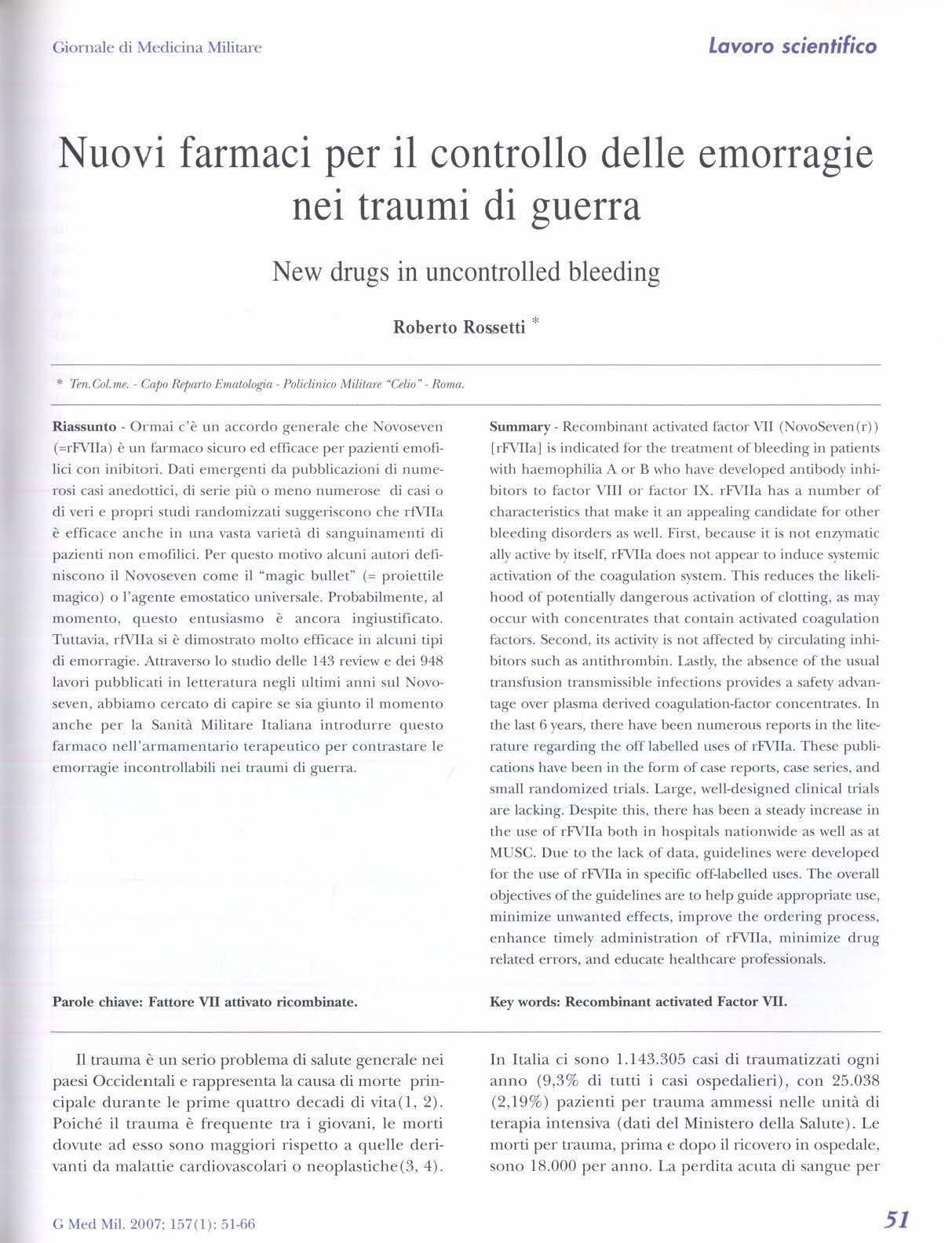
* Tf'/1. Col. me. - Caj>o Repwro Ematologia - f'oliclinico Militare ··c.,1io " - Roma.
Ri assun to - Ormai c'è un accordo genera le che Novosevcn (=rFVUa) è un farmaco sicuro ed efficace per paziemi emolìlici con inibitori. Dati emergemi da pubblica1.ioni di numerosi casi anedott.ici, di serie più o meno numerose di casi o di veri e propri studi randomizzali suggeriscono che dVria è efficace anche in una vasta varietà di sangu inamenti di pazienti non cmoli lici Per questo moriYo alcuni autori definiscono il Novoseven come il "magie bullet" (= proiettile magico) o J'ageme emostatico universale. Probabilmente, al momento, questo entusiasmo è ancora ingiustificato Tutlavia, rMia si è dimostrato molto efficace in alcuni tipi di emorragie. Attraverso lo studio delle 14~ review e dei 948 lavori pubb licati in letteratura negli ultimi anni sul Novoseven. abbiamo cercato di capire se sia giunto il momento anche per la Sanità Militare Italiana introdurre quesw farmaco nell'armamentario terapeutico per contrastare le emorragie incomrollabili nei traumi di guerra
Surum ary - Rccombinant activatccl factor YII (NovoSeve n (r)) [rF\11aj is indicaccd for the tream1ent ofb leeding in patients with haemophil ia A or B who have developed antibocly inhibiLOr.~ LO factor Vlll or factor IX. rF\7Ila has a munber of ch.u-acteristic~ thal make il an appealing candidate for other bleeding dism·ders as we l l. Fi1·st, hecaus e it is not enzymatic a lly active by itself, rFVI Ia docs 1101 appcar to induce sysr.emic activation or rhe coagulation systcm. This reduccs thc Iikclihood or potcntially dangerous ac tirntion of cloning. as may occur with concentrates thaL contain activated coagulation factors. Second. its act.ivity is not affected by circuJating inhibitors such as a11tithromb i n. Lastly. the absence of the usual transfus ion transmissible infcctions provides a safety aclvantage ovcr plasma dcrivcd coagulation-facror concenb·ates. In ù1c lasr 6 years, there have been numerous reports in the l ircrarnre regarding ù1e off labelled uses of rFVlla. These publicatiom have been in the fonn of case reports, case series. and small randomiLecl rria ls. Large, well-desig11ed clinica! trials are lacking. Despite this, ù1ere has been a st eady increase in thc use of rF\' Jl a both in hospital s nationwide as well as at MUSC. Due LO thc lack of data, guide l ines werc developed for the use of rFVIla in speci.fic off-labellecl uses. The overa.11 objeclives of the guidelines are LO help guide appropriate use, minimize unwamed effects, improve ù1e ordering process, enhance time ly admin istration of rFVIla, minim ize drug rel ateci errors. and ed u cate heahhcare professionals
Paro le chi ave: Fa u orc VIl attivato ricombinate.
Il trauma è un serio prob lema di salu te generale nei paesi Occ idental i e rappresenta la causa di morte princ i palc durante le prime quattro decadi di vita(l, 2).
Poiché il trau m a è frequente u·a i g i ovan i, l e morti dovute ad esso sono maggiori rispetto a que ll e clerivan ti da malalti e cardiovascolari o neoplastiche (3, 4).
Key words: R ecombinant ae tivate d Factor VII.
I n Italia ci sono 1. 143 305 casi di traumatizzati ogni anno (9,3% d i nmi i casi ospedalieri), con 25.038 (2, 19%) paz ienti per trauma ammessi nelle unità di terap ia intensiva (dati de l Min istero de lla Sa l u te). Le morti per trauma, prima e dopo il ricovero i n ospedale, so n o 18 000 per a n no La perdita acuta cli sangue per
trauma è la principale causa di morte immediata o iuiziale(5, 6, 7, 8). In uno studio di autopsie su 255 morti consecutive per trauma, l'emorragia, da sola o abbinata ad un grave trauma cranico, era la causa di morte nel 79 % dei casi (9). Signilìcativamente, molte cli queste morti sono awenute durame le prime fasi di cure pre-ospcdaliere. Il tempo intercorso txa il u·aurna e la morte era meno cli un ' ora nel 66,5 % dei casi e da 1 a 6 ore nel 24,6 % Nei paesi europe i le cause di morte dovute a rraumi sono da attribuire principalmente ai traumi pelvici, alle fratture con pNrlita di tessuto e ai traumi addominali. I progressi nella cura del trauma si sono ouenuti con il sistema rapido di trasporto. larianimazione , la correzione dell'ipotensione, le stTategie di controllo del danno con la chirurgia d'emergenza e le procedme di embolizzaaione angiografica Tuuavia, l'instabilità emodinamica spesso richiede l'infusione di soluzioni co ll oid i e ciistalloidi e la n-asfusione di emazie concentrate che portano alla diluizione e al consumo
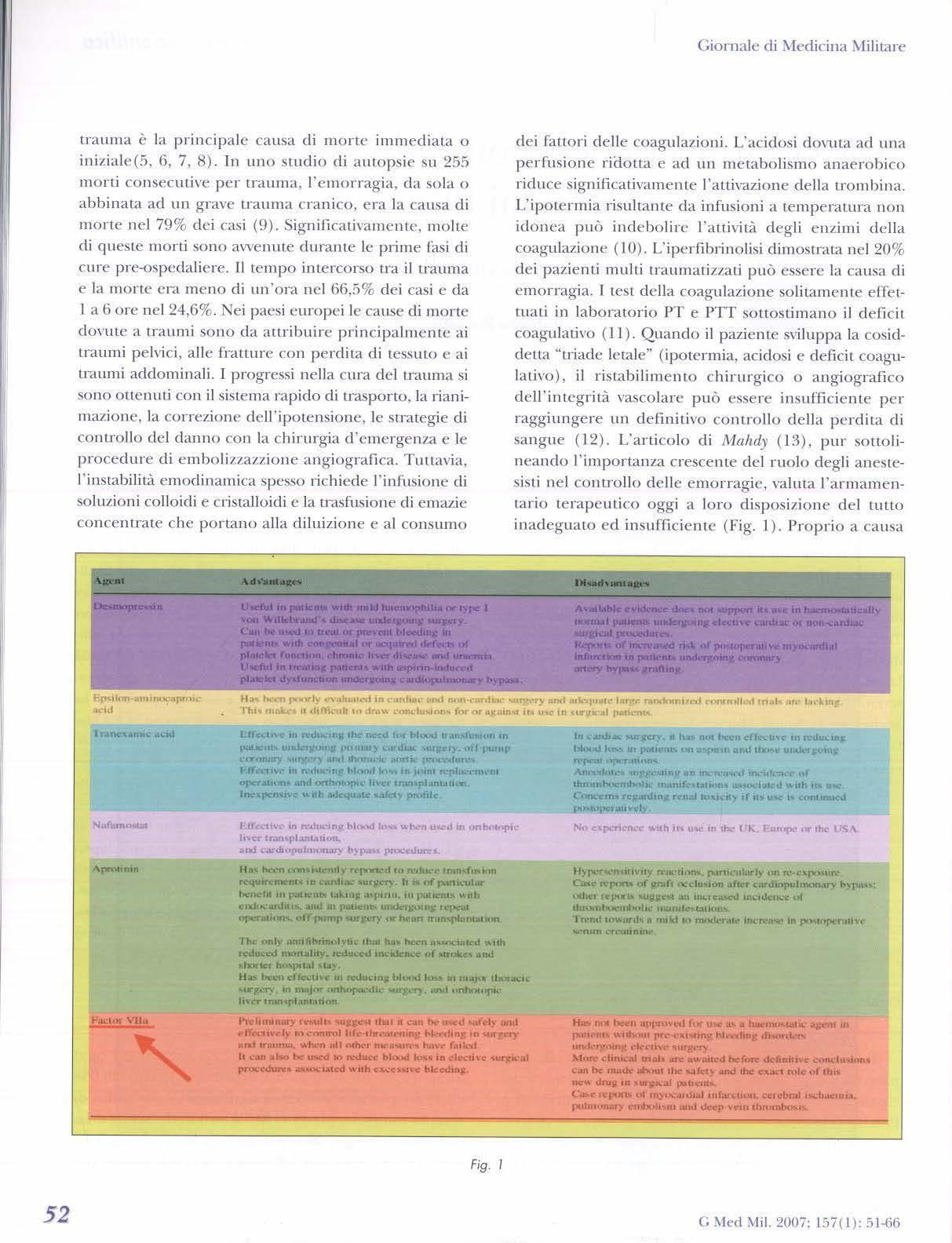
A.,......mn
LI~ I I"" KI UT• l « hl ,,rcr '""'i'L' qu i., •ruc:t~ p,uftlc
I ft ctt\. in n:.duc1n,- hlill~ .,,,"'lii. "Mn o~ In ,mtwcnri la"" lrM11pl.m1.,u~ Am.1 c udl(•puJ 1 onM) h\J p1~cùu1t!t
H•"' hot'ft ,~wuMlcnrly rC'p'Wled ,,.. l\"l.tt.k.•t- lnand.-km rc,qultt1l1em• In .-.n1,.,. ""'{lff)' h ,. of ptttk.-ulr t~ne·ld m pal~nb tà.tn, m.ptrau In pouenb. ~ilh .,,.;1.,,,anla -. lWd •• put1c11111 w..S..ri:0111$ r.,,...a _..ikllh, olTpnmp ourgc,ry or tr111L<J'llant1111un
Tlw: -1y 11ntlftlwia,,lylic lhot ha> hccn p~.,,aalrd 1aluced monahty. acdu,,.,J indtJc1M;è of 111rm<e1 •ll<I •,-In hu,pllal lay.
dei fauori delle coagulazioni. L'acidosi dovuta ad una perfusione ridotta e ad un metabolismo anaerobico riduce significativamente l'attivazion e della trombina. L'ipotermia risultante da infusioni a temperatura non idonea può indebolire l'attivi1à degli enzimi della coa1:,'lllazione (10 ) . L ' iperfi.brinolisi dimostrata nel 20 % dei pazienti multi traumatizzali può essere la causa di emorragia. I test della coagulazione solitamen1e effe ttuali in laboratorio PT e PTT sottostimano il deficit coagulativo ( 11 ) Quando il paziente sviluppa La cosiddetta "ttiade letale" (ipotennia, acidosi e deficit coagulativo) , il ristabilimento chirurgico o angiografico dell'integrità vascolare può essere insufficiente pe1raggiungere un definitivo controllo della perdita cli sangue (12). L ' articolo di Mahdy ( 13), pur sottolineando l'importanza crescente del ruol o degli anestesisti nel controllo de ll e emorragie, va luta l ' armamentario terapeutico oggi a loro cfoposizione del tutto inadeguato ed insufficiente (Fig. I) P roprio a causa I.C ,,r I I J "1Uh I uun un ltm..."Cffl\t'C" UIJ.C I 4.'(lflltnucJ 1~ h.JJ,CJ&IU\o~I l'/, Uf'Crten ,: "' 1h lr, """ tn 11>c, liii. r n,r,c ,.,. 1h, l'l<il\ H)r,.T...,, nlvuy ,.....,r1...,. ('llrtl<'1lflrly ,m l'l" ,,.,,....in, O.. n,ructo <>f' pfl .-..:du ton afcn cardli>J'Uhnoft4l'JI b,t>"••• ud~ rcp b ""IIJn& an llk.rr.ùCJ t~uktll:c ul thnxnlroenrl'<•l1< 11111nilc tatk" Tttnd ndkl"' mnd<'ntk" tnc ..,.,.., In rt<l,-r<'fllllV( 'il"Nffl ctC'aflftffl,r
H;u. bectl dre..""t,~C ua n:ducans t,lood h.>u •• "''Il'• tb&•aat< ....-g,-.v In majnr ""hòpa.,dl.c ""1! 't) nnd 11nhot,,p. 1t,,;~hlf' Vllu u...CT' arm,tp111111nrinn
Pn,bnrl11111y •~h 'WJ:l:è'\O thot u """ t..- d "'11cly canJ fftcuv~ I)' to cnnnul hfl-· t hr •rn nt: hl...~h n n -c.ur ny
•r.t tr111mia.. v.fk."11 nll otl'k'r n.r.: -.1arr-1 MVII"' fAtk"it h c<1n •'"" h: an ""1utc! bl"';J lu,;• tn l«thc <urg..-nl pn.1'.""<dun:• .n~1a1tcd ""h c.li,,\,;cJw,--c bk'cdin.$
I
Hll>i , tt.,.,n DJ~'l'tlH'd rur'"" ,., " """"'°""'"' iq;enl n pu1rn1 \\lrho II l'f~hnn i,1.,...,1111 dt,wmJ."' 11'1<1'"1)'!<>111 Murh"<" ""'F.''f} .t.lon, clink:al mlii., .att IIWIUted hc-(un, Jcftairlvc ('OndllllflM ~"" hc nw<k ah,ut lhe ulet) and ltr CUCI rote ,lf Utd """ dt'Ujl ID >1trj111<ul pa!tttllf,, (,~~ Rl,.Xl>: ul nl,),~41Jut.l u1fa, 1.:lU..lll. C'CJl:'br.d as....~JULI pullHORAry I: ,.JllJll IU w1J Jc...-p \\UII lhrucnl'tf,,;a
ili questa frustrazione gli auton s1 sono concentrati negli ullirni anni sul Novoseven (fattore VII attivato ricombinante o rFVIla ) utilizzato prevalentemente, come vedremo , nei pazienti emofilici con a lto titolo di inibitori. Il fattore VII natirn è un a proteina di 50 k.Da vita mina K dipendente prodotta dal fegato, e so lo l'J % del fauore VII c irco la nella fonna attivata. La sua emivita è di 2.5 ore (Fig 2). Il fattore VII attivato ricombinante è prodouo da un 'azie nd a danese e si trova in commercio con il nome di Novoseven o Niastase. La molecola di base si ch iam a Eptacog Alpha. Viene prodotto in fiale da 1.2 mg pa,i a 60.000 unità f'd il costo medio per il trattamento di un paziente adu lto è di circa 5.000 - 7.000 S. Il meccanismo d'azione del Novoseven è rappresentato in maniera schematica nelle figure 2, 3 e 4. Essenzialmente rFVJia s i lega al fattore tessutale, in maniera ciel tutto esclusiva nel sito del danno vascolare causa dell'emorragia, aumentanclo, nella fase iniziale, la produzione di modica
quantità di trombina che conduce all"auiva1ione piastrinica. Questo primo meccanismo è fattore tessutale dipendente. Sulla parete delle piastrine auivate rFVIla contribuisce ad attivare il fattore X. Questo meccanismo, che è fauore tessntale indipendente, porta alla produzione di grandi qnanrirà di trombina ("burst" trorn bi nico). li coagulo che si forma è paruco la rmente resistente ("super clot'') perché rFVIIa è in grado di attivare l'inibitore della fibrinolisi T.A.F.I •( Lhrombi n-activarable fibrinolysis inh ibitor) (Fig. 4).
Alcun i esperimenr i rli 'vfonroe pubblicati sul British Journal of Haematology nel l99ì hanno confermato che il rFVIIa agisce esclus i vame n te sulle piastrine attivate e la sua atione è inibita clall"acidosi ma 11011 ùall'iporermia (Fig. 5) (]4).
La frnsrrazionc dei medici, che si occupano della traumatologia, ha fatto sì che negli ultimi dieci anni sia stata pubblicata in letteraLUra una notevole quantità di lavori sull'utilizzo del rFVIla. lnfaui, da una
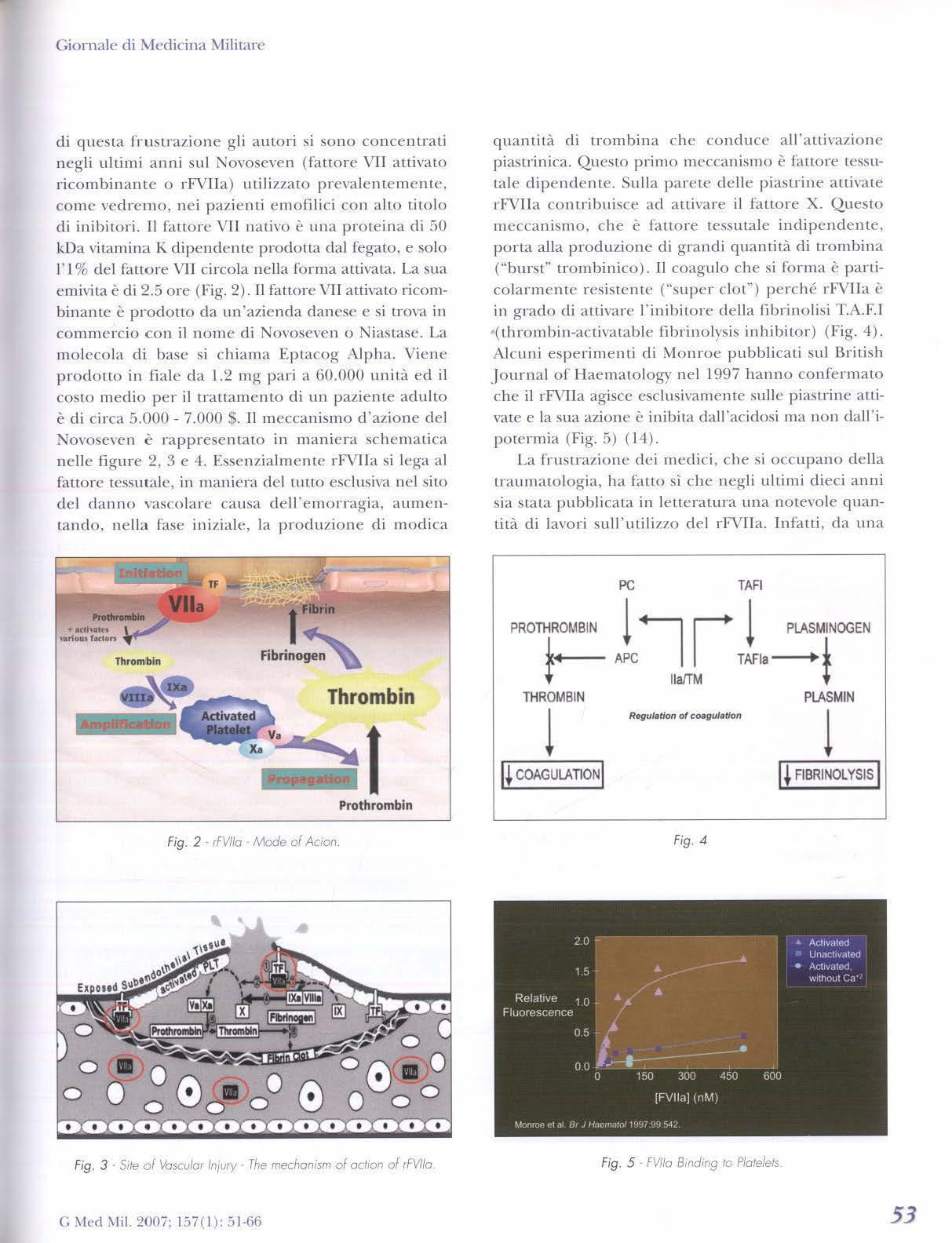
PROTHROMBIN
PC TAFI
!7 r !
PLASMINOGEN
APC TAFla --+ i
lla/TM
THROMBIN PLASMIN
Regulation of coagulatlon
I+COAGULATION I
FIBRINOLYSIS I
4
ricerca che abbiamo effettuato alla fine del ITIC'SC di dicembre del 2006 Ml "pubmed", risultano pubblicati 948 larnri e 163 review 1iguarclanti il rF\'Ila. Il primo lavoro sull'rFVIIa è stato pubblicato da Ula Iledner nel Hl83 e de5crivc\'a l'utilizzo ciel nuoYo farmaco in due paLienti affetti da emofìlia complicata dalla prci.cnza di inibitoti ad alto titolo con emorragia grave. Il primo pa1i<:>nte prt>senta\'a un sanguinamento ma!>!,i\'O a li\'cllo del muscolo gastrocnemio che coim olge\a il ginocchio. l i !,econdo sanguin.wa copiosamente dopo l'e!,traL.io1w di due molari nonostante il trattamento con acido trancxamico. Entrambi furono trattati e guariti con l'urilino del Novoscvcn. Questi rii,ultati, benché preliminari, aprirono la strada a ll 'uso del r f VTia come agente "b\'•passaute" nell'emofìlia complicata da inibitori ad alto titolo ( 15). Il primo ca~o di utilizzo del Novoscven fuori indicazione, nel 111onclo, è :.Lato pubblicato '>ll Lancet nel 1999 da Ciii Kenel. Cn
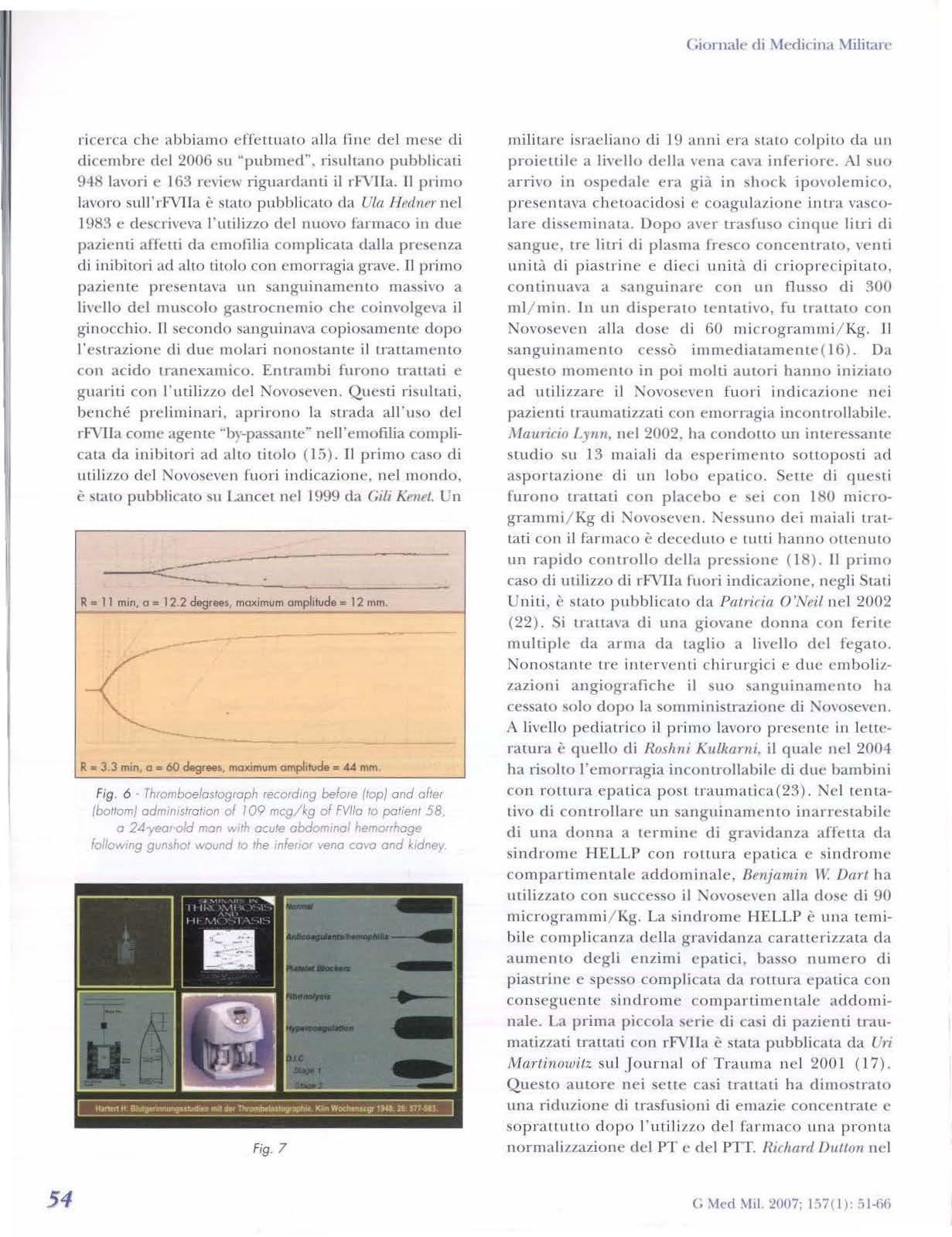
R • 1 1 min, o., 12.2 degree1, moxim1.1m omplitude = 12 mm -------j
(R• 3 3 min o • 60 degn,.,., maximum ompltrude =44 mm
Fig. 6 · Thromboelastogroph recording be fore {top) o nd ofter {bo1tom/ administrotion o/ I 09 mc9/kg of FVJ/o lo polient 58, o 24-yeor·old man v,,ilh ocure obdominol hemorrhoge folfowing guns1I01 wound ro the infer,or veno covo ond k,dney
mi litare israeliano di 19 anni era stato co lpito da un proiettile a li\'ello della , cna ca\'a inferiore. Al suo arrirn in ospedale era già in shod. ipO\olemico, presentava chetoacidosi e coagula1ione inlra vascolare cli~~eminata. Dopo a\ er tra:.fuso cinque litri di ~anguc, ire litri di plasma fresco concentrato, n~nti unità di piastrine e dieci unità cli cr i oprccipitaro, conti11ua\'a a sanguinare con un flusso di 300 ml / min. In un di!>perato tcntati,o, fu trattato con N0Yoseve11 alla dose cli 60 microgramllli / Kg. Il sanguinamento cessò imrnecliatamentc(lfi) Da questo momento in poi molti auwri hanno ini1iato ad utilizzare il Novoseven fuori indicazione nei pazienti traumatillali con emorragia incon1ro!labilc. Mauriri o l ,pm, nel 2002, ha condotto un interessante Sllldio su 13 nrniali da esperimento sottopos t i ad aspona,ione di un lobo epatico. Sette di questi furono trattati con pla c ebo e \Ci con 180 microgrammi / Kg cli Novose,cn Nessuno dei 111aiali trailat i con il farmaco è deceduto e tutti hanno ottenuto un rapido controllo c(('lla pressione (l8). Il primo caso cli utiliuo di rFVIla fuori indica,ione, negli Stati Unit i , P stato pubblicato da Palriria O'Neil ne l 2002 (22 ) . Si t ratta\'a di una giO\ ane donna c o11 ferit e multiple da arma da taglio a li\'cllo ciel fegato. Nonostante tre interventi chirurg-ici e due cmbo l izLazioni ang iografìche il suo s,mguinanwnto ha cessato ,olo dopo la sornministra,ione cli J O\'ose\'cn. A livello pediat1 irn il primo lavoro presente in letteratura è quello di Roshni Kulkami, il quale nel 2004 ha risoho l'emorragia incontrollabile di due bambini con rottura ep,Hica post traumatica(23). cl rentativo di controllare un sa11guinamento inarrestabile di una donna a termin<' di gra\'idanLa affeua da sindrome HELLP co11 rottura epa ti ca e sindrome compartimentale addominale, J-Jenjamin W Dari ha utiliuato con ,ucccsso il :--:ovoseven alla dose di 90 microgrammi/Kg. La sindrome HELLP è una temibile com plicann della grav id an,a caratteriaata eia aumento degli enzimi epatici, basso numero di piastrine e spe>sso complicata da rottura epatica con conseguente .sindrome companimeotalc addominale. La prima piccola serie di casi cli paLicnù traumatiuati rrattati con rFV l! a è stata pubblicata da (hi MartinowiLz su l J ournal of Trauma nel 2001 ( 17). Questo amore nei sette casi trattati ha dimostrato una ridu,ione di trasfusioni di emazie concentrate e soprattutto dopo l'utili ;,1.0 cie l farmaco una pronta normai illazione del PT l' del PIT. Rirhard Dullon nd
2004 ( 19) ha, per primo, imuiw e dimostralo che il NovoseYen pur normalizzando il PT ed il PTT in tutti i pazienù lrauaLi, interrompeva l'emorragia solo in alcuni di essi. Quindi ha stabilito che il PT ed il PTT non sono dei tcsts che esplorano la coagulazione del paziente u aumatizzaLO in maniera completa Per tale motivo ha introdotto w1 vecchio metodo di screening utilizzato sin dal 1948: il tromboelaswgramma. Utilizzando questo test, infatti, ha dimostrato che il rFVlla va utilizzato solo in quei soggetti che iniziano a norrnaliaare la curva del Lromboelastogramma, indipende11tcmenle dal PT e dal p n· dopo la prima dose (Figg. 6, 7). Nel 2005. Uri M.artinowilz. raccogliendo tutte le espe1icnze ed i dati presenli in letteralllra. pubblicava del le linee guida per uti lizzare al meglio il Novoseven anche fuori indicazione (21). In sostan.la iWartinowilz raccomanda, prima di somministrare il farmaco , di correggere racidosi e l'ipotermia. di trasfondere piastrine sino ad un valore d i almeno 50.000 e crioprecipitato per portare il fibrinogeno a 50 mg/ di.
e.a a I
In~ h<:nxmby U WC k;ut 11<Ullhlt, fòtm ot llbDte :u,d li !Uli«i.ttd w,r!, bl3hm<rtdl1J.Aml>l!lfUUtnt whoundaJpcm,puttdtt>mop:tt>hy!CT) th!nrhrre hounlllirrtbt ,.tttrUL"ltt:a:rrtbtolhtm.,rrtq: on,:tru:llh.1ve.in1,1<:rcac.n11K-"" umeoft!,,~IJWDIU n:htrd10Plbocqucn1b \\e q:fll to<L:lrnmnt...t>ctbtt1<canhlru:ua:tivzrd tn:tor\'11 llfVIW cmm!tl:elH:maon::i growd, !rcr :imtmhal btmotthat:t-
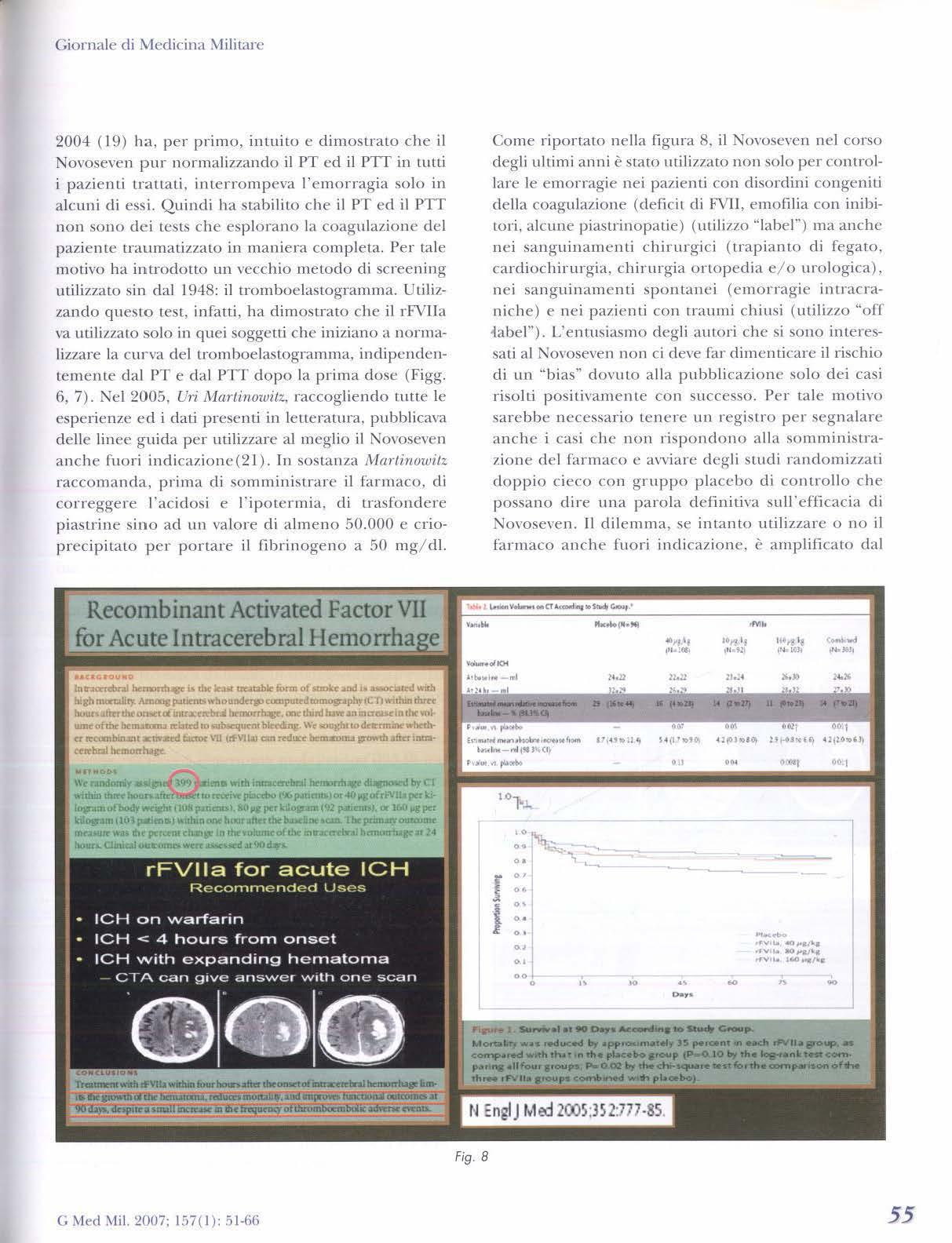
Come riportato nt>lla figura 8, il No\'oSe\'en nel corso degli ultimi anni è stato urj!izzato non solo per controllare le emorragie nei pazienti con disordini congeniù della coagulazione (deficit di FVII, emofilia con inibitori, alcune piasuinopatie) (milino '·Jabel") ma anche nei sa11gu111ame11ti chjrurgfri (trapianto di fegaro, cardiochirurgia, chirurgia ortopedia e / o urologica ) , nei sanguinamenti spontanei (emorragie incracranirhe) e nei pazienti con traumi chiusi ( utili zzo "off fabel " ). L' entusia5mo degli aut.ori che si sono interessati al Novoseven non ci deve far climcnticare il rischio di un "bias" dovuto alla pubblicazione solo dei casi risolli positivamente con successo. Per tale motivo sarebbe necessario tenere un registro per segnalare anche i casi che non rispondono alla somministrazione del farmaco e avviare degli studi randomizzati doppio cieco con gruppo p lacebo di controllo che possano dire una parola definitiva sull'efficacia di Novoseven. Il dilemma , se intanto utilizzare o no il farmaco anche fuori indicazione, è amplificato dal
fatro che ogni decisione in qut·,to scenario è quasi sempre associata a mortalità, morbicà ed alto costa òella ternpia(25 ). In realtà in lcucratura possiamo già individuare alcuni (non· in tullO) studi rando111ivaù in doppio cieco che riguardauo l'ULili11.o del Novoscven in di\'er.st• situa,ioni emorragiche. Jeffns. ad esempio, ha dimoslrato un ,,rnlaggio consistente nel lrattare i pa7iemi con <:patopatie gra\'i prima di eseguire una biopsia epalica(26). L1n la\'Ot'O piuuosto ~ignificatirn e ben condotto è quello di Friedrirh pubblin,to nel 2003 su l.ancel che dimostra una ridu1i one del con umo di emazie concentrate. '>l,Hi'>ricanwnte 1-ignificati, o, nei puien ti ~oltoposti a prostatectomia retropubica(27). U110 studio cffruuato su 245 pa1ienti con sanguinamento del tratto ga,troint<·stinale superiore dO\uto a grave epatopatia (Chi ld - Pugg A- 20%; Ch ild-Pu gg B= 52°f; Chilcl Pugg e;,,, 28%) non ha climoMrato un ,-antaggio signifìcatiHl nt'll'u,o del Novos<·ven. Questo lal'oro tuttavia ha rassicurato circa la ~icurcua in termini di a,senLa cli importanti effetti collaterali (= fenomeni trmnbotjçi) del :Novose\·en (28).
Phase lii study (the [rFVlla in Acute Hemorrhaglc Stroke Treatment] Trial) is now in progress to confirm these results (675 patients)
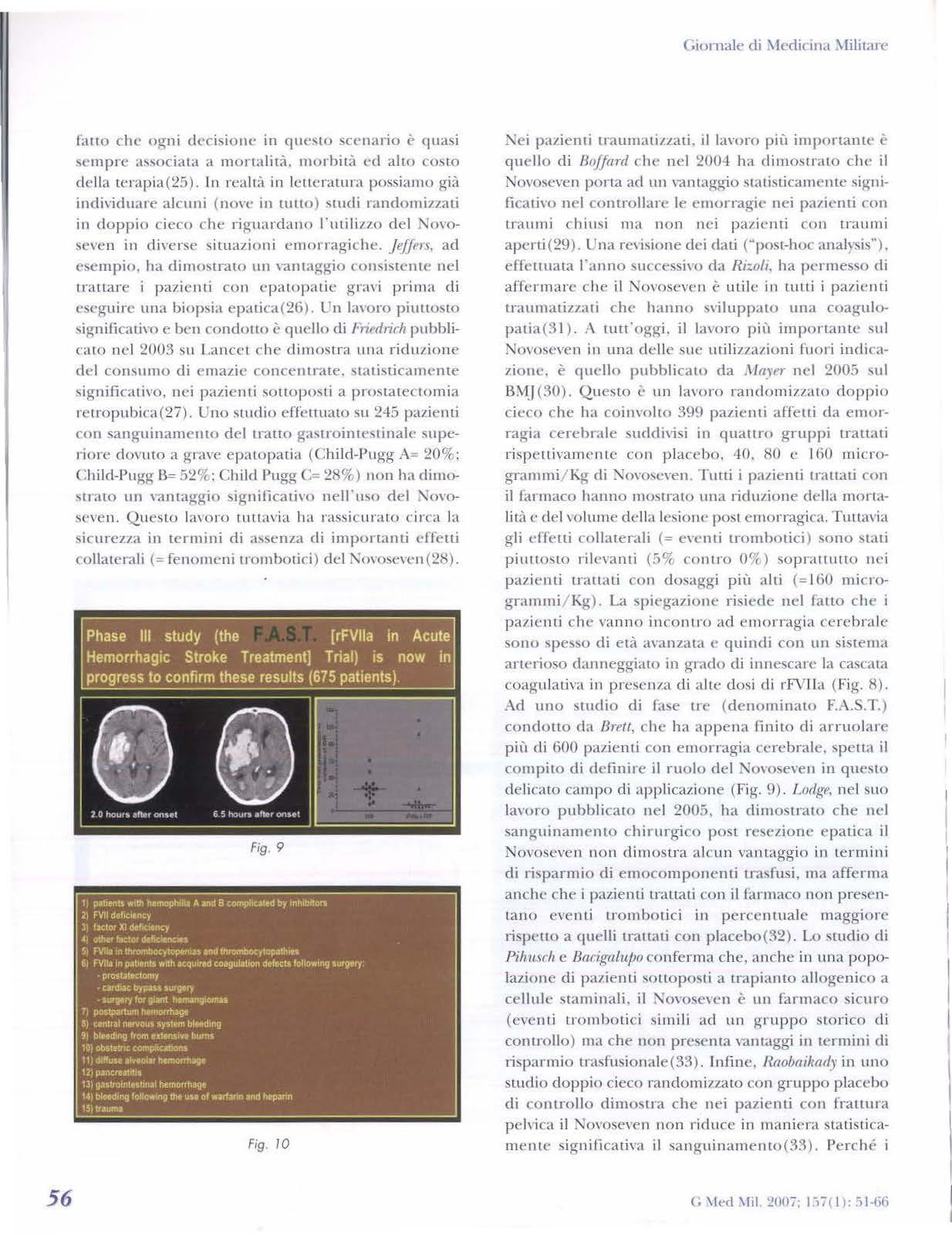
1) Jmjenls •1111 htmophtlla A and B comptlcaltd by lnhl!Jtton
21 FVtl 11er~1tncy
3) facto, Xl deficiency
4)0lll«bclordlfidlnatt
5) FVllo in llvclffll>OC'/IOl>'lnln aftd a,rambocylapathill
6j FVIII In pallenl& wltll acqulrld coaguhltlOn doftctt foll.,.t,,g su~try:
• prostateclomy
• cardiac bypau • IW9t'Y
· lur;t,Y lor pi
7) poaljlaflllm hamonhage
8) Clfltral non,ou, lytlem bl d1ng
I) blffd'"ll !rom tx!anllvt burns
10) absw:ric com;,lcillJOIIS
Il) diffuse .,...,benlontlagt
12)panc,Nlitll
13) gntrolnlHUnal hemorr~tgc
14) bleeding foflo"""9 tlle uu of •ortJrtn and heparin
t5)1Run1a Fig. 10
:\rei paLicnti traumatiLLati. il la\'oro più imponante è quello di Boffanl che nel 2004 h a dimostrato che il Novo~cven porta ad u11 vantaggio statii.ticamente signilìcati\'o nel controllare le emorragie nei p,11icnti ron traumi chiu~i ma non nei con tra11mi apcrti(29). Una re\i,ione dei dati ("post-h oc analysis"), effettuata J' anno ~urcessin> da Rir.o/i, h a permesso cli affermare c h e il Novosewn è utili' in tutti i paLienti traumaùaati che hanno wiluppato u1M coagulopatia(31) \ tutt'oggi. il l,l\oro più importante sul Nmoi.cven in un a delle sue uLili71a1ioni fuori indica7io11e. è quello pubblicaLO da ,\laJPr nel 2005 ~ul BMJ (30). Questo è un la\'Oro ranclomiuato doppio cieco che lta coin\'olto 399 paLienti affetti da emorragi,1 cerebrale sudcli\'isi in quattro gruppi trattati rispe11ivam<:'ntc con placebo. 40 , 80 e 160 microgrammi/Kg cli );'m·o,c\·en. furti i pa1iemi trattati con il farmaco hanno mosU"alO u11a ric!u,ione della mortalità e ciel vo lum e della lesiouc post e111orragica. Tuttavia gli effeni collaterali Cc= e\·cnti trombotici) sono st,ni piuttosto rilernnti (!i% contro 0%) sopratrutto nei pa7icnti trattati con dosaggi più a l ti (= 160 microgrammi/Kg). La spiega7ionc risiede nel fatto che i pa1icnti che va nn o in contro ad emorrag ia cereb r ale s0110 ,pes!.o cli età a\'anzata e· quindi con u11 sistema arterioso danneggiato in grado di innescare la cascata coagu latiYa in prest'nn di alte dosi di rFVlla ( Fig. 8). Ad uno studio di fase tre (de11ominato F.A.S.T.) condotto da Bretl, che ha appena finito cli arruo lare più di 600 paLienti con emorragia cerebra le, spetta il compito di definire il ruolo ciel .N0Yoseve11 in questo delicaro cam po di app licazion e (Fi g. 9). Lod{{t>, nel s uo larnro pubblicato nel 2005. ha dimostrato che nel sanguinamento chirurgico post re'>eLiom,· epaLica il Novoseven n o n dimo stra alcun vantaggio in termini di ri,parmio di emocom p o11enti trasfusi. m a afferma anche che i pazienti trattati con il farmaco non presentano eventi tromborici in perccn tuale maggiore ,;spello a quelli trattati con placeho(32). Lo smdio cli Pihu1 ch e Bnrigalupo conferm a ch e, anche in una popoluion e di pazienù ~ottopo~ti a trapianto a ll ogenico a cellule staminali. il No,·oscH.'n è un farmaco sicuro (event i trombotici si mili ad nn gruppo sto ri co cli controllo) ma che non presenta ,-antaggi in termini di ri~parmio trasfusio11ale (33). Infine , Uaobailwd)' in uno studio doppio cieco randomin:ato con gruppo placebo di comrollo ctimo'>tra che nei pa,ienti con frattura peh ica il Novoseven non riduce in manier;i statisticamen te signi lìcati\'a il sanguinamento(33). Per ché i

risultati di tuLLi questi lavori sono così differc11ti? lntanw perché, notor-iameme, è difficile calco lare con precisione la perdita ematica in corso di emorragie spontanee o post ch irurgiche Secondo, ma più import.ante. è perché la somministrazione di l\'ovoseven nei differenti protocolli avviene con "timing" differenti. t\"el protocollo disegnato da Friederich. per esempio. il rFVIla è somministrato durante l'intervento chirurgico, appena prima del sanguinamcnt0; mentre negli sLUdi di Raobaihady e di Lodge, rFVIIa è stato somminisu·ato al rnomcnt0 dell'incisione della cute. Ricordando che la vita media del rFVIIa è di 2.5 ore circa, il ''timing" della somministrazione di Novose\'en assume un'importanza fondamentale.
Conclusioni
Ormai c'è un accordo generale che Novoseven è un farmaco sicuro ed efficace nei pazienti emofìlici con inibitori. Come abbiamo visto, dati emergenti dalla pubblicazione di numerosi casi anedouici, di serie più o meno numerose di casi o di veri e prop,·i studi randomizzali suggeriscono che rfVIIa è efficace anche in una vasta , ·arietà di sanguinamenti in pazienti non emofilici. Per questo morivo alcuni au101 i definiscono il Novoseven come il "magie bullet' ' (= proieuile magico) o l ' agente emostatico universale. Probabilmente, al momento, questo entusiasmo è ancora ingiustificato. Tuttavia. rfVIIa si è dimostrato molto efficace in alculli tipi di emorragie (Fig 10). Nuovi studi prospettici dovranno rispondere alle seguenti domande:
• rFVfla è veramente in grado di agire in presenza della triade letale (acidosi, ipotermia e coagu l opatia)?
• qual'è il momento giusto per somministrare rFVlla?
• qual'è la dose ottimale di rFVIIa?
• rFVIIa può essere milizzato in corso di DIC?
• quanto costa esattamente un trattamento con rFVHa?
1el l 'attesa che i prossimi studi forniscano delle risposte a queste domande, ritengo che anche la Sanità Militare dell'Esercito Italiano. al pari delle Sanità Militari di altri Eserciti (USA, Regno Unito, Israele) deve avviare un prnrocollo di ricerca per utilizzare il Novo• seven nei traumi di guerra. A questo proposito abb iamo disegnato un progetto che st iam o per sottoporre al Dipartimento di Sanità dell'Esercito ed alla DireLione Generale della Sanità Militare.
I. Committee on inju.ry, prevention and contro], Institute of Medicine (1999): Mttgnirude and cosls. in: Bonnie R}, Fulco CE, Livemum CT (eds): Reduring lhe Burden of lnjury. Nalional Acadcmic Prcss. Washi11gto11 DC, pp 42-52.
-2. Krug E. G., Sharma G. K, Lozano R. ( 2000): Th,, global b11rt!P11 ofinj111y.
Arn J Public Health 90: 523-526.
3. Trunkey D. D. (1983): Trnwna.
Sci Am; 249: 28-35.
4. Chiara O., Cimbanassi S. (2003): Organiz.ed ?ì-auma Care: does volume matler and do trauma cenlers save lives?
Curr Opin Crit Care 9: 510-514.
5 . Sauaia A., Moore F., Moore E. E., et aL (1995): Epidcmi0Iom1 of trauma cleaths: a rcassessment. J Trauma 38: 185- I 93.
6. SampalisJ. S., Boukas S., Lavoie A. et al (1995): Preuen table deallt evalualim, of Ilte appro/Jrialeness of tfie on site /renana care provided &y Urgences- Sani/ /Jhysiciam.
J Trauma 39:1029-1035.
7. Cooper D.J. , Mc Dermott F. T., Cordner S. M. , Tremayne A. B. and the Consultive Committee on Road Traffic Fatalities in Victoria ( 1998): Qualily assessmenl of tlte management of road trafjìc Jatalities al a leve[ I trauma cenler compmed wilh other hospila/.s in Victoria ,A tt.slralia. .J Trauma 45:772-779.
8. Shackford S. R., Mackersie R. C., Holbrook T. L., e t al ( 1993): Tfw ejidetrtiolO[J)' eflmuma rlealh: ci po/Ylllalion based anal)1sis. Arch Surg 128: 571-575.
9. Cbjara O. , ScottJ., Cimbanassi S. et al (2002): Trauma deaths in an It alian urban area: a11 audi! of pre-hosf>ifrtl anrl in-hospital lrrmma care lnjur y 33: 553-562.
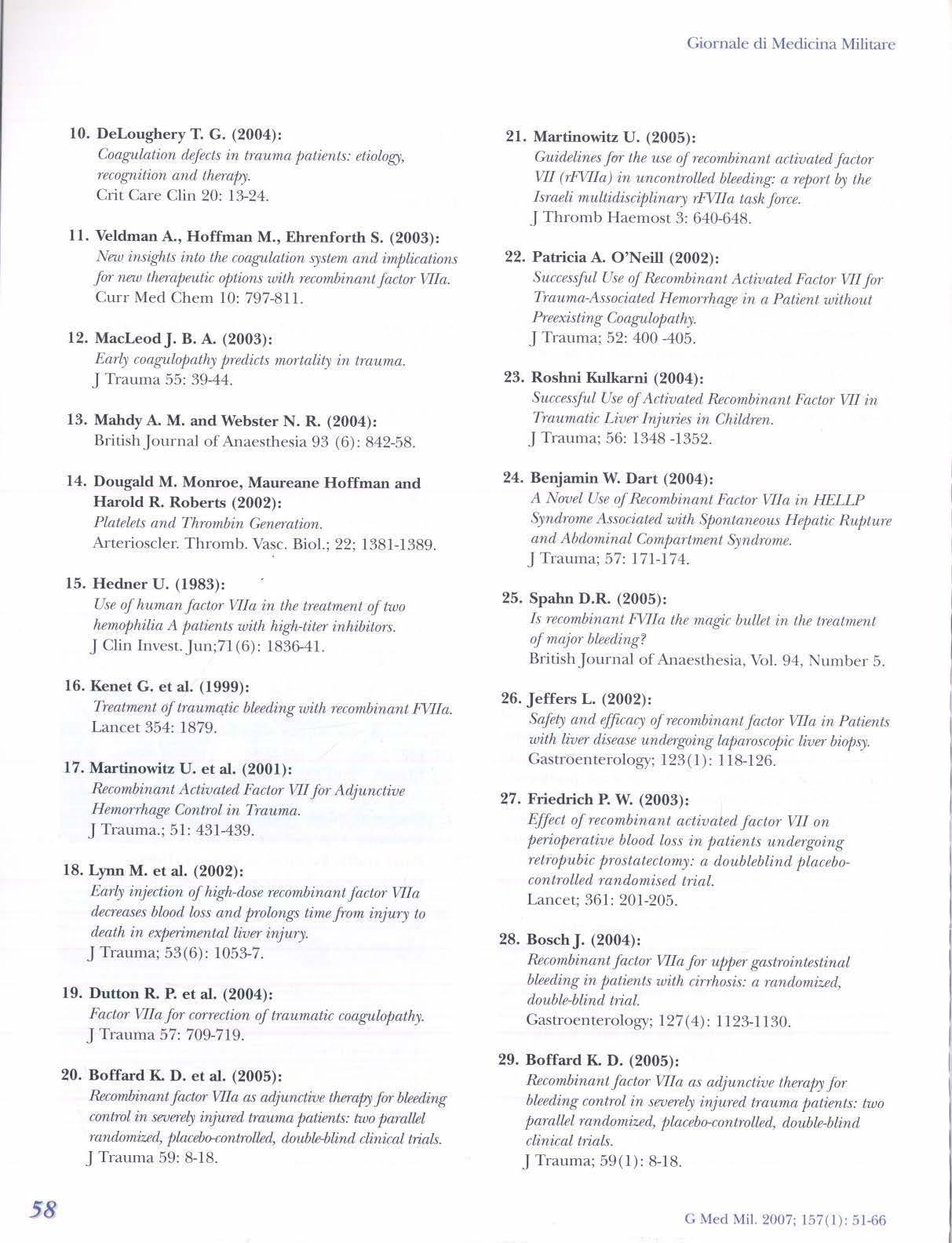
10. DeLoughery T. G. (2004) : Coagulation defects in trauma j)alients: etiology, recognition and therapy.
CriL Care Clin ~O: 13-24.
l l. Veldman A., Hoffman M., Ehrenforth S. (2 003): New insights into the roag;u!,ation syslem and implications /or new therapeutic ojJtions wilh recombinanl Jaclor Vlla. Curr Med Chcni IO: 797-811.
12. MacLeodJ . B. A. ( 2003): Early coagulo/mthy fJ1edicls mortalit.y i11 trauma. J Trauma 55: :;i9-44.
13. Mahdy A. M. and Webster N. R. (2004): Britisb .Journal of Anaesthesia 93 (6): 842-!'iS.
14. Dougald M. Mom·oe, Maureane Hoffman and Harold R. Roberts (2 002): Pl,atelets rwd Thrombin Ceneration. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.; 22; 1381-1389.
15. Heclner U. (1983): Use oj hurnan Jactor VI/a in the treatrne11t oj two hernophilia 1-l /wtients with high-titer inhibitors. J Clin Invest.Jun;71(6): 1836-41.
16. Kenet G. et al. (1999): Treatment of traurna,Lir bleeding with recombinant J<Vlla. Lancet 354: 1879.
17. Martinowitz U . et al. (2001): Recombinant Artivaled Factor VII /or Adjunctive H ernorrhage Contro[ in Trauma. J Trauma.; 51 : 431-439.
18. Lynn M. et al. (2002): t;arty injertion of high-dose rPcombinant Jaclor Vlfa decreases bl,ood loss and prolongs time /rom injury to death in experimenlal liver irijury. J Trauma; 53(6): 1053-7.
19. Dutton R. P. et al. (2004): Fa ctor V[Iafor rorrection of traumatic roag;ufo/mthy. J Trauma 57: 709-719.
20. Boffard K. D. et al. (2005): Recomlrinant facto,· VIIa m adjunctive therapyfor bleeding con trol in severely injured trauma patients: two paraUel randomiz.ed, placebo-conlmlled, doubfe.blind clinir,a{ trials. J Trauma 59: 8-18.
21. Martinowitz U. (2005): Guidelines Jor lhe use oj recombinrmt fltlivated Jaclor VII (rfYlla ) ùt uncontrolled b/,eeding: a report by lhe !~meli mullidisciplinary rE1'lla task farce. J Thromb Haemost 3: 640-648.
22. Patricia A. O'Neill (2002): Successful lJ~e of Recombinant Activaled Faclor Vii Jor Trauma-Associated l-lemorrhage in o Patient witlwuf Preexisting Coagulopathy. J Trauma; 52: 400 -405.
23. Rosbni Kulkarni (2004): SucCPssjiil Use ojilrtivated Recombina11t fi'actor VII in Tramnatir Liver lnjuries in Children. .J Trauma; 56: 1348 -1352.
24. Benjamin W. Dart (2 004): A Nove/ Use of.Recombinanl Faclor VI/a in HELLP Syndrome Associated with Spontaneous llepatir Hupture a11d Abdominal Com/Jartnuml Syndrome. J Trauma; 57: 171-174.
25. Spahn D.R. (2005 ) : ls rerombinant F\l!Ja lhe magie bulle/ in ihP treatment of major bleeding? British.Journal of Anaesthesia, Voi. 94, :--lumber 5.
26. Jeffers L. (2002): Srtjèty m1d efjù:ary oj rerombinant Jactor Vlla in Patients with liver disease undergoing laparoscopir liver biopsy. Gastroc11terology; 123(1): 118-126.
27. Friedrich P. W. (2003): Effect of recombinant activater/ Jactor VII on perioj,erative blood loss in patients undergoing relropubic prostatectomy: a doubleblind /1lacebocontrolled randomised trial. Lancet; 361: 201-205.
28. BoschJ. (2004): Recombinanl factor Vlla far upper gastrointestinal bleeding in j)alients with cirrhosis: a rmulomized, r/oub/e-blind tria[. GastroenteroJogy; ]27(4): 1123-11 30.
29. Boffard K. D . (2005): &combinant factor Vlfo as adjunrtive lherapy Jor bleeding control in severely injured trauma. patienls: two parali;,/ randomi.zed, placebo-controlled, double-blind clinica{ lrialç, J Trauma; 59(]) : 8-)8.
30. Mayer S. A. (2005):
Recombinant al"livaled Jactor VII for awle in lmcerebral hemorrhage.
N Engl j Med. ; 352(8): 777-785.
31. Sandro B. Rizoli (2006):
H.ecornbinanl activated Jartor VII as rm adjunctive therapy for blPeding rontrol in severe trauma patients witlt coagulopathy: subgroup analysis /mm lwo randomized trin1s. Criticai Care.
32. Lodge J. . PA. (2005):
Recombinant r-oaguk1tionfàctor l'Ila in major liver rPsertion.
Anesthesiology; 102(2) : 269- 275.

33. Pihuscb M. , BacigaJupo A. (2005):
RPrombi11ai1l activated Jarlor VII in treatnuml of bleedi ng romjJ/icationJ jollowing hematopoietir slem celi transplantation.
J Thromb Haemost; 3 : 1935-1944.
34. Raobaikady R. (2005):
Use of activated recombinanl roagulation factor \fil in /Jnlients undergoing reconslrurtion .mrgeryfor lraumalic frarture of pelvis or pelvis and acetabulurn: a double-blind, rrmdomized, /Jlaceborontmlled tria!.
British.Journal of Anaesthesia 94 (5): 586-91.
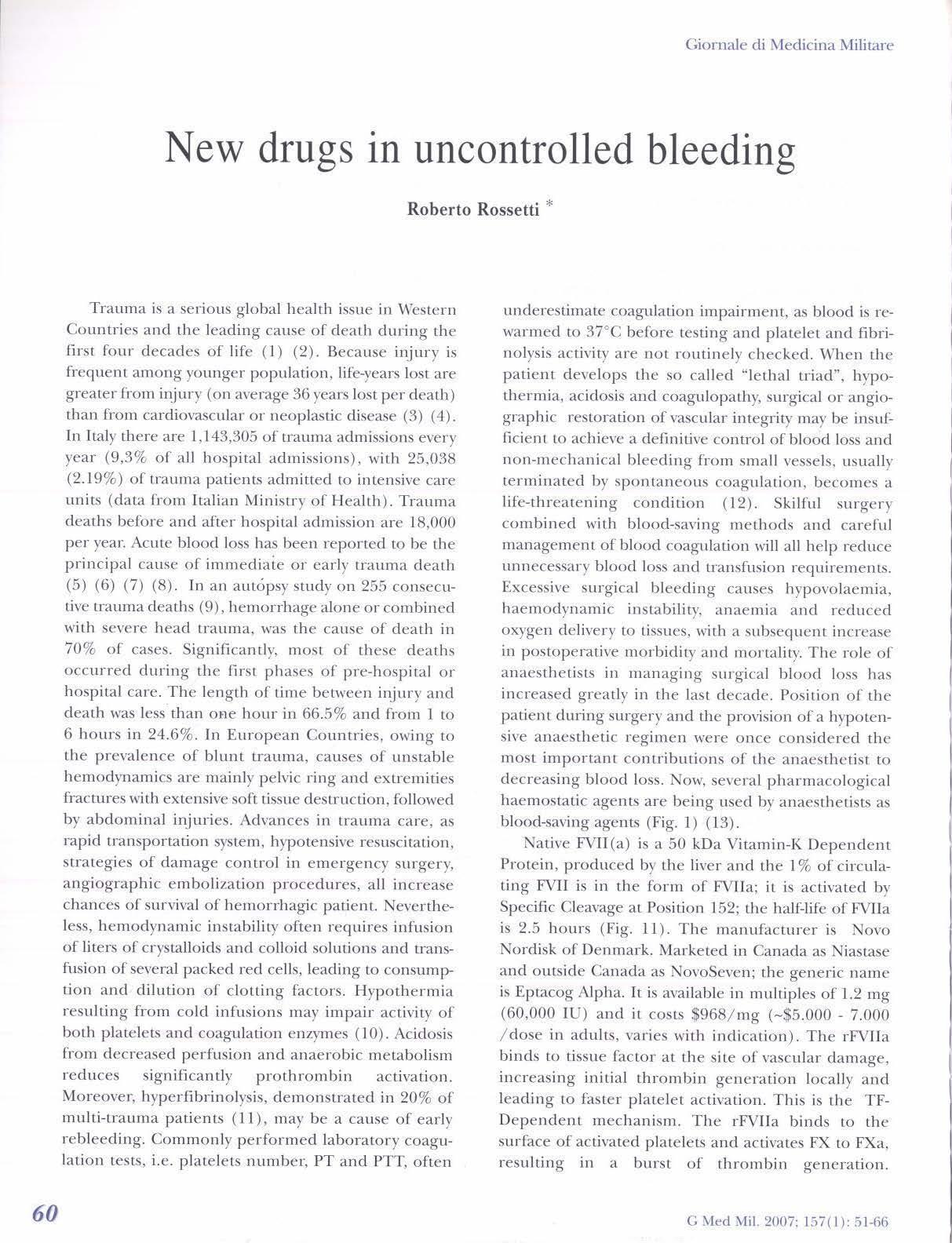
Trauma is a se1ious global healrh issue in vVcstcr11 Countries and the leading cause of death du1ing che first four decades of !ife (1) (2). Because i1~jur y is fre<inent among younger population, life-years losr are greater from iujury ( on average 36 years lost per deatb) than from cardiovascular or neoplastic disease (3) (-:I). ln [1.aly there are l , 143,305 of trauma admissions every year (9,3 % of a li hospital admissions), with 25.038 (2.19 % ) of trauma patients admitted to intensive care units (data from Italian Ministr y or Health). Trauma dearhs before and after hospital admission are 18,000 per year. Acute b lood loss has been reponcd to be the principal caus<" of immediate or carly trauma deaL11 ( 5) (6) (7) (8) Tn an autupsy stmly on 255 consecutive trauma deaths (9), hemorrhage alone or combincd with severe head trauma, was the cause of dcath in 70 % of cases. Significancly, 1110s1 or thesc deaths orcurred duri.ng the fìrst phases of pre-hospital or hospital care . The length of time betwccn injury and deach was lcss than otie hour in 66.5 % and from 1 to 6 hours in 24.6 % Jn Europcan Countries, owing to the prevalence of blunt trauma, causes of unstable hemodynamics are main ly pelvic ring and exlremities fractures wilh extcnsive soft tissue destructio11, fo l lowed by abdomina l injuries. Advances in trauma care , as rapid transportation system, hypotensive resuscitation, stra tegies of damage control in emcrgency surgery, angiographic embolizaLion proccdures, ali increase chances of survival of hemorrhagic parient. Nevertheless , hernodynamic instability often r eqnires infusion of l iters of cq,stalloids and colloid solurions and rransfusion of severa! packed red cells, leading to consumprion and dilution of clouing factors. Hypothermia resulting from co lei infusions may impair activity of both platelets and coagulation emymes (10). Aciclosis from clecreased perfusion and anaerobic mei.abolism reduces sign ilì cantly prot.hrombin activation. Moreover, h ypcrfib1ino lysis , demonstrated in 20 % of multi-trauma patients (11) , may be a cause of earl y rebleeding. Commonly performed laboratory coagulation tests, i.e. plate le ts numbe r, PT and PTT. often
underestimatc coagu laLion impairment, as blood is rcwarmed co 37°C before tesrjng and platelet and fibrinolysis activity are not ro11tinel y checked. \i\,ncn the patient develops the so ca ll ecl '·Jethal triad ", hypothermia, acidosis and coagulopall1y, surgical or angiographic restoration of vascular integrity may be insul~ fìcient Lo achicve a defìniLive contro! of blood loss and noo-mechanical bleeding frorn smal l vessel s , usuali)· Lerminated by spontaneous coagu l ation. bccomcs a li fe-threaten in g condition (12). Skilful surger y combined with blood-saving methocls ancl careful managernem of blood coagulaLion will ali help reduce unnecessar y blood loss and tra11sfusion requirements . Excessive 5urgical bleeding causes hypovolaemia, haemodynamic instability, anaemia and reduccd oxygcn deliver y to tissues. with a subsequcnt increa5e in postoperative morbidiry ancl monality. The role or anaesthetists in managing surgical blood loss has increased greatly in the last decarle. Position of the patient during surgery and tl1e provision of a hypotcnsive auacsthetic regimen were once considerccl the most importan1 comributions of the anacsthctist to decreasing blood loss. Now, severa! pharmacological haemostatic agents are be i ng used by anaesthetists as blood-saving agcnrs (Fig. 1) (13).
Native FVII (a) is a 50 kDa Vitamin -K Dependent Protein, produced b y thc liver and the l % of c irculaLing FVII is in the fonn of F'V ll a ; it is activatecl b y Spccific C leavage at Position 152; the half-life of FVll a is 2.5 hours (Fig. 11). The manufacturer is Novo Norrlisk of Denmark. Marketed in Canada as Niastase and outside Canada as >JovoScven; rhe g e ne1·ic namc is Epracog Alpha. It is available in nrnltiples of 1.2 mg (60 ,000 IU) and it COSLS $968 / mg (-$5.000 - 7.000 / dose in a<lults , varies with indication). The rFVlla binds to rissue factor at the site of vascular damage , incre asing initial throm bin gencration locally and leacling LO faster platelet activation T hi s is the TFDependent mechanism. The rFVIIa binds to thc surface of activated pla telets and activaLes FX to FXa. resulting in a bnrst of thrombin generation.
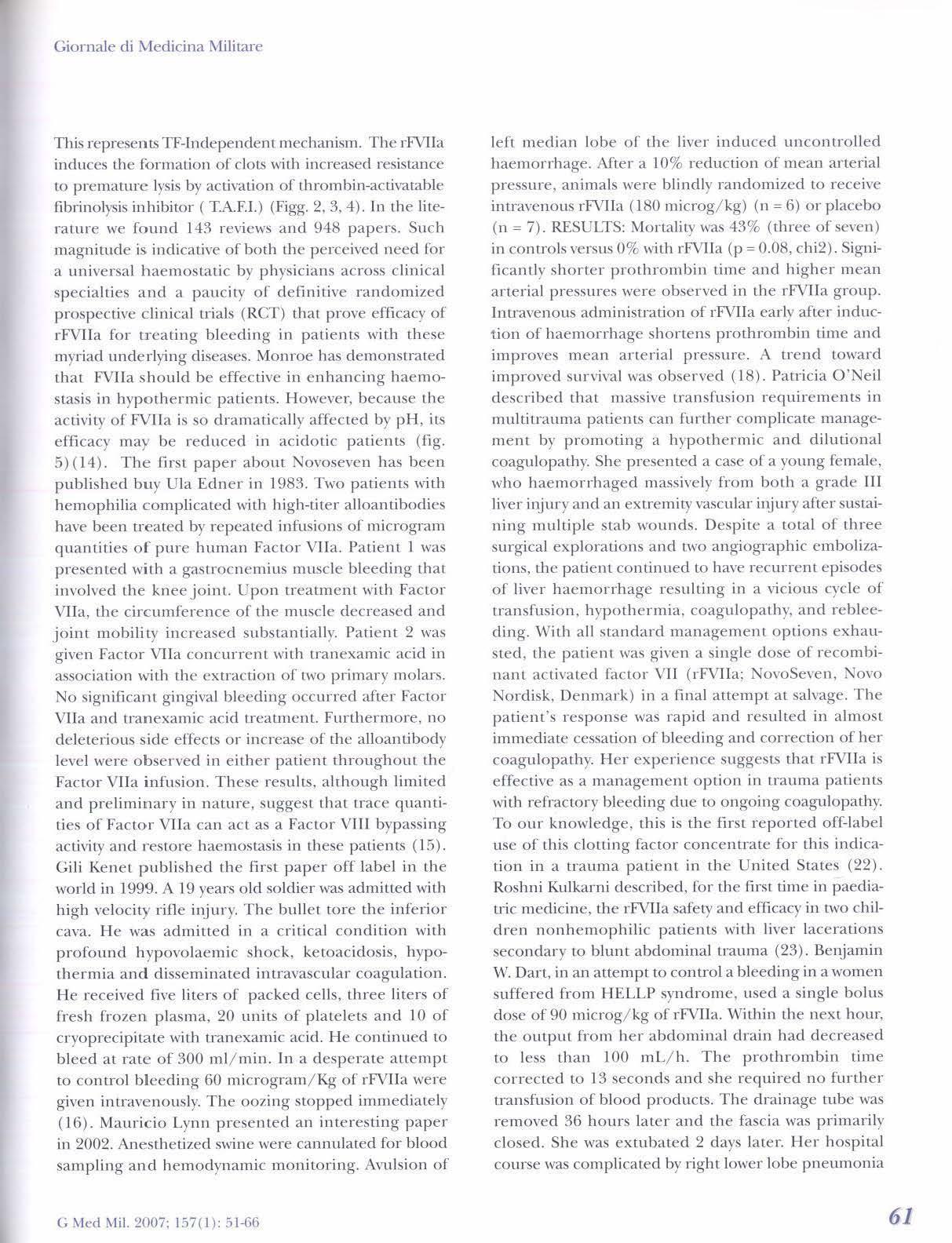
This represents TF-Independent mechanism. Thc rFVIla induccs tbc formation of clots with increa~ed resistancc to premature lysis b y activation of Lhrombin-acti\'atabk lìbrinolysis inhibitor ( TA.F.I.) (Figg. ~. 3, 4). In Lhe literatun· we f01111d 143 revicws anù 948 papers. Such magnitude is indicative of both thc perccived need for a universal haemostatic by physicians across clinica! spcciallies a nd a paucity of defìnirive randomized prospcctive clinica! Lrials (RCT) that prove effìcacv of rfVIla for trcating blceding in palients with these my1-iacl underlying diseascs. Monroe has clemonstrared that FVJTa should be effectivc in enhanc in g haemostasis in hypothermic patients. Howcver, because the acLivity of FVlla isso dramatically affccted by pH, iLS efficacy may be reduced in aciclotic patients (fig. 5)(14). The first paper abont Novosevcn has bcen publishccl buy Ula Edner in 1983. Two patients wiù1 hemophilia complicateci with high-titer alloantiboclics have been u·eated by repcaLed infusions o.f microgram quantities of pure human Factor Vlla. Patient 1 was present.ed with a gastrocnemius musclc bleeding that iu\"olved the knee joint. Upon treatmenL witl1 Factor Vlla, the circumference of tilt' muscle clccrcased and join t mobili ty incrcased substan tially. Patien t 2 was given Factor Vlla concurrent with tranexamic acid in association with ùie cxtraction of two primary molars. No significant gingival bleeding occurred after F'actor Vlla ancl tranexamic ac:id trcat111c11t. Furù1ermore, no dcleterious side effects or increase of thc a lloan t.ibody leve! wcre observed in either pat.ient throughom the Factor Vlla infusion. These results, alihough limitcd and preliminary in nature, suggesL that rrnce quantities of Facror VII a can act as a Factor Vlll bypassing acti,~ty ancl restare haemostasis in these patients ( 15) Gili Kenet published t.he first paper off label in the world in 1999. A 19 years old soldier was admilted with high vclocity ritle injury. The bullet core the infe1ior cava. Hc was a<l111itted in a cririca l condition with profound hypovolaemic shock, ketoacidosis, hypothermia an d disseminateci intravascular coagu lation . He rec e ived five liters of packed cells, three liters of fresh frozen plasma, 20 uuits of platclels and 1O or cryoprecipitate with tranexarnic acid. He conùnued Lo blecd at rate of 300 ml/min. In a despcrate auempt to conrrol blceding 60 microgram / Kg of rFVIla were given intravenously. The om.ing stopped immecliatel y (16). Mauricio Lynu prcsented an interesting paper in 2002. Anes th etized swine were cannu lated for blood samp lin g and hemodynamic monitoring. Avuls ion of
left median lobe of the liver inùuccd uncontroll ed haemorrhage. Afrer a 10 % reduction of mean arteria] pressure, animals were blindly randomizcd Lo receive intravcnous rFVIla (180 microg/ kg) (n =6) o r placebo (n = 7). RESULTS: Mortality wa5 43% (three ofsen:n) in conu·ols versus 0% with rFVlla (p =0.08, chi2). Signifìcantly shorter prothrombin time ancl higher m ean arteria! pressures were observcù in the rFVITa group. lnu,wenous adminisrsat ion of rFVIla carly after inductio n of haemorrhage shortens prothrombin time and improves mean arteria! pressur<'. A trend toward irnpron:d sun~val was observed ( 18). Pau;cia O'Neil described that massive transfusion requircments in multitrauma patiems can further complicate management by prornoting a hypothermic and dilutional coagu lopathy. She prcsemed a case of a yonng female, who haemorrhaged massiYely from both a grade III l iver i11jur y and an extremit:y vascular irtjury after sustaining multiple stab wounds. Despite a tota! of three surgical exploralions and l'NO angiographic cmbolizations thc patient conùn ued lo ha,·e recurrcnt cpisodes of liver hacmonhage resulting in a vkious cyc!e of transfnsion, hypothermia. coagulopathy. and rebleeding. With all standard management options ex hausted, Lh e patien t was gi\'en a single dose or recombinanl activated factor VII (rFVIIa; NovoSeven, Novo Nordisk, Denmark ) in a tìnal attempt at sa lvage. The patient's rcsponse was rapid and res11lted in almost immediate cessalion of bleeding and correction of her coagulopathy. Hcr cxperience suggests that rFVIIa is effective as a managcmelll option in tranma paticnts with refractory b leedin g due to ongoing coagulopathy. To our knowledge. this is the first reponed off-labe l use of this clouing factor concentrate for this indicatùm in a trauma paLient in the Uniteci States (22). Roshni Ku.lkarni described, for the lìrst time in paediau-ic medicine, ù1e rFVlla safety and effìcacy in two children nonhemophilic patients with li\'er lacerations secondary ro b lun t abdominal trauma (23). Ber'.jamin W. Dart, in an attempt to contro! a bleeding in a women suffered from H ELLP syndromc, used a single bo l us dose of 90 microg/ kg of rFVlla. Wiù1in the next hour, thc output from her abdominal drain baci clecreased to less than 100 mL / h. The prothrombin time co rrected Lo 13 seconcls ancl she re qui1-ed no funher transfusion of blood proclucts. The drninage tube was removed 36 hours latcr and tbe fascia was primai-ily closed. She was extubated 2 days later. H er hospital course was complicared by right lowcr lobe pneumonia

and a prolonged ileus. She was discharged honw I month after adrnission (24). Martinowitz describ<'d se\'en massively blecding, multitransfuscd (media n, 40 uniL5 of packed cells), coagulopathic trauma patients were trcated with rFVHa alter failurc of co,n-e ntional meas11rcs to achicvc haemostasis. The rcsults of this report "uggest that in trauma patients rFVIla may plaY a role "" an adjuncti, e haemo<;tatic measure, in addition to surgical haemostatic tcrhniqucs, ancl proviclcs che motivati.on for rontro lkd animal and clinica) trials (17). \ s Du tton ~aid in his paper. F\'lla produred an immediate imprO\cment in PT in e,eq patient, rcgardless of the source of coag11lopathy. Thc clinica! signifìcancc of chis findi11g is not clear, becau~c PT may not be a good test of coagulation function in the presence of exogenous FVTJ a. Laborntory in\'c-;tigation has suggcsted that a h igh dose of FV ll a sho11ld triggcr a thrombin burst in almost any patient with exposed ti,;sue facto1 and a minimally arl<'quate platelet count. More sophi~ticated tests of coag11la1io11 ma) be recp1ired to guid<' 1h e use · of FVlla; Dutton ha, obtaincd thromboelastograril (TEG ) recordings beforc and after F\1la u,e in a small su bset or pacients. Each of ù1csc patient~ ~howed a pattern of rc-,ponse sirnilar to che cxample in Figure 6 and 7. with ,in improvcmcnt in the onset of clotting. the ratt> or clot formation, thc maximum ampliwdc, the time to reach a stable clot, and tbc rate of ~ubscquPnt clcH lysis (19). In 2005 U ri Maninowil7 published guidclines for tlw use of rF\' Ua in uncontroll<'d bleedi11g (2 1 ). The problem with ù1i~ magnituciC' of repons is the p<>t<'nùal publication bias of positive cascs, wh ich. understandably. cditors are more likelr to publish (fìg. 8). Regisui c!> of similar patiem groups are abo 1-usceptiblc to submission and publication bias of successfu l cascs. Only rcccntly, 'no respoudcrs' and cornplications of rFVIla treaunent have bccn desc,ibccl in bleeding paticnts. Faced wirh a patient wiù1 uncontrolled blecding the clinician is thus lelt with signifìcant uncertainty as to whethcr he or she is obli gcd to use rFVI l a in an 'off-l abel ' or 'out-o f-license ' indication or whether this could be ,dthheld as thcrc is littlc published high lcvel scientilìc cvidence nor approvai by auv health authority in Europe or the US. This dilemma is amplifìed by rhe fact that an} decision in this scenario is often associateci with monality. morbidity and high cost (25). Acti\'atcd recombinant factor VII (rFV II a) has bccn shown fromjeffe, r's paper lo be effecti\'e in corrccting prolonged prothrombin time
(PT ) in cirrho 1i c patients. The main objecriH ' or thi~ s111cly was to e\'aluate 1he cffcct of 4 (5, 20, 80, and 120 g / kg) doses of rFVlla on correction of PT and che time LO achie,e haemo-.ta~is in cin hotic paùent'> wirh coagulopath)' who are undergoing- laparoscopil li\'er biopsy. Se\e111y-one patien1s (pans I and 11 ) with advanced liH! r disease (Child-Turcoue B or C). platelet count 2:60,000 / mm3, and PT in 1hc rnnge of 3-15 ~eronds abovc normai wcre incluclecl in the swdy. Efficar)' endpoints wcre normalization of' PT and time to hat·mostasis. PT was corrected to n ormai le\'el, (< I~. I seconds) in thc majority of patient~. The durntion of nonnalization of PT was longer in patiell[s trcatcd witl1 highcrdoses ofrF\' lla. Forry-eight (74 %) of65 patients (part fl ) acl1ic, f'd hacmostasis within 10 minutes. No correlation bctween ù1e time to haemostasis and duration of corrC'ction of PT was observcd. None uf the paticnts required operati\'c inter\'Clltion or transfu~ion of blood / blood product, to comrol bleeding. One thromhotic eH'llt ancl on<· rase or disseminateci intravascular coagulation wcn· reportect, but both events wcrc considcred by thc investiga1or as unlikel\' to be rcla1ecl to trca1me11t with rFYIIa. Thc result~ of this srudy suggest that treatmcnt with rFVTla may offer benclìt for paticnts with livcr diseasc undergoi11g- laparoscopic biop,) ( 26) Rccombinant anirnted fac1or \'li (factor Vlla) has prohaemostatic cffects in bleeding patients with rnagulation abnor111ali1ies. Fricdrirh (27) aimed to test t he hypot hesis that rccombinan t f'actor Vita co uld reduce periopcr,1ti,,e blood loss in paticnLc; \\Ìth normai coagu lation systems. Thereforc, we as~cssed safety and eflìcacy of thb drug in patients undergoing rctropubic prostatectonw, which is often a<,soriaced with major bl ood loss and need for transfusion. In a doubl<'-blind, randomisecl placebocontrolled trial, Fricdri c h 1·ecordecl blood loss and transfusion requirements in 36 paticnts undcrgoing retropubic pros tatcctom, , who wcrc randomised to reccive an intraycnous bolus of rcrombinaut factor \'Ila (20 microg/ kg or •IO microg/ kg) or plac<'bo in tll(' early operative phasc. Median pcriopcrative blood lo!>~ wao; 1235 mL (lQR 1025-1407) and 1089 mL (9281320) in g1oups givcn rccombinant factor Vll a 20 mirrog/ kg ancl 40 microg/ kg, respcctively, co1npared with 2688 mL (] 707-3565) in the placebo group (p=0 .001 ). Sc,cn of t1,clYe placcbo-1reated patiems wcrc transfuscd, whercas no paticnts who rccc ivccl 40 microg/ kg r ccombinan1 factor Vll a needcd transfusi.on. The odch ratio fo1 recei,-ing any blood procluct
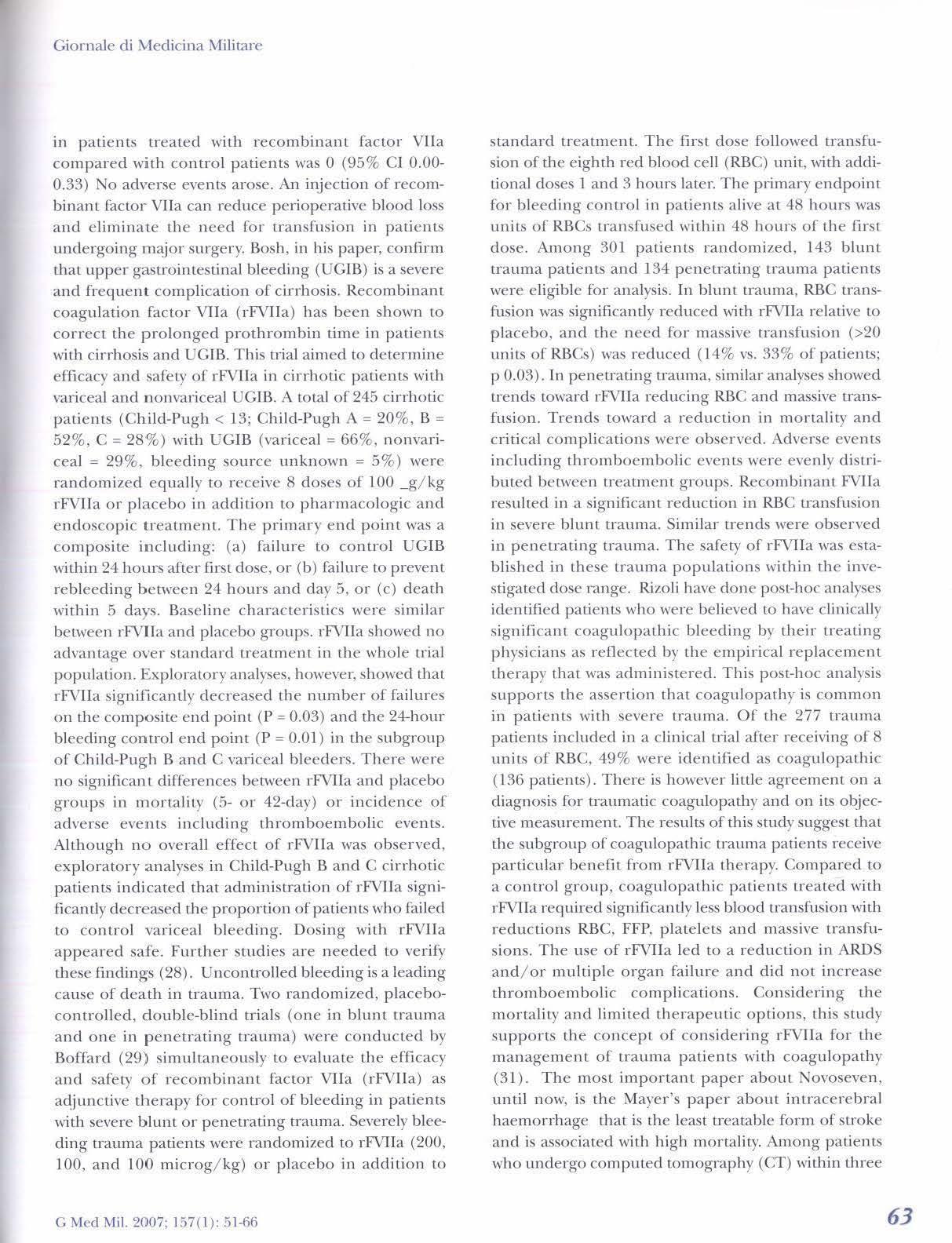
in patien ts treatecl w;th recombinalll factor VI la compared wi th contro! patients was O (95% Cl 0.000.33) No adverse events arose. An iajection of recombinanl làctor Vlla can reduce perioperativc blood loss and eliminate the need [or c.ransfus ion in patients undergoing m~jor surgery. Bosh, in his paper, confirm that upper gastrointestinal bleecling (UG IB ) is a severe and frcquent complication of cirrbosis. Recombinam coagulation factor Vlla (rFVIla) has been shown lO correct the prolonged prothrombin time in palients with cirrhosis and CG IB. This o;al aimed to clctermine efficacy and safety of rFVll a in cirrh otic paticnts wiù1 variceal and nonvariceal UGIB. A tota! of 245 cirrhotic patients (Child-Pugh < 13; Chilcl-Pugh A= 20%, B = 52%, C = 28%) with UGIB (variceal = 66%, nonvariceal = 29%, bleeding source unknown = 5%) were randomized equally to receive 8 doses of 100 _g/kg rFVlla or placebo in addition to phannacologic and endoscopie Lrealment. The primary end point was a composite including: (a) failure to contro! UGIB within 24 hours aftcr first dose, or (b) fai Iure to prevent rebleeding bct:wecn 24 hours and day 5, or (c) death within 5 days. Baselinc characterisLics were similar between rFVIla and p lacebo groups. rFVlla showed no advantage over standard treatment in thc whole tria! populalion. Exploratory analyses, howeyer, showcd ùrnL rFVIIa significantly decreased the number of failurcs on rhc composi re end point (P = 0.03) and the 24--hour bleeding contro] end poinL (P =0.01) in the snbgroup of Chi ld-Pugh Band C variceal bleeders. There were no signilìcan I differences betwccn rFVlla aud placebo groups in monaliLy (5- or 42-day) or incidencc of adverse evenLs including thromboembolic events. Although no overall effect of rFVI la was observed, exp loratory analyses in Child-Pugh B and C cirrhotic patients indi cated thar administraLion of rFVIIa significantly decrea5ed the proportion of paticnts who failed Lo conLrol variceal bleeding. Dosing with rFVJJa appeared safe. Further studies are needed to verify thesc f-i11dings (28). Uncontrolled bleeding is a leading cause of dca_th in trauma. Two randomiz.ed, placebocontrolled, double-blind trials (one in blunt trauma and one in penetrating trauma) were conducted by Boffarcl (29) simultaneous l y to evaluatc the effìcacy and safety of recombinant factor Vlla (rFV ll a) as aqjunctive therapy for contro] of bleeding in palients with severe blum or penetrating trauma. Scverely bleeding trauma patients were ranclomized to rFVIIa (200, 100 ami I 00 rnicrog / kg) or placebo in addition to
standard treatmenL. The first dose followed u·ansfusion of the eighth red blood celi (RBC) unit, with addiLional doses 1 and 3 hours later. The p1;mary endpoint for bleeding contro! in patients alive at 48 hours was units of RBCs transfusecl within 48 hours of the fìrst dose. Among 301 patients ranclomized, 143 blunt trauma paticnLs and 134 penetrating trauma patiems were eligible for analysis. In blum trauma, RBC lransfusion was significaHtly reduced with rFVIla relative to placebo, and the necd for massive transfusion (>20 units of R.BCs) was reduced ( 14 % vs. 33% of patie11ts; p 0.03). ln penetra ring trauma, sim il ar analyses showcd trends toward rFVUa reducing RBC and massive transfusion. Trends toward a reduction in monalicy and critica] complications were observed. Adverse events including tlirornboc111bolic eve11ts were evenly distributed betwecn treatrnent groups Rccombinant FVlla resulted in a significant reduction in RBC transfusion in severe blun1 trauma. Similar trends were observed in peneLrating trauma. The safety of rFVIIa was cstablished in these traL1ma populations within the investigateci dose range. Rizoli have clone post-hoc analyses identificd patienLS who were believed to have clinically significant coagulopaL11ic blccding by Ll1eir treating physicians as reflectcd by thc ernpi1ical replacement Lberapy thac was administerect. This post-hoc analysis supports the assertion that coagulopathy is common in patients with severe trauma. Of the 277 trauma patients included io a clinica! tria! after receiving of 8 units of RBC, 49 % were idenlified as coagulopatbic ( 136 paticnts). Thcrc is howcvcr lit tic agreemen t on a diagnosis for traumatic coagulopathy and on its ol~jective measurement. The results ofthis study suggest LhaL the subgroup o[ coagulopathir trauma patients receivc particular beneGL from rF'Vlla Lherapy. Compared tO a control group, coagulopathic patients treated with rFVria required significantly less blood transfusion with r eductions RBC , FFP, platelcts and massive transfusions. The us e of rFVIIa led to a rcduction in ARDS ancl / or multiple organ failure and dici not increase th romboembo li c complications. Considcring the mortality and limited therapeuric options, this srndy supports the concept of considering rFVTTa for thc management of trauma patients wirh coagulopathy (31) . Tbc most impottant paper about Novoseven , unti! now, is the Mayer's paper about inu·acerebral haemorrhage that is the !cast treatable form of stroke ancl is assoc iateci with high mort.ality. Among patients who undergo computed tomography (CT) within three
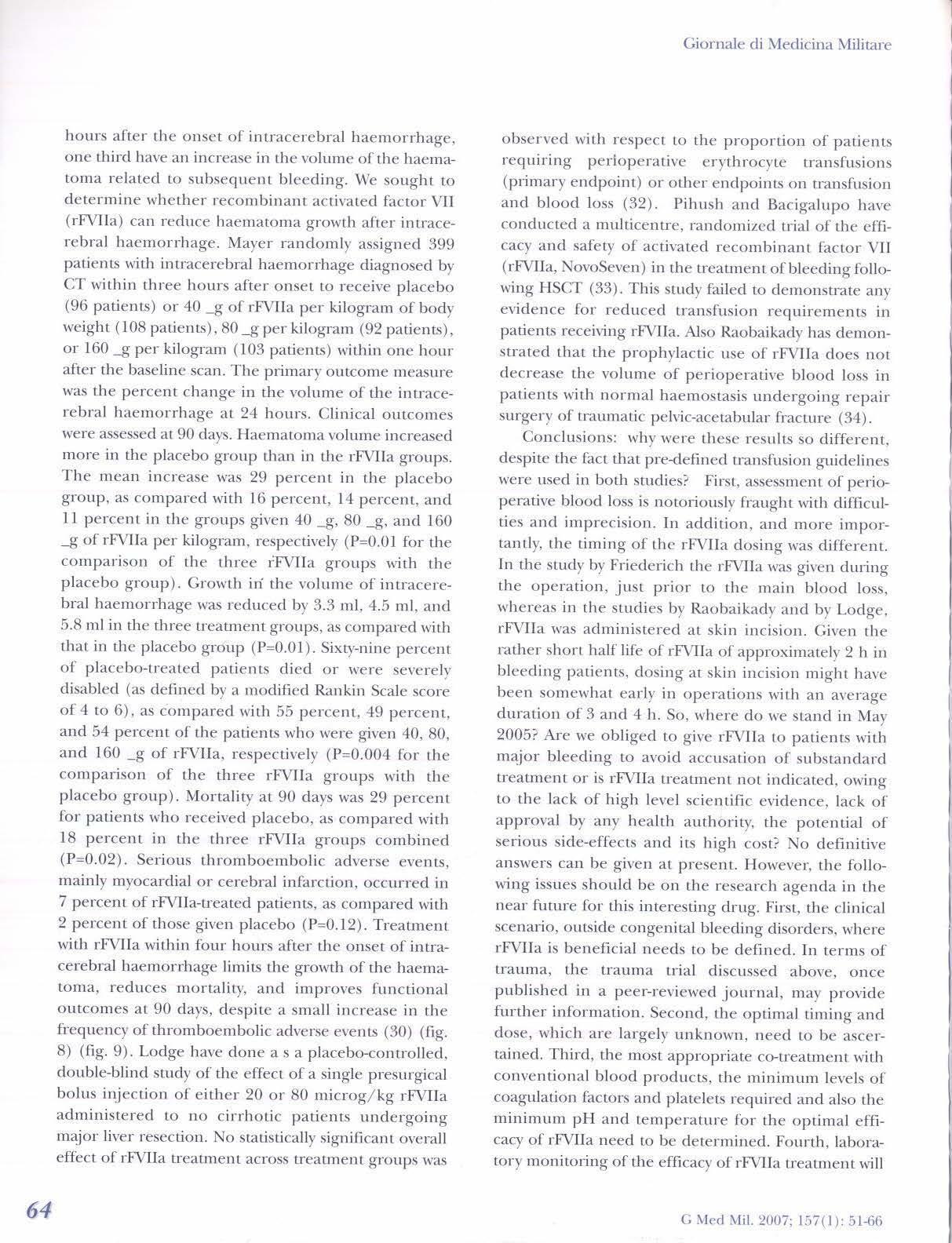
hours arter Lhe on set or in tracerebral haemorrhage, onc third have an increase in the volume ofthe hacmatorna relateci LO suhsequenL blccding. v\"e sought to determine whether recombinant activated factor VU ( rFVll a) ca11 rcrlnce baeniatoma growth afler incracerebral haeinorrhage. Maycr rand om l y assigned 399 patients wilh intracercbral haemorrhage diagnosed b y CT within three hours after onseL LO receive placebo (96 patients) or 40 g or rFVIla per kilogram of body weight (108 paLicnts), 80 _g per k.ilogram (92 patienrs), or 160 _g per kilogram (103 patients) wilhin one h our aftcr the baselinc scan. Thc primary outcomc measure was the percent c han ge in the vo lum e of thc in tracerebral haemorrhage al 24 h ours. Clini ca) ontcomes were assessed at 90 days. Haematoma volume increased more in the placebo group than in Lhc rFVIla grn ups . The mean in crease was 29 percent in the placebo group, as compare<l wich 16 percenr, 14 percent, and 11 percent in thc groups given 40 g, 80 g, and 160 _g of rFVlla per kilogram, respective ly (P"'0.01 for the comparison of the three 1'FVIJa groups with the placebo group). Growth in the vo lum e of intracerebral haemorrhage was rcdu cecl by 3.3 ml, 4 5 ml, and 5.8 ml in the tJ1ree treatment groups, as cornparecl with that in the placebo gr011p ( P=0.01). Sixty-nin e perccnt or placebo-trealed paLients died or were sevcre ly disabled (as clefincd by a moclificd Rankin Scale score of 4 to 6), as compared with 55 percent, 49 percent, and 54 perccnt of t he paticnts who were given 40, 80, and 160 _g of rFVIla. rcspectively (P =0.004 for the compariso n of Lh e Lhree rFV Il a groups with thc placebo group). Mortality at 90 days was 29 percent for paùents who rcceived placebo, as compared with 18 percem in the three rFVIIa gronps comb in ed ( P=0 .02 ). Serious Lhrom boembolic adversc even ts, mainly myocarrlial or cercbral infarction, occurred in 7 pe rcem of rFVll a-Lreated patient5, as compa red with 2 percent of those given placebo ( P=0.12). Treatment with rFVTia w itlii.n four hours a fter tl1c onset or intracere bral baemorrhage limiLS Lhe growth of the haemaLorna, reduces mortality, and improves runctional o utcom es a l 90 days, despitc a small in crease in the frcquency of Lhromboembolic adverse eveni.-; (30) (lìg. 8) ( Jì g. 9) l odge h ave clone a sa placebo-comrolled, double-blind study of tlw effec L of a single presurgical bolus inj cction of cithe r 20 or 80 m.icrog/ kg rFVIla adm inistered to no c irrh otic patients undergoing major liver resection. No s taListica ll y sign ifì cam overall effect of rFVUa Lreatrnent across treatmenl groups was Giornale di
observed with rcspect to the proportion of patients requm ng perioperative eryt h rocytc transfus ions (primary endpoinr) or oLher endpoini.-; on rransfusiou and blood loss (32). Pihush aud Bacigalupo have conducted a multicemre, randomized tria! of Lhe cfficacy and safety of actiYated recornbinant factor VTI (rFVIIa, NovoSeven) in the treatrnem of bleedi.ng fo ll owing IISCT (33) This swdy failed to demonstrate any evidence for rcduced Lransfusion requirements in patients receiving rFVlla. AJso Raobaikady has demonstrated tbat the prophylactic use of rFVIIa does not decrease th c volume of perioperative bloocl loss in patients with norma] haemostasis undergoing repair surgery of traumaLic pelvic-acetabuJar fracLUre (34).
Conclusions: why were thcse results so <lifferent. clespitc the facL that pre-detiued transfusioH gu id elines wcrc used in both sn1dies? First, assessrnent or perioperative blood loss is nowriously fraught with difficulties and imprccision. Io adctition, and more importamly, Lhe timing of Lhc rFVIIa dosing was differcnt. fn ù1e study by Friecle1ich the rFVIIa was given during the operation, just prior to the main blood loss, whereas in the studies by Raobaikady and by L odge, rFVIIa was admiu istered at skin incision. Given Lhe rather short half Life of rfVHa of approx im ate ly 2 h in bleecling patients, closing ai: skin inc is ion might havc been somewhat ear!y in operations wi t h an ave rage duratio11 of 3 and 4 h. So , where do we slanci in May 2005? Are we obligccl to gi\"e rFVTla ro patients with major bleeding to avoid accusat ion of substandard treatment or is rFVIIa treaunent not indicat.ed, owing Lo the Jack of hi gh le\'el scientific evidence , lack of approva] by any heallh authori Ly, the potential of serious side-effects and i ts high cost:- No definitive answers ca n b e givcn at present. Jl owever, thc following issues s hould be on Lhc research agenda in the near furure far ùlis in terestin g drng. First, the clinica] scena1io, outside congenita] bleeding clisorders, where rFVIIa is beneficiai needs to be defined. In terms of u-auma, Lhe trauma tria! discussed above, once published in a peer-reviewed journaL may provide furù1er infor111 ation Second, ù1c optima l Liming and dose, which a r e large l y unknown, need to be ascertained. Third, the most appropriate co-u·eatrncnt with conventional blood products, the minimum levels of coagu lation factors and platelets required and also the minimum pH and Lempcrat.ure for the opuma l efficacy or rFVUa neecl to be determined Fourth, laboratory moni toring of ù1e efficacy of rFVlla treawieut wi ll
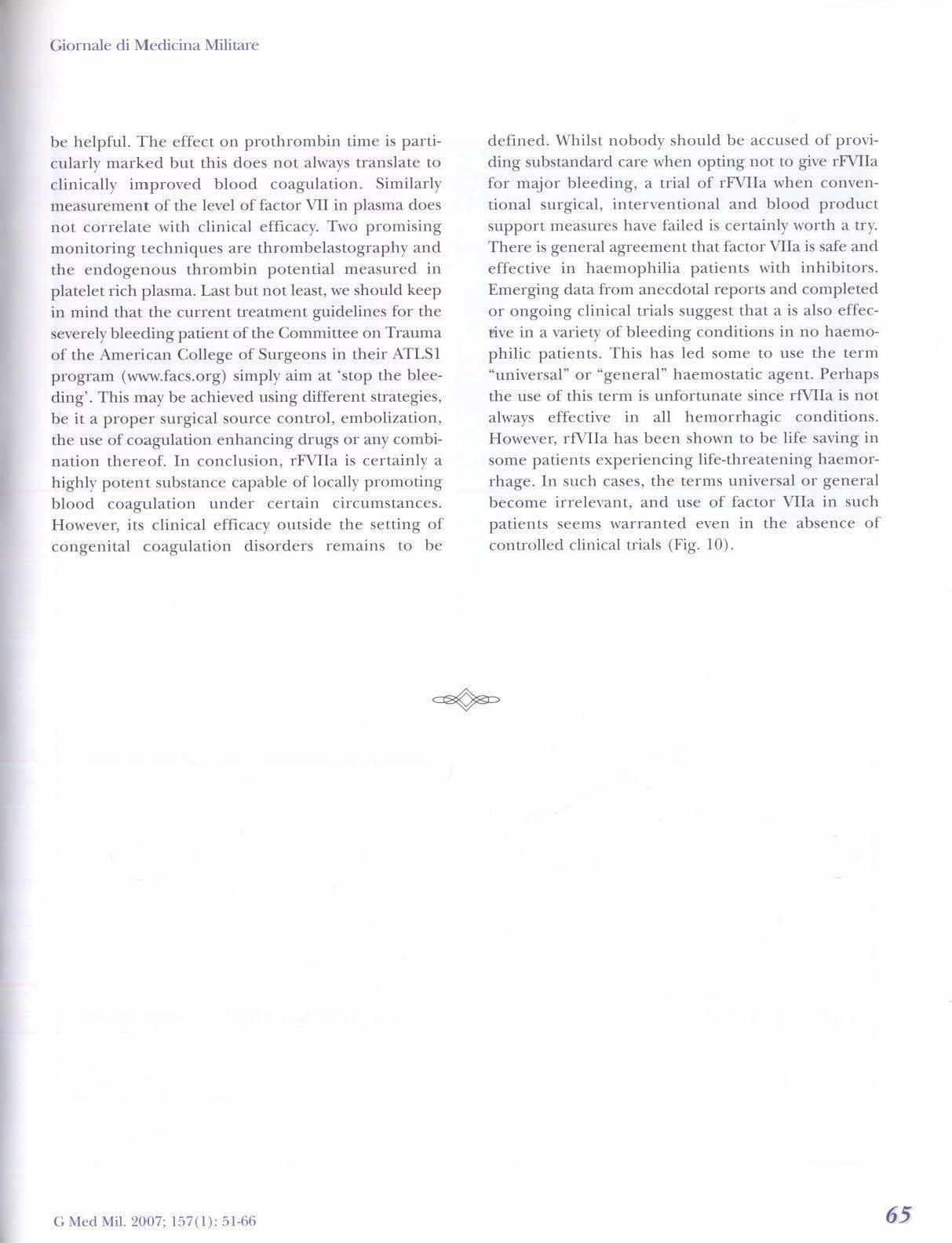
be helpful. The effect on prothrombin time ispanicularly rnarked but this does not always transiate to clinicall y improved blood coagulation. Similarly measurement of the leYel of factor VU in plasma does not correl ate with clinica! effic acy. Two promising moniLOring techniques are thrornbelastograph y and che cndogenous tbrornbin potential measured in platelet rich plasma. Last but not least. we should keep in mind that the currcnt treatment guidelines for thc se\'erely bleeding patient of the Committee on Trauma of the American College of Surgeons in their ATLSl program (www.facs.o rg) simply aim at ·stop the bleeding ' . This may be achieved us i ng diffcrent su·ategies, be it a proper surgical source contro! , embolization, the use of coagulation enhancing drugs or any combinati on thereof. In conc l usion , rFVT l a is ccrtainly a highly potent substance capable of local ly promoting b lood coagularion under certain circumstances. Howe,,er, its c linica] efficacy outside tbe setting of congenita! coagulation disorclcrs remains to be
de.finecl Whilst nobody s hould be accused of pro viding substandard care when opting not tu give rFVIIa for major bleeding, a tria! of rFVIIa whcn conventional surgical, interventional and blood product support rn cas ure s have failed is certa inly worth a try. There is generai agreement thal fanor VT!a is safe and effective in haernophilia patients with inhibitors. E merging data frorn anecdotal reports ancl comp leted or ongoing clinica! trials suggest tbat a is also effecrive in a variety of ble e di ng conditions in no haemophilic patients This has led some to use the term ''universal" or "genera]'' haemostatic agcnt. Perhaps the use of ù1is tcrm is unforwnate since rMia is not always effcctive in ali hemorrhagic conclitions. However, rMia has been s hown Lo be life 5aving in some patients expericncing life-threatening haemorrhage. In such c ases , the terms universal or generai become irrelevant, and use of factor Vlla in such patienls seems warranted even in thc absence of controlled clinica! trials ( Fig. 1O).
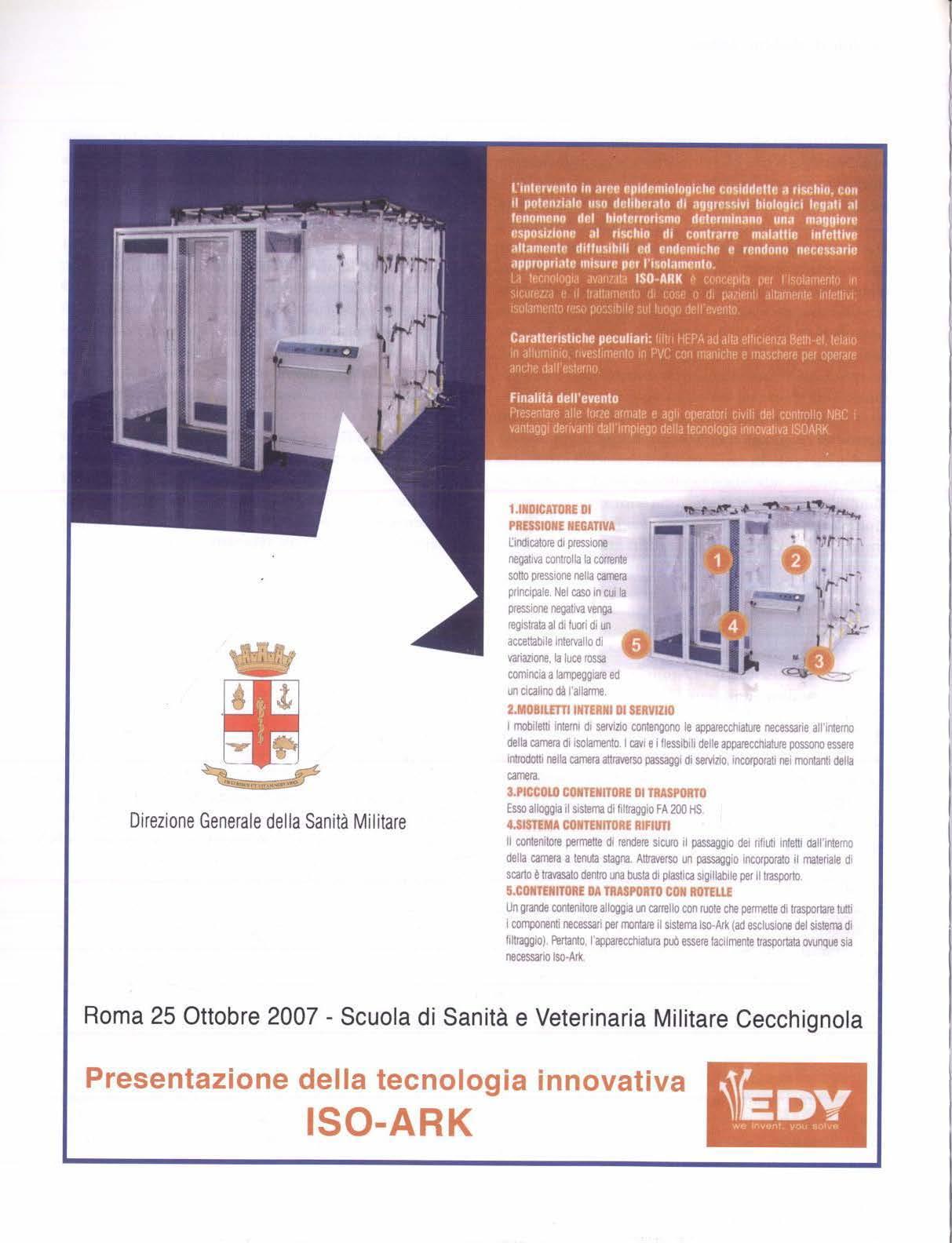
1.INDICATORE DI PRESSIONE •EGATIVA
t:1nd1catore dJ pressione nega!Jva controlla la correflle sotto pressione nena camera principale. Nel caso IO CUl la pressione negalwa voo;ia reg1s1ra1a al 01 fuOfi di un accettabile inteivallo di variazione. la luce rossa comincia a lanl)egg1are ed un acahno dè l'allarme.
2.MOBllffil INTERNI DI SERVIZIO
I moblfe1t1 lntem1 d1 servlzto c011tengono le apparecchiature necessarie all'interno della camera d1 isolamento. I cavi e i lless1b11i delle apparecctuarure possono essere 1ntrodottJ nella camera attraveiso passaggi di servlz10. incorporati nei monlanti della camera
3.PICCOLO CO!ITEMITORE 01 TRASPORTO
Esso alloggia Il sistema di filtraggio FA 200 HS
4.SISTEMA CONTENITORE RIFIUTI
Il contenitore permette d1 rendere sicuro 11 passaggio del nfiut1 Inietti dall'interno della cameia a tenula stagna Attraverso un passaggio incorporato il ma1ena1e d1 scarto è travasato dentro una busta di plastica s1g1llab1le per Il trasporto
5.CO~TENITORE DA TRASPORTO CON ROTEllf
Un grande ccnlemtore alloggia un carrello con ruote che permette di trasportare tutti I con'4J()nenti necessari per morrtare il sistema lso-Ark (ad esclusione del sistema d1 t11tragg10) Pertanto. l'apparecchiatura può essere lac,lmente uasportata ownque sia necessario !so-Arie.
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE
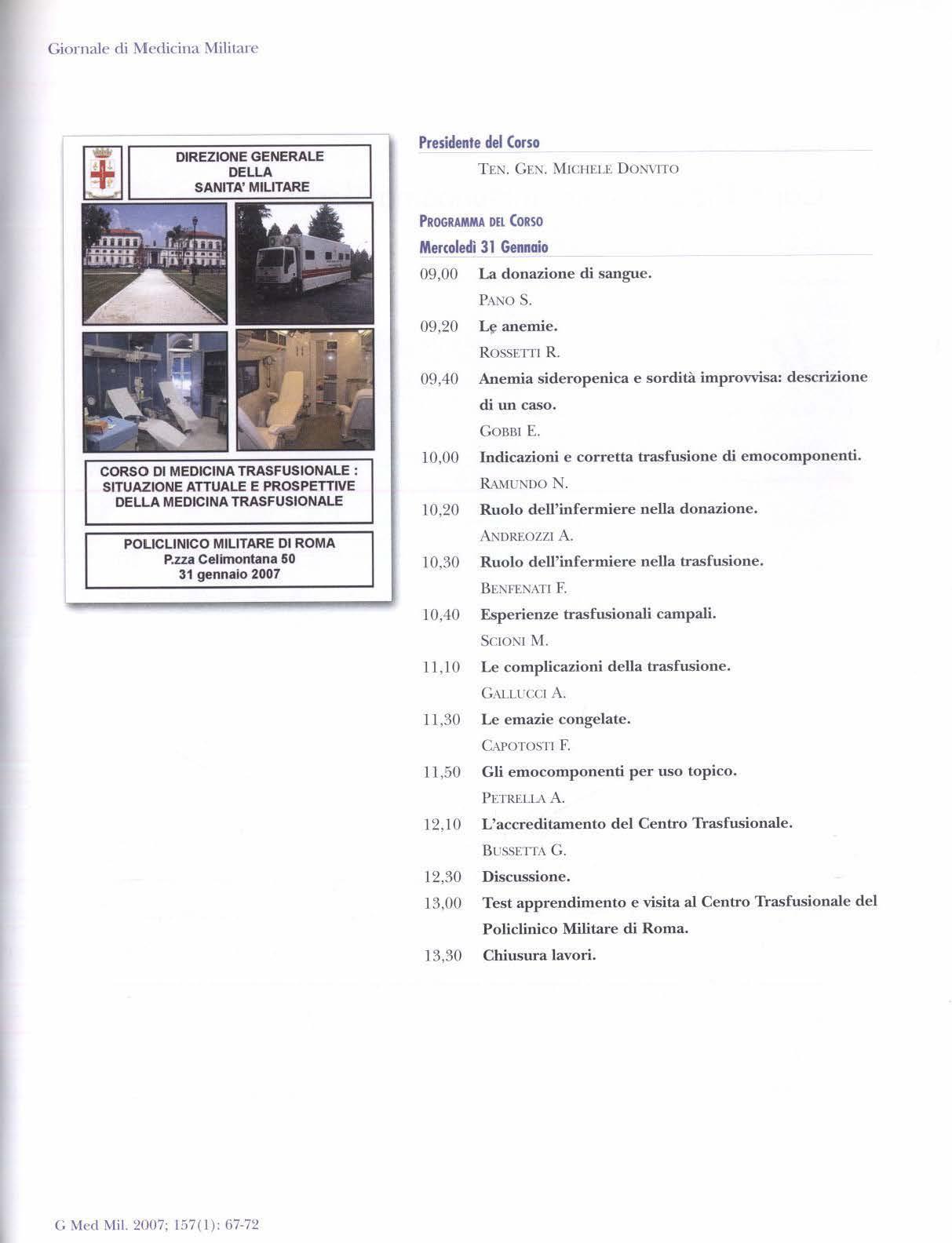
CORSO DI MEDICINA TRASFUSIONALE : SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE
POLICLINICO MILITARE DI ROMA
P.ua Celimontana 50 31 gennaio 2007
Presidente del Corso
T EN CD!. MICHELE D ON\'ITO
PROGRAMMA DU (ORSO Mercoledì 31 Gennaio
09,00 La don azion e di sangue.
P ANO S.
09.20 L~ anemie.
R OSSETT I R.
09,40 Anemia siderop enica e sordità improvvisa: descrizione di un caso.
GOBBI E.
10,00 Indicazioni e corretta trasfusione di emocomponenti.
R A.Ml:NDO N.
10,20 R uol o dell'infermi ere nella donazione.
ANDREOZZI A.
I 0,30 Ruolo dell ' infermiere nella trasfusione.
BENF'ENATl F.
10,40 Esperienze trasfusionali campali.
SClONI M.
11, l O Le complicazioni della trasfusione
G , \LLL'.CCI A.
11,30 Le emaz ie con ge late.
WOTOSTI F.
11,50 G li emocompon enti per u so topico.
P t::TRELLA A.
12, 1 O L'a ccr edi tam e n to d e l Centro Trasfusionale.
BussEITA G.
12,30 D isc ussione
1 3,00 Tes t a p p r e ndim e n to e visita al Cen tro T r asfusion ale del P oliclini co Militare di Rom a
13,30 C hiusur a l avori.
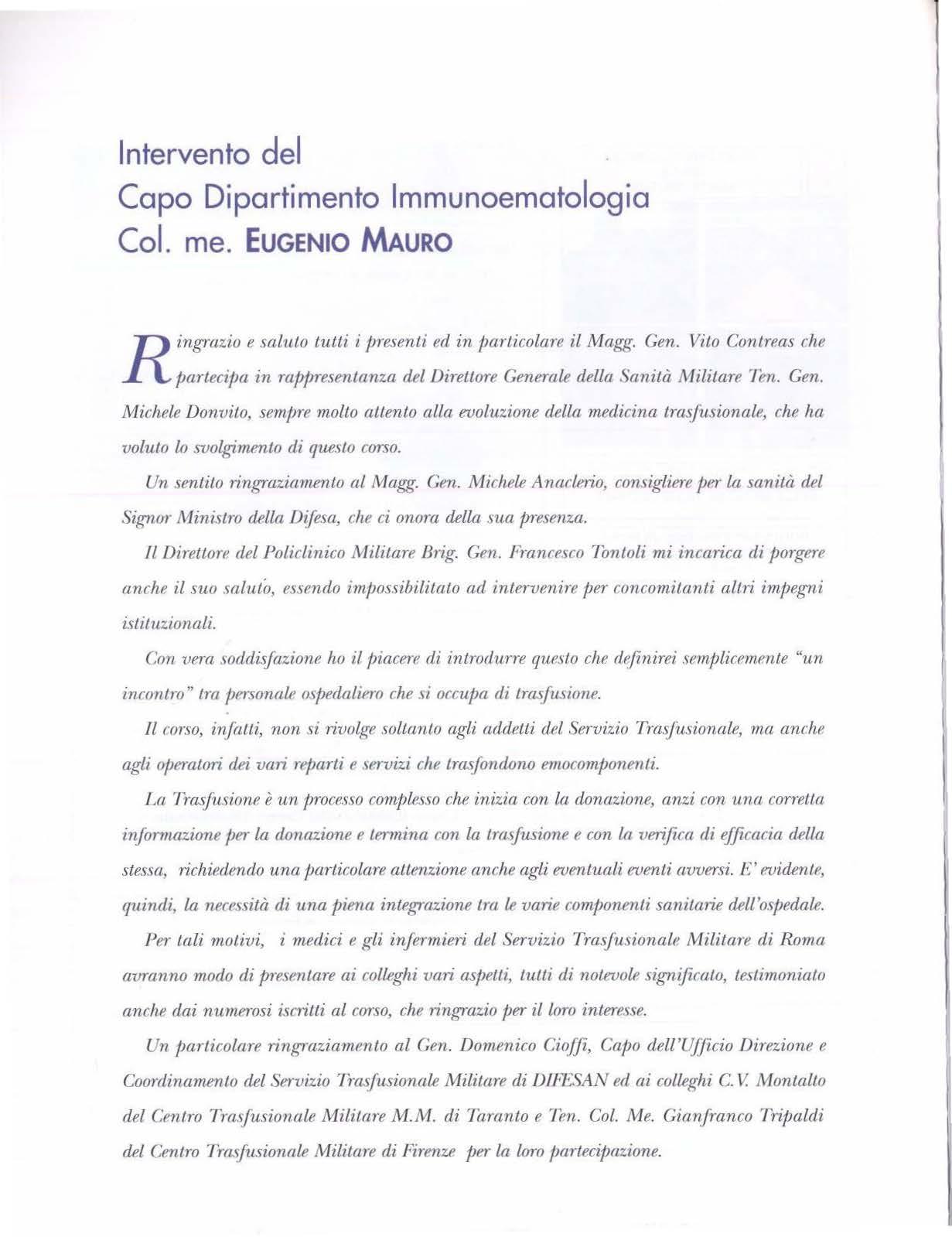
Ringrazio e saluto tutti i /Jresenti Nl in particolarP il Magg. Gen. Vito Conlrms che partecipa in rappresentanza dPl Direttore Gent>rale della Sanità MilitarP Tm. Gen. Michele Donvito, sempre molto allento a/La evoluzione della mfdicina trasfusionale, rhe ha voluto lo svolgi:menlo di questo rorso.
Un sentilo ringraziamento al Magg. Gen. MiclLPle Anarlmo, consiglierP pn la sanità del Signor Ministro della Difesa, rhe ci onora delù1 .ma presmza.
Il Direllore del Policlinico Militare Brig. Gen. f"ranCPsro 7òntoli mi incarica di porgMe anchP il suo saluto, essendo im/1ossibilitalo ad intervenire per roncomilanti altri impegni istituzionali.
Con vera soddisfazione ho il /Jiacere di introdurre questo che definirei semplicemente "un incontro" tra /Jersonalf ospedalirro che si occupa di trasfusione.
Il rorso, infalli, non si rivolge soltanto agli addetti del Servizio Trasfusional<1, ma anche agli operatori dei vari reparti e ~ervizi rhP trasfondono emoromponenti.
La Trasfusione è un processo complPsso che inizia con la donazione, anzi con uuo con·ella informazione per la donazioni' P tPrmina con la trasfusioni' e con la verifica di efficaria della stessa, richiedmdo una partù;olarP attenzione anche agli eventuali eventi avversi. 8' evidente, quindi, la necessità di una pinw integrazione tra IR variP romponenli sanitarie dell'os/Jedale.
PP'r tali motivi, i rnPdici e gli infermieri del Servizio Trasji.J.sionall' Militare di Roma avranno modo di presmlare ai roll.eghi vari aspelli, lutti di notevoli' signifiralo, testimoniato anchP dai numerosi iscritti al corso, rhe ringrazio per il loro interesse.
Un /1articolare ringraziammto al GPn. Domenico Cioffi, Capo dell'Ufficio Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare di DIFESAN ed ai colleghi C. V. Montallo del Cmtro Trasfusionale Militare M.M. di Tamnto e Tr>n. Col. Me. Gianfranco Tripaldi del Centro Trasfusionali' Militare di Firenze per la loro partecipazione.
m occasione del J72° Anniversario dello costif'Jzione del Corpo
// Ten Gen Michele Donvilo. Direi/ore Generale dello Sanità Militare e Capo del Corpo d1 Sanità dell'Esercito
consegno l'ANesfoto al /'0.er1k> dello Sanità Militare al Col.me. Eugenio /vlouro. Direffore del Centro Trasfusionale del Po/1c/in,co Militare di Roma

Gratitudine intendo man~festare al Ten. Col. me. Stt>fano Tranquilli ed al suo staff di DIFESAN per aver provveduto alla organizzazione dell'evento.
J\ll i sia permesso, in questa sede, citare i ronvenzionati civili del Dipart imento di Immuno ematologia per la loro qualificatissima collaborazione quotidiana. La dottoressa
Ileana Galani, biologa e garante della validazione biologica degli emocomponenti; !,e dottoresse
Susanna Pano e Laura Majjei che presenteranno proprie relazioni in questo wrso; i coll,eghi ematologi Maurizio Bartolini e Pi ero lacovino della Struttura Complessa di Ematologia dell'Azienda OsjJedaliera S . Giovanni Addolorata, diretta dalla professoressa Luci ana
Annina La crescita qualitativa del nostro Dipartimento si deve anche al loro validissimo e significativo contributo .
Cenmonio Sanitario dell'Esercifo.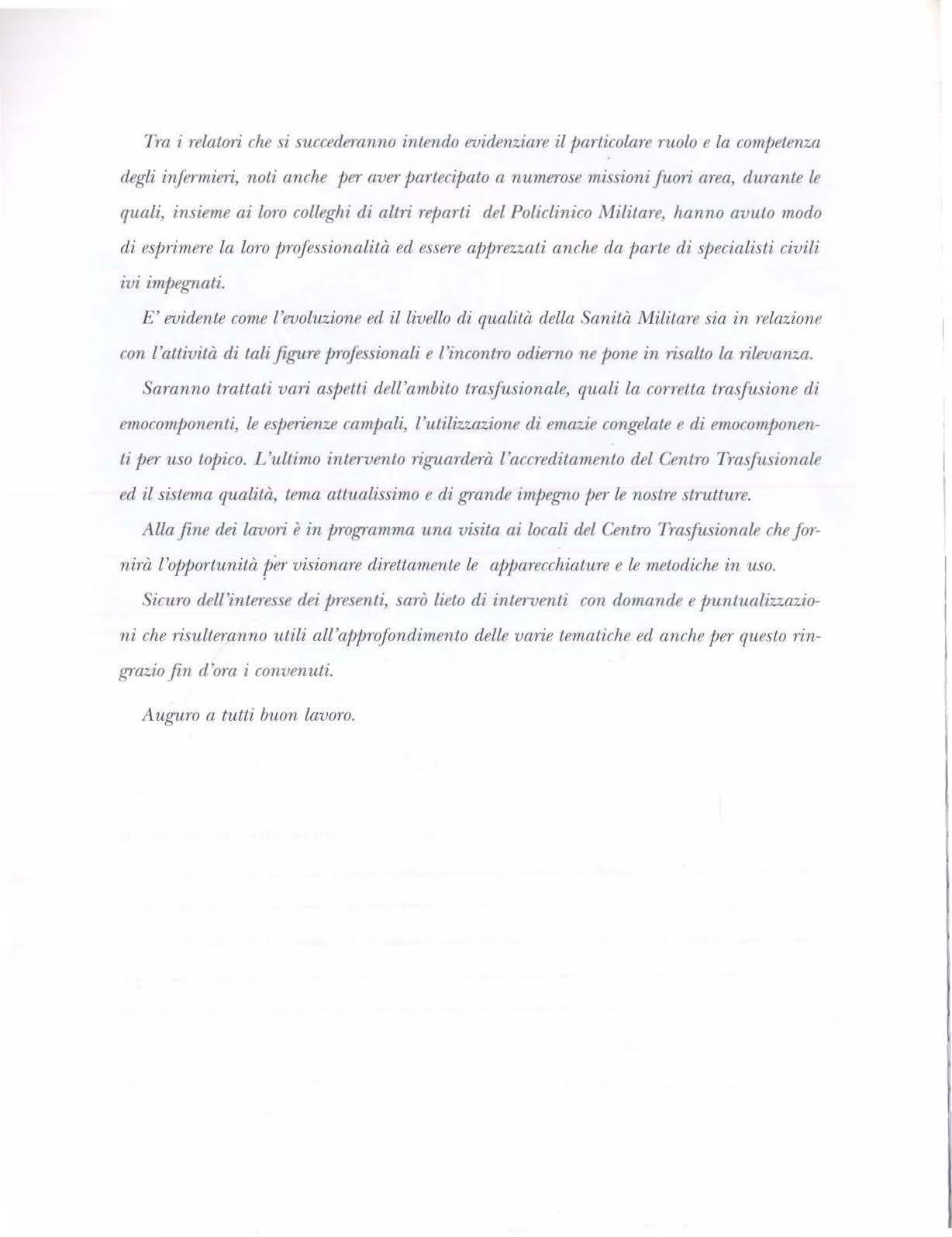
1Ì'a i relatori che si succederanno intendo evidenziarf il /Jarticolare ruolo e la rom/Ntenza
degli injfrmieri, noli anche /><Yf aver parlPripato a numerosP missioni fuori arPa, durante le quali, insieme ai loro colleghi di altri re/>arti del Policlinico Militare, hanno avuto modo di esprinu>re la loro professionalità ed essPre apprezzali anrhP da parte di specialisti civili ivi impegnati.
E' evidente carne l'Pvoluzione ed il livello di qualità della Sanità Jvlililare sia in relazione con l'allivilà di tali figure professionali e l'incontro odierno ne pone in risalto l-tt rilevanza. Saranno trattali vari as/Jefli drll'ambito trasfusionale, quali la corrrtta trasfusione di emocomponenti, le es/Jerienze mmpali, l'utilizzazione di emazie congelate e di emocomponenti f>er uso topico. L'ultimo intervento riguarderà l'accreditamento del Centro Trmfusionale ed il sistema qualità, tema atlualissirno e di grande imjJegno per le nostre strutture.
Alla ji,nf dei lavori è in pro!fmmma una visita ai locali del Centro TrasfllSionale che fornirà l'opportunità p'er visionarP direttamn1 te le afJparecchiat ure e le metodiche in uso.
Sicuro dfll'interessf dfi presenti, sarò lieto di inlr>rventi con domande e puntualizzazioni che risulteranno utili all'ajJjJrofondimento del/,e varie tematiche ed anrhP j1er questo ringra:io fin d'ora i convenuti.
Auguro a tutti buon lavoro.

!'Jtt,tato al merito btlla 6anità JtlHitare
/\14Lmfra ~rZtsfusian:tlt heJ Jlalidinira c#llilifzare <iLeli:a
•tr il biutumo t btttrminantt contributo tornito con chiara comptttn) a . 11lt,11ìma prof t11ionalità t
ottimalt g:tstiont bi uomini t mtHi ntll ' usicurart un puntualt t rigoro•o supporto tra•f usionalt in •atria t fuori arra t ptr quanto (atto a tuttla t 1illbaQ11arbi4 btlla bila umana.
~llUl , 4 <6mgnu 2005 ~1 ~inffgn limraù blla.,iamtà~ilitan trn. • ~it\tlt ~inorifJJ
The Second European Federation of Neuropsychiatry Congress
22-24 November 2007
Convitto della Calza
Florence ltaly
Pre si dent: Pr of M Tr imble (UK ) Chai rman: Prof F Monac o (I)
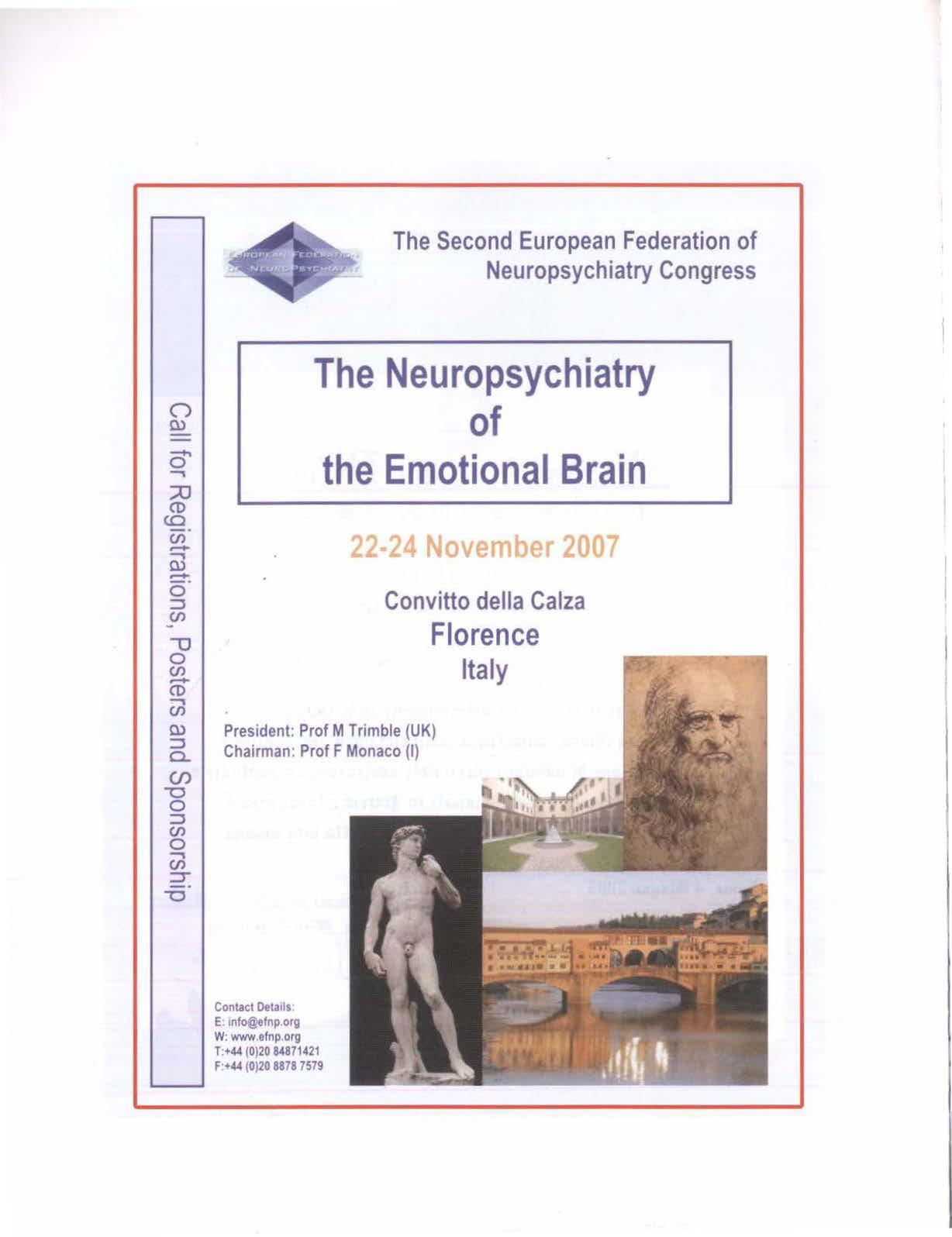
Contaci Oeta1ls · E 1nfo@efnp org W: www .efnp.org
T:+44 (0)20 84871421
F·+44 {0)20 8878 7579
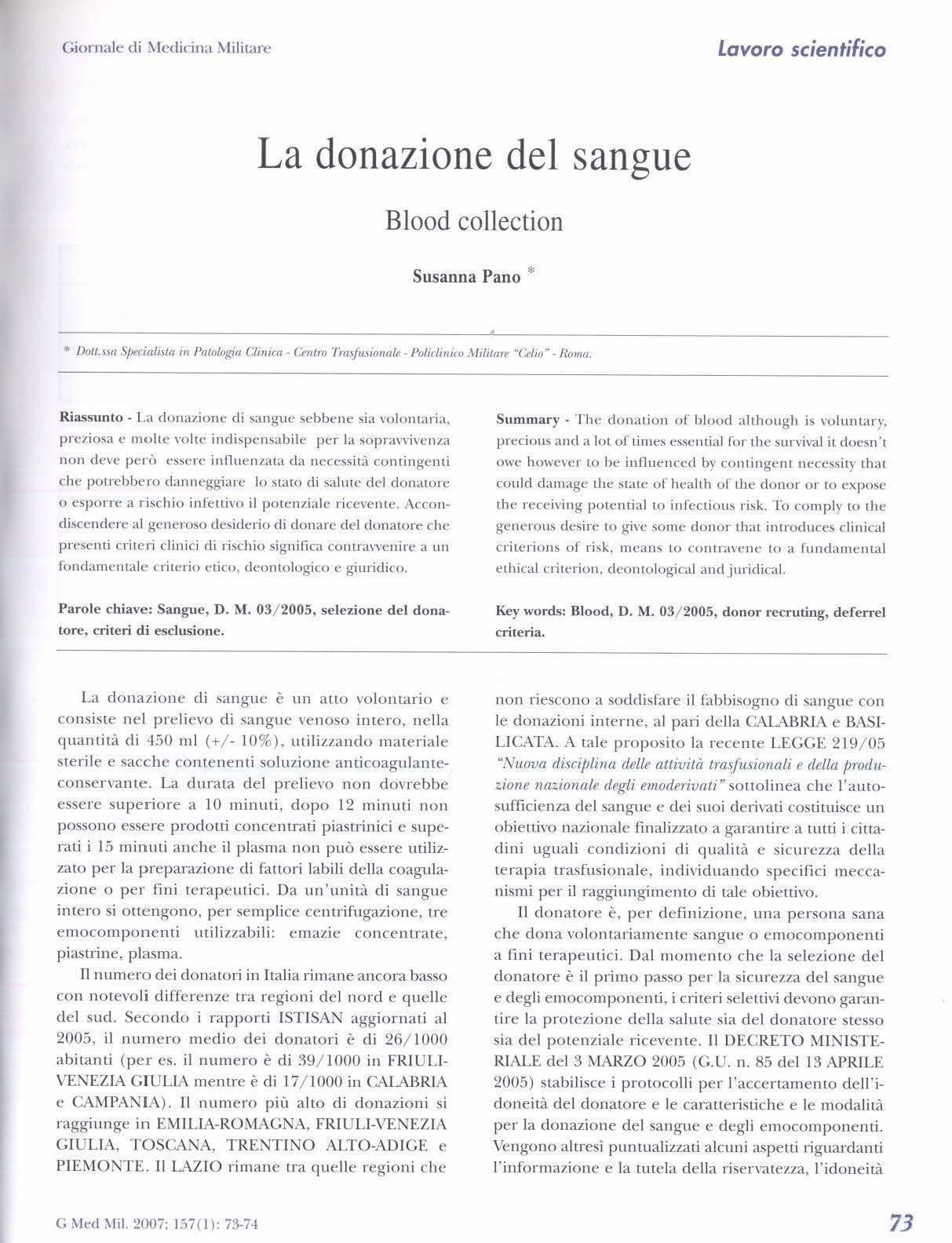
·* Dott.is,1 Specialista i11 Patologia Clìnira • Cmtro Tm-.Jmùma/,e • Policlinico Militar, "C,e/w" -Ro//la.
Riassunto - La dona;,jone di sangue sebbene sia volonca1·ia, preziosa e multe volte indispensabile per la sopravvi\'cnza non deve penì esse-re influenzala da necessità conting·enLi che potrebbero danneggiare lo stato di sa l 11te del donatore o esporre a rischio infeLtivo ìl potenziale ricevente. Accon• discendere al generoso deside1-io di donare del donatore che presenLi criteri clinici di ,·ischio significa contravvenire a un fondamentale criterio etico, deontologico e gìu 1idico.
Parole chiave: Sangue, D. M. 03 / 2005, selezione del donatore , c rite ri di esclusione.
La donazione di sangue è un alto volontario e cons iste nel prelievo d i sangue venoso intero, nella quantità di 450 ml (+/- 10 %), utiliaando materiale steri l e e sacche contenenti soluzione anricoagulanteconservante. La durata ciel prelievo non dovrebbe essere supe1·iore a 10 minuti. dopo 12 mimai non possono essere prodotti c.oncentrnti piastrinici e superati i 15 minuti anche il plasma non può essere util izzato per l a preparazione di fattori labili della coagulazione o per fini terapeutici. Da un ' unità di sangue intero si ottengono, per semplice centrifugazione, tre emocomponenci milizzabili: emazie concentrate, piastrine, plasma.
n numero dei donatori in Italia rimane ancora basso con notevoli differenze tra regioni de l nord e que ll e del sud. Secondo i rapporti fST I SAN aggiornati a l 2005 , il numero medio dei donatori è di 26/1000 abiLanti (per es. il numero è cli 39/1000 in FRIULIVENEZIA GIULIA mentre è d i 17/10 00 in C.ALABRl A e CAMPANIA). li numero più alto di donazioni s i raggiunge in EMILIA-RO MAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO-ADIGE e PIEMONTE. Il LAZ IO rimane tra que ll e regioni che
Summary - The donation of bloocl although is vo l untary, precious ancl a lot of limes essen tfal for tbe survival il doesn ' r owc how ever LO be in11uenrcd by cont ì ngent necessìry that co1ilcl damage the state of health or the donor 01· to expose rhc receiving potenLial LO inf'ectious rbk. To comp\y co che generous desire Lo give some donor Lhat introduces clinica! criterio11s uf risk. means LO cuntn1n~11c to a fundamemal eLltical crilerion, cleont0logical and jnridical.
Key words: Blood , D. M. 03 / 2005, donor recruting, deferrel cri te ria .
non riescono a soddisfare il fabbisogno di sangue con. le donazioni interne , al pari della CAI.ABRTA e BASILICATA. A tale proposito la recente LEGGE 219/05 "Nuova disr.iplina dell.e attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" sottolinea che l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivali costituisce un ob ie rtivo nazionale finalizzato a garamire a mtti i ci ttad i ni uguali condizioni cli qualità e sic urezza della Lerapia trasfusionale, individuando spec ifi ci meccanismi per il raggiungimento d i tal e ob iettivo.
Il donarore è, per definizione , una persona sana ch e don a vo lontariamente sangue o emocomponenti a fi ni terapeutici. D a l moment0 che la selezione del donatore è il primo passo per la sicurezza del sangue e degli emocomponemi, i cri teri se letth~ devono garantire la pro tezi one della salute sia de l donatore stesso sia de l potenzi ale ricevente. 11 D ECRETO Mi l\'lSTERlALE del 3 MARZO 2005 (G.U. n. 85 de l 13 APRILE 2005) sLabilisce i protocolli per l 'accertamento de ll 'idone i tà ciel donatore e le caratte1isti che e le modalità per la donaz i one del sangue e deg li emocomponemi Vengono altresì puntualizzati alcuni aspetti 1iguardanti l'informazione e l a tutela de ll a riservatezza. l'ido n e i tà
alla donazione, il consenso informato , g li esami obbligatori da eseguire ad og11i donazione ed i controlli periodici solitamente annuali. La presenza di alcune patologie, l'assunz ion e di determinati farmaci anche a scopi 11011 terapeuùci (ad esempio stero idi o ormoni a scopo di culturismo fisico) o particolari stili di vita. determinano criterio di esclusione temporanea o permanente del candidato donatore per la tutela della salute propiia e/o del potenziale ricevente. La va l utaLione delle cond izi oni genera li di sa lute deve essere eseguita "con particolare attenzione a si tu azion i quali debi l itazione, iponutriLione , e d e mi , ittero. anemia, c ian osi, dispnea, instab ilità mentale, intoss icaz ione a lcolica, uso di stupefacenti e abuso di far maci''. I risu ltati della valutazione devono essere riportati nell'apposita ca rte ll a sani taria. L'unità di sangue racco lta , per essere validata biologicamente, deve risultare negativa a lla sierodiagnosi per: LUE, HIV-Abl-2 , HBSAg, IICVAb, HCV NAT. L e TRANSAMINASI ALT (con metodo ott imi zzaw) non devono superare due vo lt e il limite normale. La regione LAZIO", come molte altre, ha esteso la i;cerca del gcnomà virale anche per HB V ed HIV; permettendo il raggiungimento di un grado di sicurezza degli emocomponenti cd emoderivati mai raggiunto in passato. Nel caso dell' H CV la ricerca NAT è in grado di evidenziare i cost itu e nti virali in media dopo tredici g iorni dall'infezione. Inoltre, la contemporanea determ in azione del titolo anticorpa le associata alla ricerca del gcnorna virale, ha permesso di ridurre ulteriormente il rischio in fetùvo trasfusionale intervenendo anche in quelle situazioni in cu i la so la ricerca degli ant i corpi o ciel genoma non sarebbe potuta essere s uffi ciente a sve lare una patologia infettiva. Esistono, infatti, situazioni in cui g li anticorp i antiHCV sono positivi, il test di conferma RIBA risulta positivo mal' HCV NAT è negativo: ci ò può indicare o una pregressa infezione da HCV senza più replicazione viral e. opp ure una cu infezione da HBV che a volle inibisce la replicazione virale del virus dell'epatite C. Il riscontro cli HBSAg n egativo con HBV NAT positivo può essere presente nei mutanù cscape opp ure in soggetti portatori di bassi li ve lli di HBSAg non rilevabilj dalle comuni metodiche cli laboratorio (sarebbe quindi opportuno valutare anc h e l ' HB CAb) .
In co nclusi o n e , l'at ùvi tà svolta quotidianamente dai Cen t ri Trasfusionali mira ad un ulteriore passo sui percorsi di qualità a fi anco dei D onato1; per ass icurare ad ogn i malato la mi g li or cura possibile e la più adeguata, ricordando sempre che il sangue è un bene
ins ostituibi.le perché non è sintetizzabile in laborarorio, prezioso perché' disponibile in quantità limitata, indispensabile alla terapia e a ll a sopravvivenza.
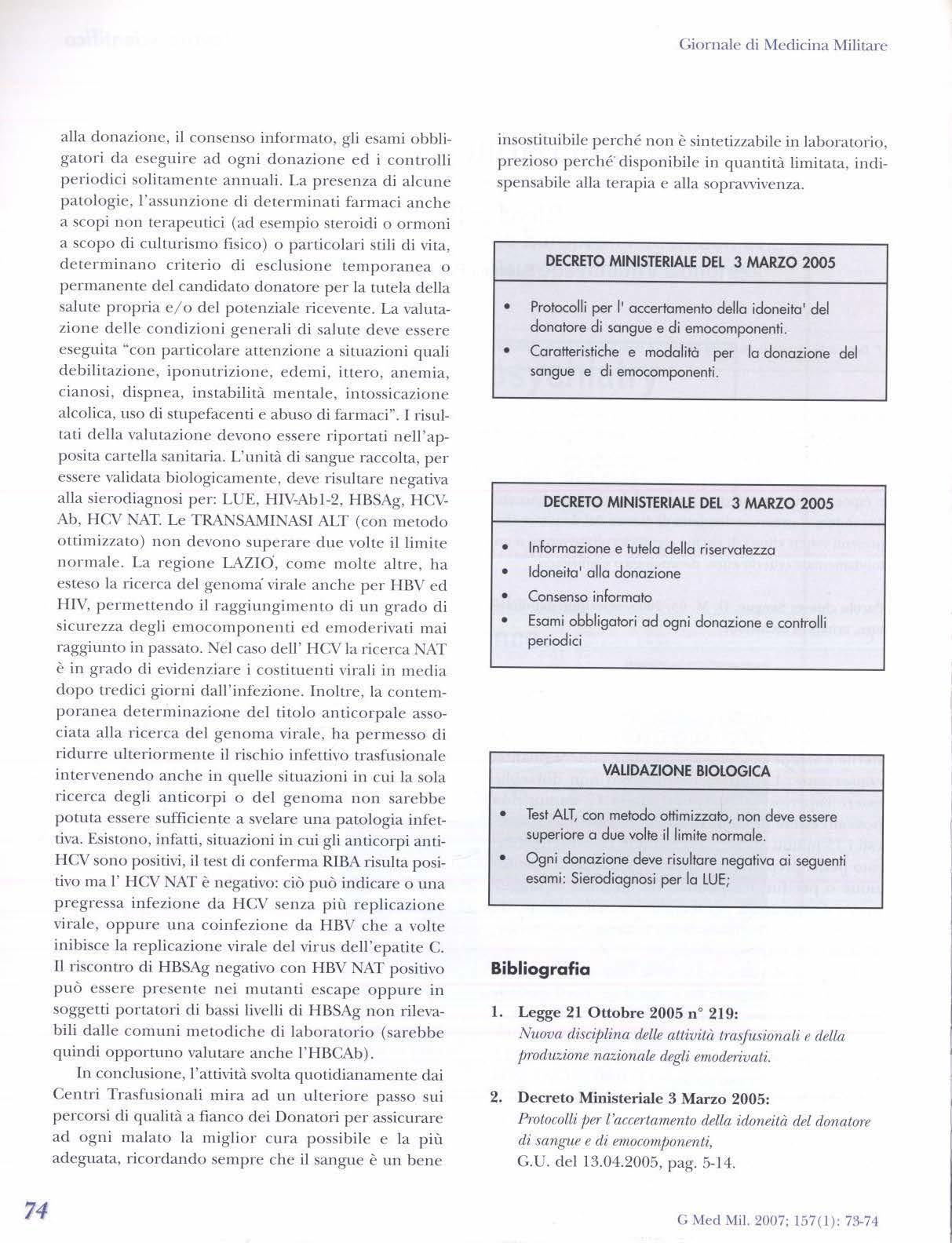
DECRETO MINISTERIALE DEL 3 MARZO 2005
• Protocolli per I' accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti.
• Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti
DECRETO MINISTERIALE DEL 3 MARZO 2005
• Informazione e tutela della riservatezza
• ldoneita' alla donazione
• Consenso informato
• Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici
VALIDAZIONE BIOLOGICA
• Test ALT, con metodo ottimizzato, non deve essere superiore a due volte il limite normale.
• Ogni donazione deve risultare negativa a i seguenti esami: Sierodiagnosi per la LUE;
1. Legge 21 Ottobre 2005 n ° 219: Nuova disciplina dell,e (rttivilà trasfusionali e della produzione nazionale d!!gli enwd,erivati.
2. D ecre to Ministeriale 3 Marzo 2005: Protocolli per l 'accr>rtamenlo della idoneità del donatore di sangue e di ernocom/;onmti, G.U. ciel 1 3.04.2005, pag. 5- 14
* Dol/.1sa Specir,b.sta in Ematologia• Cen/ro 7ìw,fusionale - Polirlù, iro Militare "Celio" - Roma.
Riass unto • Con il termine anemia i in tend<' u na riduzione drllaconcentrazione di emoglobina ( H b) cli un soggeuo supe1iore al 10% rispetto ad un soggetto sano de llo stesso sesso cd età, che viv11 alla stessa altitudine e che abbia lo ste~so tipo di emoglob ina. Oltre alle patologie emacologiche che primitivamente si caratterizzano per la pre~enza di anemia (Mielod isplasie, Anemia Aplastica, Emoglobinopatie e Talass<'mic, Anemie Emo l it iche), l'anemia è ~pesso un segno e s i ntomo che si accompagna a numerose patologie di interesse internistico e / o ch irurgico ed oncoloi.,>ico. La conta rcticolocitar ia e il <:alcolo dell 'indice reticolotita,io sono utili per una prima diagnosi d ifferenziale trn anemie iporigenerative ed anemie da perdit.a o di.,truzion!" critrocita ria. Nella patogenesi dell'anemia da ma.lattia cronica si possono sm,~tppone più cause quali LUl deficit di fonzionc mido llare, tma carenza marziale e vi tam in ica e la perdita e / o disu·ut.ione e1iu·ocit.aria.
Parole chiave : Ane mia , indice retic olocitario , malattie croni ch e, epcidina.
Summary - A n aem ia means a red u ction in H b concentrat.ion in a s u bject m~jor than 10% compared LO an heal Lhy sub jcct age and sex matc h ed, l iving al ù1e sarne alti rude and presenting t bc same haernoglobin type. In addition to haemawlogicaJ diseases primarly character izcd by anaemia (M)'elodisp lastic Synclromes. Aplastic Anacmia, l laemoglobinopathies and Thalassemias. H acrnolytk Anaemias). anaemia is ofte n a sign and a symprom a,companying man)' imernal, surgical and onco logical discascs. T h e reticulocyte co u nt and i ndex a re u sefu l in d i ffc r cntiating Hyporigenerative anaemia and hlood loss or destruction anaemia In chron ic disease anaemia pathogcnesis many factors ovcr lap suc-h as bone marrow f'a i lure. iron and YÌLamin defi<:it and b l ood loss and / or destrunion
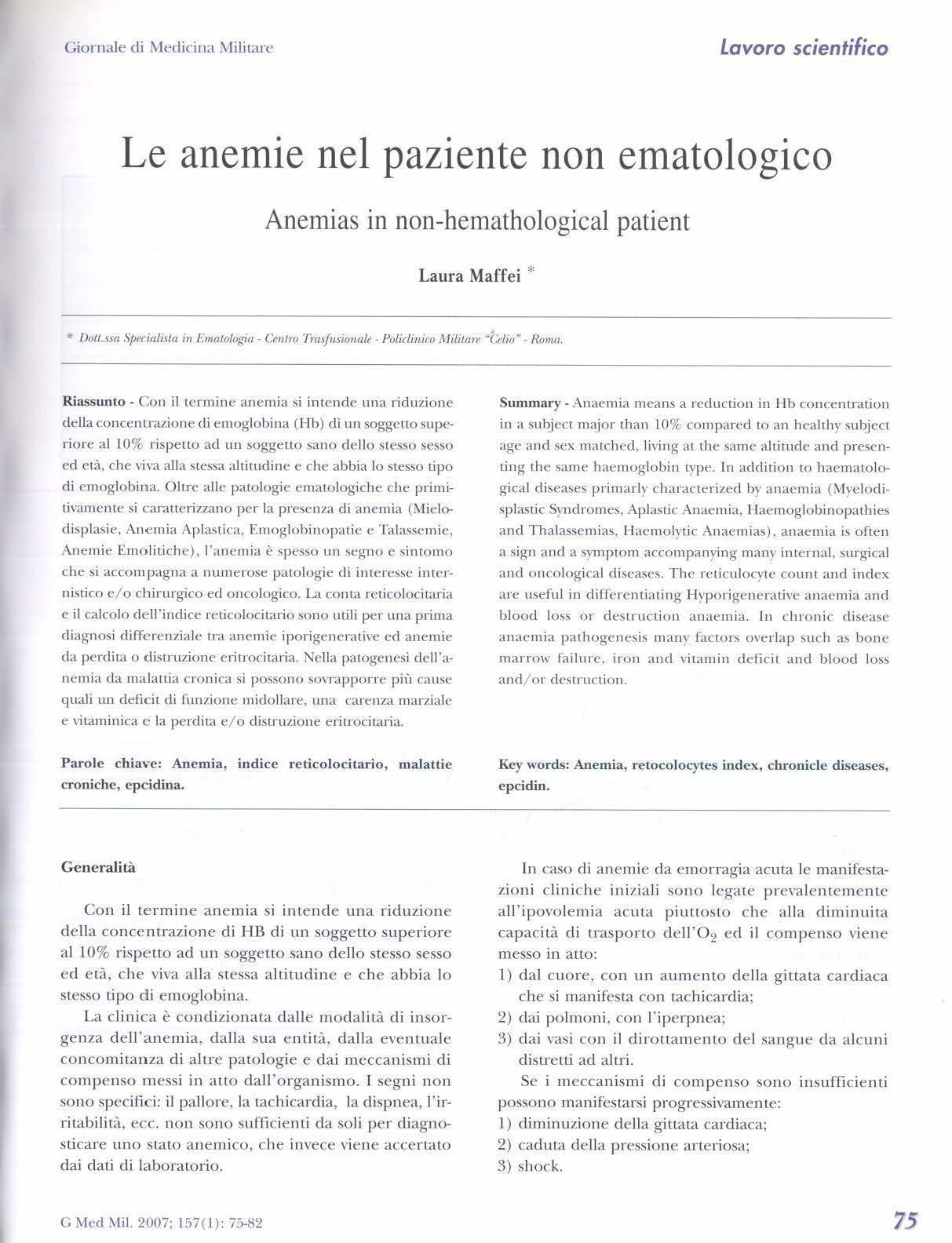
Generalità
Co n il te rmi ne a n emia s i imende u na r i d u zione de ll a co n ce n t r az ione di HB di u n soggett o su p e ri o re a l l O% ri spetto ad un sogge tto sano d e ll o s tesso sesso ed e tà. c h e v iva a ll a stessa a l tit u d i ne e c h e abb ia lo s tesso Lipo d i emoglob i na .
La clinica è condi zionata da ll e m o d al ità d i in sorge n za dell'anem ia, d alla s u a ent i tà, da ll a event u a le concom i tan za d i a l tre pat o logie e d ai meccan ism i di co m penso messi i n atto dall 'organismo. I segni non sono spec ifici: i l pall ore, la tachicardia, la d is pn ea, l' irr i tab ilità, ecc. non sono sufficienti da so li p er di agnos ti ca r e u no sta to anemico, che i nvece viene accertato daj d aù di laboratori o . G
Key words : Ane mia , re to col ocytes iudex, chrouicl e diseases, e pcidin.
In caso di anem ie da emorragia acu ta le man ifestaz ion i cl ini c h e in iziali sono legate pn'Yale n temenLe a ll ' i povo l emia ac u ta p iu ttosto che a ll a d imin uita capacità d i trasporto de ll 'O 2 ed il compenso viene messo in atto :
1 ) da l cuore, con u n au m e n to de ll a gittata card iaca c h e si m a ni festa con tach icardia;
2) dai pol moni, co n l'iperp n ea;
3) dai vas i co n il d iroua m e n to de l sangue da alc un i distre t ti ad al tri
Se i m ecca n is mi d i compenso sonu i nsufficie n ti possono manifestars i progressi vamen t e :
l ) d i m inu zio n e de lla gitta ta card iaca;
2) caduta d el la pressi one arteriosa; 3) sh oc k
Nelle a nemie a lema insorgenza la massa sanguigna circolante rimane sostan.lialmcnte stabile e le manifestazioni cliniche so no legate al d i minuito trasporto tissutale di 0 2 e ai meccanismi di compenso correlati con la riduzione della massa eritrocitaria che si metlono in atto a livello:
1) molecolare (eritrocitario e tissutale) con una sommazione di effetti legata a modificazioni de l p H , della C02 e del 2,3 DPG che portano ad una riduzione di affinità dell'emoglobina per 1'02 con conseguente aumentata cessione di 0 2 ai tessuti.
2) circolawrio e dinamico, a livello dell'apparato cardiovascolare mediante un aumento della gittata cardiaca da una parte ed il dirottamento ciel flusso sanguigno dagli organi o tessuti a basso consumo di 02 verso quelli ad alta estrazione di 0 2 (Tab. 1). La capacità di adattamento dell'organismo fa sì che un soggetto tolleri bene livelli mo lto bassi di emoglobina, talvolta oltre il 50% dei livelJi normali nel caso d i anemie croniche, mentre è sufficiente la perdita rapida di un terzo della massa emoglobinica perché si manifestino col lasso cardiocircolatorio e shock. Le manifestazioni cliniche del l'a nemia, elencale secondo l'ordine di insorgenza e gravità sono riassunte nella tabella 2.
Classificazion e
Le anemie possono essere classificate da un punto cli vista cinetico o da un punto di \ista morfologico. Queste classificazioni non sono mutualmente esclusive, ma , anzi, si integrano a vicenda. In ogni caso, nell 'approcc io diagnostico di uno stato anemico, il primo parametro da valutare è rappresentato dai reticolociti ed in particolare dalrindicc reticolocita1io, in cui la conta relicolocitaria è corretta in base a ll 'emaroc1ito del pazi e nte (Tab. 3) e che consellle di orientarsi in modo semplice e rapido verso un 'ane mia da perdita o distruzione eritroc itaria 1·ispetw ad una iporigenerativa, sia essa di natura carenziale o no.
Sul piano morfologico le anemie si classificano in:
l) Normoci tiche normocromiche;
2) Macrocitiche normocrom iche;
3) Microcitiche ipocromiche.
I no l tre l'osservazione di anisopoichi l ocitosi o di altre partico lari atipie morfologiche eritrocitaric (sferociti, ellirrociti, ecc.) fornisce ulteriori i ndicazioni circa la natma d e ll'anemia.
TAB. l · PY02 DEI VARI TESSUTI
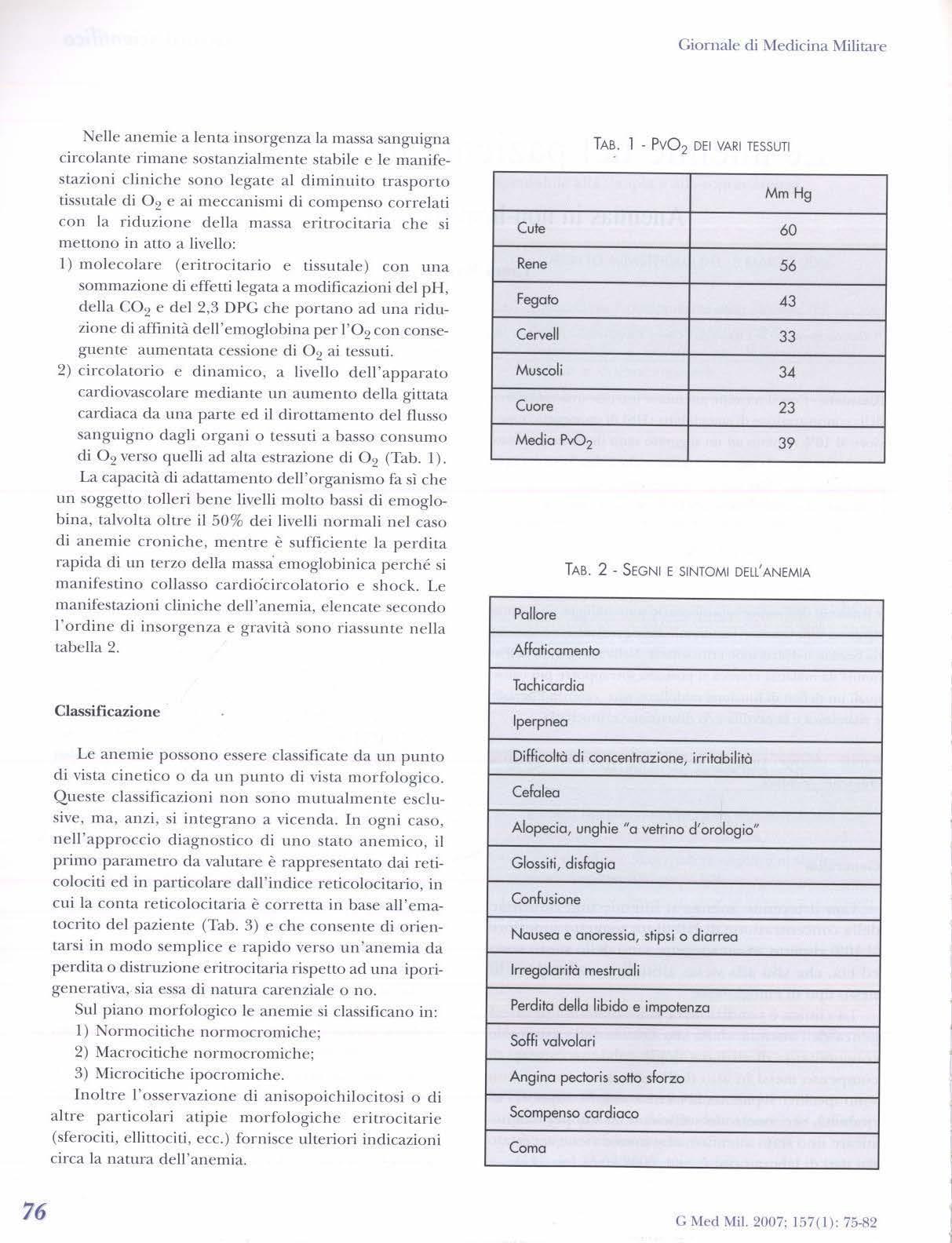
Pallore
Affaticamento
Tachicardia
Ipe rpnea
Difficoltà di concentrazione, irritabilità
Cefalea
Alopecia, unghie "a vetrino d 'orolog io"
Glossi ti, disfagia
Confu sio ne
Nausea e anoressia, stips i o diarrea
Irre golari tà mestruali
Perdita d e lla lib ido e impotenza
Soffi valvolari
Angina pectaris sotto sforzo
Sco mpenso c ard iaco
Coma
TAB 3 - C ALCOLO DELL'INDICE RETICO LOCI TAR IO [IR)
IR = (Reticolociti % x Ht del paziente / 45)/FC
Se IR<l = anemia iporigenerativa.
45= valore di Ht norma le; FC= fattore di correzione, che varia in base all'ematocrito
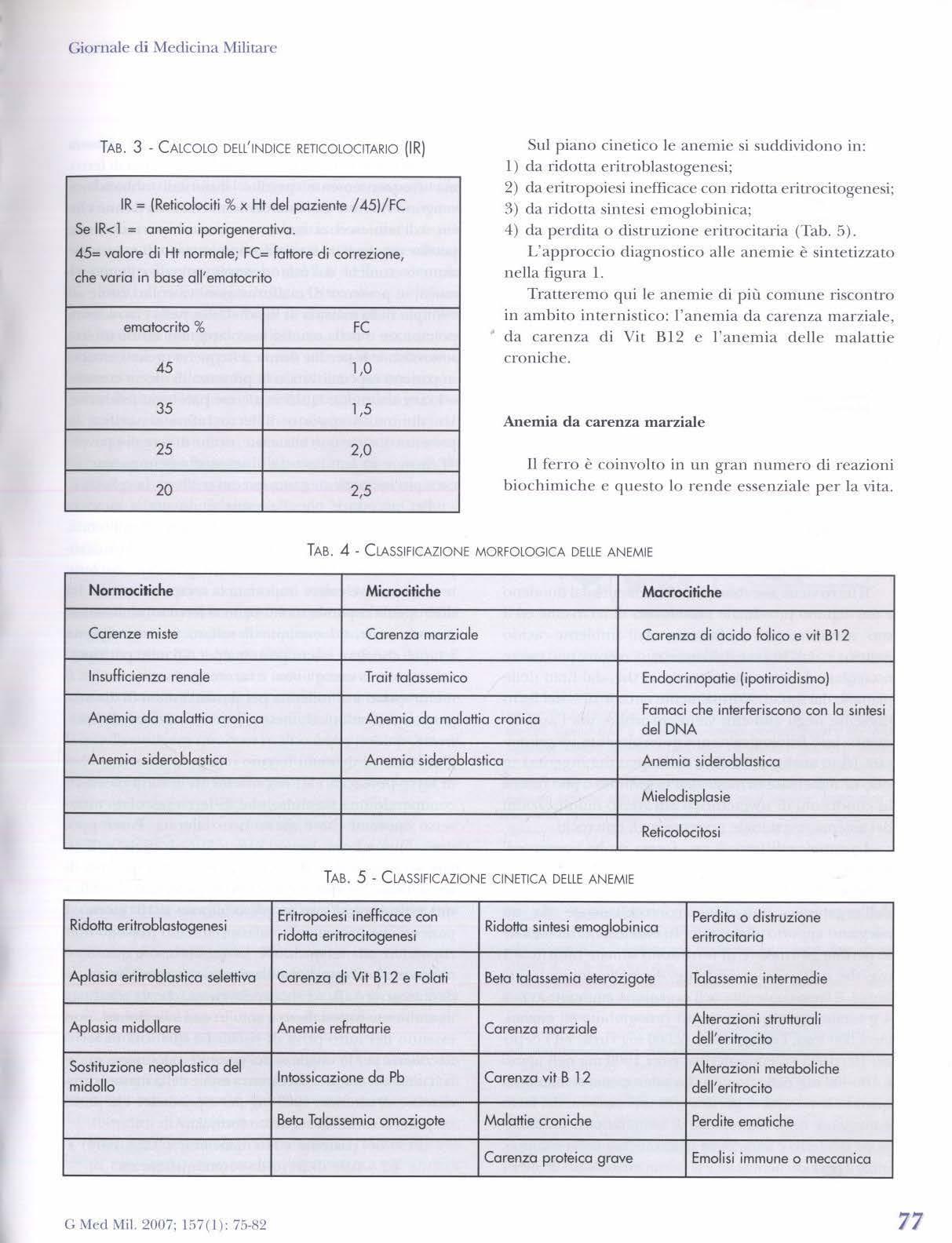
Normocitiche
Carenze miste
Insufficienza renale
Anemia da malattia cronica
Anemia sideroblastica
Su l piano cinetico le anemie si sud dividono in:
1) da ri dotta eritroblaslOgencs i;
2) da e1itropoiesi inefficace con 1idotta ei-itrocitogenesì; 3) d a ridotta simes i cmogl obin i ca; 4) da perdit.a o distr u zi o n e er itrocita1·ia (Tab. 5).
L ' a p procc io diagnost ico a ll e anemie è sintetizzato nella figura 1.
T ratte r emo qui le anem ie d i più comune 1iscontro in a mbito i n ter ni stico : l'anem i a da carenza marziale, ' da care n za d i V i t 81 2 e l 'anem i a de ll e ma lattie cro ni c h e.
Ane mia da c arenza marz ia le
li ferro è coinvo lt o in u n gran numero dì reaz ioni biochimic h e e qn esro l o rende essenziale per l a vita.
TAB. 4 - C LASSIFICAZIONE MORFO LOGICA DELLE ANEMIE
Microcitiche
Carenza marziale
Trait tala ssemico
Anemia da malattia cronica
Anemia sideroblastica
Ridotta eritroblastogenesi
TAB. 5 - CLASSIFICAZIONE CINETICA DELLE ANEMIE
Macrocitiche
Carenza di ac ido folico e vii B12
Endocrinopalie (ipotiroidismo)
Fornaci che interferiscono con la sin tesi del DNA
Anemia sideroblastica
Mielodisplasie
Reticolocitosi
Eritropoiesi inefficace con Ridotta sintesi emoglobini ca
Pe rdi ta o distruzione ridotto eritroc itogenesi eritrocitaria
Aplasia eritroblastico selettiva Carenza di Vi t B1 2 e Foloti
Aplasia midollare Anemie refrattarie
Sostituzione neoplastico del Intossicazione do Pb
Belo ta lassemia eterozigote Talassemie intermedie
Carenza marziale
Ca renza vii B 12
Alterazioni stru tturali dell'eri trocito
Alterazioni metaboli che midollo del!'eritrocita
Beta Talassemia omozigote M a la ttie croniche
Perdite ematiche
Carenza proteica grave Emolisi immun e o meccanica
Giornale eh
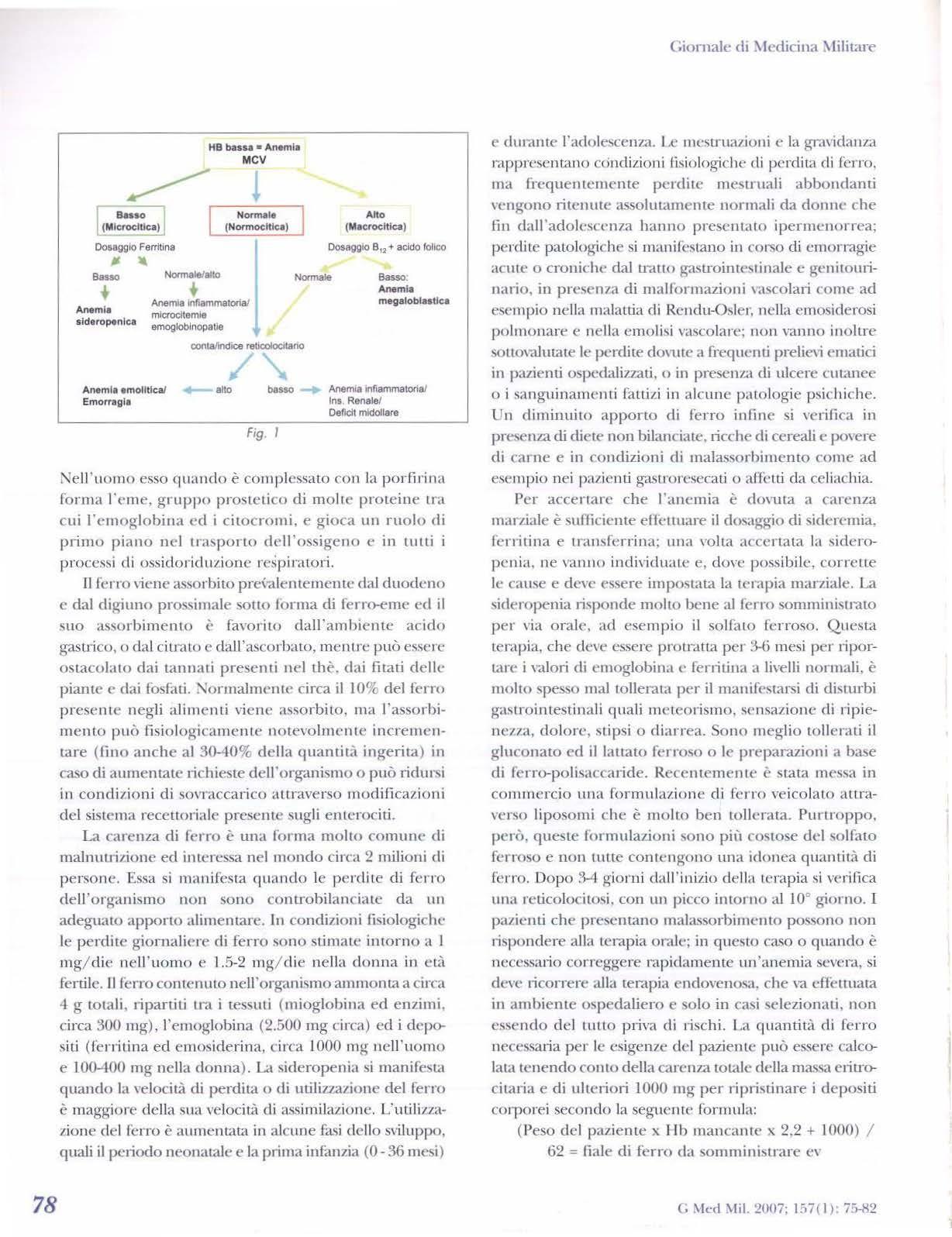
Basso (Mlcroclllca)
Dosaggio Ferritina
HB bassa • Anemia MCV
Normale (Normocltlca) Alto (Macrocitica)
Dosaggio B,, + acido folico
Basso Normale/alto Normale Basso
Anemia alderopenlca
Anemia lnflammatoria/ mlcrocdemte emogloblnopaue conta/Indice re!K:oloouino
Anemia tmollllca/ Emorragia i- alto basso
I
Anemia megalobtutlca
Anem,a infiammatoria/ lns Renale/ Deficit midollare
Nell'uomo esso quando è complc!>sato con la porfirina forma l'eme, gruppo prostetico di molte proteine tra cui l'emoglobina cd i citocromi, e gioca un ruolo di primo piano nel trasporto clcll'ossigeuo c in tutti i proces&i di ossidoriduzione re~pirawri.
TI ferro viene as!>orbito prefalentemcnt<· dal duodeno e dal digiuno pros,imale sotto forma cli ferro-eme ed il suo a&~orbimenlO t· fayorito dall'ambiente acido gasuico, o dal citraLO e dall'ascorbato, mentre può essere ostacola10 dai tannati presenti nel ù1è. dai fitati delle piante e dai fosfati. :S:ormahnellfe circa il 10% del ieno presellle negli alimenti viene assorbiw, ma l'assorbimento può fisiologicamente notevolrnernc incrementai-e (fino anche al 30-40% della quantità ingerita) in caso di aumentale richieste dell'organismo o può 1idtm,i in condi,ioni cli sovrncca1ico attraverso modificazioni del sistema recetwriale presellte sugli emerociti.
La carena di ferro è una forma mo lt o comune di malnuui,ione ed imeressa nel mondo circa 2 milioni cli persone. Essa si manifesta quando le perdile di fl:'rrO dell'organismo 0011 sono controbilanciate da un adeguato apporto alimentare. ln condi1ioni fisiologiche le perdite giornafa•re di ferro ~ono stimale intorno a 1 mg/die nell'uomo e 1.5-2 mg/ die nella donna in età fertile. li ferro contenuLo nell'organismo ammonta a circa 4 g totali, ripartiti tra i tessuti (mioglobina ed enzimi, circa :~OO mg). l'emoglobina (2.500 mg circa) ed i depos iti (ferritin a ed emosiderina, circa lOOO mg nell'uomo e 100400 mg nella donna). La sideropenia si manife\ta quando la ,elocità di perdita o di 11tilizzalione del ferro è maggi ore della sua veloc ità di a.~similazione. L'uliliaazione del ferro è aumentata in alcune fasi dello sviluppo, quali il periodo neonatale e la prima infaiuia (0 - 36 mesi)
e durante l'adole~cenza. Le mescrua,ioni e la gr.n iclanza rappresentan o cond izioni fisiologiche di perdita cli ferro. ma frequentemente perdite me..,truali abbondanti ,cngono 1itenute as.solutamcnte normali eia donne che fin dall'adolescenza hanno presentaLO ipennenorrea; perdite patologiche si manifestano i11 corso cli emorragie acute o croniche dal tratto gastrointe\tinale e genitomìnario, in presen,a cli malformazioni ,-ascolari come ad esempio nella malattia di Rendu-Osler, nella emosiclerosi polmonare e nella emolisi vascolare: non vanno inoltre souovalutate le pcrclite dornte a frequenti prelie,·i ematici in pazienti ospedalizzati, o in presenLa cli ulcere cutanee o i sanguinamenti fatliLi in alcune patologie psichiche. Un diminuito ap p orto di ferro infine si verifica in pre<,en.ta cli rlie1e non bilanciale, ricche di cereali e po,ere di carne e in condizioni di malassorbimento come ad e~emp io nei p,vienti gastrorcsecati o affetti da celiac hia.
Per accertare che l'anemia è dovuta a carenza ma11iale è sufficiente ellettuare il dosaggio di ~idc1 l·mia. ferritina e trnusferrina; una \'Olta accertata la sidcrop e ni a, ne vanno individuate e, clu,·e poss ibil e, corrette le cause e dc,·e essere impostata la terapia m,:ll'1iale. La ,ideropen ia 1isponcle molto bene al ferro somminisu-ato per via orale, ad esempio il solfato ferroso. Questa terapia, c h e den: essere protratta per 3-6 mesi per 1iportare i valori cli emoglobina e feniù11a a li,·elli nonnali, è molco spesso mal tollerata per il manifestarsi cli disturbi gastroimestinali quali met<>orismo, sensazione di ripien ena, dolore, stipsi o diarrea. Sono meglio tollerali il gluconato ed il lattato ferroso o le prepara7joni a base di (erro-polisaccaride. Recentemente è stata me~sa in commercio una formulazione di ferro ve icol ato attraverso liposomi che è molto ben tollerata. Purtroppo. però. queste formula.Lioni sono più costose del solfato ferroso e non wue contengono una idonea quantità di f<:'1To. Dopo 3-4 giorn i dall ' inizio <lella terapia si verifica una reticolocito~i. con un picco intorno al 10° gioi no. I p a,icnti che pre~entano malassorbimento possono non ri&pondere alla terapia orale; in quesw caso o quando è neccssa1io corregge re rapidamente u11 'anemia severa, si deve ricorrere alla terapia endovenosa, che ,-a effettuata in ambiente ospedaliero e solo in cm,i selezionati, non essendo del tutlo p1iva cli ,isc hi. La quantità di ferro n ecessaria per le csigeme del paziente può essere calcolala tenendo conto della caren7.a totale della massa e1itrocitaiia e di ulteriori l 000 mg per ripri~rinare i depositi corporei seco11do la seguente formula: ( Peso del pa1iente x l l b mancante x 2,2 + 1000) / 62 = fi ale di ferro eia somministrare cv
Anemi e da carenza d i vit B J2
La carenza di Vit Bl2 dovrebbe essere sospettata in tuui i pazienti con anemia di origine incerta e / o nei pazienti con disturbi neurologici. Essa diventa più frequente con il progredire dell'età, e la sua prevalenza varia nelle diverse casisitiche dal 2 al 15 % . a seconda dei limiti di normalità adortati. 011 re alle condizioni ereditarie, la carenza di Vit 13 l 2 si può manifestare per un insuflìciente apporto dietetico, come accade nei vegetariani e nei vegani , o per un malassorbimento, come avviene nelle condizioni di ridotta o assente produzione di fauorc intrinseco o nella ipo-acloridria in corso di gastriti autoimmuni, nella atrofia gastrica o in corso di terapie protratte con inibito1i di pompa protonica, IT2 antagonisrj o biguanidi. Ancora , una carenza di Vìt B 12 si può manifestare nei gastro o ileoresecati , o nei pazienti affelli da malattia Celiaca o Morbo di Crohn o ileiLi. li me-ccanismo di assorbimento ed il metabolismo della vit Bl 2 sono il1ustraù nella figura 2.
L'anemia da carenza cli VitB12 t· tipicamente un·anemia macrocitica con indice reticolocirario basso; tuttavia la macrocitosi può eSSC:'re mascherata dalla concomitante carenza marziale , comune in corso di gastriti, celiachia e M. dì Crohn. La carenLa di Vit B 12 deve essere sospeuata in tutti i paLienù che presentano un 'anemia inspiegata, sin torni neurologici o neuropsichici inspiegati, manifestazioni gastrointestinali. Devono inoltre essere considerati a rischio cli sviluppare la carema i soggetti anziani, considerata l'alta frequenza cli atrofia gastrica in questa popolazione, e i soggetti affetti eia patologie autoimmuni. l test diagnostici a nostra disposizione s0110:
• Dosaggio della Vit Bl2: economico e facilmente attuabi le, gravato però da ll a variabilità degli indici cli riferimento a seconda della metodica usata, con se nsibi lità e specificità discutibili (falsi positi\,i e falsi negat ivi)
• Dosaggio dell'Acido Metilmalonico: altamente sensibile ma costoso e non facilmente dispon i b ile. Aumenta in caso di deficit di Vit Bl2, la specificità è limitata dal fatto che in caso di insufficienza rena le può dare falsi positivi.
• Dosaggio de ll' Omocist.eina: altamente sensibile, ma poco specifico. Aumenra anche in caso di deficit di Acido folico e Vit 86, livelli condizionati anche da abitudini cli vita (fumo, alcol, caffè).
• Dosagg i o dcll'O l ouanscobalamina (ridoua in caso di carenza): promettente , ma costoso ed ancora
oggetto di swdio, altamente sensibile e promettente anche dal punto di vista rlella specifìcità. Una volta accertata la carenza, devono esserne accertate le cause, che son ben chiare in caso cli pazienti vegetariani o vegani o nei gastro ed ileoresecati o in caso di patologie gastroenteriche note. Negli altri casi è raccomandabile la gastroscopia , soprattutto nei pazienti più giovani. considerato l'aumentato rischio di insorge11La cli neoplasie gastriche maligne nei pazienti con anemia perniciosa.
Quando sono presenti anemia o segni neurologici deve essere somministrata Vit B 12. La terapia può essere effettuata per via orale nei casi di inadeguato apporto
GntnlnLMWI b'MI Cfnul•ti,o-q n
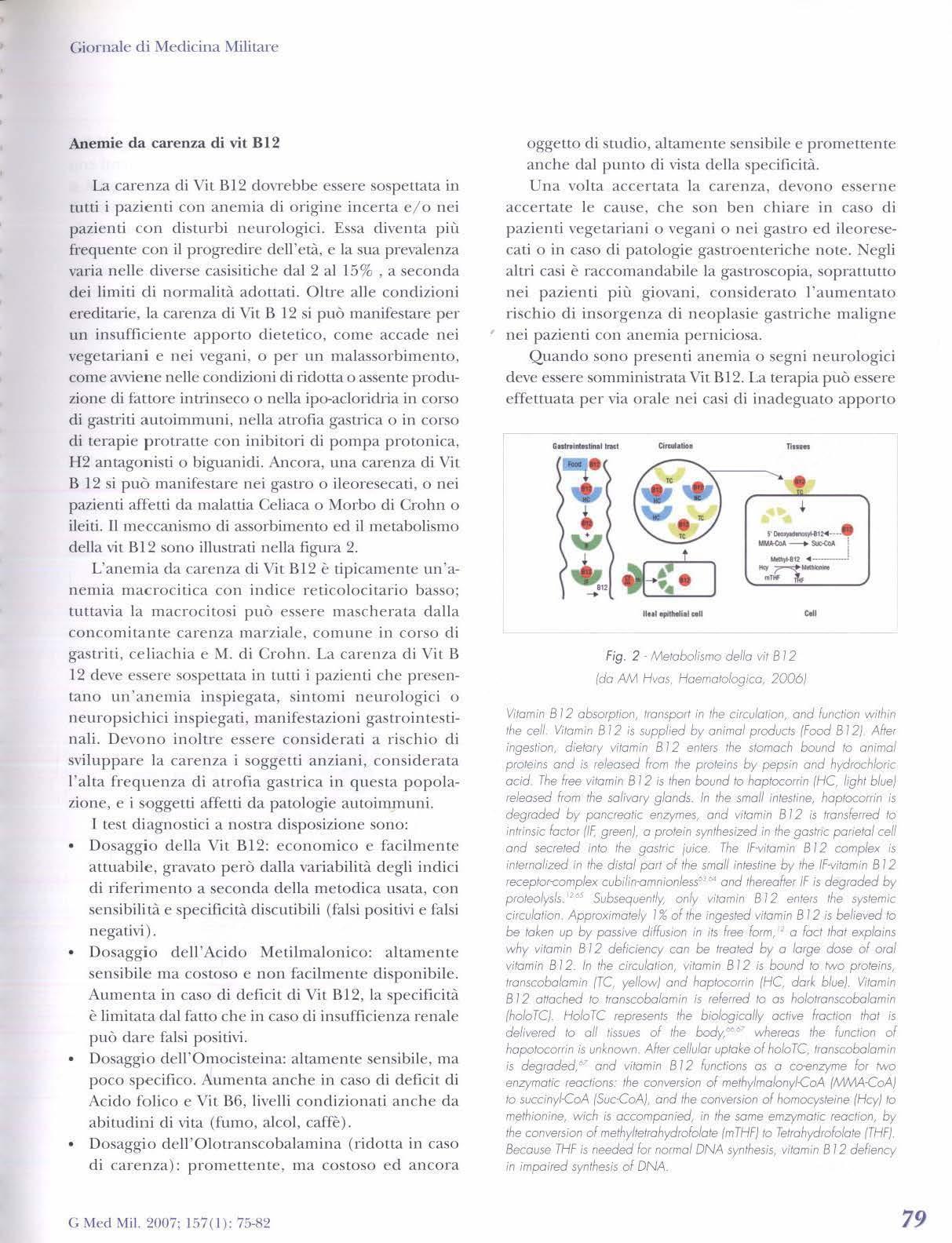
lluloplllltllol coll Coli
Fìg 2 - Metobolisn,o dello vit B 12 (da NA Hvos. Hoemotologico, 2006}
Viiomin BI 2 obsorplion, fronsport in lhe circulalio11, and luncrion within the celi Vitomin 81 2 is supplied by onimo/ p1oducls /Food 812} After inges tion, dietory vitamin B I 2 en ters fhe stomach bound io animai prateins ond is reieosed from the proteins by pepsin and hydrochloric acid Th e free vitarnin B 12 is then bound to ha plocorrin (HC, /ight blue} releosed From the salivory glands In the sma/1 intestine, haptoc.orrin is degroded by poncreatic enzyrnes, ond vitomìn B I 2 is /ronsferred ta in/1/nsic lactor {IF green}, a pro!ein synlhesized in the g ostnc ponetal ce/I o nd secreted inia the gastric ;uice. The IF-vilamin B I 2 camplex is inlemolized in the distai pari oF the sma!I intestine by th e IF·vifamin B 12 recep1or-complex cubilin-omnionless'-'" ond thereafter IF is degraded by proleolys!s . ,,,, Subsequen tly, only v1 tom1n 812 ente,s the syslem 1c circulalìon Approximately I% of the ingested vitomin B 12 is believed la be ra ken up b y passive diffus,on in ifs free form, o foci 1h01 explo,ns why vifomin B 12 de ficiency con be treoted b y a /orge dose of ora/ vitamin B 12. In the circulation, vitomin B I 2 is bound lo fwa prateins, /ranscobolom,n (TC, yellow} ond hopfocorrln (HC, dark blue}. Vi/amin B 12 offached la lronscobalomin is referred fa as holotranscobalamin /holoTCJ. HoloTC represents lhe bio/agicol/y active froction thai is delivered to o/I tissues of the body,· · 6 whereas the function of ho potocorrin is unknown After cellular uptake of ho/oTC tronscobolamin is deg roded;· and vitamin B I 2 functions os a co-enzyme far fwo enzymafic reoctions · the conversion of me thylmalonyl-Co A /MMA-CoA} lo succinyl-CoA (Suc-CoA ) and the conversion of homocysleine (Hcy) to methionine, wich is accampanied, in the some emzymofic reaction, by me conversion of methyltetro hydrofolote {mTHFJ 10 Te/rahydrofo/ole /THF). Beca11se THF is needed for normai DN A syn thesis, vitamm B I 2 defiency in 1mpa ired syn thesis of DNA.
dietetico o per via parenterale nei casi di malassorbimento. Gli scheini posologici variano nei diversi Paesi e i11 base all'esperienza del medico. Una volta iniziato il trattamento bisogna monit01izzare i parametri ematologici, con la conta reticolocitaria dopo 1 settimana e l'emocromo dopo 1 e 2 mesi. Non deve essere trascurato il dosaggio della ferritina, per evitare l'insorgenza di una carenza marziale dovuta all'aumentato fabbisogno per la ripresa dell'eritropoiesi. Poiché dopo l' inizio della terapia con Vit Bl2 è stata osservata una rapida riduzione dei livelli di acido folico , è utile associare i folali. Non è streuamente necessa1io il dosaggio pe1iodico della Vit B12. E' discutibile iniziare il Lrattamento in quei pazienti che presentino bassi livelli di Vit B 12 in assenza di altri segni. h1 questi casi è più corretta l'osservazione e la rivalutazione dopo 6-12 mesi.
Anemia d e lle malattie c ro niche
L ' anemia è una conseguenza comune in corso di infezioni , compresa l'infeziona da HIV, la tubercolosi, le endocarditi baueriche e le osteomieliti, ma può insorgere anche in pochi giorni durante una sepsi. Anemia si osserva anche in corso di malattie infiammatorie generalizzate come le patologie autoimmuni o le malattie infiammawrie intestinali, il mielosa multiplo ed alLre neoplasie. Queste anemie sono caratterinate da una ridotta sideremia, ridotta capacilà ferrolegaute (transfenina), ferritina aumentata e accumulo di ferro nei macrofagi midollari, ad indicare una incapacità di utilizzare il ferro di deposito. L'assoc iazione tra infezioni , iposideremia ed anemia infiammatoria sugge,isce che l'iposidercmia sia uno dei meccanismi di difesa dalle infezioni.
La scoperta <lell'Epcidina, delle sue interazioni con la proteina esportatrice del ferro ferroportina ed il suo ruolo nella regolazion e del trasporto d e l ferro hanno fornito un chiarimento sui meccanismi molecolari alla base dell'emocromatosi ereditaria e dell'anemia delle malattie croniche: l'epcidina è un regolatore negal.ivo dell 'asso rbimento intestinale del ferro e del suo rilascio da pane dei macrofagi tessutali e d egl i epatociti. La produzione di epcidina è regolata omeostaticamentt> dall ' anemia e dall'ipossia: quando l'organismo è in carenza di ossigeno la produzione di globuli rossi deve aumentare e cli conseguenza diminuisce la produzion e di epcidina (Fig. 3). Viceversa le citochine infiammatorie, in modo particolare la l L-6,
fanno incrementare i livelli di epcidina. Aumentati livelli u1inari di• epcidina si osservano in pa1ienti con anemia infiammato1ia. Qu es ta si svilHppa perché si riduce la quantità di ferro disponibile per la sintesi di emoglobina e la produzione di eritrociti. Infatti. le condizioni cliniche in cui è aumentata la produzione di epcidina sono a5sociate comunemente ad anemia. Pazienti con anemia infiammatoria presentano elevati livelli urina1i cli epcidina. L'eccesso di epcidina sembra quindi essere la chiave patogenetica dell'anemia infiammatoria. così come la carenza di epcidina è alla base di molli casi di emocromatosi ereditaria. E' ipotiz7.abile che lo sviluppo di agonisti o antagonisti farmacolog-ici ctell 'epcidina possano essere utili nel traltamento cli queste condi7ioni. Inoltre, l'osservazione che nelle anemie da accumulo cli ferro l ' espansione dell'eritrone ad opera dell'anemia e dell'ipossia sernb1i regolare negativamente la produzione di epc iclina suggc1isce che l' eritropoietina potrebbe essere efficace nel trattamento delle anemie infiammatorie , come g ià osservato in corso di neoplasie.
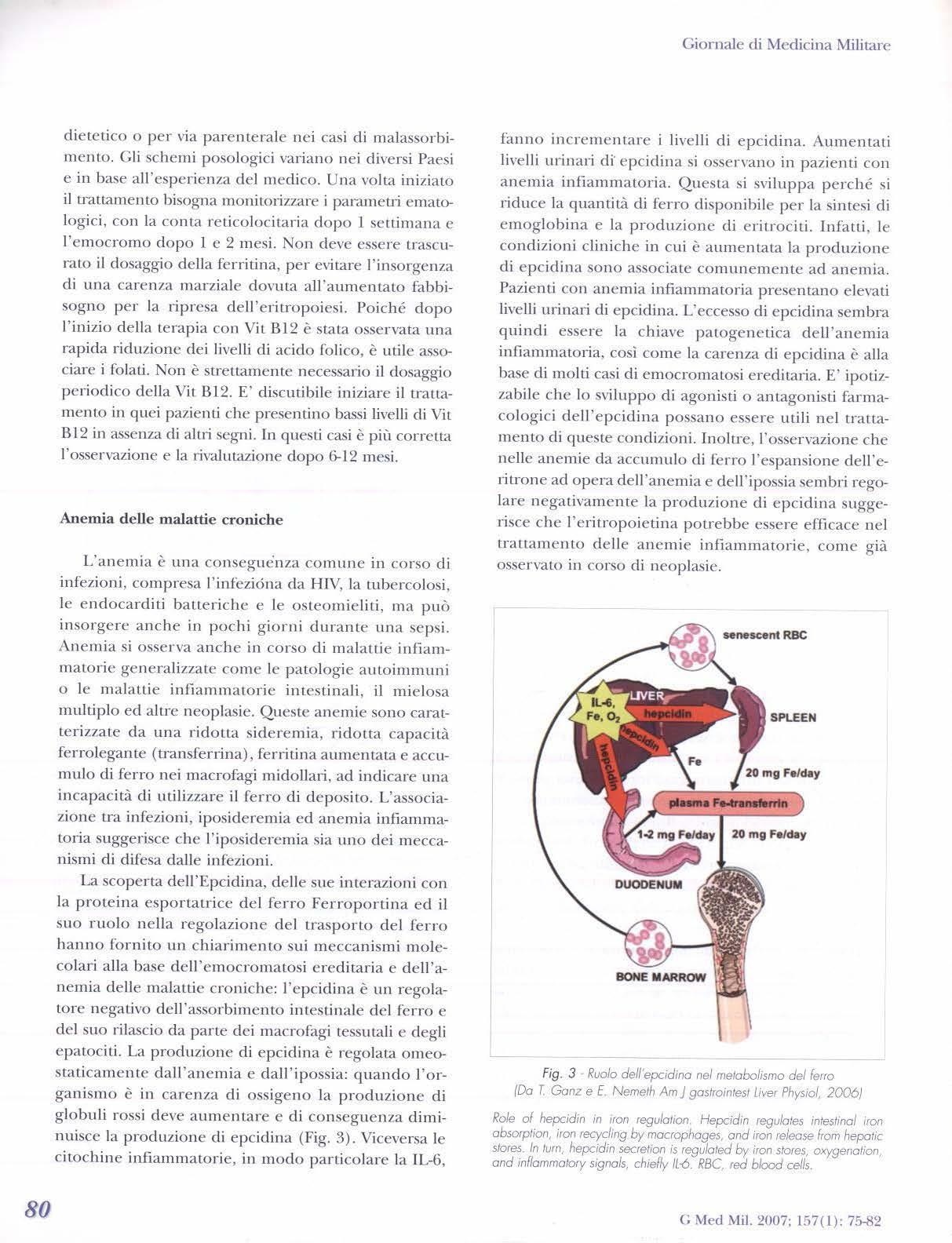
Fig. 3 Ruolo dell'epcidino nel melabolismo del ferro (Do r. Ganz e E. Nemelh Am J gas/roinlesl Liver Physiol, 2006)
Role of hepcidin in 110n regulalion, Hepcidin reguloles intestina/ rron obsorption, iron recycling by macrophoges. ond iron release from hepotic slores. In lurn, hepcidin secretion is reguloted by iron slores, oxygenclion, and inflommalory signals, ch,efly /l-6. RBC, red blood cells.
Bibliogra fia
l. SaJvidio E. , Gaetani G F. , Crosby W.H.: Le A ne-mie, UTET 1989.
2. Frazer D.M. & Ande r s on G.J. lron Import<;.: I. intestina/ iron absorption and its regulation. Am J P hysio l gastro intes t L ivt>r Phys io J 289:63 1635,2005
3. Gasch e C. , Lomer M.C.E. , I. Cavill I. & Weiss G.: lron, anemia. and inflommat01y bowel diseases. G u t 53 :1190- 1197,2004.
4. Brill J.R. & Baumgardner D.J.: Normocytic Anemia.
American Fam il y Physician voi 62 / n. I O (noYem ber 15, 2000).
5. A.M. Hvas E. Ne:w diagnosis and lreatme11 / of vitarnin BI 2 d~ficimcy.
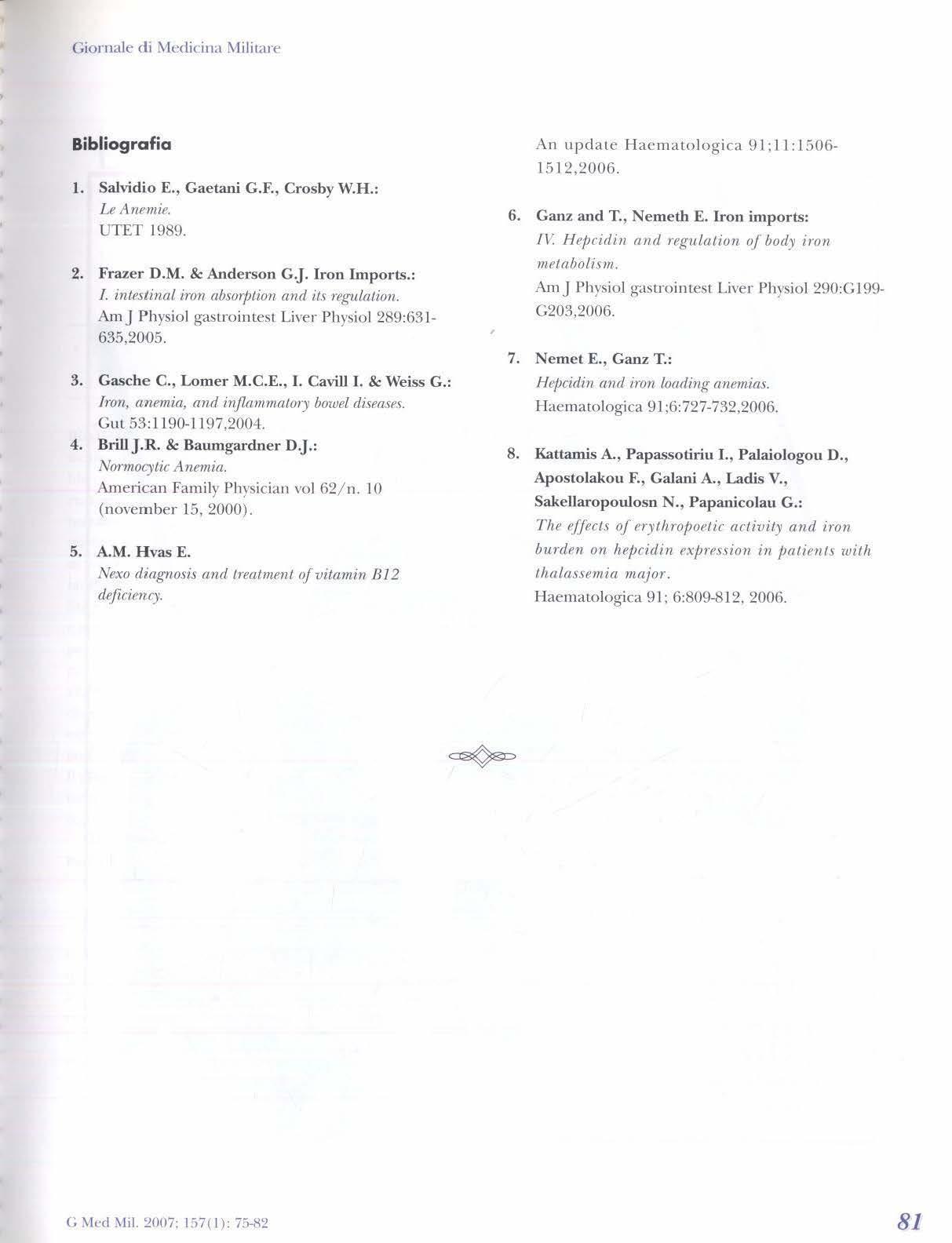
An update H acmatologica 91:ll:15061512,2006.
6. Ganz and T., Nemeth E. Iro n imports: Ii'. Hepcidi11 and regula.tion of body iron metabolism.
Am J Physiol g-as t roi m est Liver Physio l 290:G I 99C203,20 0 6.
7. Nemet E. , Ganz T.: Hepcidin anrl iron loadiug anernias. H ae m atologica 91 ;6:727-732,2006.
8. Kattamis A., Papassotiriu I. , Palaiologou D. , Apostolakou F. , Galani A. , Ladis V. , Sake lJaropoulosn N. , Papanicolau G.: The effecls of erythropoelic activity and iron burdn1 on hepcidin l'X/J'l'Pssion in patient~ with thalassemia major. Haemaw logica 9 1: 6:809-812, 2006.
tn cla c. .-:ia 1• • • '' < l\'J 10110 ore. glionc di ·> )(• COIJ) O <l
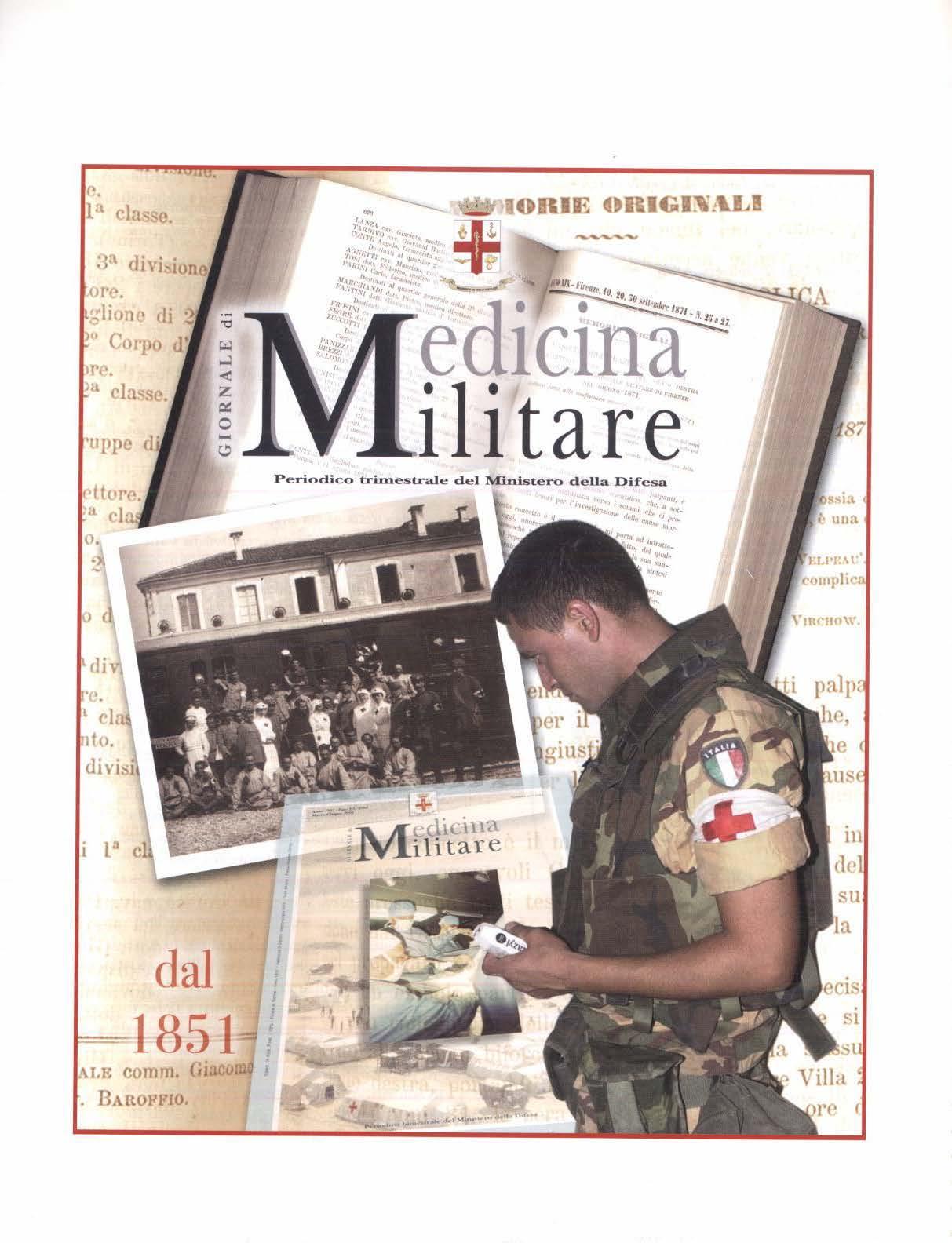
dal
1=1851
~T.R comm. Giaco
. BA ItOFFlO,
Guido Bu sset ta *
* Magg. m,. Ca/10 Srr11izia l111m11nill'matofogia e Sieroriirolufiill • R,spomab,t,, tfd Sistem<1 di G,,slione jJrr la Qualità del Centro TrasjiLiionnlPPolirlinirn i\1i/i/r,rf "(,dio·· Uomu.
Riassun to - Proteggere la salute pubblica, garantire qualità, sicurezza, efficacia delle specialità mcdidnali e garantire la libera circo l azione dei medicinali a ll'interno del mercato europeo sono elemenLi alla base dell'adozione di ttnle le norme che negli tt!Limi anni hanno conLras,egnaw il campo Lrasfusionale. La normativa i1aliana recependo le dirctti, e di Strasburgo ha adottato nel 2005 due prm·verlimenti in cui meglio sono stati rlelin i 1i l'ambito di lavoro, le responsabilità e l 'obbligatmictà del mantenimento di accreditamento e autorizzazione che i centri trasfusiona li cle1·ono garantire per potei- operare. Per la prima rnlta è· stata imposta l'i,tilllzione cl-i un ~i~terna di gestione pe1· la qual ità rispondente alla norma fSO 900 l :2000. li Centro Trasfusionale ciel Po liclinico Militare di Roma, condividendo pienamen te quanto espr-esso dal legislatore, ha adouaLO tutte le iniziative per poter mellersi a norma nel tempo richiesto.
Il progeuo q ua l itù, ini7iato nel novembre 2005, ha così avuto termine nel febbraio 2007 con la l'is i ta ispettiva cli Eme Terzo cerl.ifiG1lorc.
P arnle c hiave : UNl EN ISO in im1m111o e ma to lo gia.
La normativa italiana ha voluto megl io delìnire tuue le auivilà in ambito trasfusionale in accordo con quanto g ià normaro a li\ ello europeo con le Diretùve 2002/98/CE e D irettiva 2004 / 33/CE riguardanti rispeltivamcnre ''!\'orme cli qualità e sicurezza ciel sangue umano e dei suoi componenti" e "Requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti".
L 'UE considera queste due direuive uno strumento primario per: proteggere la salute pubbl ica. garantire qua lità, sicurezza, efficacia delle specialità medicinal i e garamire la libera c i rcolazione dei medicina li all'interno ciel mercato europeo.
C: \1ed .\-lii. 2007: l'17(1):

Summ ary - To Protect public heallh, guaramee th<' qnality, security. effect il'encss in medicai specialirics and Lo guaramee the free movemen1 in Eurnpean Market are the basis of new laws in lransfusional world.
According with Strasburgo Po l itics in 2005, ltaly adopted two lega.I measures which better clescribe che rules, responsibilities, ancl the oblige of maintenance ù1e regional permission and authorizaLion that ali transfusional cenu·es must possess.
For the lìrst time a quality management system accountable to ISO 9001:2000 is obligatory. The military transfusio11al centre of Ylilitary Generai Hospita l of Romc, full sharing the new laws, has adopted ali neccssaries initiatives LO perform what requestecl.
The "project [or ù1e quality" open in November 2005 has bccn fìnished in February 2007 with Lhe Audil ofan chccking Organizaùon.
Key words: UNI EN ISO in inununo emato l ogy.
P er sens i bilizzare ancora di più sia gli operatori del settore che l 'opinione pubb lica, c i rca il prob lema della sicurezza de l sangue e dei suoi componenti e derivati il decreto legisl ativo 191/05 e la legge 195 / 05 stabiliscemo inoltre atli sanzionatori per il mancato rispetw di quanto previsro (Figg. 1, 2) .
Ancora una volla il legislatore si è soffermato sui concetti d i ·'autoriaazionc'' cd "accreditamento" che necessar iamente le strutture trasfusionali devo n o possedere come requis i ti fondamentali per l'eserci zio d i tutte le attività riguardanti la racco l ta, il controllo, la lavorazione. la d is t ribuz ione del sangue umano e
L. 2 19/0 5 ,p,
Art. 22 - ··Chiunque preleva, ~cura , raccoglie conserva o distribuisca sangàe al di fuori delle ,stmtture accreditate o senza aùtorizzaz1oni. è pun la reclusione da 1 a 3 anri1lèonJa mult ~ 1 10.329 €. Se il colpevole è pers~ ercrtl:'f' la~rofessione sanitaria alla corÌ~a.s~guelfl 'iii'ierdizione della professione"
1
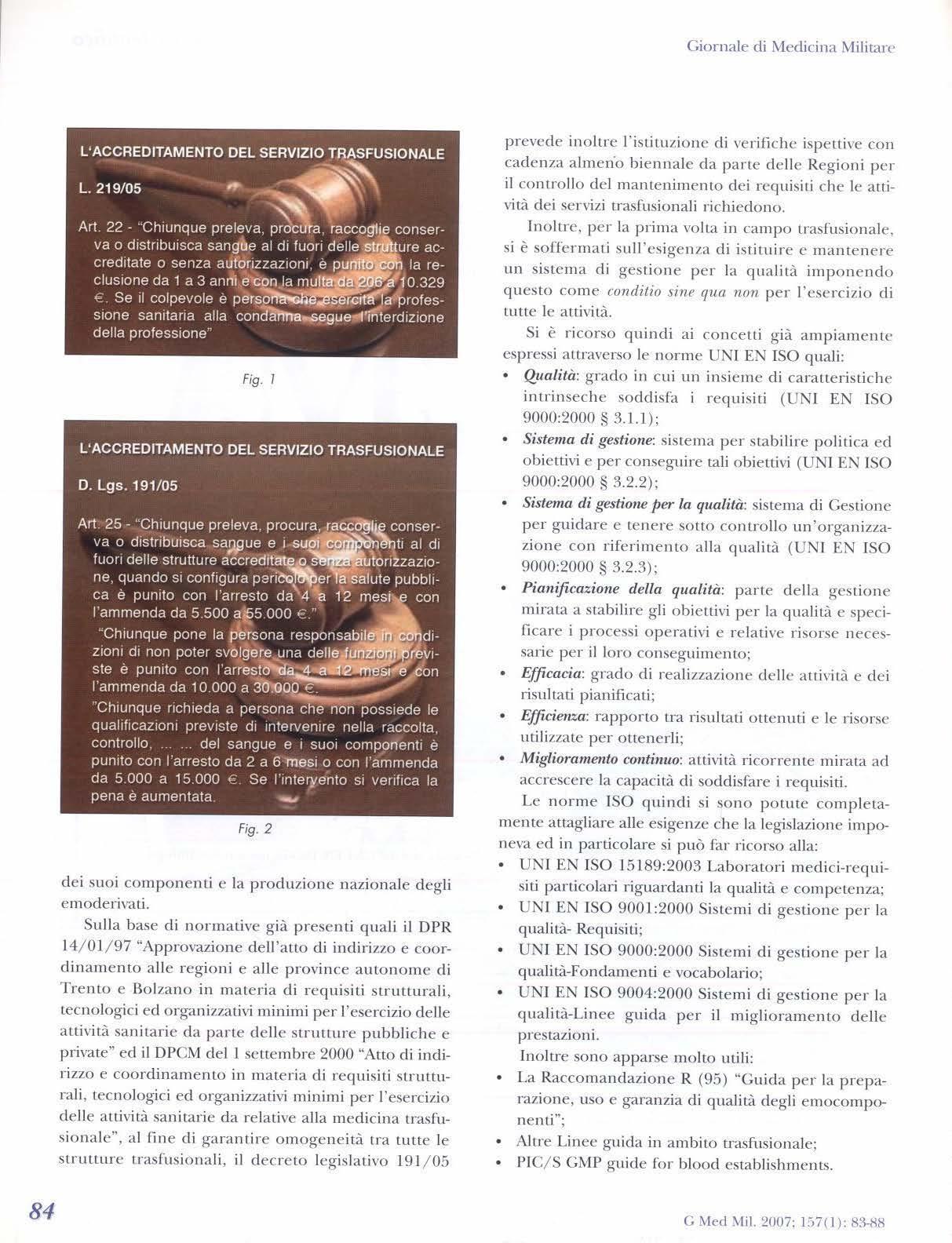
Fig. 2
dei suoi componenti e la produzione nazionale degli emode1ivati.
Sulla base di normative già presenti quali il DPR 14/ 01 /97 "Approvazione dell'atto cli indirizzo e coordinamento alle region i e alle province autonome di Trento e Bolzano in maLeria di requisiLi strutturali, tecnologici ed organiz7.ativi rninjmi per l'esercizio delle atLività saniLaric da pane delle strum_1re pubbli c he e private" ed il DPCM del I settembre 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia cli requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle auività sanita1ie da relative alla medicina Lrasfus ionale" , al fine di garantire omogeneità tra Lutte le stru Lture tras fusionali, il decreto legislativo 191 / 05
prevede inoltre l'istituzione di verifiche ispeltive con cadenza a lmen o biennale da pane delle Regi on i per il controllo del maruenimento dei requisiti che le artività dei servizi trasfusionali richiedono Inoltre per la p1ima volLa i11 campo trasfusionale. si è soffermati su ll'esigen za di istituire e mantenere un sistema di gestione per la qualità imponendo questo come conditio sine qua non per l 'esercizio di tutte le attività.
Si è ricorso quindi ai concetti g1a ampiamcme espressi attraverso le norme UNI EN ISO quali:
• Qualità: grado in cui un insieme di cara ueiisticlw intrinseche soddisfa i requisiti (UNl EN ISO 9000:2000 § 3.1.1);
• Sistema di gestione: sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire ta]j obiettivi (UNl E:---J ISO 9000:2000 § 3.2.2);
• Sistema di gestione per la qualità: sistema di Gestione per guidare e tenere sotto controllo un'organiZLazione con 1"iferime11Lo alla qualità (UNI EN ISO 9000:2000 § 3.2.3);
Pianificazione della qualità: parte della gestione mirata a stabilire gli obieuivi per la qualità e specificare i processi operativi e relative risorse necessarie per il loro conseguimento:
• Efficacia: grado di realizzazione delle attjvità e dei risultati pianificati;
• Efficienza: rapporto tra risult.ati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli;
• Miglioramento continuo: attività ricorrente mirara ;id accrescere la capacità di soddisfare i requisiti. Le norme ISO quindi si sono potute completamente au.agliare alle esigenze che la legislazione imponeva cd in parùcolare si può far t"icorso alla:
• UN I EN ISO 15189:2003 Laboratori medici-requisiti particolari riguardanti la qua li tà e competenza;
• UN I EN ISO 9001:2000 Sistemi cli gestione per la qualità- Requisiti;
• U I EN ISO 9000:2000 Sistemi di gestione per la qualità-Fondamenti e vocabolario;
• UNI EN ISO 9004:2000 Sistemi di gestione per la qualità-Linee guida per il miglioramento delle prestazioni.
Inoln-e sono apparse molto utili:
• La Raccomandazione R (9.5) "Guida per la preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti";
• Altre Lince guida in ambito trnsfusionale;
• PJC/ S GMP guide for bloocl establishments.
La legge 219/05 contempla inoltre che il Servizio Trnsfusiona le Mi litare attui in maniera autonoma tutto quamo pre\~Sto dal la legge. 11 Cent.-o Trasfusionale del P ol iclinico M il itare <l i Roma s i è da s u b ito awa lso di una consulenza esterna p er poter istitu i re un s islema di gestione per la qualità. Il lavoro effen u alo è slato mirato alle altivit.à di:
• Selezione de i canditati alla donazione;
• Raccolta, preparazione, co11scr vazio11e, preparazione, conservazione, assegnaz ione del sangue umano e de i s u o i componcnù;
• Va li dazione degli emocornpone11 1i e tutte le attività d i laboratorio de l Centro;
• ln vio de l P la~ma raccolto ai centri d i produz ione di emoderiva ti;
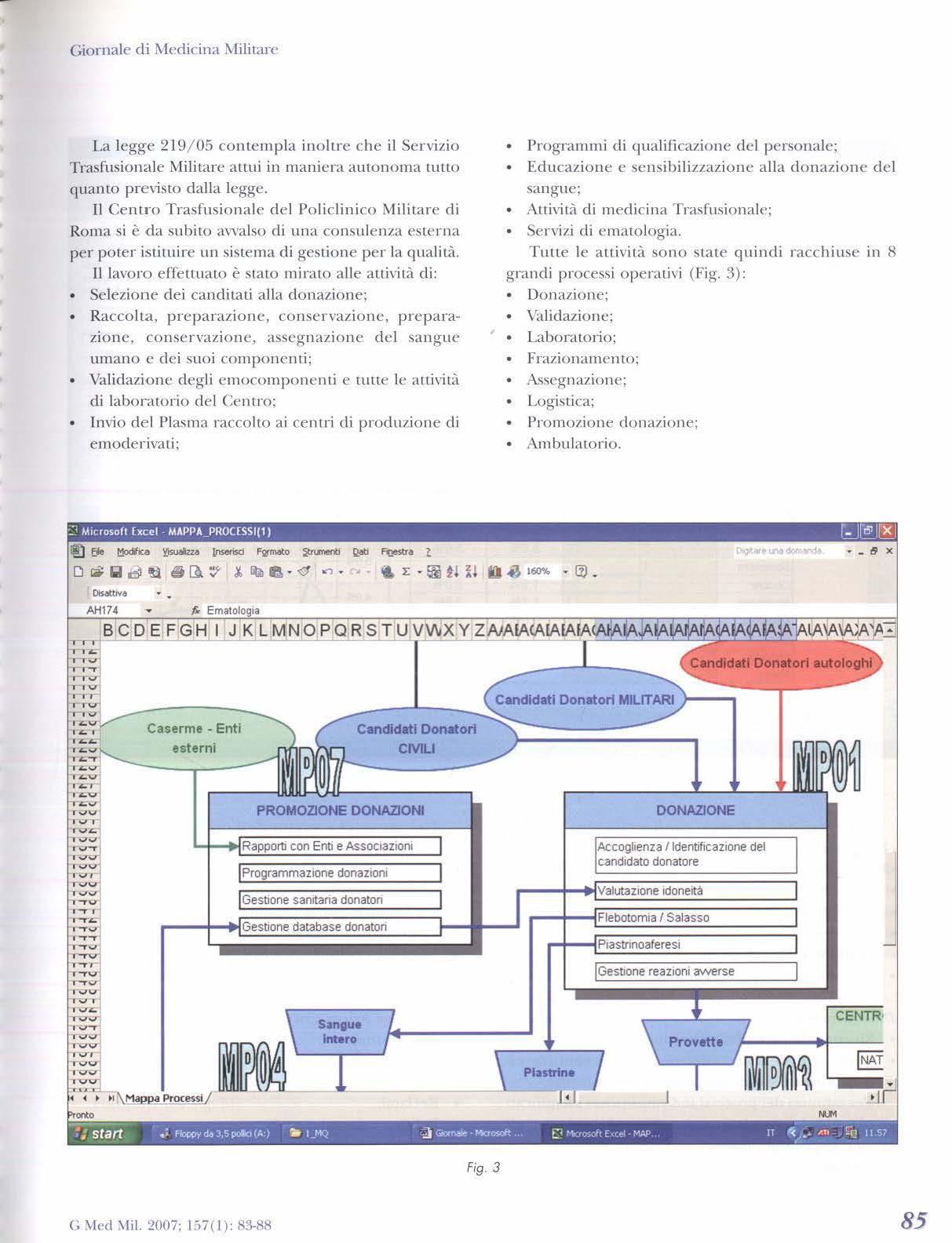
:::1 M1c rosoft [xcel - MAPPA PROC[SSl(1)
I!) Eie M<>dl'ica '!'.ìswizz• Jr,s,,<is<I Fq,mato Qatl ~a i
Ematolog1a
Caserme - Enti esterni
PROMOZJONE DONAZIONI
Rapporti con Enti e Assoc1arioni
! Programmazione donazioni
! Gesoone sanitana donaton
Gestione database donaton
Sangu• lntaro
• P rogrammi di qualificazione del personale;
• Educaz ione e sensib ilizzazione al la donazione del sangue;
• Attivi tà di medicina Trasfusionale;
• Servizi cli emawlogia.
Tutte le attività sono state quindi racchiuse 111 8 grandi processi operativi (Fig. 3):
• Donazione;
• Validazio11e; '
• Laboratorio;
• Fraz ionamento:
• Assegnazione;
• Logistica;
• Promozione clonazione;
• Ambulacorio.
Accoglienza/ Identificazione del candidato donatore
/ Salasso -1---1 P1astnnoaferes1
!Gestione reazioni avverse
Oltre a questi si devono consi<lerarc a lLri proce~si che potremmo definire:
01gr111izzativi
• Gestione drl sistema di gestione per la qualità;
• Gestione ciel Pe rsonale;
• Gestione della documentazione;
• Gestione dell'approvvigionamento;
• Gestione delle apparecchiature.
lJi miglioramento:
• Ri esame da pane della Din·,ione;
• Ge::.tione delle non conformità, d e lle> a,ion i corretLivc , pn:·ve11Liw e di 111igliora111c 11to.
Per ognuno dei processi indicati si sono identificati gli obiecti,·i, le correla,ioni documentali, gli input, gli output, le fa~i <lei proce ss i , g li in<li catori mi surabi li e le inrcrazioni.
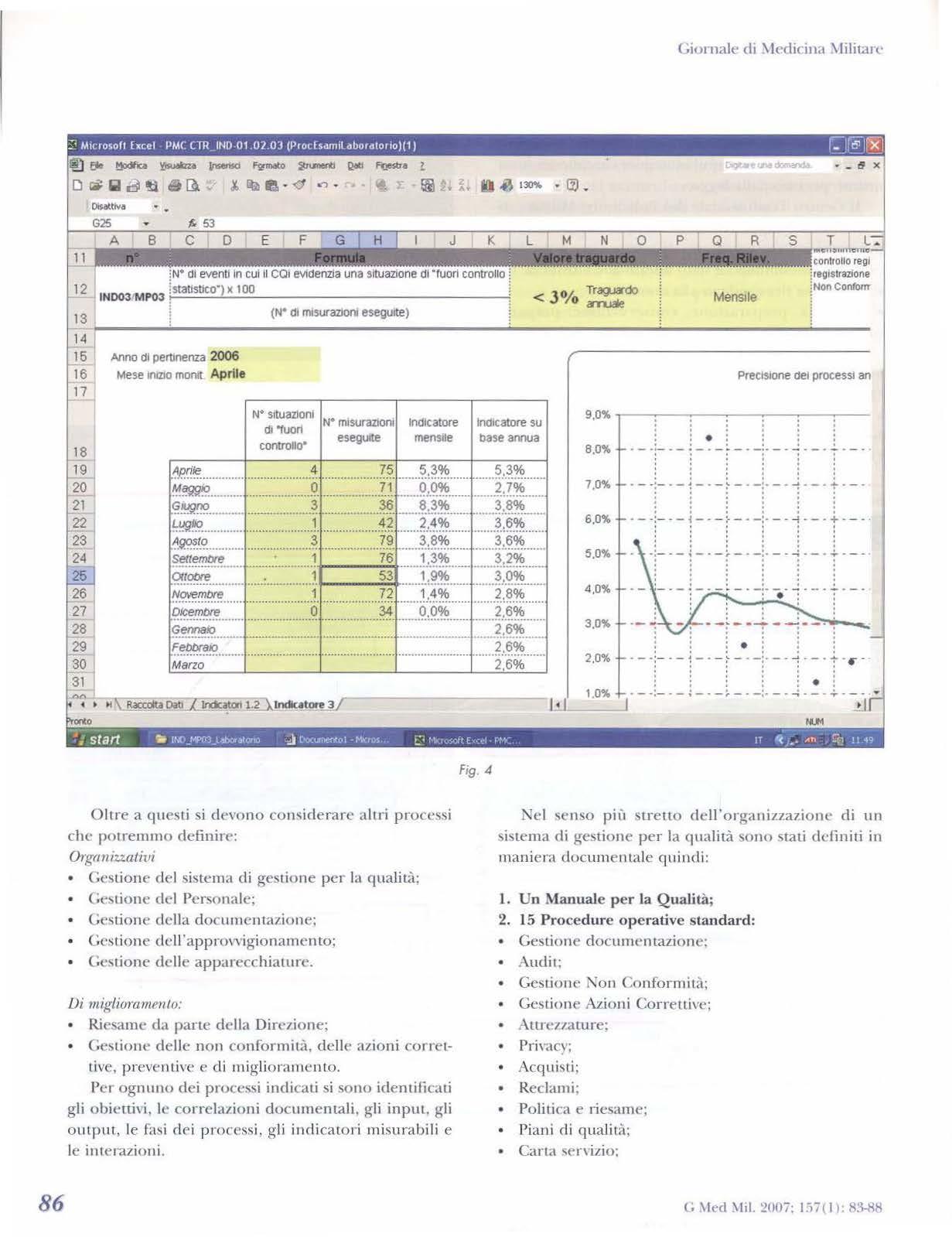
Nel \enso più s tretto dell'organizzazi o ne di un si:>tema di gestione per la qualità sono stati definiti in maniera documentale quindi:
1. Un ManuaJe p e r la Quali tà;
2. 15 Pro ce dure operative standard:
• Gestione documcm.uione ;
• Audit;
• Gestione Kon Conformità;
• Gestione Azioni Correlli\'c:
• Atlr<' 11aturc ;
• Prirn cy;
• Acquisti;
• Reclami;
• Polit ica e riesame;
• Pi ani cli qualità;
• Carta ,en uio ;
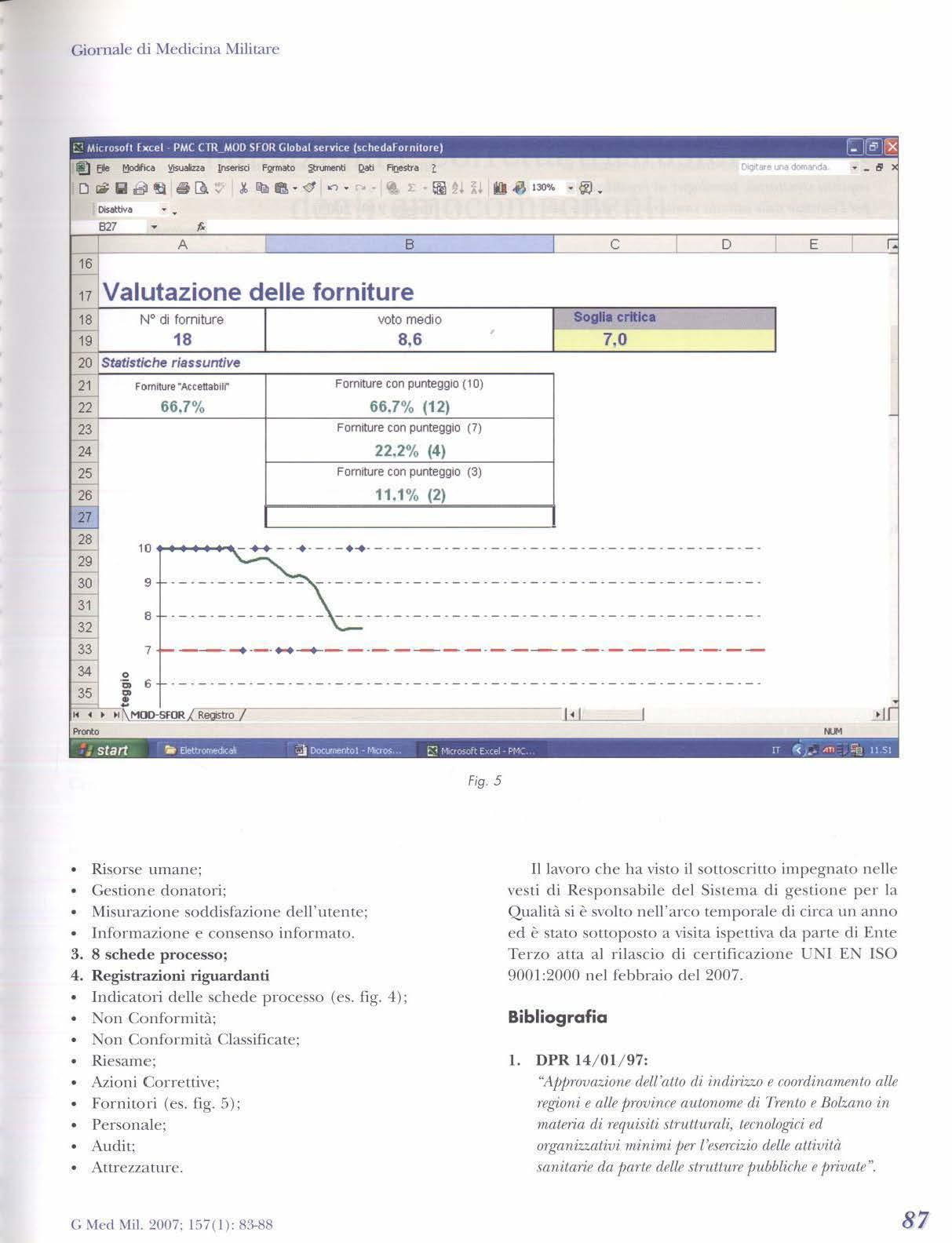
• Risorse umane;
• Gestione donatori;
• Misurazione soddisfazione dell'utente;
• In formazione e consenso informato.
3. 8 sch ede p rocesso;
4. Registrazioni riguardanti
• 1nclicaturi delle schede processo (es. fig. 4);
• Non Conformità;
• Non Conformità Cl~sificate;
• Ri esame;
• Azioni Correttive:
• Fornitori (es. Jìg. 5);
• Personal e;
• Audi t ;
• Atu·ezzaturc.
5 Il lavoro che ha visto il sottosc1itto impegnato nelle vesti di Responsabile ciel Sistema cli gestione per la QualiLà si è svolto nell'arco temporale di ci rca un anno ed è stato sottoposto a visita ispettiva da parte di Ente Terzo atra al rilascio di certificazione UNI EN [SO 9001 :2000 nel febbraio del 2007.
l. DPR 14/ 01 / 97: "Approvai.ione dellàllo di i11dirizzo i! rorrrriinamento allP regionì e al/p jJrovinre r,,utonomP rli Trento f Bolzano in materia di requisiti slrull-urali. tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio del/,e allività sanitrtrie da j1arlP ddle slru tture pubbliche e privale".
2. OPCM l settembre 2000:
-Allo d1 mdiriz.::.o e coordmnmn1/o in materia di requisiti slrullumli, ternologià ed orgrmiz.zatiui 111ini111i j,er /'r.1rrchio dflle attiuità sanitarif da relat/T!e alla medicina lrwf11-1io11ale "
3. Direttiva 2002 / 98 / CE:
"Normr di qualità e sicwnz.a del wngw, umano e dPi 11wi ro111pone11ti ·•.
4. Direttiva 2004 / 33 / CE:
"Requ11iti trrniri dPI 1a11gur r dtgli emocompo11n1li ".
5. Direttiva 2002 / 98 / CE:
"Normr di qu"lilrì P sirn1nzo del \'tt11g;11 e umano e dri lllOÌ ro111ponn1ti".
6. D.Lgs l 91 / 2005:
'·A1111a:.ionf della direlliva 2002/ 98/ CE rhr stabi/1ve norml' dì qualt!à e di 1ff1nr.:Za pi'/ la rar/'Olla, il
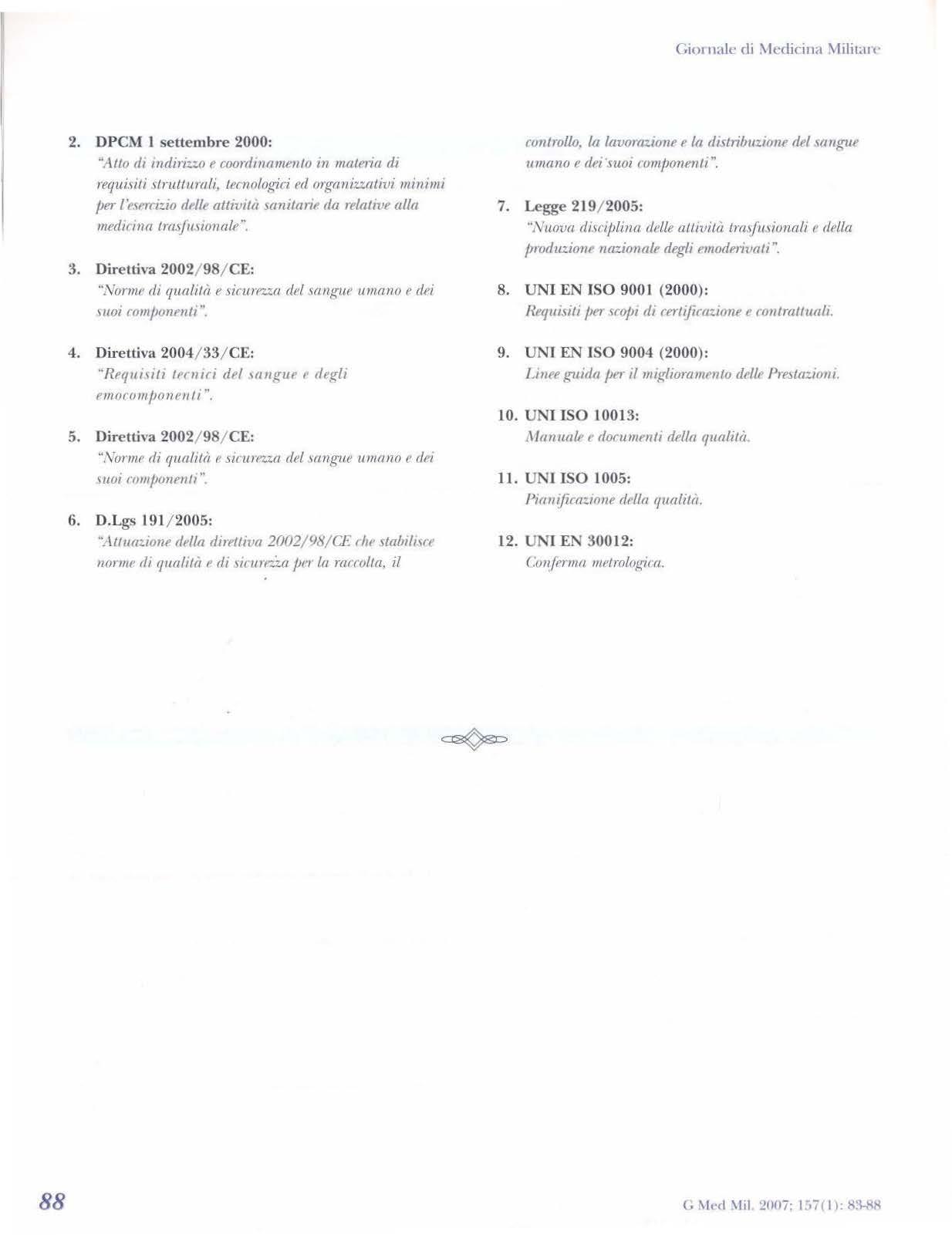
rontrollo, la lavora:.wne e la distribu:.ume del vmgue umano e dri suoi wmponmti''.
7. Legge 219 / 2005: "li/uova di1riplinn dd/,e allività lra.'>)it~ionali I ' della prodza.ione na::.ionale degli emoderivati".
8. UNI EN ISO 9001 (2000): Requisiti Jm· scopi di rertijìm:.ione e rcmlrattuali.
9. UNI EN ISO 9004 (2000): J inee guida pn· il migliorammto drllr Presta::.io111.
10. UNI ISO 10013: Mmwnlr l dorw11e11tì d<1lla qualità
ll. UNI ISO 1005: J>ia11ifira::.io11e drlla qualità.
12. UNI EN 30012: (.'onferma 111elrologim.
Co rr ec t use of emocomponents
Nicola Ramundo *
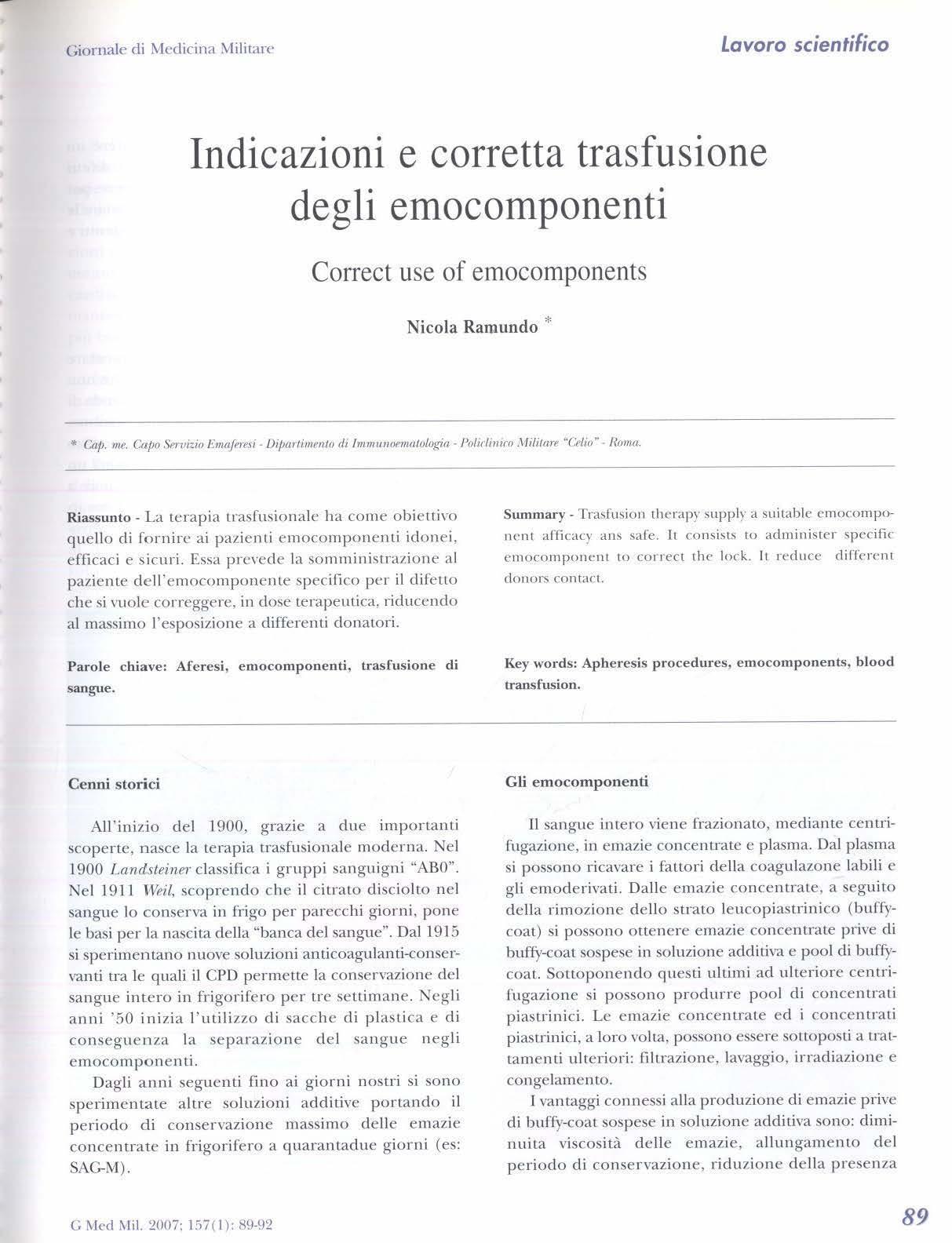
* Cap. me. Ct1po SPmizin Emafn-esi • Dipwti.11wnto di hn1111111&riu1/olo[(ia - l'olir/1111rn Militare "Celio'" Homa
Ri ass w1to - La terapia trasfusionale ha come obiettivo quello cli fornire ai pazienLi emocornponemi idonei, efficaci e sicuri. Essa prc,·ecle la somministrazione al paziente clell'emocomponenle specilìrn per il difetto che si vuole correggere, in dose terapeutica, 1irluce11do al massimo l'esposizione a clifferenLi clonaLOri.
Paro le c hiave: Afe resi , e m oco mpon e nti , trasfu s i o n e di sangue.
Summary - Tra~fusion therapy s11pply a suitable cmocomponcnt afficacy ans safe. Il consist<, to adminisrcr specific emocomponenl to co, rect thc lock. l t reduce clifkrcnt donor:s contact.
Key wo rds: Apbcres is procedures, emoco m p o ne n ts, bl ood transfus io n .
Cenni s tori ci
All'inizio ciel 1900, grazie a due importanti scoperte, nasce la terapia trasfusionale moderna Nel 1900 Landsteiner classifica i gruppi sanguigni "ABO". Nel 191 I Wl'il, scoprendo che il citrato disc iolto ne l sangue lo conserva in frigo per parecch i giorni. pone le basi per la nascita della "banca del sangue". D al 1915 si sperimentano nuove sol uz ioni anticoagulanti-co n servanti tra le qua li il CPD pennette la conservazione del sangue intero in fr igorifero per tre seuimane. Negl i anni '50 iniz ia l'uti l izzo cli sacche di plastica e di conseguenza la separaz ione del sangue negli emocomponen ti . Dag li anni seguenti fino ai giorni nostri si sono speri mentate a l tre soluzioni additive portando il peri orlo d i conservaz ione massi mo de ll e emazie concentrate in frigorifero a quarant.adue g iorni (es: SAG-M)
Gli em ocompone nti
Il sangue intero viene frazionato , medi ante centrifugaz.ione, in emazie concentrate e plasma. Dal plasma si possono ricavare i fattori de ll a coagulawne lab ili e gli emoder ivati. D a ll e emazie concentrate, a segu i to della rimozione dello strato leucop iastrinico (buffycoat) si possono ottenere emazie con centrate prive di buffy-coat sospese i n soluzione additiva e pool di buffycoat. Sottoponendo questi u l timi ad ulteriore centrifugazione si possono produrre pool di concentrati piastrinic i Le emazie concentrate ed i concentrati piastrinici, a loro vo l ta possono essere sottoposti a l nlltame n ti ulteriori: filtrazione, lavaggio, irradiazione e conge lamento.
I vantaggi connessi a ll a produzione di emazie prive di buffy-coat sospese in so l uzione additiva sono: diminuita viscosità de ll e emazie, allungamento de l periodo di conservazione, ticluzione de ll a presenza
cli microaggrega1i e corncguentc riclu,ione delle reazioni trasfusionali.
L a fìhraLione è una procedura che permette di ridurre il num ero cli le u coc iti n e ll ' uni tà d a trasfonclen: a meno di 100.000. La lt'ucodcple7iOll(' può essere effettuata in laboratorio, a letto d<'I p uiente o "p r estorage''. I Yantaggi delle unità leucodepkc sono: 1;mo1ione dei baucii. riduLione del rischio di 1rasmissione di alcu11i virus (es: c itom egalo\'i rus) riduzione del 1·iKhio di immuniuaLione HL-\.
Nuo\'e po!>Sihilità terapeutiche sono offe n c dalla aferesi produtùrn che pem1etc cli sele1fonare da Lm unico donatore l'emocomponcme o gli emocomponenti da trasfondere riducendo l'~posiL.ione del paziente a dilkrcnti donatori.
La terapia trasfusionale
L'approccio trasfusionale cambia a seconda del ti p o di paLicnte. 'ì':cl paLicme chirurgico la trasfusione è
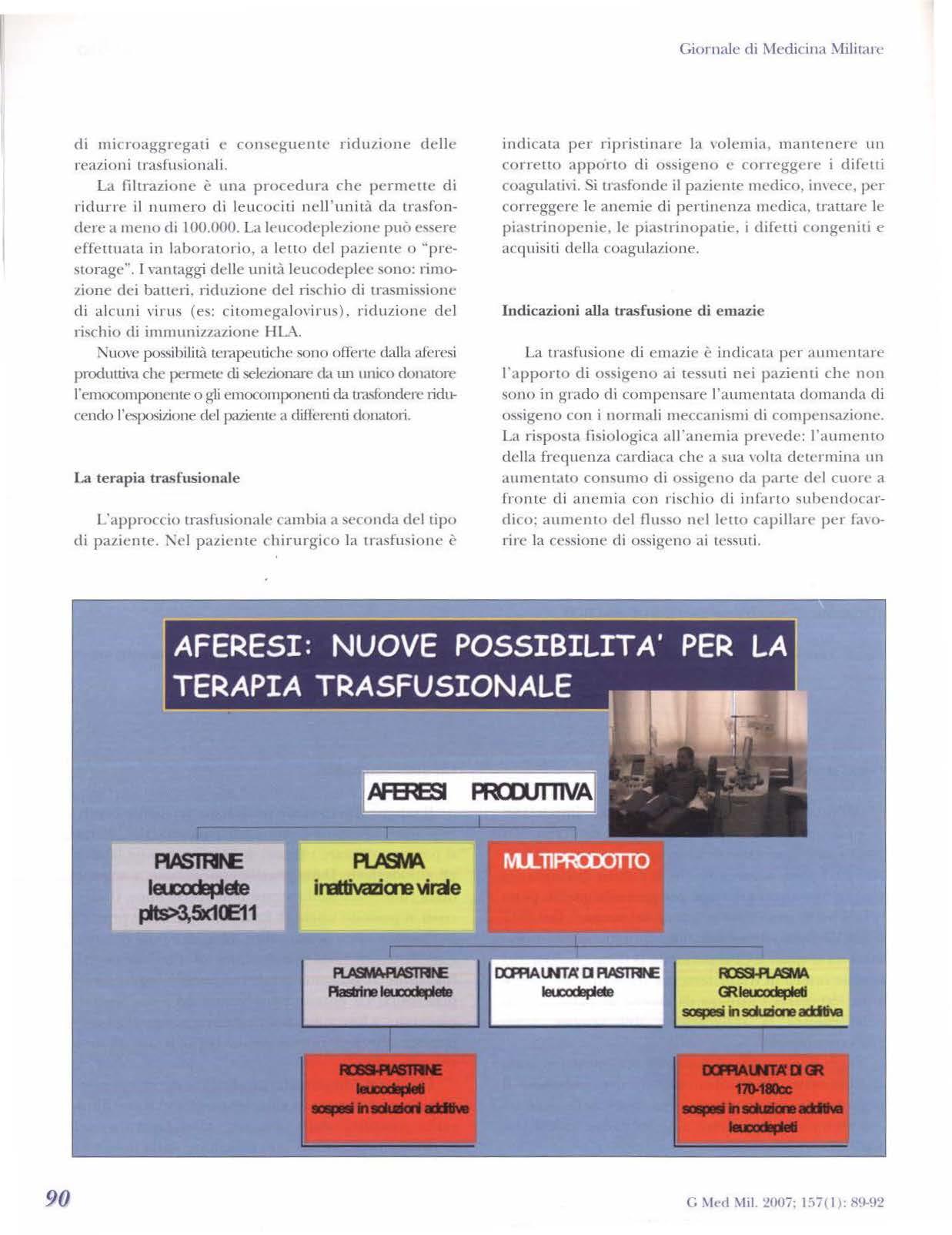
indicata per ripristinare la volemia, mantenere un cor r etto apporto di o~sigeno e correggere i difeui coagulati, i. Si tra~fonde il paticme medico, invece, per correggere le anem ie di penincnn tllcdica. trattar(' le piastrinopcnie, le pia~trinop.itie, i difetti congeniti e acquisiti della coagulaLione.
Indicazioni alla trasfusione cli emazie
La trasfusione di emazie è indicata per aumentare l'apporto di os'>igc n o ai tessuti nei pazient i che non so n o in grado di compe n sare l' a um entata domanda di os,igeno con i normali meccanismi di compcnsa,ione.
La risprn,ta fisiologica a ll' anemia pn·, ecle: l'aumemo della frcquenLa rardiara che a sua ,olta determina 1111 a11menta10 con,umo di ossigPno da parte del cuore a fronte di ane mi a con rischio di in farto s n bendocardico: aumento del flu,,o nel letto capillar(' per fa,orire la cess ione cli ossigeno ai tessuti. IXFAAlHT.« a fll.05TlN: RlBfl.ASfM leu:ooai.. ~la!Codepel 90llplli
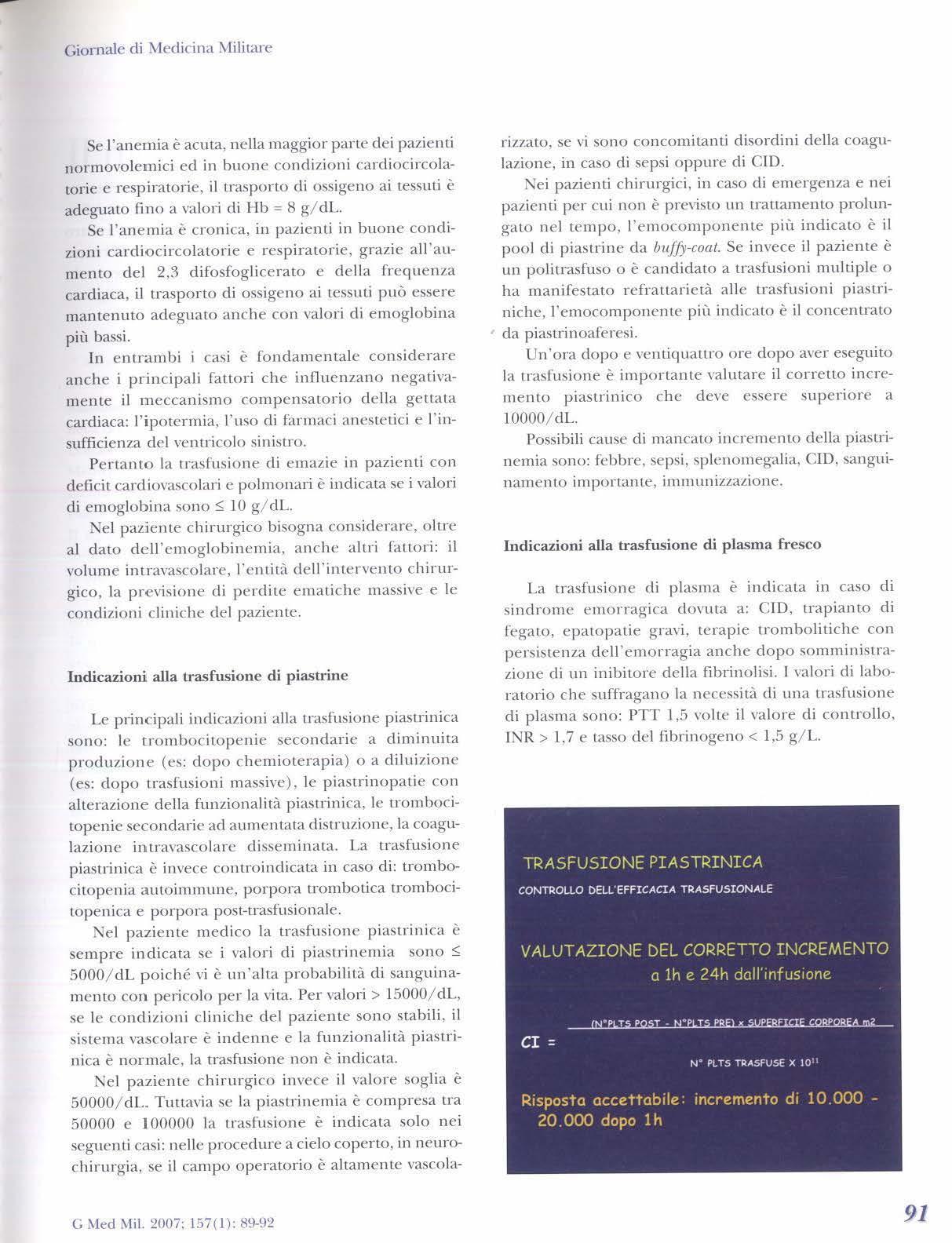
Se l'anemia è acuta, nella maggior pane dei pazienti normovolemici ed in buone condizioni cardiocircolalOrie e respiratorie, il trasporto cli ossigeno ai Lessuti è adeguato fino a valori di Ilb = 8 g / dL.
Se l'anemia è cronica, in pazienti in buone condizioni cardioc i rco latorie e respiratorie, grazie all ' aumento de l 2,3 difosfoglicerato e della frequenza cardiaca, i.I trasporto di ossigeno ai tessuti può essere mantenuto adeguato anche con vaioli cli emoglobina p iù bassi.
In entrambi i casi è fondamentale considerare anche i principal i fattori che influenzano negativamenle il meccanismo compensatorio della gettata cardiaca: l'ipotermia, l'uso di farmaci anestetici e l'insufficienza del venu·icolo sinistro.
Pertanto la trasfusione di emazie in pazienti con deficit cardiovascolari e polmonari è indicata se i valori cli emoglobina sono~ 10 g / dl.
Nel paz_iente chirurgico bisogna considerare, oJu-e al daw dell' emoglobinemia, anche altri fattori: il volume intravascolare, l'entità de ll' intervento chirnrgico, la previsione cli perdite ematiche massive e le condizioni cliniche del paziente.
Le principali ind icazioni alla rrasfusione piastrinica sono: le trombocitopenic secondarie a diminuita produzione (es: dopo chemioterapia) o a diluizione ( es: dopo trasfusioni massi\'(; ), le piastrinopatie con alterazione della funLionalità piasuinica, le trombocitopenie secondarie ad aumentata distruzione , la coagul az ione intrayascolare disseminata. La trasfusione piastrinica è invece controindicata in caso cl i: trornbocitopenia autoimmune, porpora trombotica trombocitopenica e porpora post- u·asfusionale.
1el paziemc medico la trasfusione piastrinica è sempre indicata se i valori d i piastri nemia sono 5000 / dL poiché vi è un'alta probabilità di sanguinamento con perico lo per la vita. Per valod > 15000/ dL, se le condizioni cliniche ciel paziente sono stabili , il sistema \·ascolare è indenne e la funzionalità piastrinica è normale , la trasfusione non è i ndicata.
Ne l paziente chirurgico invece il valore soglia è 50000 / dL. Tuttavia se la piastrinemia è compresa tra 50000 e 100000 la trasfusione è ir1dicata so lo nei seguenti casi: nelle proce<lure a cielo coperto, in neurochirur6ria, se il campo operatorio è altamen te vascola-
rizzato, se vi sono concomitanti disordini della coagulazione, in caso di sepsi oppure di CIO.
l\'ei pazienti chirurgici, in caso di emergenza e nei paziemi per cui non è previsto un trattamento prolungato nel tempo, l'emocomponente più indicato è il pool di piasuinc da bn/fl'-coat. Se invece il paziente è un politrasfuso o è candidato a trasfusioni multiple o ha manifestato refrattarietà alle u·asfusioni piastriniche, J'emocomponente più ind icalo è il concenmlto da piastrinoaferesi.
Un 'ora dopo e n ntiquauro ore rlopo aver eseguito la trasfusione è importante valutare il corretto incremento piastrinico che de\'e essere superiore a 10000/ dL.
Possibili cause di mancato incremento della piastrinemia sono: febbre , sepsi, splenomegalia. CID. sanguinamento importante, immunizLazione.
Indicazi oni alla trasfu sione di p lasma fresco
La trasfusione di p lasma è indicata in caso di sindrome emorragica do\'uta a: CTD, trapianto di fegato, epatopatie gravi, terapie trom holitiche con persistenza dcli ' emorragia anche dopo somministrazio11e cli un inibitore della fibrinolisi. I valori di laboratorio che suffragano la necessità cli una trasfusione di plasma sono: PTT 1,5 volte il valore di controllo , fNR > 1.7 e lasso del fibrinogeno< 1,5 g / L.
I n assenn di sindrome emorragica la trasfusione di plasma è indicala -,olo in caso di PTI, exanguinotrasf usione e porpora fulininanlc <lei 1H·onato per deficit congenito di proteina C o S. Trasfondere il plasma è controindicato invece per ripri,tinare la Yolcmia, per mantenere la pressione aneriosa o oncolica, per utilizzai lo come li9niclo di sostitu7ione nel plasma exchange ad e c cezione cht> per la terapia della PIT.
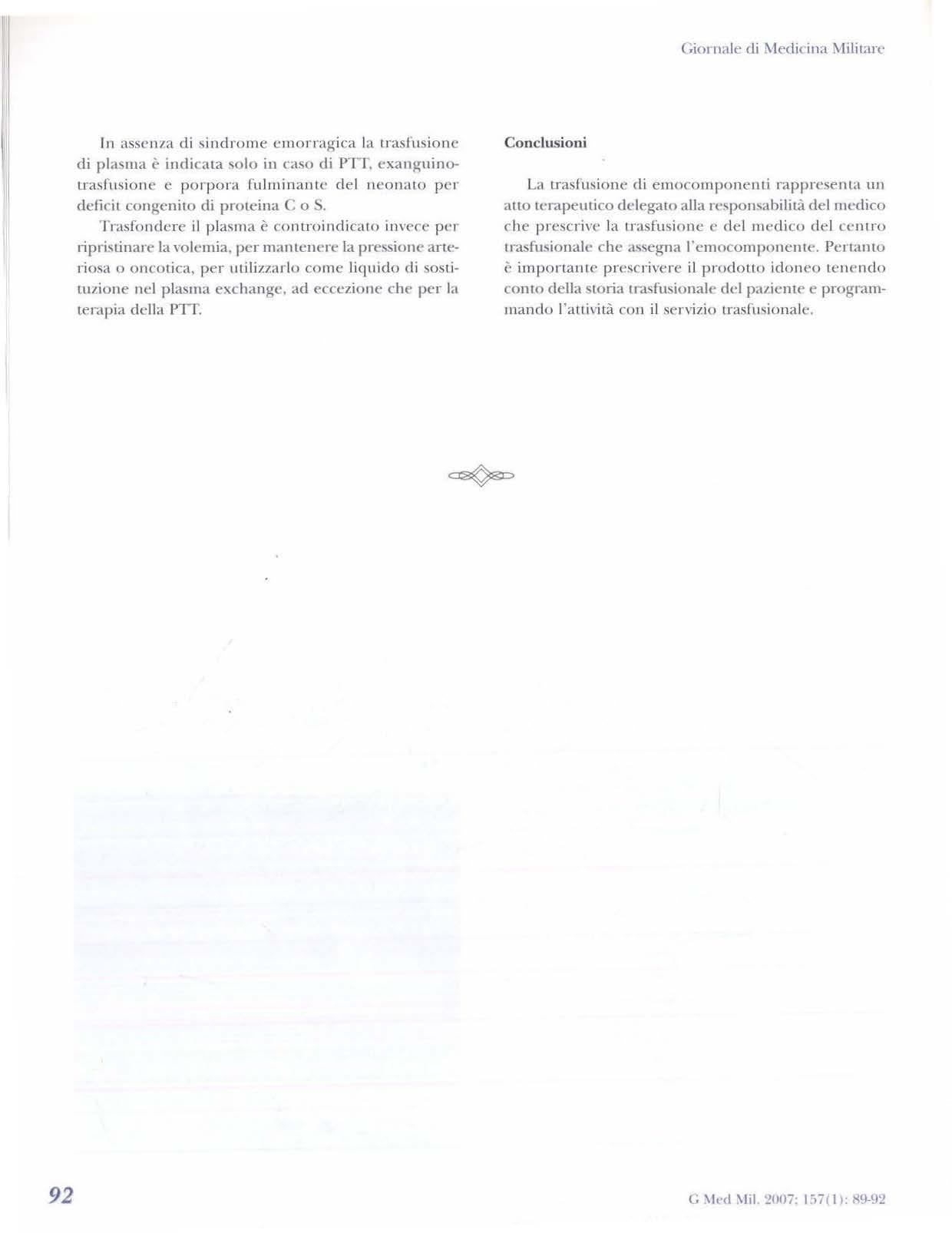
Conclus ioni
La trasfusione di emocomponenti rappresenta un ano t<'rapeutirn delegato aJla rl',pomabilità ciel medico che prescrive la trasfusione e de l m e dico del cc mro trasfusionak c he a<,segna l'cm ocomponentt>. Pc1 tanto l· importame prescrivere il prodotto idoneo tcn<'ndo conto della ~toria trasfll!>ional e del pa1iente e programmando r auività con il .servizio trasfu~iona le .
* S. Te.n, Co Sa spr RS - Ufficiale rnordinatore delle at1111iti1 mfi:rrnieristirhe. Airowgo - Dipw-ti11w>1fll r/1 lmmurwemalolugia - Po/irlinico Afililare di Ro11111.
Riassunto - Questo articolo descrive il ruolo delrinfrrmiere nell a dona.lionc cli sangue.
Donare sangue costi cui see una auivi1à molto importante nella Medicina Trasfusionale, ma purtroppo in Italia, e specialmente nelle 1egioni del Sud, il numero di donatori risulta essere ancora scarso.
li servizio trasfusionale militare deve garan1ire le scorte necessarie per I'atli,·ità cieli' ospedale mili tare e predisporre le unità di sangue da destinare alle missioni mi l ita1i.
11 servizio trasfusiona le militare c-ollabora. inoltre, cùn le su-uuure sauitarie civili.
1n questo comesto. quindi, gli infermieri cle\'0110 operare con autonomia e responsabilità in tre differenti aree assistenziali c he 1·ichiedono appropriate conoscenze professionali e abilità decisionali: area tecnico-professional e, educazione sanitaria e suppono psico logico anche al line di incrementare il numero di donazioni di sangue.
Le recenli riforme hanno creato uno specifico percorso formati,·o e l'attuale legislazione sulle professioni sanitarìc ha conu·ilmito consi<lere,•olmente a .-ivalu1.a1T il ruolo dell'infr·nniere.
Parole c hiave: Don az ion e di sang u e, ru o lo d e ll ' infe rmi e re oel servizio trasfus io n ale mUitare, sost e gn o p s icologic o.
Introduzione
Il Senri zio Trasfusionale costituisce una realtà partico lare, che si discosta da alcun i aspetti della normale routine ospeda li era. opera nei confronti della sLrUttura d'appartenenza, de l singo lo, ma soprattutto de ll a co ll ettività. ln partico lare, la corrispettiva rea l tà militare si prefigge il compilo di raggiungere la completa autonomia delle Forze Armate in ambito u-asfusiona le e, soddisfatta tale esigenza. di collaborare con le strutture sanita1ie civili.
Summar y - This anicle repons thc nu1·se role in a blood clonalion. Give blood is a Yery important acti\'ity in transfusion rnetlicine. but unfortunately ù1erc are not many donors in ltaly. specially in so nthern counuies.
The army blood service have to guarantce Lhe bloocl ~tocks for the military hospital and dra\, up in advance the bloocl units 1·or rhe military operaLions. Then tran~fusion servicc cooperate with civilian hospiral.
So nurses havc to work with antonomy and respon~ibilities in ùiree differenL nursing areas which requirc appropriate knowledge as Kell a~ professional :md decisional skills: clinic area. healLh educ.ition and psychological support to increase h lood donalions, wo.
Rccr,111 reforms h.ive ncated a specific ecl11calional path, and thc present legilibtion on nursing con t ributed considerab ly to reva l uc nurse's profcssional role.
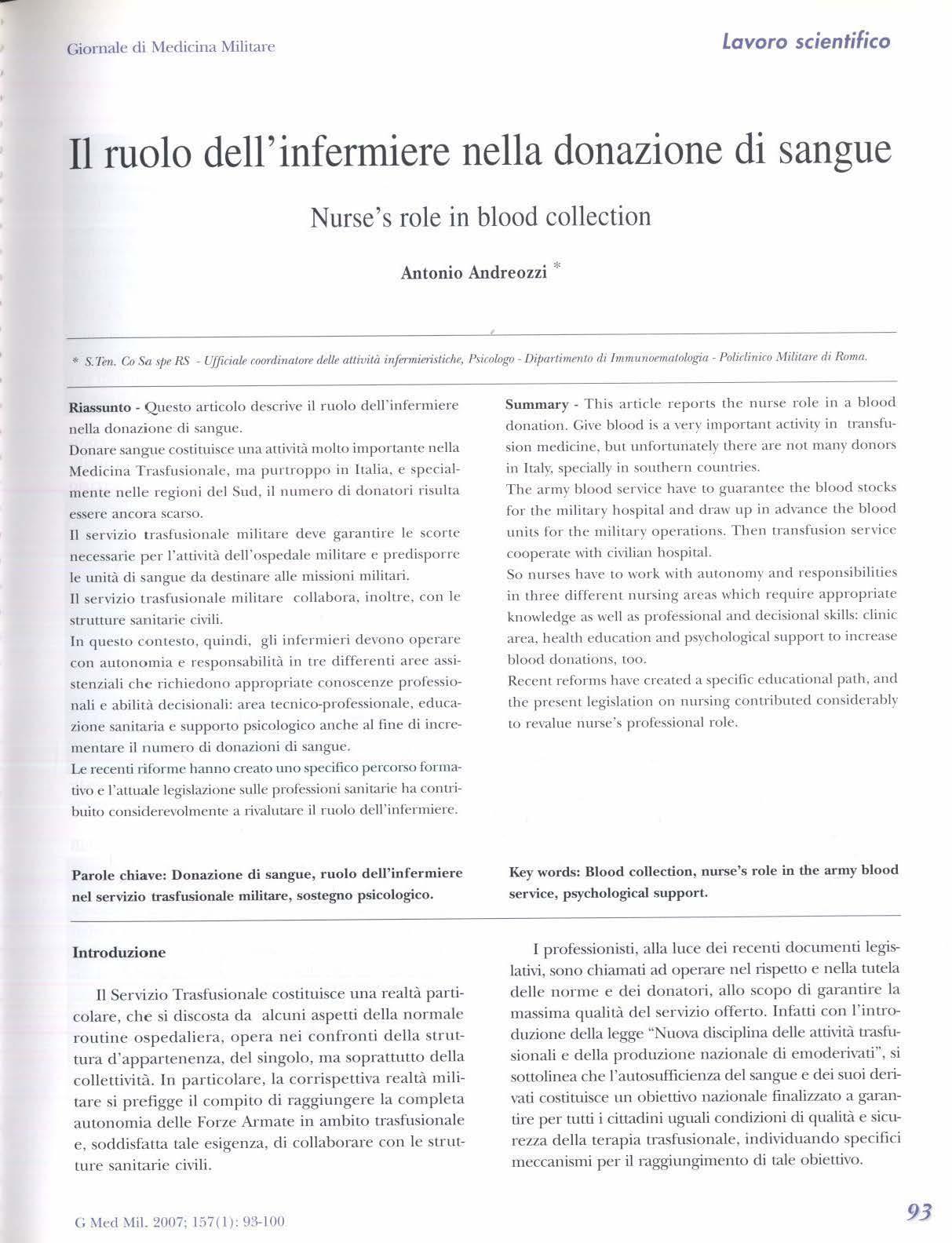
e; :\1ecl
Key word s: Blo o d collec tion, n urse's ro le in the a.rmy blood se rvi ce, p sychologi cal s upp o rt.
I professionisti, a ll a luce dei recenti documenti legislati\ri , sono chiamati ad operare nel rispeuo e nella tutela delle nonne e dei donatori, allo scopo di garantire la massima qualità rle l servizio offerto. I nfatti con l'introduzione della legge "Nuova disciplina delle atti,rità trasfi.Jsionali e della prod u zione nazionale di emoderiva6", si sottol inea che l'autosufficienza del san1:,rue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire per tutti i cittadi n i uguali condizioni di qualità e sicurezza de lla terapia L:ra5fus iona le, individuando specifici meccanismi per il raggiungimento di tale obieuivo.
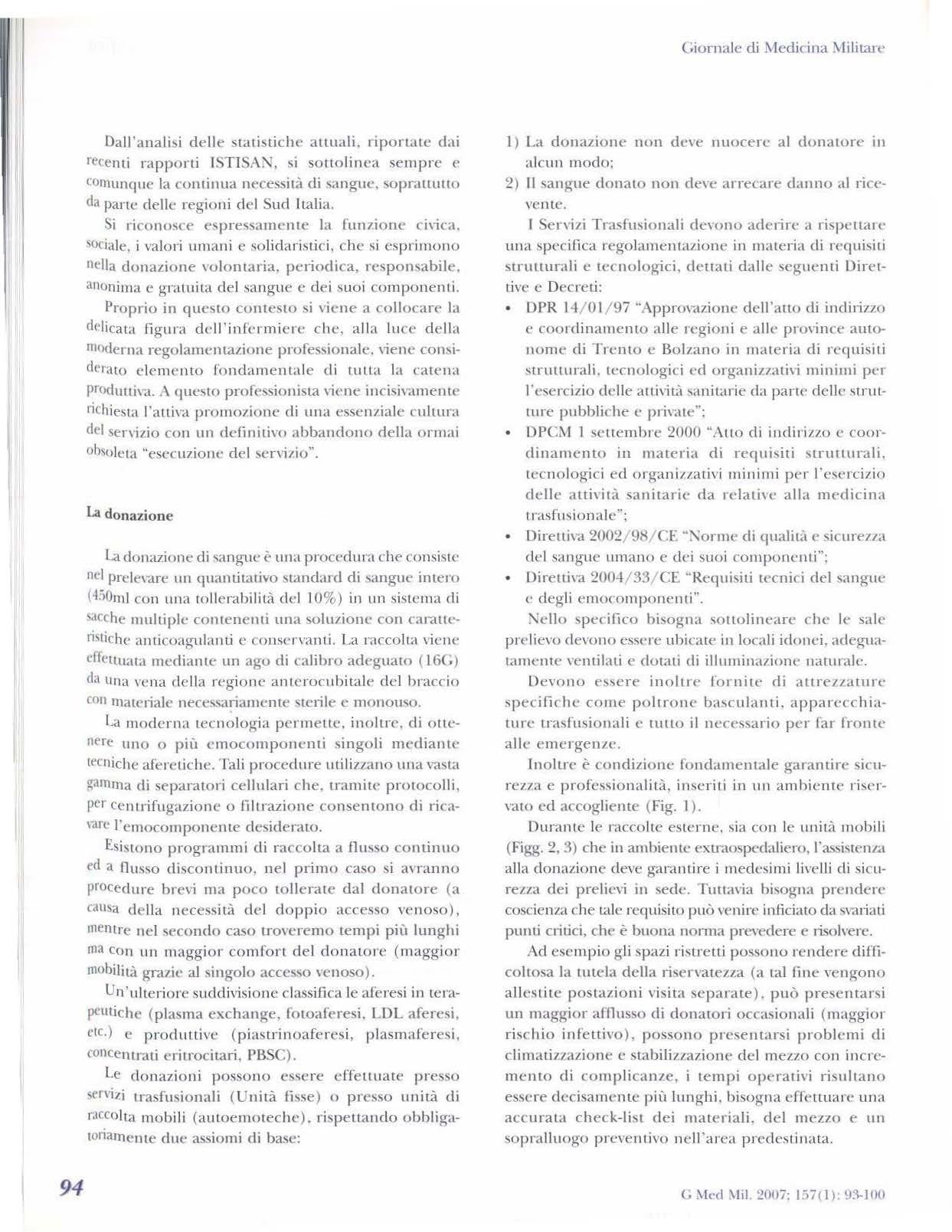
Dall'analbi delle statistiche auuali. riportate dai recenti rapporti ISTISAN, ~i sottolinl'a sempre e comunque la continua necessità di sanguc, soprauutto da parte delle regioni del Sud Italia. Si riconosce espressame nt e la fu111ionl' ci,ica. ,ociale, i valori umalli e ~olidaristici, chc si esprimono n<.>lla donaLione ,olontaria. periodica, respomabile, anonima e gratuita del sangue e dei ~uoi componenti.
Proprio in qucsto co11testo si ,iene a collocare la rl<'licata figura dell'infcrmierl' che. alla luce della moderna regolamt'ntaLione profes~ionale, ,iene comidt•raro elemento fondamentale di tutla la catena produuirn \ quc~to prof't>ssionista viene incisirnmente iichiesta l'atti,"tl pro11107ione di una esse117iale culLura del ,en-i7io con un dcfiniti,-o abbandono della ormai obso leta "esecuzione.; del scrvi:,io".
La donaz io n e
La donazione di sangul' è una procedura che consiste nel prele,-are un quantitativo st.:mdarcl di sangue intero (450inl con una tollerabilità del 10 %) in un siswma cli ,arche multiple contenenti una solu1ione con carattcri,tiche amicoa 611ilanti e conservanti. La raccolta viene effettuata mediante un ago di cal ibro adeguato (16(,) eia una l'ena della regione antcrocubitalt> del braccio con inate1iak nece\.sariamente '>tc1ile e monow,o.
La moderna tecnologia permette, inoltre. di oncnere uno o più cmocomponcnti singoli mediante t<'Cniche aferetiche. Tali proccdnre utiliuallo u11a \'asta lf,linma di separatori cellulari che. tramite protocolli, per centrifugazione o fìltrazione consentono di ricararc l'cmocornponcme clcsideraw.
EsisLOno programmi di raccolta a fln'>SO continuo ed a Clusso discontinuo, nel primo caso si avranno proce dure brevi ma poco tollerate dal donatore (a causa della necessità del doppio accesso venoso), mentre nel 'ieconclo Clli>O tro,cremo tempi più lunghi ma con 1111 maggior comfort ciel donatore (maggior n1obilità gralic al singolo accesso ,cnoso).
Un'ulteriore suddivisione classifica le aferesi in terapeutiche (p lasma exc han ge, fotoafrresi. l.DL aferesi. etc.) e produltivc (piastrinoafercsi. plasmaferesi, concentrati eritrocitari, PBSC).
Le donazioni possono es'iere effettuate presso ,mizi trasfmionali (Unirà fi'>se) o presso unirà di 1,trco lta mobili (autoemoreche). rhpetlando obb ligawriainente dne as~iomi di ba~e:
l) La dona7i<rne non dc,e nuocei e al donatore in alcun modo;
2) Il sanhrue donato non de,·c arrecare danno al rict'ventc.
1 Sen'i7i T ra!,fusionali cle,·ono aderire a ri~1wua1 t' una spccilìca regolamcnta1ione in materia di requisiti strutturali e tc·cnologici, dettali dalle seguenti Dirt>ttivc e Decreti:
• DPR 14/ 01 / 97 ".\pprorazione dell'atw di incli1izzo e coordinamento alle regioni e alle p1mince autonome di Trt"nto e Bol1ano in materia di requisiti sLruuurali. tecnologici ed organiaati,i minimi per l'eserci7io delle attività sanitarie da pant' delk srrutture pubbliche e prirate":
• DPCJ\I l settembre 2000 "'Atto di incliriao (' coordinamento in materia di rc<]uisiti ,trutturali, tecnologici ed organi11ati\'i 1llinin1i per l'estrcizio delle att i\ità sanitari(- eia rl.'lati,c alla medicina trasfusionale";
• Direni, a 2002; 98 ' CE "l\:onne di qualitù e sinu-e7,a del sangue umano e dei suoi componenti";
• Direlli\'a 2004 / 33 CE "'Regni<;iti tecnici del 'iangue e degli emocomponcnti".
. elio specifico bisogna sottolineare che le sak prelie\'o de,·ono essere ubicate in locali idonei, acleh111ata111erne \'Cntilati e dotati di ill11111ina1ione naturale. Devono e~~cre inoltre fornite di an re11 aturt' specifiche come polrronc basculanti, apparecchiature trasf'u5io11ali e tutto il necessario per far fronw alle emergenlc.
lnoltrc è condizione fondamentale garantire sicureaa e professionalità, in~eriti in 11n ambiente riser\",lto ed accogliente (Fig. I).
Durante le raccolte esterne, sia con le unità mobili (Fi gg. 2, 3) che in ambiente extraospedaliero, l';mi~tenz.1 alla donaz.ione deve garanrire i medesimi livelli di sicureua dei prelic,,i in sede. Tutta\ia bisogna prendere coscienza che télle reqnisito può wnire infic iato eia ~,"ariati pu11ù criùci, chc è buona norma prevedere e risol\'erc.
Ad esempio gli spazi ristretti possono rendere diffìcoltosa la rmela della risen-atetla (a tal fìne vengono allestite postazioni visita ~eparate). può p1-ese11tar\i un maggior af'nusso di clonato1i occasionali (maggior rischio infettivo), possono presemarsi problemi di climati71aLione e stabiliuazione del mezzo con incremento di complica111e, i tempi operati\'i risultano essere decisamente più l11nghi, bisogna effettuare una accurata check-list dei materiali. ciel mezzo e un sopralluogo pre\'eutivo n e ll 'area predestinata.
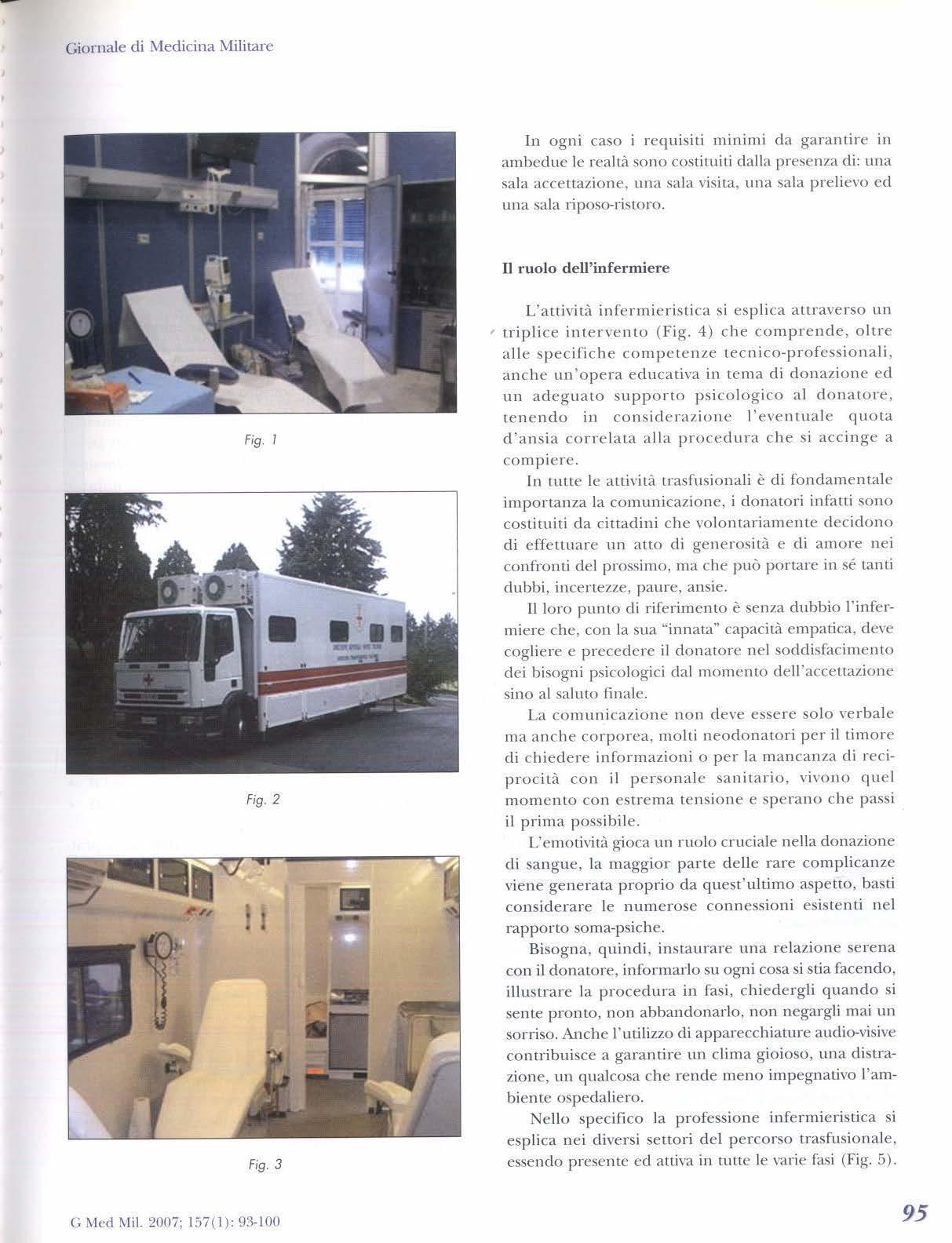
In ogni caso i requisiti minimi da garantire in ambedue le realtà sono costituili dalla presenza di: una sala accettazione , una sala visita, una sala prelievo cd una sala 1iposo-ristoro.
L ' attività infermieristica si esplica attraverso un triplice intervento (Fig. 4) che comprende, oltre alle specifiche compctenLe tecnico-professionali, anche un 'opera educativa in tema di donazione ed un adeguato supporto psicologico al donatore, tenendo in considt>razione J'evenrnale quota d'ansia correlata alla procedura che si accinge a compiere.
In tutte le attività trasfusionali è di fondamentale importanza la comunicazione, i donaLOri infatti sono costituiti da cittadini che volontariamente decidono di effettuare un atto di generosità e cli amore nei confronti del prossimo. ma che può portare in sé tanti dubbi, incertezze, paure, ansie.
Il loro punto di rifedmcmo è senza dubbio l'infermiere che, con la sua "innata'' capacità empatica , deve cogliere e precedere il donatore nel soddisfacimento dei bisogni psicologici dal momento dell ' accettazione sino al saluto finale.
La comunicazione non deve essere solo verbale ma anche corporea, molti neodonatori per il timort' di chiedere informazioni o per la mancanza di reciprocità con il personale sanitario, vivono quel momento con estrema tensione e sperano che passi il prima possibile.
L'emotività gioca un ruolo crucia le nella donazione di sangue, la maggior parte delle rare complicanze viene generata proprio da quest'ult.imo aspetto, basti considerare le numerose connessioni esistenti nel rnpporto soma-psiche.
Bisogna, quindi, instaurare una relazione serena con il donatore, informarlo su ogni cosa si stia facendo, illustrare la procedura in fasi, chiedergli quando si sente pronto, non abbandonarlo , non negargli mai un sorris o . Anche l'utilizzo cli apparecchiature audio-visive contribuisce a garantire un clima gioioso, una distrazione, un qualcosa che rende meno impegnativo l' ambiente ospedaliero.
Nello specifico la professione infermieristica si esplica nei diversi settori del percorso trasfusionale, essendo presente ed attiva in tutte le \'ari<" fasi (Fig. 5).
Tecnico professionale
• Conoscenza normative trasfusionali
• Accessi vascolari
• Tecniche di prelievo
• Gestione unità sangue
• Gestione complicanze
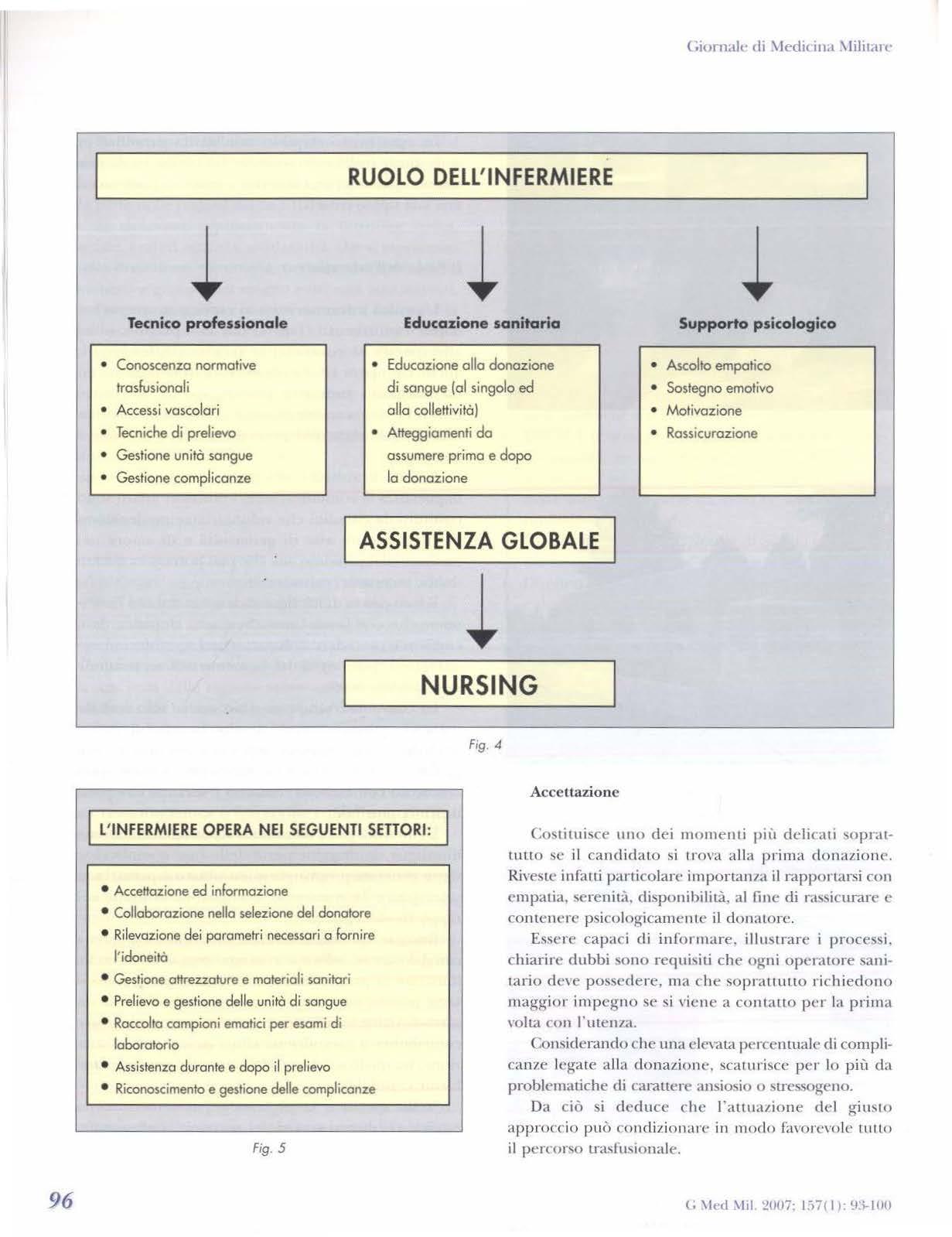
Educazione sanitaria
• Educazione alla donazione di sangue (al singola ed o lla collettività)
• Atteggiamenti da assumere pri ma e dopo la donazione
Fig 4
L' INFERMIERE OPERA NEI SEGUENTI SETTORI :
• Accettazione ed informazione
• Collaborazione nello selezione del donatore
• Rilevazi one dei parametri necessari o fornire l'idoneità
• Gestione attrezzature e materiali sanitari
• Prel i evo e gestione delle uni tà di sangue
• Raccolto campioni ematici per esami di loborotorio
• A ssistenza duran te e dopo il prelievo
• Riconoscimento e gestione delle complicanze
Fig. 5
Supporto psicologico
• Ascolta empotica
• Sostegno emotiva
• Motivazione
• Rassicurazione
Accettazione
Co,Lilu isce u110 dei momenti più de l icati sopratt u tto ~e il cand ida to si t rova a ll a p rim a <lonali o n e. Ri vesle in fat t.i p a rricolare importan?a il rapponarsi con empatia, serenità, dispo n ib ilità, al fine di ra'isicurare e co m e n cre psico logicame n1 e il d omuor c
Esse r e capaci d i i nfo r mare. illu str are i process i, c hia ri re dubbi sono requis iti che ogni operatore saniLario cit've p ossede r e, ma c h e sopra u uuo ri ch ie d o 11 0 m agg- ior impeg n o se s i vie n e a con t a tto per la prima ,olta con l'mc111a.
Comid eran do c h e una eleYata percentuale di com pl icanze lega te a ll a d o n az io n e. sca t ur isce pe r lo pi ù eia p roblemaòc h e di caram: re a nsiosio o strcssogeno.
Da ciò si ckduce c h e l'auua1io n e cie l g i us t o approccio pu ò co ndi z io n a re in modo favo r evole t u tto il perco r ~o trasfmiona le.
La selezione
Questa attività viene regolata da una precisa normativa a carattere na1ionale (Decreto Ministeriale del 3 marzo 2005 pubblicato sulla G.U. n. 85 del 13 aprile 2005) che definisce i requisiti per accertare l 'idoneità alla donazione di sangue e di emocomponenti.
Questo iter procedurale inizia con un primo intervento da parti." dell'infermiere che, se opportunamente formato, può aiutare il donatore alla stesura del quesùonario anamnestico, fornendo tutti i chiarimenti necessari per consentire di affrontare l a do11azio11c consapevolmente. Segue poi la rilevazione di ll.Itti quei parametri vitali e corporei richiesti per valutare l'idoneità (frequenza cardiaca. pressione arteriosa, emoglobi11emia o emocromo, peso corporeo, stalllra) annotandoli accuratamente sulla ~chec.la individuale. E' altresì importante segnalare al medico responsabile dell'unità cli raccolta eventuali segni e / o sintomi che potrebbero essere utili in sede di visiLa medica.
Attrezzature e materiali
Vengono all"occorrenza utilizzali presidi specilìci.
• Sistemi di sacche multiple (Fig. 6):
• Provette per esami di laboratorio generali e specifici: Tennosaldawri;
• Disinfeu.anLi con rnonostick allo iorlopcH'ido11e;
• Tamponi per medicazioni compressive;
• Bilance agitatrici (Fig. 7);
• Dispositivi e farmaci di emergenza: Fig. 6
• Registri ed etichette rndifìcate;
• Fiigo,·iferi (per le raccolte esterne)
La prepara1ione del sito e.li prelievo per la donazione di sangne o di ernocomponcnti 1;chiede la disinfe,ione della regione anterocubitale del braccio intcressaLO. Essa è una procedura avente scopo di ridurre. si110 a livelli accettabili , la carica dei contaminanti microbici present.i nell'ambiente o su specifici substrati.
L'eseculione ciel prelievo con tecnica asettica è una rnanO\'ra fondamentale per garantire la sicurezza trasfusionale poiché minimizza il rischio di contaminazione degli emocomponenti da trasfondere.
Gli antisettici utilizzabili comprendono.
• Clorexidina in soluzione alcolica;
• Ammonio quaternario in soluzio11c alcolica;
• Alcol isopropilico a l 70 % ;
• Solulioni a base iodata (iodopmidone).
E" importante praticare, durante l'applicazione, una rnano\Ta di sfregamento e rotazione a spirale per consentire una rimoLione meccanica df'i germi presenti. L"antiscttico necessita cli un adeguato Lempo di contatto di almeno trc:nta secondi per esercitare la propria azione.
Ind ossare sempre guanti monouso non sterili. di misura adeguata , rhe conservino una buona sensibilità a l tatto e con 1·acconezza di cambiarli ad ogni pro eed u ra/ donatore.
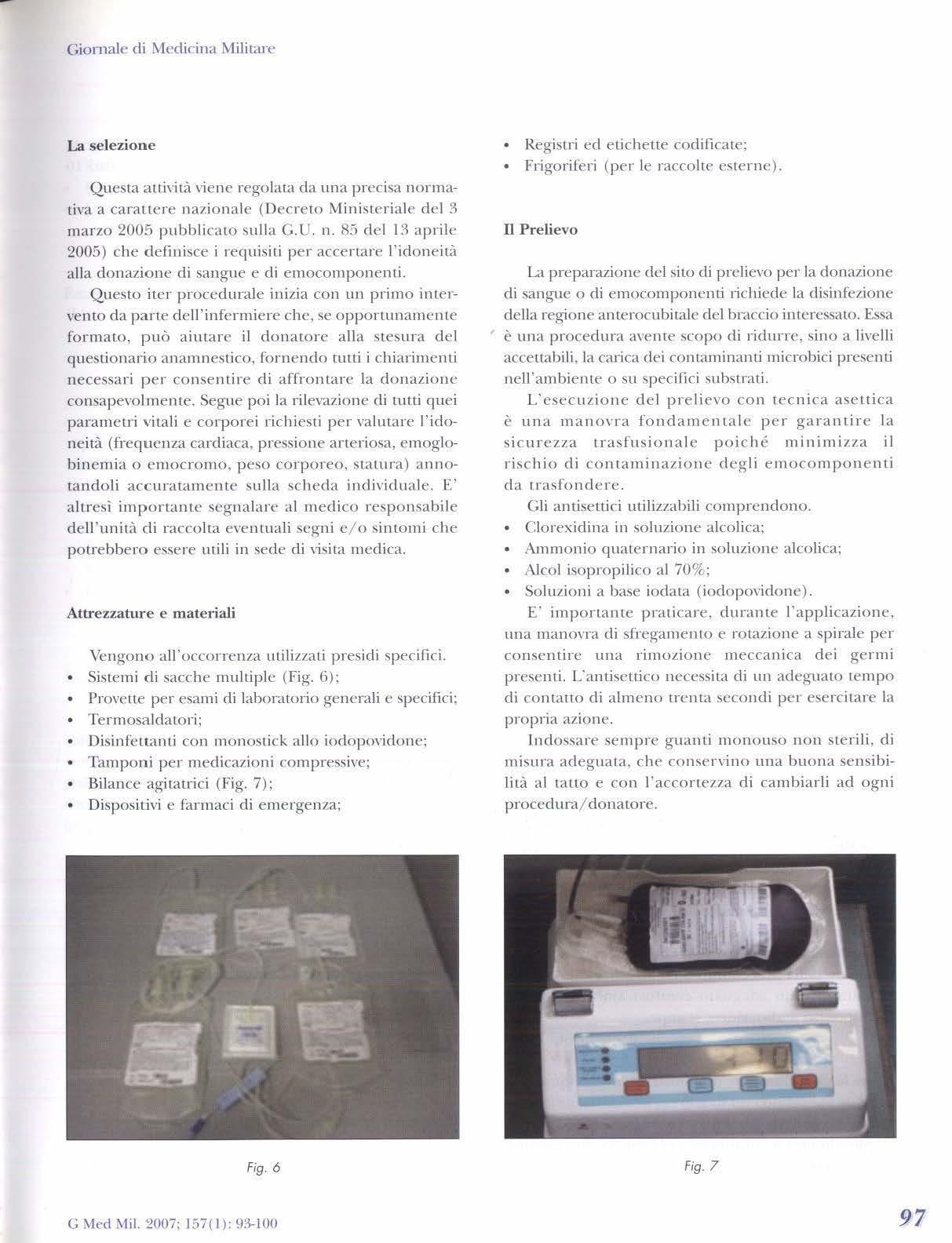
7
li sangue per uso trasfusionale viene prelevato in sacche multiple (trip le , quadruple, quintuple) all'interno di un sist<"ma a circuito chiuso costitu i to da materiale plastico nessibile so litamente in polivinilc lornro. li Kit è dotato di un dispositivo a campana per il prelievo dei campioni ematic i con valvola cli protezione. un sistema di sicurezza per l'ago ed un lìltro deleucocizzante. In o ltre all'interno del circuito è presente una soluzione con caratteristiche anticoagulanti e conserrnnti che, nel caso del SAGM, permette la conservazione dell'unità per 42 giorni.
Per ridurre il rischio di emo li si in fase cli raccolta i l sistema adotta un ago di calibro 16 G.
P rima di ogni procedura le sacche dovranno essere ispezionate con cura da parte del persona.le infermi<"ristico, ponendo particolare aucnz ione ad eventual i anoma li<" , data di scadenza, stato di conservazione, alterazioni visibili del contenuto.
Successivamente reperire una vena dalla conforma,:ione anatomica adeguata àll'esigenza. prefr·rendo le vene della regione antecubira le del braccio (brachiale, cefalica, basilica) con decorso l ineare e ben comenute dal Lessuto circostante.
Una vo l ta eseguita la venipuntura, è necessario fissare l'ago in maniera id onea onde evitare la fuoriuscita dello stesso o impedimento a l deOusso.
Durante la donazione
• Bisogna far assumere al donatore una pos1z10ne idonea che consenta un 'adeguata perfusione cerebrale;
• Vigi lare continuamente sulle condizion i fisiche del soggetto;
• Avvertire il donatore cli segnalare qualsiasi tipo di disturbo oggeuivo o soggetLim;
• Controllare l'accesso venoso cd il corretto svolgimento della procedura;
• GaranLire w, adeguato comfort ambientale, con dispositivi au<lio, video, stampe.
Dopo l a donazione
• i nvitare il donatore a m antenere la posizione distesa per almeno 5 / IO minuti apµlicando una medicaLione comprc.ss i,·a con lamponi emostatici:
• Predisporre il 1wcessa1io per garamire un congruo ristoro cori stazionamento contro llato per a ltri 10 minuti:
• Riveste fondamental e imponauLa prescrivere per la giornata:
- Una dieta ricca di liqujdi ;
- L'astensione da attività sportive intense;
- L'astensione da lavori pesanti;
- L'evitare la permanenza in ambienti chiusi, caldi o troppo affo ll ati.
Riconoscimento e gestione delle comp licanze
Nelle donazioni di sangue le comp li canze si presentano con estrema rarità ma, allo stesso tempo, richiedono un riconoscimento tempestivo e l'attuazione di tutte le previste manovre di in tervento.
Le comp li ca n ze sì dividono in reazion i locali e reazioni sistem iche (Fig. 8) e possono verificarsi m relazione a t r e variabi li fondamentali:
• Manualità dell ' operatore;
• Reattività del donatore;
• Condizioni arn bien tali scaden ri.
Irritazione cutanea
Dovuta spesso a reazioni allergiche che si manifestano nella regione deputata alla venipuntura Sono causate prevalentemen te dalla tipologia di disinfettantf' utilizzato e dalla sensibilit à cutanea del donatore ali 'ant isettico.
• Irritazione cutaneo
• Ematoma
• Lesioni nervose
• Lesione arterioso
• Flebite
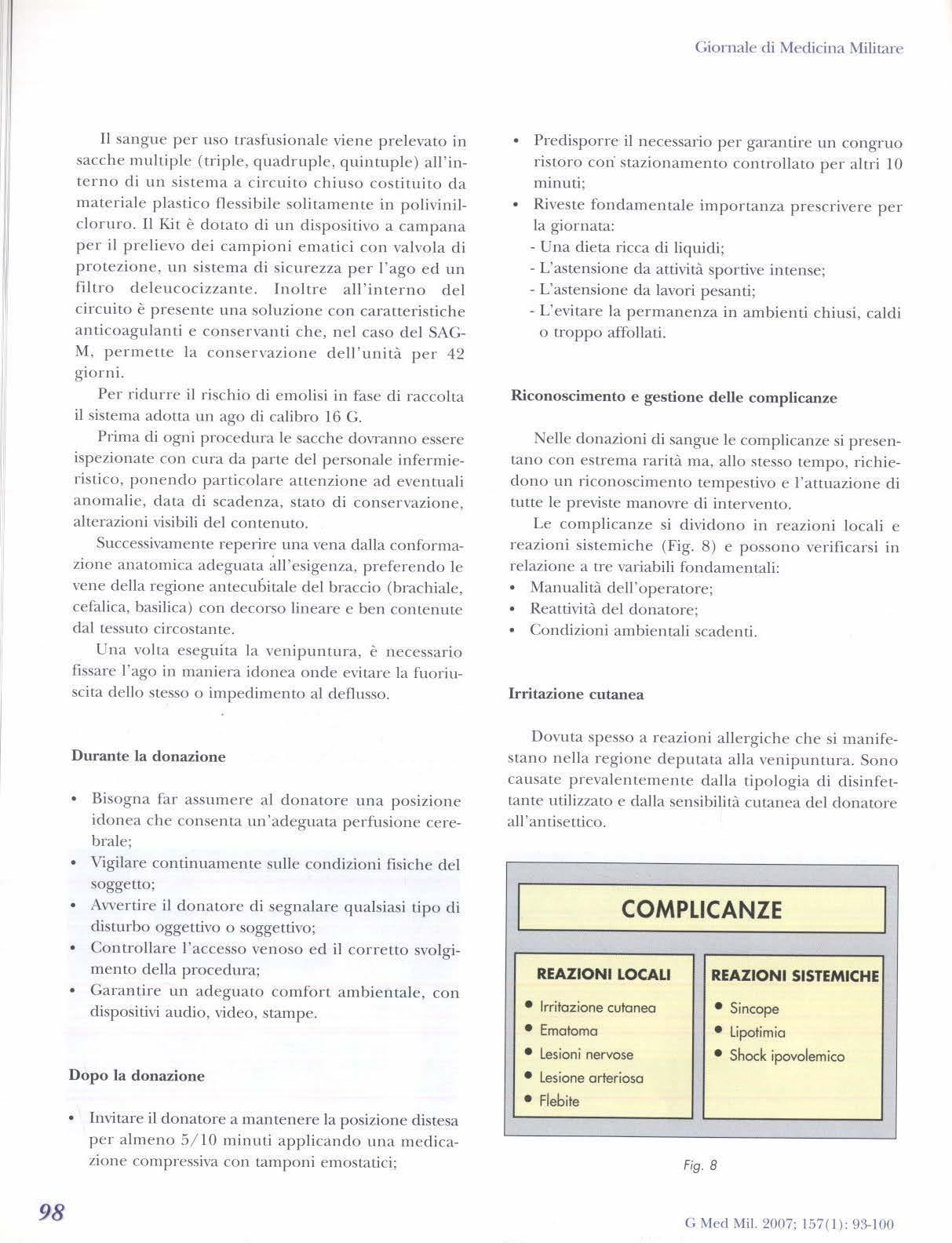
Fig. 8
• Sincope
• lipotimia
• Shock ipovolemico
Manovre e terapia:
Rimuovere il disinfettante con un lavaggio accurato;
• Raccogliere dati anamnestici s ull'episodio allergico;
• Utilizzare soluzioni alternative ed in altre sedi cutanee.
Ematoma
Caratterizzato da una raccolta di sangue all"interno di un tessuto a seguito di uno stravaso ematico. Le cause vengono 1intracciatc quasi esclusivamente nella poca manualità da parte dell'operatore oppure nel caso di prelievi indaginosi.
Manovre e /prapia:
• Rimuove re il laccio emostat.ico;
• Estrarre l'ago;
• Esercitare pressione in sede con tampone;
• Praticare impacchi freddi;
• Yledicarc con pomate analgesiche e / o eparinoidi;
• Informare il donatore su ll 'eve ntuale ematoma e sul tempo di riassorbimento.
Lesione nervosa
Dovuta ad irritazione dei rami nervosi muscolocutanei.
Si manifesta con dolore intenso che in so rgendo in sede di venipuntura si irradia al braccio. Pu ò causare una liew impotenza funzionale all'ano interessalo ma in genere si 1isolve spontaneamente.
Manovre e Terapia:
• Antalgic i e kinesirerapia.
Lesione arteriosa
Durante il prelievo si riconosce per la velocità del flusso in uscita , per il colore rosso vivo del sangue, per il getto pulsante e, nel caso di lesione ampia, si evidenzia la formazione di crnawma imporrante.
J\1a110vrP e terapia.:
• Rimuovere il laccio emostatico cd estrarre l'ago;
• Esercirare un 'accu rata compressione della zona per a l meno 10 minuti;
Applicare, succcssivamenre, una medicazione compressiva.
Flebite
Infiammazione lungo il decorso del vaso interessato, si presenta come un cordone dolente e può accompagnarsi da adenopatia sarellitare ascellare, febbricola e lieve leucocitosi.
Può evolvere in trombonebite superficiale o in linfangite.
1'v1.ano11re e terapia:
• Farmaci antibiotici e antinfiammatori locali.
Sincope e/ o lip otimia
Perdita temporanea dello stato di coscienza (esci usivamente nel caso di sincope) con sintomatologia vegetativa (sudorazione, pallore, ipotensione).
Etiologia: riflesso vaso-vagale, iperventilazione, emorragia. ipoglicemia, reazioni emotivo-psicologiche.
Manovre e t erapi<i
• Sospendere il pre1ievo; Estrarre l'ago (in previsione di eventuali convulsioni);
• Posizione trendelemb1irg;
• Allentare abiti streui;
• Somministrare Sol. fisiologica;
• Se necessario: midodrina cloridrato 10-20 gtt.;
• Se è presente nausea e/o vomito ruotare la testa su un lato;
• Nel caso di contrazioni o spasmi: far respirare in un sacchetto;
• Se insorgono comp li canze cardiache o arresto: rianimazione cardio-polmonare.
Sh ock ipovo lemico
Complicanza ranss1ma in ambito trasfusionale, viene scatenato dalla perdita di un consistente volume di sangue a cansa di errori tecnici o per particolari condizioni fisiche del donatore non emerse in sede di visita medica.
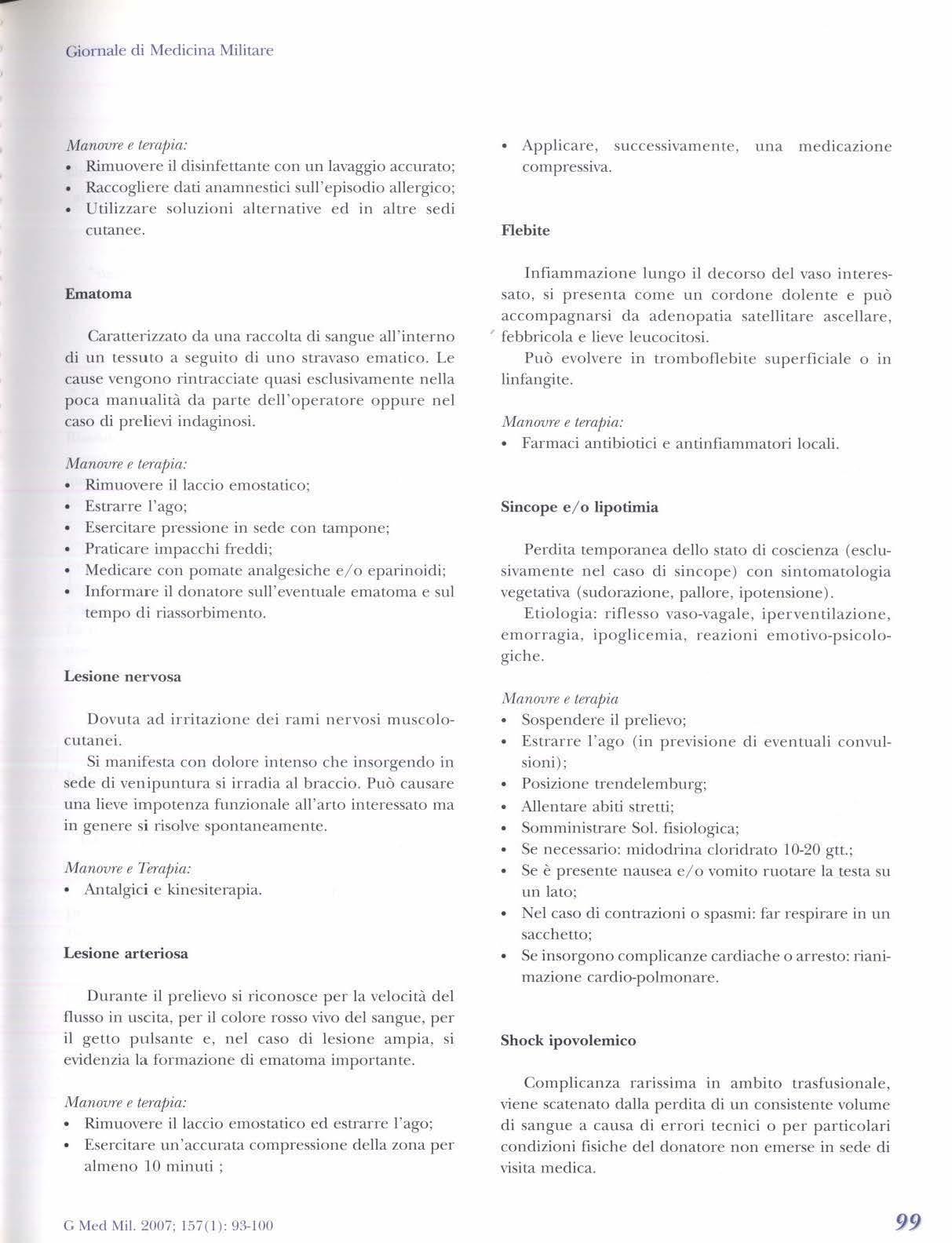
Med Mii. 2007; 157( 1 ): 93-10/J
\1an(nlrf' P lem/Jia:
• Eliminare Il' cause (sospendere il prelievo);
• Tenere pervio un accesso venoso;
• Fa, assumer<' posiLione Tre11rlelemburg:
• Ripi-i stinarc la volemia e la pressione sanguigna;
• Ripristinar<' l'auivitù cardiaca (ad <:sempio mediante l'u,o di farmaci simpaticomimctici).
Il Si,tema Sanita1io Na1iomùt· ha regi,1rnto negli ultimi tempi un profondo cambiamen to che richiede, tra l'altrn, la presenza di infermieri competenti e di a l to profilo profrssionalt'. Sono neu:~sari opcrncori -,anitari formati cou i più recenti programmi 11nivcr;itari. idonei a fornire un ampio e notevole bagaglio di cecnico-scientifiche, che pennet ta loro di interwnire in qualsiasi ambito e con cstrt'ma sic urezza e prokssionali1:;ì.
Tutto ciò si coniuga perfettamente in quella che è la delicata realtà 1ra.sh.1Sionale 'don>, anch<' il ~empi ice gesto rlel donare sangue, cos1i1Ubc<' un ~c1io impegno che \'edc l'infermiere non ,olo re,1><msabilc della procedm,1 tecnica ma anche rlell'opcra '>Ociale clw lo vede i111erprcte.
La dedizione e gli alt.i \'alori umanj vedono il pnsonale •,anitario operar<· con abnegaLione nei confronti del pro~ simo, stimolando la nascita di un sentimemo d'amore per la proft•,-,ione ed un .profondo ,i-,pcno per la sollcrem..a.

Bibliografia
I Mo laro G . L. : Il Jm,fievo di sanguP P la teraj>ia lmsfw,ionale. SIMT I 1996.
2. DPR 14/0 1/ 97: "tlppro11m.ione rfp/l'atto di indirizzo e roordinrunl'1llo allP regioni e allP prar1ince autonome rii Trento t • Boh:.ano in malPna di req1111il1 strutturali. IPnlOlv[!ici rii mganiz.zalivi minimi ptr l'esPrci:.io delle a1tit1ilà mnitcmP da pmtP dellP 1/ruttun, /mbhliche e private".
3. Zanetti A.: Il risrhio trasjìtsionale e /p infezioni lmsmi.Hibili. Edizione SI~IT I 2000.
4. DP CM 1 sette mbre 2000: K1llto di indinz.zo P coordinmnenlo in materia di rf'quisiti ,trn/lumli. lernologici ed organi:.zalivi minimi pn l'ewrrizio d,,tlP attit1ita sanitari,, da relative alla medicina lrwfulionalP ·•.
5. Direttiva 200 2/98/CE: ..Sonni' di qualità e siuor,.;:,a dd wngup 11111m10 e rll'i rnoi comj>onenti ".
6. Diretti va 2004 /33/ CE: ·'Reqimili lernici rirl l<llll(ltf' e degli emoco111po11enti ".
7. Decreto Ministe riale d e l 03 marzo 2005: Pubb/1raln mila G. U. 11. 85 dRI 13 aprilP 2005.
8. Registro Nazio nale e Regionale d e l sangue e d e l plasma: Rrtpj,ortn 2006.
* Mar. Ord. hl}èrmiere - Dipmtimento di lmmu11wmntologia - Polù·li11iro Mili/art di Noma.
Riassunto - La trasfusione di sang11c rappresenta una terapia comp lessa che coinvo lge varie ligure professionali. Lrn le quali medici e infermieri. Il ruo lo dell'infermiere cosLitui,ce un 'al 1iviuì essenziale , non ~olo garantendo ,L~sistenza e supporto psicologico, ma a11che monitorando l'intera procedura.
Infatti le terapie trasfusionali vedono gli infermieri impegnati in molte prncedure che richiedono approp1iaLe conoscente e ~pirito di inizialiva.
La recente legislatura. con nuo1 i percorsi formativi, r iconosce il nuovo ruolo professionale dell'infermiere contsibuendo ad e le\'are il suo prestigio.
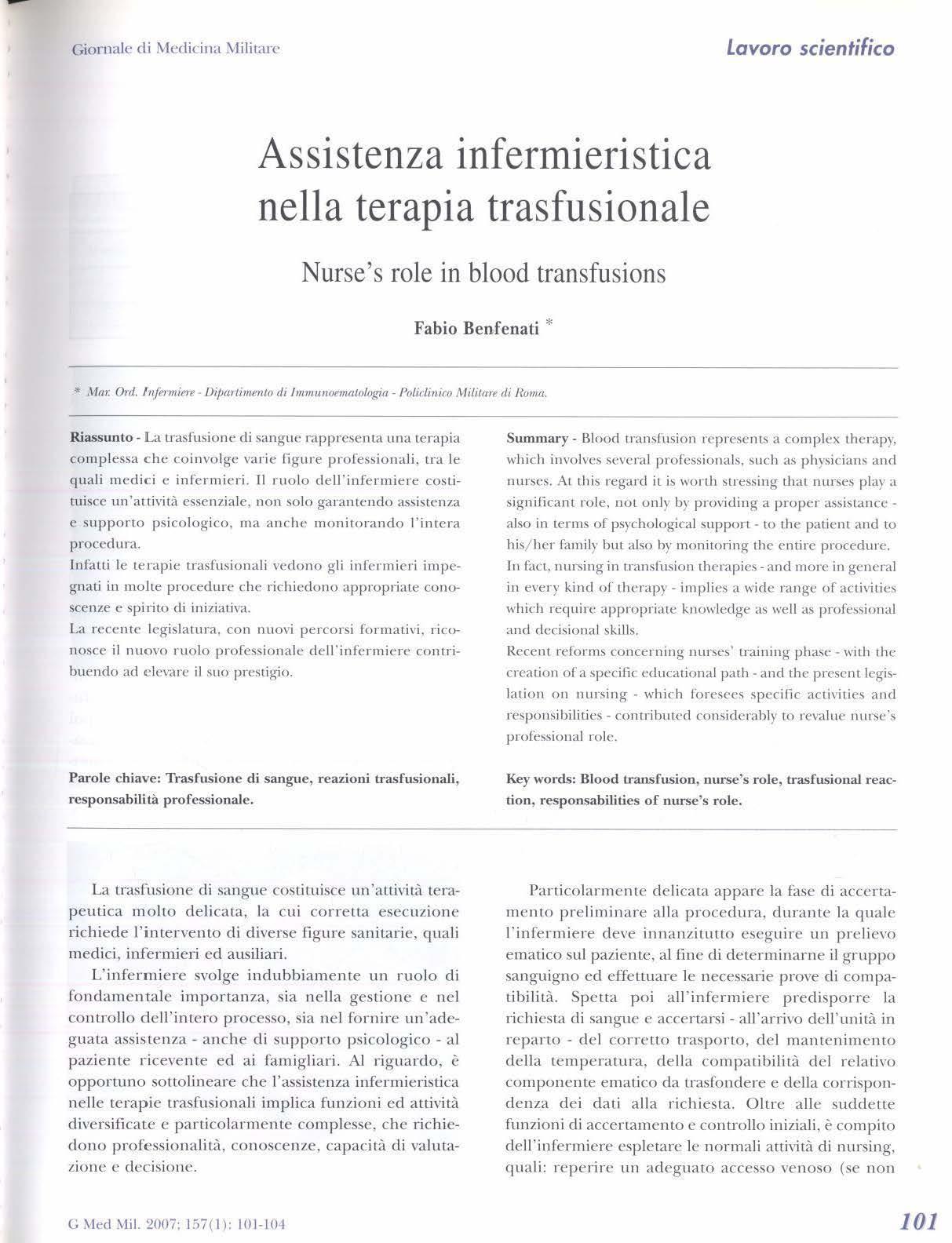
Parole chiave: Tra~fusione di sangue, reazioni trasfusionali , responsabilità professionale .
Swnmary - Blood rransf'usion represents a complex Lherapy. whirh involvcs scveral professionals, such as physiciam and nnrscs. At this regard it is 1,orth su·essi11g ùiat nurses play a signiJicam role, 110L only by providing a proper assislanccalso in terms of psychologica l suppon - to thc paticnt and to his/ her fa111il" but also hy monito1ing thc enti re procedure. In fan. 11ursing in transfusion thcrapies - and more in generai in e\'e1·y kind o r thcrapy - implics a wide range of activiùes which 1·eq11irc appropriate knowledge as well as profe ,sional ami dccisional ~kills.
Rccent reforms co11cerning uurses ' training pha,e - with thc creatiun ofa specific c<lucational path - and thc prcsC'nt legislatiun 011 nur~ing - whi(h t'ort'S<'('S specilìc anivi1ies an<l respunsibilities - contribtHçd ronsiclcrably to revalue nurse·s professional rolc.
Key words: Blood t.ransfusion, nu.rse 's role, trasfusioual reaction, responsabil.ities of nurse's role.
La trasfusione di sangue costituisce un 'attività terapeutica molw delicaLa, la cui corretta esecuzione 1ichiede l'intervento di diverse figure sanitarie, quali medici, infermie1i ed ausiliari
L'infermiere svo lge indubbiamente un ruolo di fondamenta le importanza, s ia nella gestione e nel contro ll o dell'intero processo. sia nel fornire un'adeguata assistenza - anche cli supporto psicologico - a l paziente 1·icevence ed ai famig liari. Al riguardo, è opportuno sotto lin eare che l'assistenza infermieristica nelle terapie trasfusionali implica funzioni cd attività diversificate e particolarmente complesse. che richiedono professionalità, conoscenze, capacità di , ·alutazione e decisione.
P articolarmente delicata appare la fase di accertamento preliminare alla procedura, durante la quale l'infermiere deve innanzitulto eseguire un pre lie\'o ematico sul paziente, al fine di determinarne il gruppo sanguigno ed effcLtuare le necessa1ie prove di compaLibilità. Spetta poi all"infermie-re predisporre la richiesta di sangue e accertars i - a ll 'arrivo dell'unità in 1·eparto - del corretto trasporto, del man t enimento della Lernperatura, della compatibilità del re l ativo componente ematico da LrasCondere e della corrispondenza dei dati alla rìch iesta. Oltre alle sudclertefunzioni di accenamcuto e controllo iniziali, è compito dell'infermien.· esµlctare le normali attività di nursing, quali: reperire un adeguato accesso venoso (se non
precedentememc posizionato), rilevare i parametri vitali (temperatu ra, pressione arteriosa, frequenza cardiaca) e, infine, ottenere il consenso informato. Quest'ultimo punto richiede l'intervento sinergico del medico e dell"infermiere pe1- offrire al paziente ed ai suoi famigliari i nformazioni dettagliate sulla procedura, i benefici e gli eventuali rischi correlati1
Una corretta e scrupolosa attività di controllo da parte dell'infermiere incaricato su ogni singola fase del processo determina una riduzione sostanziale dei tischi e dei danni derivanti al paziente a seguito di un'errata infusione di emocomponenti ed emoderivati (2) come risulta da uno studio del sistema di vigi lanza inglese, su ll e reazioni awerse. Anche una procedura apparentemen te semp lice come il prelievo preliminare di campioni ematici dal paziente, se non correttamente esp letata, può pregiudicare il corretto svo lgimento dell'intero processo trasfus ionale. L'evento più pericoloso, potrebbe scaturire da un'erronea identificazione del paziente che può innescare una serie di errori a catena che possono portare all'assegn azione eci alla somm ini strazione di un i tà non compatibili con ìJ ricevente.
Per ridurre i suddetti rischi, le linee guida naziona l i raccomandano diverse procedure di controllo. Innanzi tutto, l'infermiere deve accertarsi della corretta compilazione de lla provetta contenente i camp ioni ematici del paziente - che deve essere obbligator iam ente firmata dallo stesso operatore che effettua il prelievo - e della relativa scheda di ric hiesta, debitamente firmata da medico e infermiere. Un'altra forma di contro ll o viene eserci tata dagli operatori ciel centro trasfusionale all'atto della consegna della sacca su un secondo camp ione ematico de l ricevente, al fine di effettuare un ulteriore riscontro de lla compatibil ità del re lati vo componente eia trasfondere.
Come menzionato in precedenza, oltre a lle funz ioni d i controllo appena descritte l'i nferm iere svo lge complesse attività di ges ti one e somministrazione dell'emocomponente necessario al paziente, sia esso emazie conce ntrate, plasma o piastrine. Ai fini di assicurare una corretta gestione della procedura e la massima efficacia dell'emocomponente trasfuso, va sottolineata l'importanza del rispetto dei tempi di somministrazione (Tab 1), per evitare rischi di proliferazione batterica e di emolisi delle e m azie a temperatura ambiente
I D.Lg,. l / 09 / 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/10/ 1995 n ° 240.
2 Shot analisi 1996-2002.
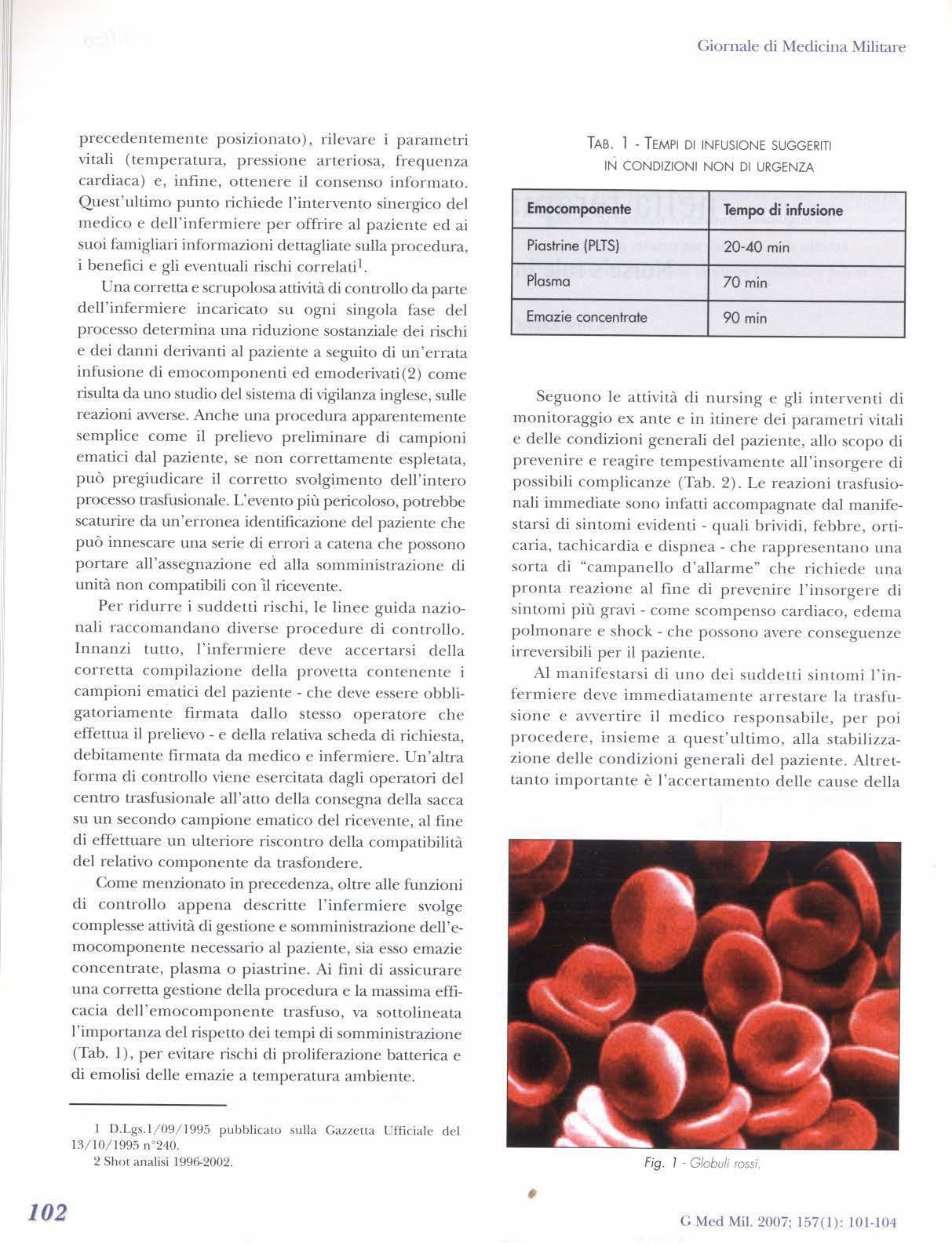
TAB. l - TEMPI DI INFUSIONE SUGGERITI IN CONDIZIONI NON DI URGENZA
Emocomponente Tempo di infusione
Piastrine (PLTS) 20-40 min
Plasmo 70 min
Emazie concentra te 90 rnin
Seguono le attività di nursing e gli interventi cli monitoraggio ex ante e in itinere dei parametri vitali e delle condi zioni generali del paziente, allo scopo di prevenire e reagire tempestivamente a ll 'insorgere di possibili compli canze (Tab. 2). Le reazioni trasfusionali immediate sono in fatti accompagnate dal manifestarsi di .sinwmi evidenti - quali brividi, febbre, orticaria, tachicardia e dispnea - che rappresentano una sorta cli "campanello d'allarme" che richiede una pronta reazione al fine di prevenire l'insorgere cli sintomi più gravi - come scompenso cardiaco, edema polmonare e shock - che possono avere conseguenze irreversibili per il paziente.
Al manifestarsi di uno dei suddetti sintomi l"infermiere deve immediatamente arrestar<: la u-asfusione e avvertire il medico responsabile, per poi procedere, insieme a quest'ultimo, alla stabilizzazione delle condizioni generali de l paziente. Al.trettanto importante è l'accertamento delle cause della
Immediate
Ritardate
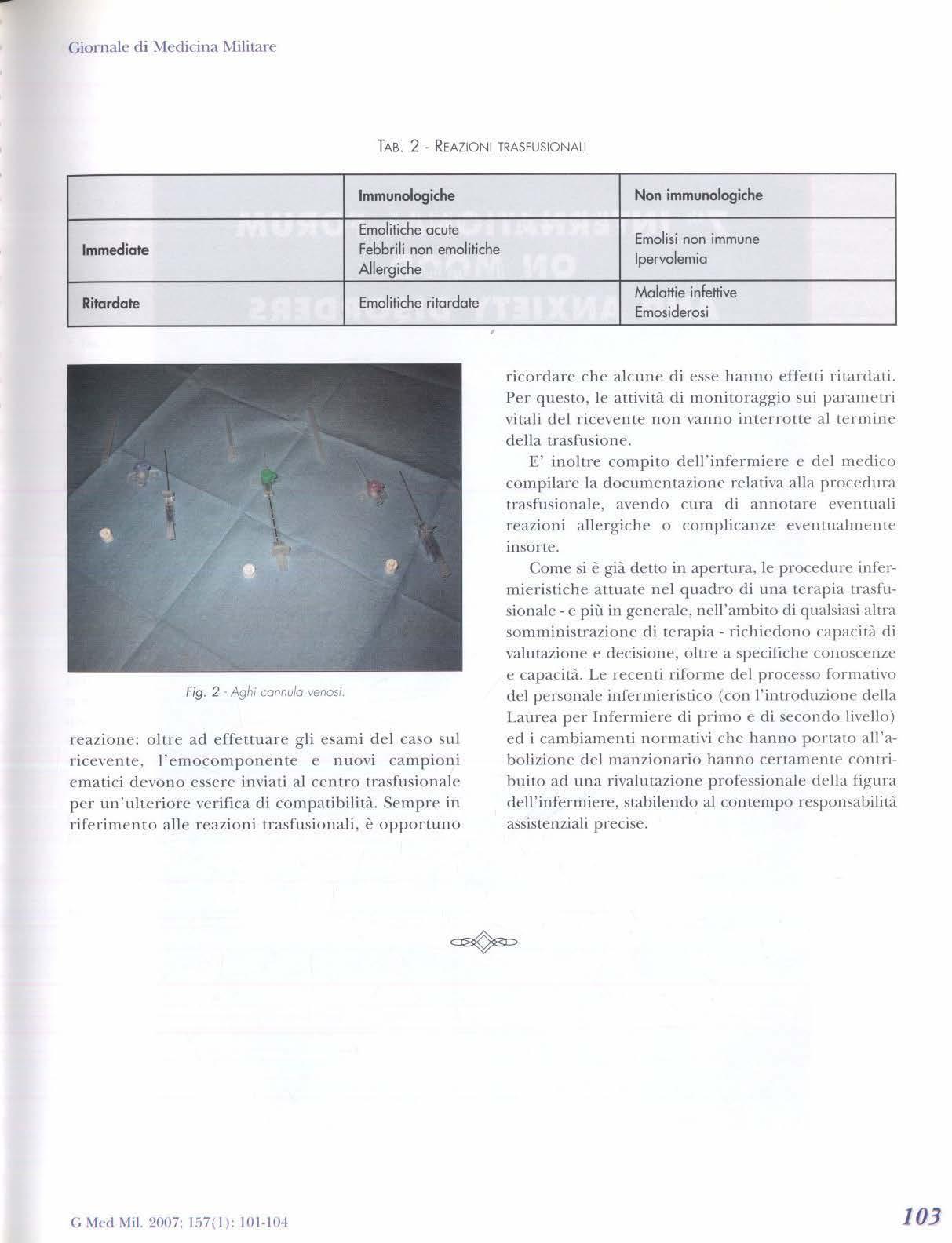
Immunologiche
Emolitiche acute
Febbrili non emolitiche
Allergiche
Emolitiche ritardate
reazione: olt r e ad effettuare gli esam i del caso su l ricevente, l'emocomponente e nuovi campioni ematici devono essere inviati al centro t r asfusionale per un'ulteriore verifica di compatib ili tà. Sempre in riferimento a ll e reazioni trasfusionali. è opportuno
Non immunologiche
Emolisi non immune Ipervolemia
Malattie infettive Emosiderosi
ricordare che a l cune di esse hanno effetti ritardati. P er questo , le attività di monitoraggio sui parametri vita li del ricevente non vanno interrotte al termine della trasfusione.
E' inoltre compito dell'infermiere e del medico compilare la documentazione relativa a ll a procedura trasfusionale, avendo cura di annotarf' evenmali reazioni a ller giche o complicanze eventualmente insorte.
Come si è già detto in apcrwra , le procedure infermieristiche attuate nel quadro di una terapia trasfusionale - e più i n generalf', nell'ambito di qualsiasi altra somministrazione di terapia - richiedono capac ità di \'a lu tazione e decisione , oltre a specifìche conoscenze e capacità. L e recenti riforme del processo formauvo del personale infermieristico (con l'introduzione d e lla Lamea per Inferm iere di primo e di secondo livello) ed i cambiame nti normativi che hanno portato all'abo li zione del manzionario hanno certamente contribuito ad una rivalutazione professionale della figura dell'infermiere , stabi lendo al contempo responsabilità assistenziali precise.
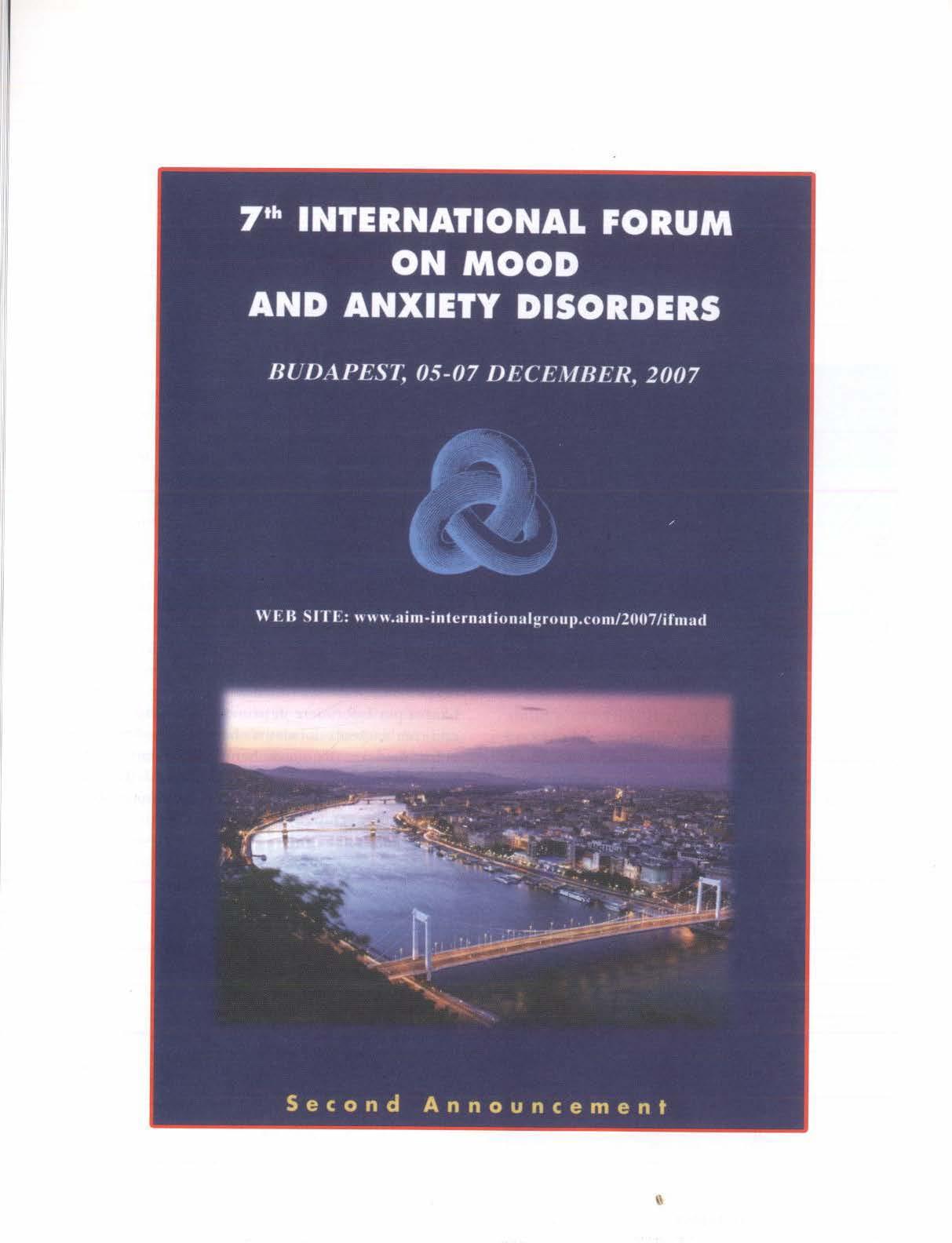
, * Tm Col."'"· - ( ,nfm ~r11•1~io /)nna/1111 l)ij,rll/lmrn/11 /mmt/11()('11/fl/11/11,;;ia - l'olu/1111w ,\filitm, ( ;•/w" - Roma.
RiassunLo • L1 tempia trasfu,ionale, perfino quando cf'frttuata nl'lle çondi,ioni più ideali. tomporta un significame rischio cli una rea1io11e a,Yer-;a. l,lii rea,ioni ,ono as~oC'ialt' ad una ,ignifìcativa morbilità cd in alcuni ntsi ,tel evolu11oni fatali. Molti deg li cwnti fata li so 11 0 legati ad l'rrori unu111i e in 11110 ,tudio di 70 ('\t'11Li fatali il ;16<{, era dm nto a re:vione emoli1irn alltta, la ml'ta dei casi eia pn:,enibilt• poiché legato ad inrompalibilira \BO donua ad errore um,1110 men11t· il 75% a ,on11nìni,,1ra,ioni al pa1it·111e sbagliato. Fino al 20% di 11llll' il" trasft11,ioni è po,,ibile il ,·erilical\i di un t'\('lllo a\'vcr,o. li rischio ptni,o è diflkilt· eia stimaH· poiché rnoh(· reazioni possono c,,t·rt' dinit,11111·11te ocnil1c l' dipt'ndc dall\1rn1raleaa clt-lla , eri fica. dalle caraurri,1 irhe dt'I 1in·\'entc e cld donat01 l' dalla diligl'n,a t' dall'e~pnicn1.1 cklln sta!T citi labor.Hm 10. l 11 altro prnhlcma è leg,llo al fauo dll' la me1ù clt·lle tra,fmioni \Ìt'nt' dk1111ata a p.vicnti ant',Lt'· L i u,ui. Qua l ora ,i ,o,pet1a 1111a rca?io1H·, la trasfmio 1tt' doHehbc essere irnmediatame11te ,ospesa e i1Hrapresc 1una Lma ,e, ie di indagini lìnali77alt' ad una diag110,i per i,rituire. quindi. l'approp1iata terapia.
Paro le chiave: Reaz ione avversa, emorragia acula, test NAT, PsoraJene.
Le reazioni trasfusionali
Una reazione trasfusionak può essere defìnita come 1111a rea,ione che compare in S<'gnito alla infusione di \angue o di uno dei suoi componellli. Le raLioni u-,L-;fusionali possono C\\ere di, i,c in immediate e ritardate.
Le rczioni trafusionali imm ediate
I ,in1omi di una reazione immediata compaiono nell'arco di minuti o di qualclw orn e non ~ono ,peci-
Summary • Transf'usion lht·rapy, even u11dcr ideai t:ondit ions, carri es a significanl ri,I.. of ,111 adve1 s(' H'action. Such rcac11011\ are as,oci.rtt'd with ,ignificant 11101hiditv and 111 ,ornc ça,c•, \,ith a fatai outcanw. '.\.losl of tlH' rcpor1ecl lataliries inl'olve human 1•rrc,.- in one ,111dy of 70 fa1ali1ies. 5W½, wcn· dtrl' 10 acutt' h,wmolrtic n·action. half of thcsc we1l' pre,·cntahl<'. ,inct' thl'' in\'oht'd an .\BO mi,match due Lo human er ror. 75~<- of thc fatalitil·, wnc due Lo adrnini,ttation of corrcnh· ffm,-mat,hed blood 10 thl' w1 ong pati<'nt. L p lO 20'{ of all tran,lusion ma\ lcad ro ,0111l' l\f)C of ach et '>t' 1eac1i011'. fhe pH·ci,c risk i, difficull Lo e\limatl'. ,intt man, r('aCliom ma\' hl· c linicalh occulr ,a< e Lll ao of repo1 ung h poor, the r·i,k i, inlluenced bj' the natu1t· or rccip1c·11t popu1,llion am i 1he ,ourcc ol do1101 b lood a11d by tlH' cliligencc a nel thc cxper ll,t' of che hlood ban k lah01 ,1ton ,raf f. \11 addition,,I prohlcm i, thar ahout one hall of transfu,ion aie gi,en 10 anestheti7ccl patients. lf a reaction i, ~mpected, 1he transfu,ion should be immecliateh discon1in11ed ancl appropriate lahorator" Lt',t, and clinirnl ,tudies undenaken LO c,1ablisch tht' diagno~i, and insti1111e appropriare 1her;.1p,.
Key words: Advcrse reaction , acute bl ee ding, trali , NAT test, Pso raJe n.
fiche rispetto all'eziologia. Essi possono includere h1 Ì\ ido, fehb1 e, on i caria. dispnea, nausea <' ,omito, senso di costriLione toracica, dolore toracico e lombare, ipotc-nsio11c, bronco-spasmo. edema angi oneurotico, anafìlassi, ,hock, edema polmonare e scompemo cong<''>ti1io. Nel pa1.icnte anestetiuato ,otropo~to ad intervento chirurgico, una reazione trasfusionale in11necliata può manifestarsi ton un sanguinamento gcncrnli11ato nella sede dell'interYenLO e shock che non , iene corrcuo dalla sommin istra,ioue di sangue U n a reazione trasfusionale immediata può es~ere emo l itica, febbrile o può esMTe dovuta a sangue contaminaLO. J !>intorni po1>sono non riflettere la -,c,·c-

C :-.kd \lii, 2007, I.ii( Il: 10:1-l l~
r ità dt' ll a rea,ion<>. U11a diagno~i ezio l ogica rich iede usua l mente degli swcti aggi11nti\'i dei lC'Sl di laboratorio (Tab. 1).
Le reaz ioni tras fus ion al i e m o litich e acute
L e re azio ni t rasfusio n a l i c m o l i ti c lw so n o cau sate dalla li~ i immunomediata delle emazie quando globuli rossi i n compatibi l i sono t ras fusi i n u n paz iente c h e possiede già il corrispondente anticorpo; tale reazione si esp li ca n e ll 'arco di pocl 1i mi n u t i. So li tarnent(' l e reaz i oni emolitiche acme clinicamente significa t ive, d i pe n dono da i ncompatib il i tà A HO e sono emolis i intra, ascolari. I mpanante meccanismo patogenetico
TAB. l - DI AGNOSI DIFFERENZIALE
DELLE REAZIONI TRASFUSIONALI ACUTE
Tipo di reazione Segni clinici e sintomi
Febbre, bri vido, dispnea ,
Emolisi acuta intravascolare rossore, vom ito, dolore lombare, emog lobinuria , emoglobi nem ia , sh oc k
Fe bbr e , iperbi li rubine mia
Emoli si estrovascolore acuto indiretta , incremento dell ' ematocrito infe riore a quello prev isto
Reazione febbrile Feb b re, brivido
Reaz ione allergico (debo le)
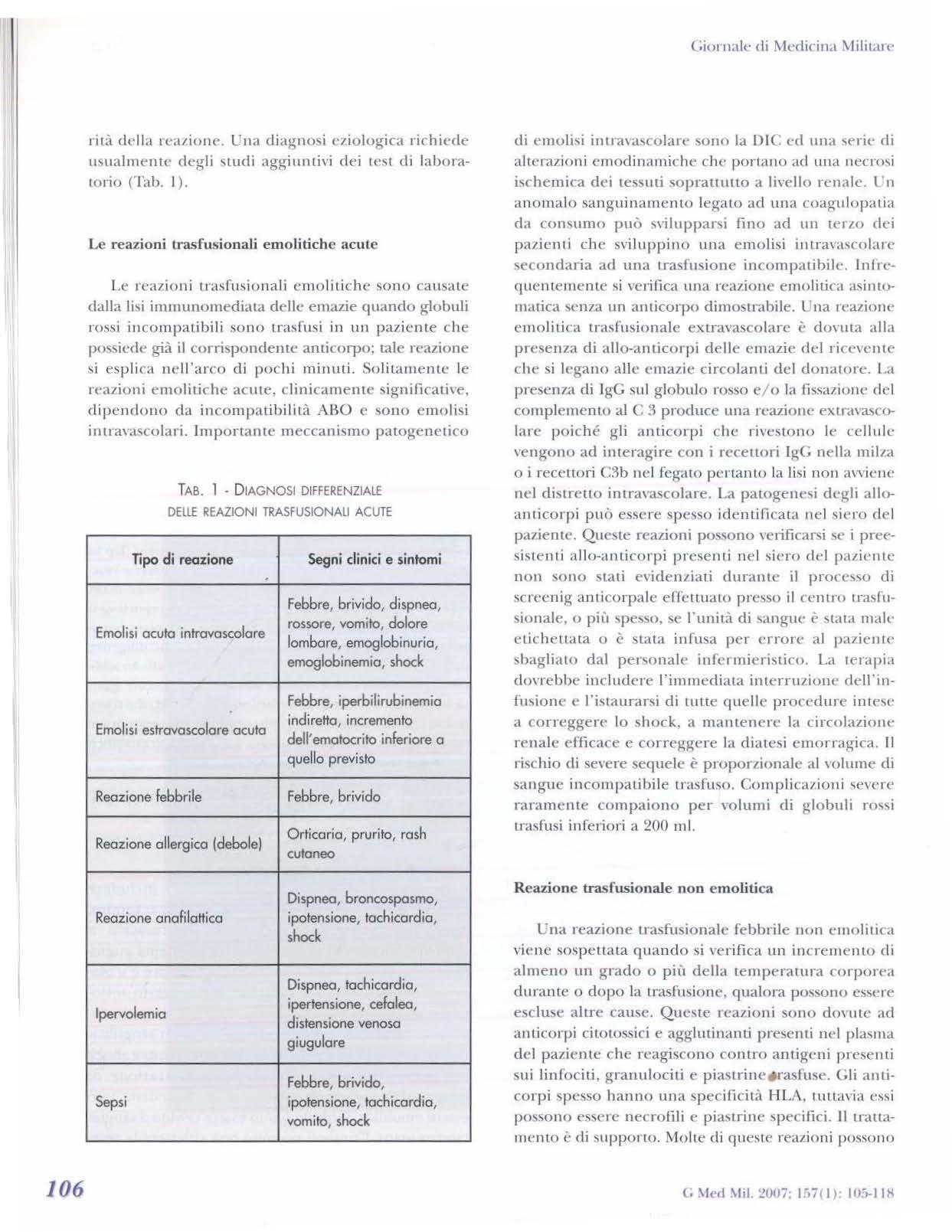
Orticario, prurito, rash cutaneo
Dispnea , broncospasmo , Reazione ana filattica ipotensione, tachicardia, shock
Dispnea , tachicardia, Ipervolem ia ipertensione, cefoleo , distensione venosa giugulare
Febbre, brivido, Seps i ipote nsione, tachicardia , vomito , shock
di emolisi intra,a.scolart' sono la D IC cd una ,erie di altC'raLi oni emodinamic h e c h e po r tano ad una necrmi i~chemic-a dei tes,llli soprattutto a li,·ello renale. l n anoma l o sang ui na111ento l egato ad una coagulopat ia da comumo può •wilupparsi fino ad un te1 i.O elci paL i e n ti che svil uppino una emo li s i i 11 LraYa<;cola1e secondaria ad una trasfusione incompatibile. Infreque nte m e n te i verifica una rca1ione emo litica asintomatica '>Cnza un anticorpo d i mostrabile. l na reazione emoliLica trasfusionale extravasco larc è do\'l1ta alla presenn di allo-anticorpi delle emaLie cie l rice,ente che s i l<•gano alle ema , ie circola n ti del donatore. I.a presenta di l gG sul g l obulo rosso e / o la fissazione de l co m p l emento al C 3 produce una reazione extravascolarc poic h é g l i anticorp i che rivesto n o le cellule \'engono ad interagire con i recettori lgG nella milta o i recettor i C3b nel fegato p crtanlO la l isi 11011 a,'\iene nel distretto intravascolare. La patogenesi degli alloanricorp i può essere spesso ide nti ficata ne l ~iero del pa1ientc. Queste reaLioni possono ,erificarsì s<> i prees i s tenti a ll o-an ti corp i present i n e l siero de l paLicnte n on sono stati eùden1iari durante il processo di scrceni g a n1i co r palc effettuato p resso il centro Lrasf'usionale, o più spes'><>, se l'unità di ~angm· è stata male etic h ellata o è stata infusa per errore al pa7iellt<' sbagliato dal per~onalt' infermit'ristico. La terapia dovrebbe includere- l 'immediata intcrn11ioue dell'infusione e l'istaurar<;i di tutte q u e lle proccdun: imc<;e a cor r eggere lo shock, a mantenere la circolaz i one rena l e efficace e correggere la diatesi emo r ragica. I l rischio di se\'Cre sequele è proporLionalc al ,o l ume cli sangue inco m patibile trasfuso Comp l icaz ioui <;ewrC' rarame n te compaiono per ,olumi di globuli ro~<;i tra<;fusi infe1iori a 200 m l.
R eazion e trasfusionale non e moli ti ca
Gna reazione trasfusionale febbrile 11011 emolitica vie n e sos pe ttata qua n do si ver i fica un increm<'nto di almeno un g rado o più della temperawra corporca d urame o dopo la trasfus ione. qualora possono essere e~cluse altre cause. Quc<;te reazioni sono dm ute ad a11 ti corp i citotoss ici e agg l utinanti presenti nel plasma del pa;,iente che reagiscono contro antigeni p 1esenti s ui li nfoc i ti, granuloci ti e pi a<;trirw rasfu se. Gli anticorp i spesso h anno una spec ific i tà HLA, t ullavia e~si pmsono essere necrofili e pia'>t rine s p ecifici. li trattalll<' ll lO è di supporto Mo l te d i quest<· r ea.lioni p ossono
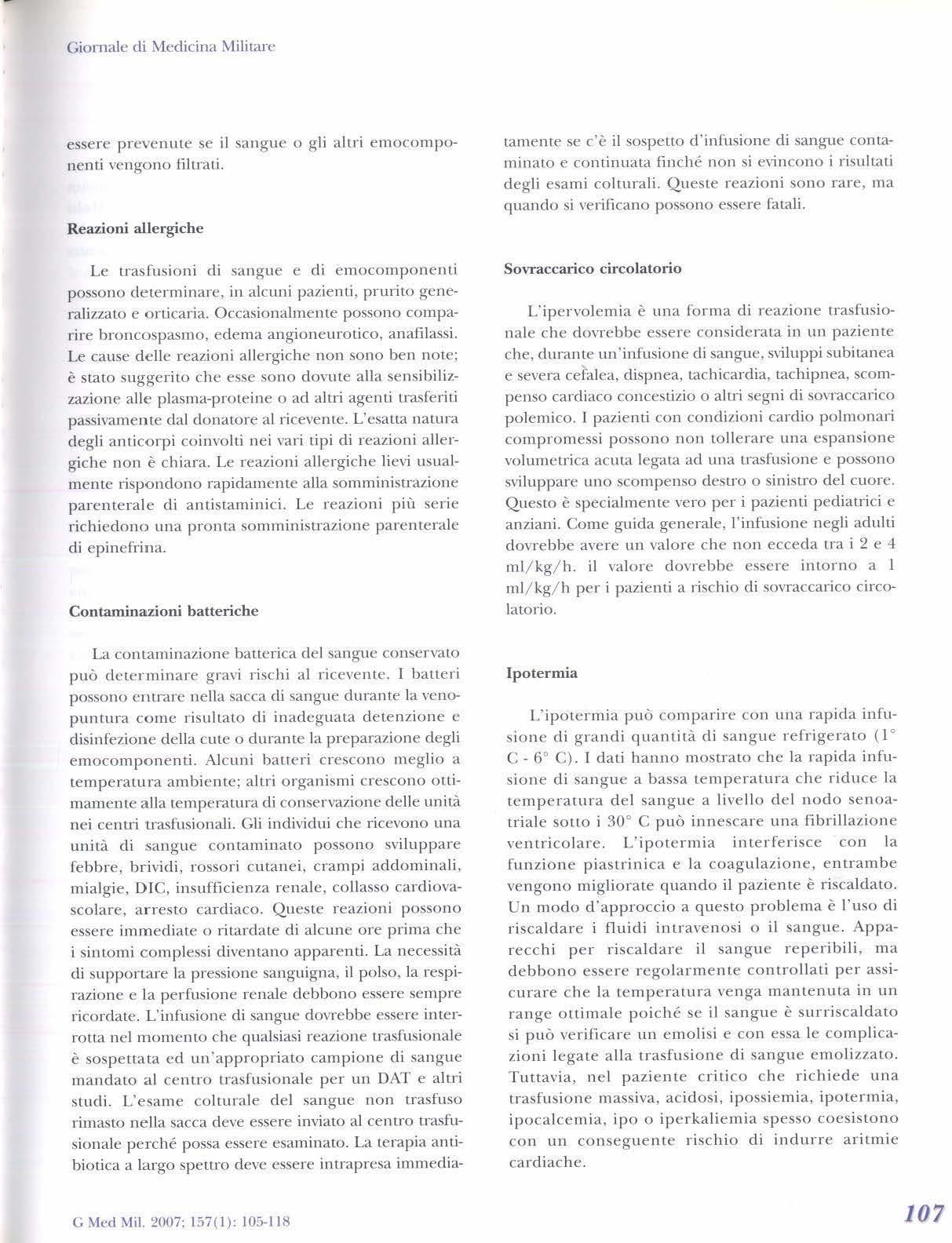
essere prevenute se il sangue o g li altri emocomponenti vengono filtrali.
Reazioni allergiche
Le trasfusioni di sangue e di emocomponenti possono determinare, in alcuni pazienti. prurito generalizzato e orticaria. Occasionalmente possono comparire broncospasmo, edema angioneurotico, anafilassi. Le cause delle reazioni allergiche non sono ben note; è stato suggerito che esse sono dovute alla sensibilizzazione alle plasma-proteine o ad alt.Ii agenti Lrasferiti passivamente dal donatore al ricevente. L'esatta natura degli anticorpi coinvolti nei vari rjpi di reazioni allergiche non è chiara. Le reazioni allergiche lievi usualmente rispondono rapidamente alla somministrazione parenterale di antistaminici. Le reazioni più serie richiedono una pronta somministrazione parenterale di epinefrina.
Contaminazioni batteriche
La contaminazione batterica ciel sangue conservato può determinare grayi rischi al ricevente. I batteri possono entrare nella sacca cli sangue durante la vcnop1111tura come risultato di inadeguata detenzione e disinfezione della cute o durante la preparazione degli emocornponenti. Alcuni batreri crescono meglio a temperatura ambiente; altri organismi crescono ort imamente alla temperatura di conservazion e delle unità nei cent.Ii trasfusionali. Gli individui che ricevono una unità di sangue contaminato possono sviluppare febbre , brividi, rossori cutanei, cramp i addominali , mialgie, DTC, insufficienza renale, co ll asso cardiovascolare, a rr estO cardiaco. Queste reazioni possono essere imm ediate o ritardate di alcune ore p1ima che i simorni complessi diventano apparenti La necessità di supportare la pressione sanguigna, il polso, la respirazione e La perfusione renale debbono essere sempre ricordate. L'infusione di sangue dovrebbe essere interrotta nel momento che qualsiasi reazione trasfusionale è sospettata ed un 'appropriato campione di sangue mandato al centro trasfusionale per uu DAT e altri studi. L'esame coltura le del sangue non u·asfuso 1imasto nella sacca deve essere inviato al centro u·asfusionale perché possa essere esaminato. La terapia antibiotica a largo spettro deve essere intrapresa immediaG
tamenre se c ' è il sospetto d'infusione di san~ue contaminato e continuata finché non si evincono i risultati degli esami colturali. Queste reazioni sono rare, ma quando si \'erificano possono essere fatali.
Sovraccarico circolatorio
L'ipervolemia è una forma di reazione trasfusionale che do\Tcbbe essere considerala in un paziente che, durante un'infusione di sangue, sviluppi subitanea e severa cefalea, dispnea, tachicardia , tachipnea, scompenso cardiaco concestizio o a)u·i segni di sovraccarico polemico. I paziemi con condizioni cardio polmonari compromessi possono non tollerare una espansione volumetrica acuta legara ad una u asfusione e possono sviluppare uno scompenso destro o sinistro del cuore. Questo è specialmente vero per i pazienti pediatrici e anziani. Come guida generale , l'infusione negli adulti dovrebbe avere un valore che non ecceda tra i 2 e 4 ml / kg / h. il valore dovrebbe essere intorno a l ml / kg/ h per i pazienti a rischio di sovraccarico circolatorio.
L'ipotermia può comparire con una rapida infusione di grandi quantità di sangue refrigerato (1 ° C - 6 ° C). I dati hanno mostrato che la rapida infusione di sangue a bassa temperatura che riduce la temperawra del sangue a livello del nodo senoatriale sotto i ~Q° C può innescare una fibrillazione ventricolare L 'ipot ermia interferisce con la funzione piastrinica e la coagulazione, en crambe vengono migliorate quando il paziente è riscaldato. l.in modo d'approccio a questo problema è l'u so di riscaldare i fluidi intravenosi o i.I sangue Apparecchi per riscaldare il sangue reperibili, ma debbono essere regolarmente controllati per assicurare che la temperatura venga mantenuta in un range ollimale poiché se il sangue è surrisca ld ato si può ver ifi care un emolisi e con essa le complicazioni legate alla trasfusione di sangue emolizzato. Tuttavia , nel paziente critico che richiede una trasfusione massiva, acidosi, ipossiemia, ipotermia , i pocalcemia, ipo o ip erkaliemia spesso coesistono con un conseguente rischio di indurre aritmie cardiache
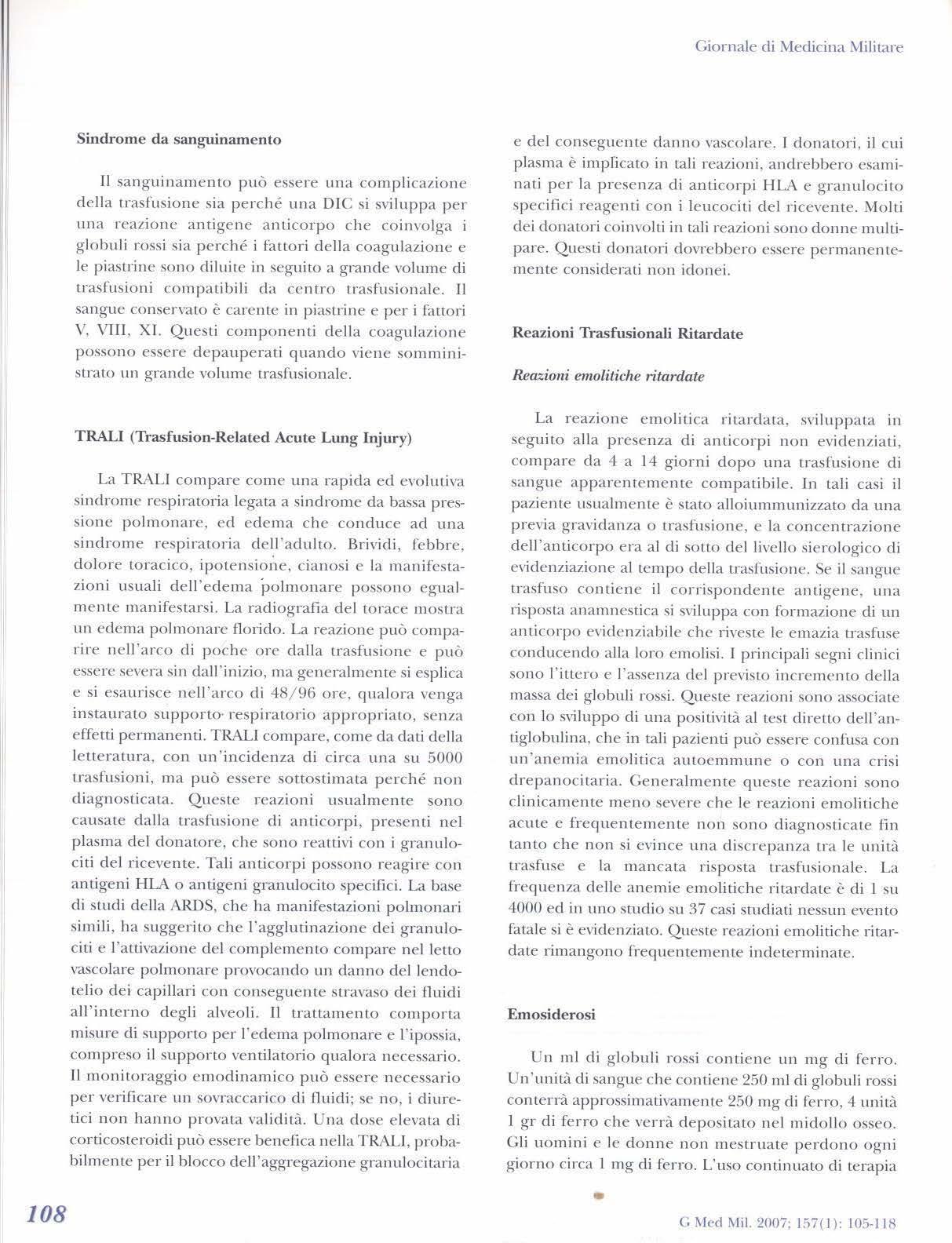
Sindrome da sanguinamen to
JI sanguinamento può essere una complicazione della trasfusione sia perché una DIC si svilnppa per 1111a reaLionc antigene amicorpo che coimolga i g lobuli rossi sia perché i fattori della coagu laLionc e le piastrine sono diluite in seguito a grande volume di trasfusioni compatibili da centro trasfusionale. Il sangue consen'ato è carcllte in piastrine e per i fatrori V. VIII , Xl. Questi co mpon enti della coagulazione possono essere depauperati quando \'iene somministrato 1111 grande volume trasfusionale.
TRALI (Trasfusion-Related Acute Lw1g Iojury )
La TRALI compare come una rapida ed evol uti va sindrome respiratoria legata a s indrome da bassa pressione polmonare, ed edema che conduce ad una sindrome respirato1ia dell'adult0. Brividi, febbre, do lore toracico, ipotensioi1e. c ianosi e la manifestazioni usuali dell'edema polmonare possono egualmente manifestarsi. La radiografia del torace mostra un edema polmonare florido. La reazione può comparire nell'arco cli poche ore dalla trasfusione e può essere severa sin dall'inizio, ma genera lm ente si esplica e si esaurisce nell'arco cli 48 / 96 ore. qualora venga instaurato supporto· respiratorio appropriato, senza effetri permanenti. TRA.LI compare, come da dati della letteratura, con un 'incidenza di circa una su 5000 trasfusioni, ma può essere sottostimata perché non diagnosticata . Queste reazioni usualmeme sono causate dalla trasfusione di amicorpi, presenti nel plasma ciel donatore, che sono reattivi con i granu loc iti ciel riceveme. Tali anlicorpi possono reagire co n antigeni HLA o antigeni granulocito speci.fici. L a base di swcli della AR DS, che l1a man ifestazioni polmonari sim ili. ha suggerito che l'agg lurin azione dei granu lociti e l'attivazione del comp lemento compare ne l letto vascolare polmonare provocando un danno de l !endotelio dei capi ll ari rnn conseguente st ravaso dei fluidi a ll ' in terno degli a lveoli. Il trattamento comporta misure di supporto per l'edema polmonare e !"iposs ia, compreso il supporto ventiJa torio qualora 11ecessario. Il monitoraggio emod inami co può essere necessario per verificare un SO\-Taccarico cli Ouidi; se no, i diuretici non hanno provata val idità. Una dose e levata di corticosteroidi può esse r e benefica nella T RALI , probabilmente per il blocco dell'aggregazione granuloc itari a
e del conseguente danno vascolare. 1 donaLOri, il cu i plasma è impficaro in tali reazioni, andrebbero esaminati per la presenza cli anlirorpi HLA e granulorito specifici reagenti con i leucociti ciel ricevente. Molti dei donatori coinvolti in tali reazioni s0110 donne multipare. Questi donato1i dovrebbero essere permanentemeute considerati non idonei.
Reazioni e molitiche ritardate
La reazione emoli ti ca ritardata. sviluppata in segu i t.o al la presenza d i anticorp i non ev id enziati, co m pare da 4 a J4 giorni dopo 1111a t rasfusione di sangue apparentemente compat ibil e. In tali cas i il paziente usualmeme è stato alloiummunizzaro da una previa gravidanza o trasfusione, e la concentrazione dell'anticorpo era a l di sotto ciel livello s ierologico cli evidcn ziazione al tempo della Lrasfusione. Se il sangue trasfuso contiene il corrisponden te antigene , una 1isposta anamnestica si svi lupp a con formazione di un anticorpo evidenziabile che riveste le emazia trasfnse conducendo alla loro emol isi. I principali segni clinici sono l'ittero e l'asseuza del previsto incremento della massa dei g lobuli rossi. Queste reaLioni sono associate con lo svi lupp o cli una positività a l test diretto dell'antiglobnlina, che in tali pazienti può esse re confusa con un ·anemia emo liti ca autoernrnune o con una crisi rlrepanocitaria. Generalmente quesle reazioni sono clinicamente meno severe che le reazioni emoli ti che acute e frequentemente non sono d iag no sticate fin Lamo c h e non si C\' in ce una discrepanza era le unità trasfuse e la manraca risposta trasfusionale. La frequenza delle anemie emo liti che ritardate è di 1 s u 4000 ed in un o srud io su 37 cas i studiati nessun evento fata le sì è evid enz iato. Queste reazioni emo litiche ritardate r im angono frequentemenle indeterminate.
Emosid eros i
Un ml cli globuli rossi cont iene un mg cli ferro. Un 'un ità cli sangue che contiene 250 ml di g lob uli rossi comer r à approssimativamente 250 mg di ferro, 4 unità 1 gr di ferro che verrà depositato nel midol lo osseo. Gli uomini e le donne non rnestrnate perdono ogni giorno c irca 1 mg di ferro. L'u so continualo cli terapia
c;iomale di l\kdicina l\lilit;m• trasfusionale in indi\i<lui con anemia emolitica <.'Xtravascolarc comt' nella talasscn11ia o nella drepanociLOsi. nei qHali il fr1ro 11011 ,iene pnduto ma riciclato, può comparire ui1 cumulo ecces'\ivo di lt•rro all'inrerno dei tessuti. Dopo un lu11go pl·riodo di lempo il ferro si accumula nelle cellulc parcnchimali portando a morte le cellule ste,,c e ad una e\'entuale i11suflìcicuLa dell'organo colpilo.
Complicazioni effettive dell a trasfusione di sangue
L a lrasmissione di \<.tri agerni infettivi con la trasfuionc I i mane la maggiore causa di prcoccupa1ione per i pa1.ienti che abbisognano di tale supporto terapeutico. Oggi. no110slan1c l'esH·,o numero di test riguardo le mala11ic ,·irali abbia ridouo il ri~chio a livelli mollo bassi, la sfiducia e il sospetto rimangono. Ironicamente. all'incrcmt·nto della sicurcZLa della trasfusione del sangue si c,·ince un aumento della preoccupazione nell'opinione pubblica e molta più cautela da pane dei medici nell'utilizure i componenti ematici. Le inle7ioni trasmesse attran·rso la trasfll',ione prn,sono cssen· ,irali. batteriche e inksta1ioni parassi1arie (Tabb. 2, 3, 4).
Emovigilanza , un importanlc melodo per migliorare la medicina trasfusionale
" elle tra..,{usioni di sangue, la nece'>sità pe1 una stru ttu mie sorveglianza d<.' Ile n:ation i awersc e la necessità per il monitoraggio continuo della sicurena sono importanti specialmente quando la severità e la natura delle reazioni awerse possono delC'rminarc così gravi complicazion i Non ~olo la trasmissione di patologie infettive o imm11ni ma anche altre reazioni come I<' intera,ioni con 111edica111enti clw necessitano essere osservati per una comp leta visione in campo della sic urezza trasfw,ionale. L 'e mmi gila n1a può C'i~t.'re uno strumento per un 'effe ttiva, sicura t.' razionale politica trasfusionale. Essa controlla cune le procerlnrc dalla raccolta alla ~0111ministrazio11e; è u11 aiuto per stabilire l'efficacia, le indica?.ioni e il dosag'){io; la sicure,.:ra per ciò che 1iguarcla la wssicità e le rea,ioni awerse immunologiche nonché la base ra1.ionalc per la valut,:11,ionc <lei costi. E' un sistema standardinato per la raccolta dei dati e la loro analisi con lo scopo di incrementare la sicurena dei prodotti labili della tra~rusionl'. Un
TAB. 2 - COMPLICANZE DELLA TRASFUSIONE
Infettive
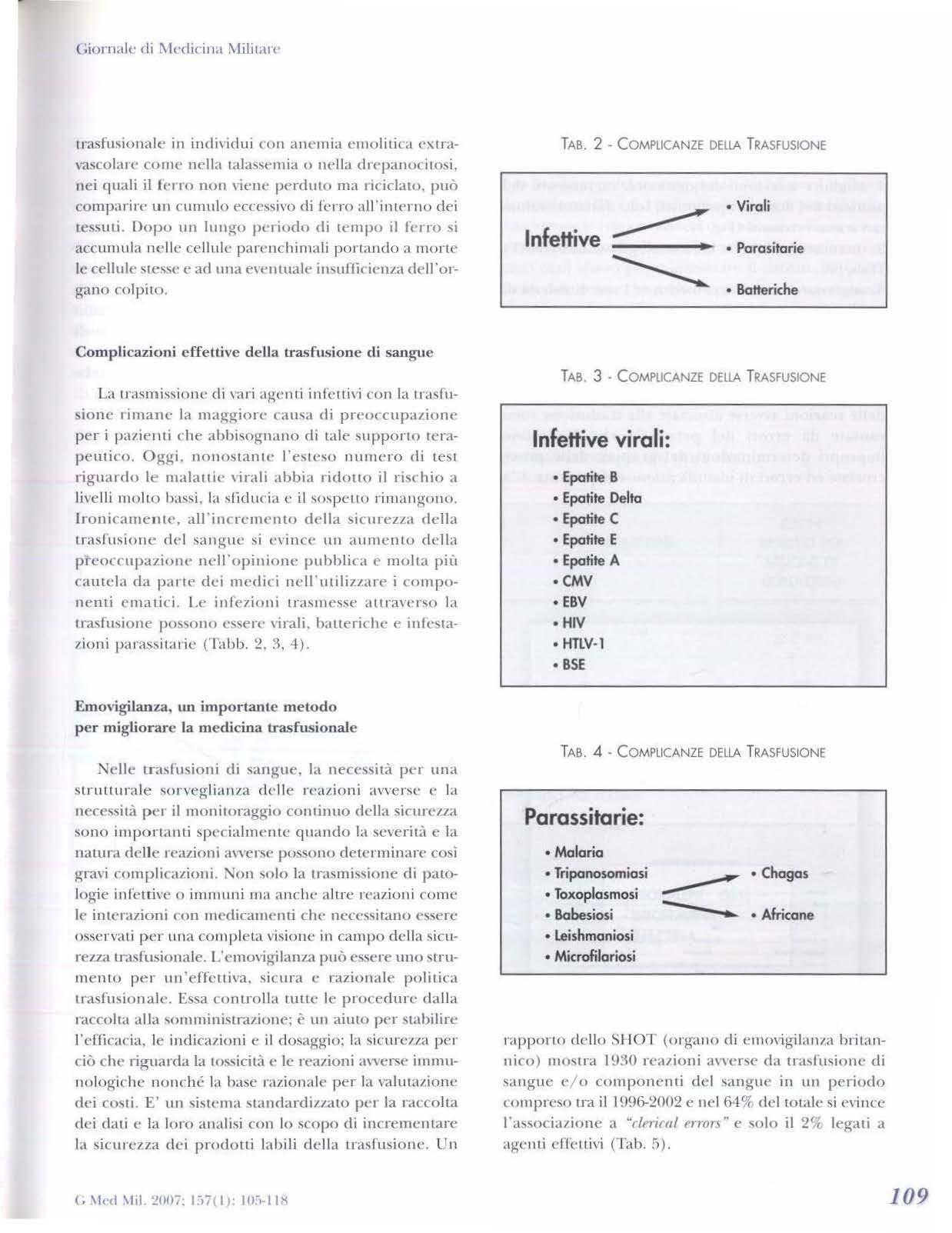
• Virali
• Parasitarie
• Batteriche
TAB . 3 - COMPLICANZE DELLA TRASFUSIONE
Infettive virali:
• Epatite B
• Epatite Delta
• Epatite C
• Epatite E
• Epatite A
•CMV
• EBV
• HIV
• HTLV- 1
• BSE
TAB. 4 · COMPLICANZE DELLA TRASFUSIONE
Parassitarie:
• Malaria
• Tripanosomiasi
• Toxoplasmosi
• Babesiosi -------
• Chagas -
• Africane
• Leishmaniosi
• Microfilariosi rapporto dello S HOT (organo di cmmigilam,a brilannico) mostra 19~0 n·a1io11i awcrse da trasrusionc cli sangue e/o componenti del sangue i n un periodo comprc,o tra il 1996-2002 e nel 64o/c del totale si evince l'a:.socia,ione a ••rfenral erro,~~ e solo il 2<1 legati a agenti el'leuivi (Tab. 5).
Come ridurre il rischio di reazioni avverse?
l. Migliore -.ele,i<rne del donatore, incremenw ciel numero dei donatori periodici, solo donatori volonuu; e non retribuiti ( Fig. l).
2. incrcmenro dei test biotecnologici (EL1St\+NAT) (Tab. 6).
3. mig li orare la sicnrezza mediante l'uso di sistemi di ,irale utilinanti reaLioni ~oh·entc det<:rgentc 1· trattamenti fotodinamici (Tabb. 7. 8).
4. iucrementare i ~istemi di compllle1 izzaLicmi per ridurre- i "cleriral l'non" la sìcurcna della sommini~trazionc degli emocompo n enti è cruciale, molte de ll e reazioni avverse a~~o,iatc alla trasfusione sono causate da errori del pe1 :,on aie che includono impropri determinazioni ckl gruppo. delle prO\e o ociate ed errori cli identilìcazione dt>I paziente. C'è
un cre5cente inreresse per dare migliori informai.ioni ai pazienti circa le loro cu re , gl i eventuali rischi e le eventuali terapie alternati\'e. Il con~cnso informato è richiesto prima di ogni trasfusione. li medico deve spiegare al pa7ieute i rischi, i benefici e le alLcrnati,e della terapia trasfusionale. Il medico valuterà l'emocompo-nente più adatto t' la dme pt>r raggiungere l'obbiettivo terapeutico richie~to. Evitare gli errori clericali della trasfmionc dovuti a incompatibilità abO portano ad istruire nuove ~trategie per ridurrf' il ri\chio rii errori latenti. un presidio chiamato '"bloodlor·· permette di introdurre un codice unico pe1 ogni paziente relativo alla rra~fnsionc di sangue. In guesw si:.tcma di barriera meccanica l'unità è in una busta cli plastica sigillata con un lttcclwuo a comb inaLione che può essere aperto solo dal n11mero trasfusionale scrirto ~111 braccialeuo del pa1icntt'.
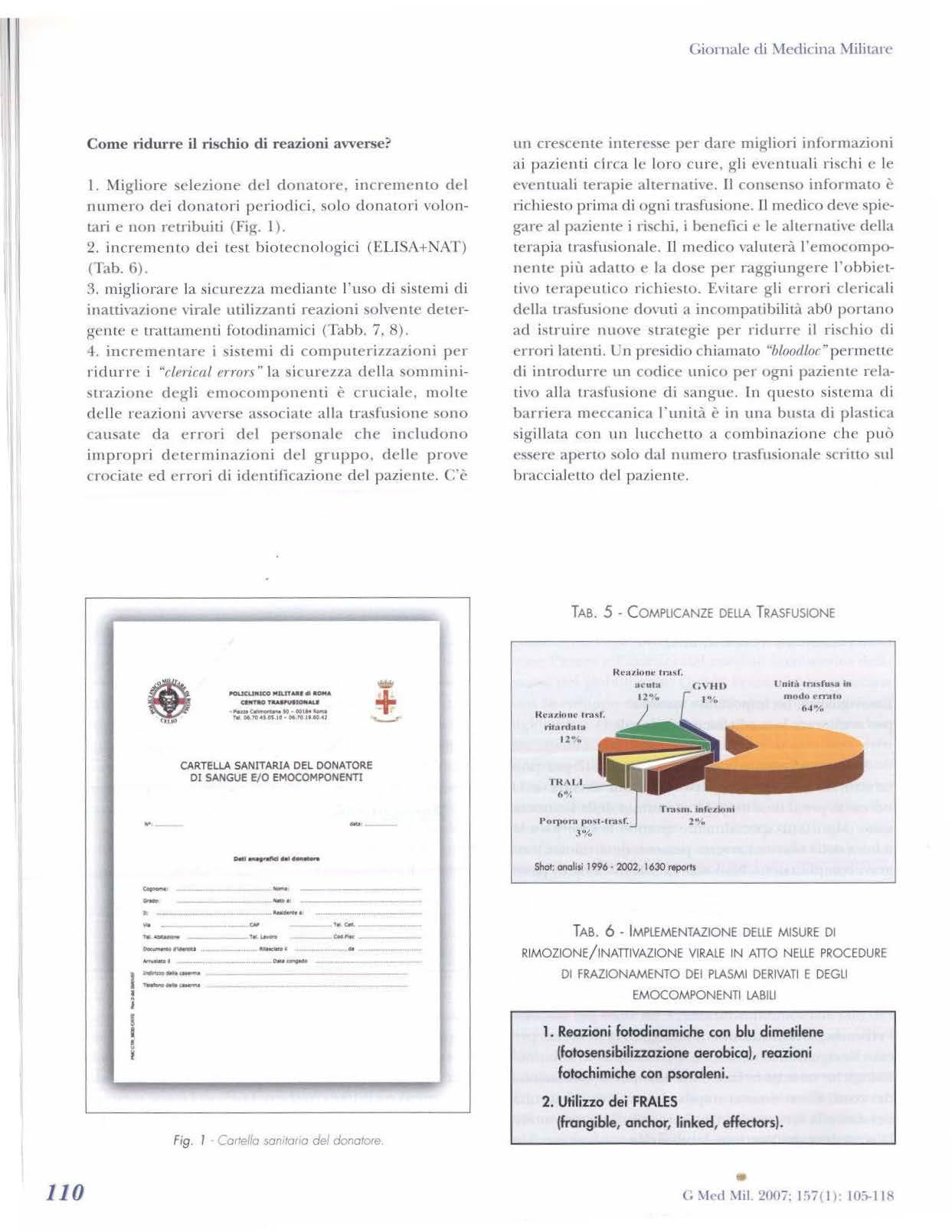
TAB. 5 - COMPLICANZE DEUA TRASFUSIONE
~IC:O NJUTMI • 11.0NA a,rf'tOTUINtrottAl.l "-ua~to 001a.-,..,._ flll Ol,,04J.Of10•0I.J019,60U .._.
CARTELLA SANITARIA DEL DONATORE DI SANGUE E/O EMOCOMPONENTIn , ,._ -o.i......,nd-1
--I i I
enitii tra'§;ru~o h1 modo rrTBto (t..t o/n
H.c:nioo c tr::,sl. riu.u·d~lll 12 •. r o.,wm po,,..,m,:r. 3'1/1)
Shot: anali,; 1996 · 2002, 1630 reparti
TAB. 6 - IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI RIMOZIONE/INATTIVAZIONE VIRALE IN ATTO NELLE PROCEDURE DI FRAZIONAMENTO DEI PLASMI DERIVATI E DEGLI EMOCOMPONENTI LABILI
1. Reazioni fotodinamiche con blu dimetilene !fotosensibilizzozione aerobica), reazi oni fotochimiche con psoraleni.
2. Utilizzo dei FRALES !frangible, anchor, linked, effectors).
Fig. 1 Cortei/o 5an,to1io del dona101e
Concl us ioni
Il rischio della trasmissione di malattie virali attraverso la terapia trasfusionale si è ridotto drarnmaùcamente negli ultimi anni per l'incremento ed il miglioramento delle procedure di selezione del donatore ed ai metodi di sc1·inning microbio logico. I n particolare il 1ischio residuo per infezione da epatite C, Be Hiv è 1iclotto grazie all'inu·oduzione della tecnologi.a (NAT) per l'e,~dcnziazjone del ,~rns ntecliante biologia molecolare, che ha considerevolmente ridotto il rischio della trasmissione nel cosiclcletto periodo finestra. Un recente report di VFlati
su mw studio mulricent1ico effellualo Lra il 2002 e il 2006 si evince che il rischio residuo cli infezione in Italia è di 1 su 5 milioni unità Lraslìtse per HCV: 1,8 per L milione di unità per HJV e 8,3 per milione di unità per 1--lBV. I n conclusione le reazioni avverse da n-asfusione di emocomponen ti sono molto basse e i cenui trasfusionali impiegano ogni sforzo per min i mizzare il rischio. Rapporti clinici dimostrano che molti di questi eventi sono causati da fatto1i inerenti il personale medico e paramedico. Secondo le opinioni più accreditate in base alJa logica dell'emovigilanza, la pote11zi,ùe seve1ità degli effetti della Lrasfusione fa. sì che sia essenziale che ogni reazione
CON TEST NAT IN AGGIUNTA Al NORMALI TESTS EIA
PERIODO PERIODO RISCHI VIRUS FINESTRA FINESTRA RIDUZIONE RESIDUO PER GIORNI: GIORNI: (%) MILIONE DI EIA NAT DONAZIONI

TAB. 8 · METODI DI IN ATTIVAZIONE VIRALE DEL PLASMA
• SOLVENTE/ DETERGENTE (S/D)
• BLU DI METILENE (MB)
• PSORALENI (S 59)
• RIBOFLAVINA
• INACTINA
tMetod iche che hanno ricevuto l'autorizzazione per l' uso clinico negl i Stati Uniti ed in Eu ropa Mi lioni di unità trasfuse
Studi in fase preclinica
(5.7-10.9)

aweri;a ,·enga cu111pletame11re 111vesLihrata per poter detcrrninarl' la sua dinamica. il' caw,<' e i lacwii predisponenti. Il primario ubhictLivo di qnesta procedura è prevenire che f"eu·mo si 1ipeta, elim111ando le cause o inuoducendo fattori corrctti,i o sistemi di difesa. Nono~wme che il supporto trasfusionale sia più ~icuro che mai. la trasfusio ne 11011 è prha di ,ischi e deve e,sere effettuata solo dopo a1tenw comidcra7iuni riguardo la sinia,,ione clinica e le specifiche necessità del pa.1.iente.
Bi bliogr afia
1. H o n.ig C. L. , Bove J. R.: Tmnsfmion a1sotiated fatalities. A rcview of Bureau of Biulogics report .1976-1978. [ransfw.io11 20:653, 1980.
2 . Frank M. M .: ComJ>lemmt in the JJat/zoJ>hJsiologJ of h11ma11 dùea.v. N. Engl.J Mcd. 3 16;1525. 1987
3. Schmidt P. J., HolJru\d P. V.: Pathogmrsis o{ the arull' rt'llal fai/uri' a1socit1ted with incompatible tmnsji1sio11. Lancct I I : I 169, 1967.
4. Sazama K.: &pori o/ 355 lranlju.s1on - auocialnl dfflth.1, 1976 lhrough 1985, lramfmion 30; 58:1. 1990.
5. Walker R. H.: Spmal 1tpor/: lraniusion ri.1//. Am .J. Clin. Path. 88; 374, 1987.
6. Gold finge r D.: Arnie hf'1110li1yc trcmsjusion rmctions: a jresh look al pnllwgt'llesis and considerations regardinl( tlU'mf>y. Transfusion 17, 85, 1977.
7. Pineda A. A. , Brzica S. M. , Taswell ll. F.: Hnnolityr tra11sji1sion reactio11: rr1rent l'xperin1ce in a large blaod ba11k \ favo Clin. Proc. 53; 378, 1978.
8. Harrison C. R. , Hayes T. C . , Trow L. L. at al. : Intra11a.1rula, haemolytic lmnsfusion rN1rtion willtout d;,li'ctable nnlibodies: a case re/mrt and m1i.ew o/ l/11' lilemtwl'.
Vox Sa11g. 51, 96; 198fi.
9. Creeowalt T. J.: Pallwg1'/ll'SU and managemrnt o/ hnnol;)lic tmm/11.1io11 l"fflf'IÌ0/1.\. Semin ll cmatol l8; 81, 1981.
10. Payn e R.: Th l' nssoriatio11 o/ frbbrile lmnsjiwon IF(lcfim1s with Te11/waggl11ti II ins.
Vox Sang. 2; 233; 1957.
11. Popovsky M . A. , Cbaplin H. C .Jr, Moorc S.B.: Transfusion 1Plated arn/1' lw1g i.11j111y a neglRCIRd ~e,-ious cmnplirntion of lwnwllterajn Transfu~ion '.l 2:589; 1992.
12. Velati C., Roman ò L., Baruffi L. e a lt.: Residu"l risli of I ra,nfusion tra 11rn11//I'(/ H('.\ ' a11d Hll " infnlionJ , \ 11/ibody .1rree11Nl blood ì11 lta/_).
Transfusion 2002; 42:96G-72.
13. Feldman S. E., Roblin D . W.: ,\ledical orculmts 111 hos/1ilnl cmP: app!icatwm of fr1ihm analJ1i~ lo hosp1ta/ q11alilJ appmisal. .JT Comm.J Qual Tmprov l99i: 23:5fi7-80.
14. Krombac hj., Kamp e S., Gath o f B .S. e alt.: H11ma11 1'1-ror: tizi' Jwrsi1lmg risk oj blood tranifwum: o re-pori offive rases. Anc~ù1 Analg- 2002; 94: 15.J-6.
15 . Linden J. V.: Errors in lransfusio11 111edici111'. ScojJI' o/ the problem. Arch Pa1 ho! Lab Med 1999; l 2'.-1:56'.1-5 .
16. Reg an F. , Tay lor C.: Blood lmnsfusion m;,dicine.
BMJ 2002: 325: l-13-7.
17. Tancon C . , Grando R. : Errori di irlmtificazionf I' trasji1.Sio11 i. Ri ~chj Sanità 2002; 5: 15-9.
18. Reasonj. : !.'errore mnrwo Bologna. Erl Il ;\l 11lino, 1994
19. Livraghi G.: La sicurrza P un modo di J>rnsare. l nodi dl'lla relf'. Genn 2003. W\1'w.Ga11dalf.ic/ nodo~ecuri ty.ht m.
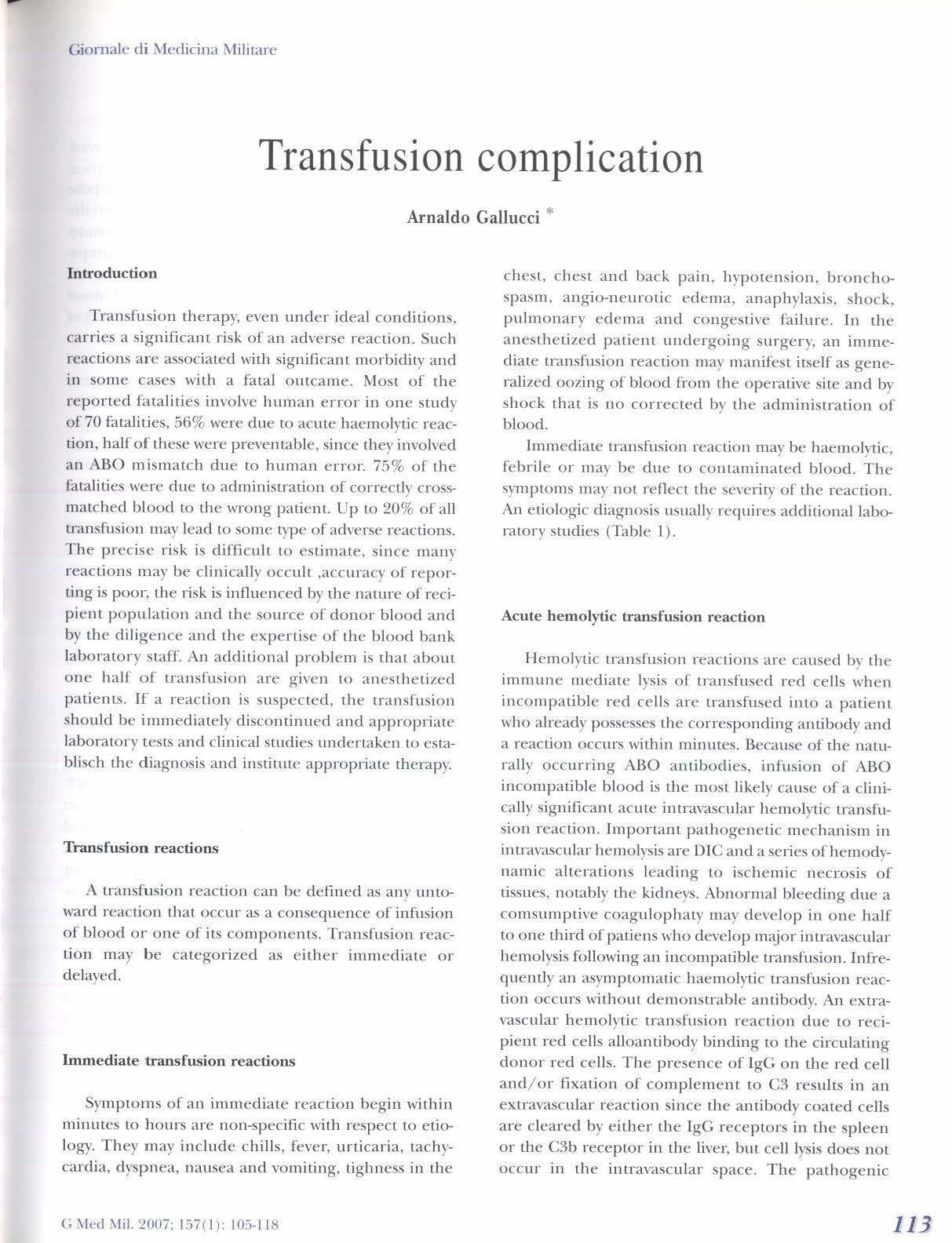
Intr oduction
Transfusion therapy, even under ideai conditions, carries a significant risk of an adverse reaction. Such reactions are associated with signifìcant morbiclity and in some cases with a fatai outcame. Most of rhe reportecl faralilies involve human error in one study of 70 fatalities, 56% were dul" to acute haemolytic reaction, haJr of thesc were preventable, since they invo!vecl an ABO mismatch due to human crror. 75% or the fatalities were due to administrarion of correctly crossmatched blood to the wrong paticnt. Up to 20% of ali uansfusion may lead to some type of ach·erse reactions. The precise risk is difficult to estimate, since rna11r reactions may be clinically occult ,accuracy of reporùng is poor, the 1isk is influcnced by ù1e nature or recipient popttlation and the source of dooor blood and by ù1e diligence and the expertise of ù1c blood bank laboratory staff. An additional problcrn is rhat about one half of transfusion are givcn to anesthetized patien ts. If a reacLion is suspected, the transfusio11 should be immediately cliscontinued and appropriate laborarory tests ancl clinica! studies undenaken to cstablisch Ù1P diagnosis and institutP appropriate therapy.
chest, chest and back pain. hypotensiou, bronchospasm. angio-neurotic edema, anaphylaxis, shock, pulmonary edema and congestive failure. In the anesthetized patient undcrgoing surgery, an immediate transfusion reacrion may manifest itselr as gencralized oozing of blood from the operative site and by shock that is no corrected by the adrninistration or bloorl.
[mmediate transfusion reaction may be haemolytic, febrile or may be due to contaminateci blood. The symptoms may not renect the seYerity of the reaction. An etiologic diagnosis usually rcquires additional laboratory stuclies (Tabi e 1).
Transfusion reac ti o n s
A transfusion reaclion can be defined as any untowarcl reaction that occur as a consequence of infusion of blood or one of its components. Transfusio11 reaction rnay be categorizcd as eicher immediate or dclayed.
Imme di ate transfu sio n reactions
or an immediate rcaction bq,rin within minutes to hours are non-specific with rcspect to etiology. They may include chills, fev<~r, urticaria, Lachycardia, dyspnea, nausea and vorniting, tighness in the
Hernolytic transfusion reactions are caused by the immune mediate lysis of transfused red cells when incompatible rerl cells are transfused into a patient who alrcady possesses the corresponding antibody ancl a reactiou occurs within miuutes. Because of ù1e naturally occurring A.BO amibodies, infu~ion of ABO incornpatible blood is thc most likely cause of a clinically signifìcant acute intrava5euJar hemolrtic transfusio11 reaction. lmportant pathogenetic rnechanis111 in intravascular hemolysis are D IC aud a sc1ies or hemodynami c alterations leading to ischemie necrosis of rissues, notably the kidneys. Abnonna l bleeding due a comsumptivc coagulophaty may develop in one ha lf to one third ofpatiens who develop major inu·avascular hemolysis following an incompatible lransfusion. Jnfrequenùy an asyrnptomatic haernolytic transfusion reactio11 occurs without demonstrab le antibody. An extravascular hernolytic transfusion reaction due to recipient ree! cells alloamibody binding to che circulating donor red cells. The presence of IgG on tbc red celi and / or fixation of complcment to C3 results in an extravascu lar reaction sincc ù1e antibody coated cells are clcarecl by either the lgG receptors in ù1e spleen or the C3b receptor in thc liver, bi.IL celi lysis does not occur in the intravascu lar space. The pathogenic
alloantibody can oftcn be idcntificd in the paticnt's scrum.Thcse reactions may occur eiLher if the paticnt's pre -existing alloantibody was mìsse<l by the biomi bank dnring 1he antibo<ly screen i ng process, or more orLen, ir the unir or blood was mislabelecl or was hung in error on a wrong patiem by the house staff or nursing staff.
The Lherapy shoulcl include immediate termination of Lhe transfusion and institution of mcasurcs Lo correct shock, maintain renai circu l ation, and correct the blceding diathcsis. Thc risk of serious sequclac is proportional to the volume of incompatib lc blood transrused. Severe complications rarely follow the the transfusion of under 200 ml. of recl ce lls.
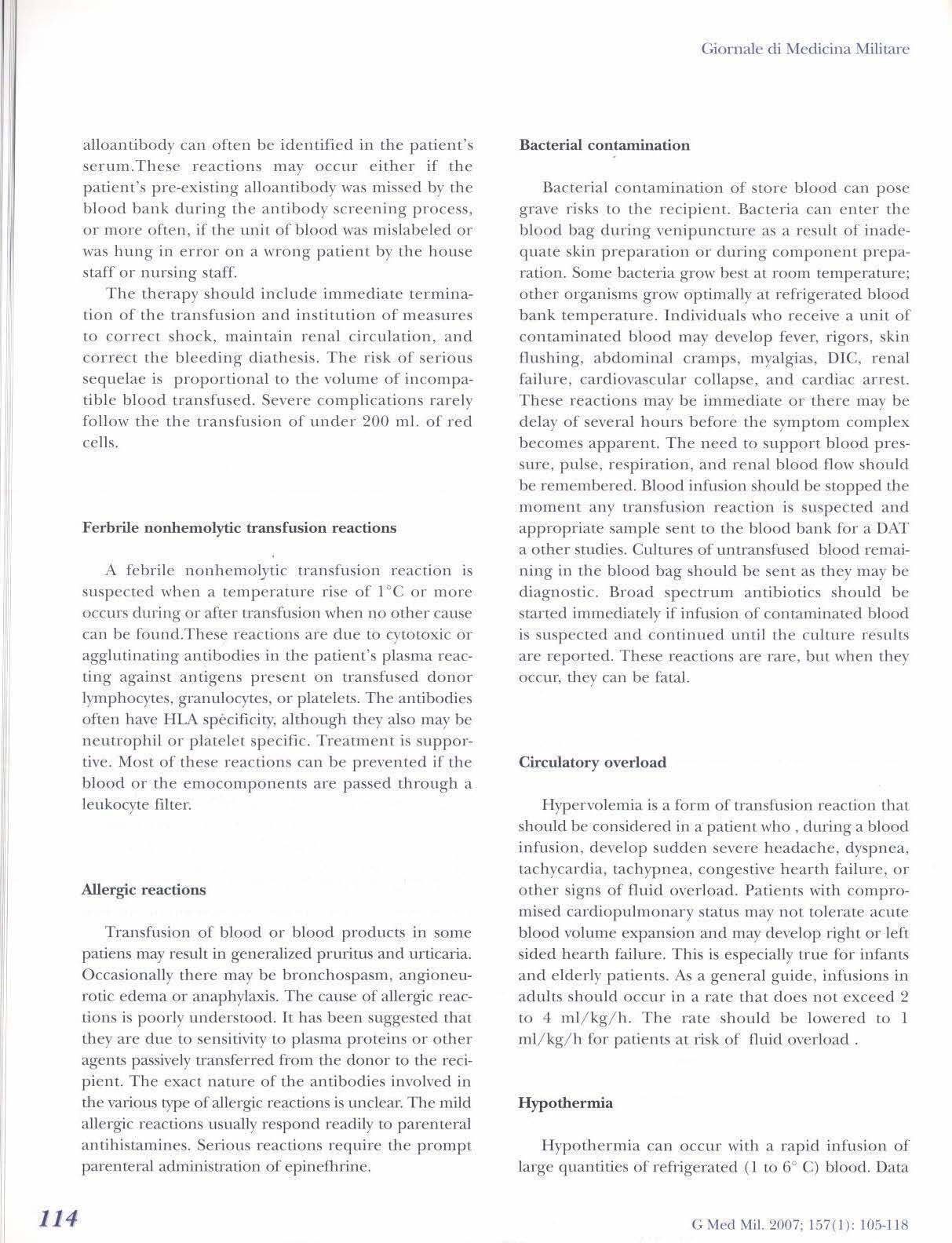
Fer brile n onhe molytic transfusion reactions
A fcbrile nonhemolytic transfusion reaction is suspecte<l when a temperatnre rise of 1°C or more occurs clnring or afler transrusion when no orher cause can be found.These reanions are due lo cytotoxic or agglutinaling amibodies in the patiem's plasma reacting against antigcns present 011 transfused donor lymphocyLes. granulocytcs, or platclcts. Thc antibodies often bave HL'\ spècificity, although thcy also may be neutrophil or platelet specific. Treatment is supportive. Most of these reactions can be prevented if the b lood or the emocomponents are passed ù1rough a leukocyLe filler.
B ac te rial c ontam.ina ti on
Bacterial contamination of store blood can pose grave risks to Lhe recipicut. Bacteria can enter the bloocl bag during venipuncture as a rcsult of inadcquate skin preparation or during component prcparation. Some bacte1ia grow best at room remperature; othcr organisms grow optimally at refrigerated blood bank temperature. l ndivicluals who receive a unit of contaminat.ed blood may develop fever, rigors, skin nnshing, abdominal cramps, rnyalgias, DIC, renai failure, cardiovascular collapse, and cardiac arrest. These reactions may be immediate or thcrc may be clelay of severa! hours before the symptom complex becomes apparent. The need to support blood p1·essure, pulse, respiration, and renai blood now should be rcmembered. Bloocl infusion shoulcl be stopped the moment any transfusion reaction is suspenecl and appropriate sample sent to the blood bank fora DAT a other stuclies. Cultures of untransfused blood rcmaining in Lhe blood bag should be sent as thcy may be diagnostic. Broad spcctrum antibiotics should be staned immediatcly if infusion of conraminated blood is suspccted and continued unti! rhe culLUre resnlt5 are reponed. These reactions are rare, but when they occur, they can be fatal.
Allergi e reac ti o ns
Transfusion o[ blood or blood prodncts i n some pa1iens may result in generalized pru1irus ancl urticaria. Occasiona ll y Lhere may be bronchospasm, angioneurotic edema or anaphylaxis. The cause of a llergie reacLions is poorly undersrood. It has been suggested that lhey are due to sensitivity tO plasma pro t eins or other agcnt5 passively transferred from rJ1e donor to the recipient. The exact nature or the antibodies invo lvecl in the v-<1.ri0tL5 type of allergie reactions is unclear. The mild al lergie reactions usually respond readily LO parenteraJ antihist:amines. Serious reactions require the prompt parenteral administration of epinefhrine.
Hypervolemia is a form of transfusi on reaction that should be considered in a patient who, cluring a blood infusion, develop sudclen severe heaclachc. dyspnea, Lachycarclia, Lachypnea, congcstive hearù1 failure, or other signs of fltùd overload. Patients with compromised cardiopulmonary status rnay not tolerate acute blood volume expansion and may develop right or left sided hearth fa.ilure. This is especia lly true for infams and elderly pa 1ients. As a generai guide , infusions in adults should occur in a rale that does noL exceecl 2 to -t ml/kg/ h. The raLe should be lowered to 1 ml/kg/ h for patienLS al risk of fluicl O\'erload
Hypo the rmia
[Iypothermia can occur with a rapicl infusion of large quantitics of refiigeratecl (l to 6 ° C) bloocl. Data

have shown rhar rapid infusion blood may lower the temperature of Lhe sinoatria l node to below 30 °C, at which point ventricular fìbrillation can occur. HypoLhermia interferes with platelet function and clotting, botb of which are improvecl when the pa t ient is warmed. One way of approaching this problem is with the use of warrned intravcnous tluid or blood. Blood warrni ng devices are avail ablc, but must be checked r egu larly to ensure that they mainta in ù1eir temperature. lf the blood is O\'erheated, hemolysis and the associateci complications of transfusing hemolyzed blood may result. However, in the critically ili patient who requires massive transfusion, acidosis, hypoxiemia, h ypothermia. hypocalcemia, hypo-or hyperka li em i a often coexist, with a conscquent risk of incluction of cardiac arrhythmias.
Bleediog syndromes
Bleeding may be a complication of transfusion eilher beca u se an an tigen-antibody reaction involving a red ccll antigcn initiatcs DIC or because coagulalion factors and p latclt't are dilucted following large volume compa6ble transfusion of bankecl bloocl. Stored b l oocl is defìcienl in platelet and in factors V, Vlll and XI. These clotting components may be depleted when a large volume u·ansfusion is given.
T r ansfusion relateci acute lung injury appcars as the sudden development of severe respiratory distress caused by a syndrome o[ low pressure pu lm onary edema resembling the adult respiratory d istress syndromc (ARDS). Chills, fever, ches t pain, hypotension, a n d cyanosis, as well as thc usual manifestation of pu lm o n ary edema, may be scen. Tbc ches t radiogarph shm,,,.s norid pulmonary edema. The reaction may occur within severa l hours of thc transfusion; it may be severe i n iti a ll y, but generally subsidcs withiu 48-96 hours wiLh appropriate respiratory support, without residuai effects. TRAU occurs with a rcportcd incidcncc of abou t 1 in 5000 transfusions, hut rnay be undcrdiagnosed. Thcse reactions usually are caused. by the transfusion of antibod. ics in clonor plasma ù1at are reactive wiù, rccipient granu l ocytes. Such antybod ies may ,·eact wit h HLA or gra nul ocy te-specific
antigcn. Basccl on studies of ARDS, which has similar pulmonary manifestation, it has been suggested that agglutination of granulocytcs ancl complement activation occ11r in the pulmonaryvascular bed. leading to capil l ary endothelial damage with couscquent fluicl leak into the alveoli. Management involves supportive measures forche pulmonary edema and hypoxia, including ventilatory supporl if required. Hemodynamic monitoring may be required to determine whether fluicl ovcrload is a factor; if not, diuretics are of no proven valuc. Very high doses of corticosleroids may be benefit in TRALI , probably by- blocking granulocyte agg regation and consequent vascular damage. Donors whose plasma is implicateci in such reactions should be examinated for the presence of gramùocytc-specific and H l.A antibodir.s reacting wiù, recipicnt lcucocytes. Many or the donors involved in such reactions havc bcen multiparous females. These donors should be perrnanenùy cleferred
Delaye d hemolyti c reaction
In the clelayecl haemolytic reacrion, developn1cnt of prcviously undctected alloantibodies occur some 4 to 14 days aftcr transfusion of apparenlly compatible blood. In sud, G.L~cs thc patient usually has been alloim11111nizerl by a previous pregnancy or transfusion, and the concentration of antibody was below the leve l of sero logic detection at rh e time of transfusion. l f the transfused blood contaim the corresponcling antigen, an anamnes Li c response e n sues with formar i on of dctcctable antibocly ùiat coats the transfused red b l ood. ce ll s and lcacls to thcir hemolysi. The principal clinica] signs a r e onsei: ofjaun cli cc ,uid absence ofLhe expected increment in red ce li mass. Thcse reactions are associateci wit h the development of a posilive clirect antiglobulin reaction, whi ch in such patiems may be confused w i th auto imm une hacmolytic anemia, or in one report with sickle celi crisis. Generally, ù1ese reactions are c linically less severe th,m thc acute haemolytic reaction and frequently are not clctectcd until more blood are orderecl fo r a transfusion-unresponsive anemia. The frequency of de l ayed. hemolytic anemia was 1 in 4000 in one report, with no deaths in ilie 37 cases studiecl. Delayecl haemolyt.ic reactions, as a result , are frequcnùy undetec ted.
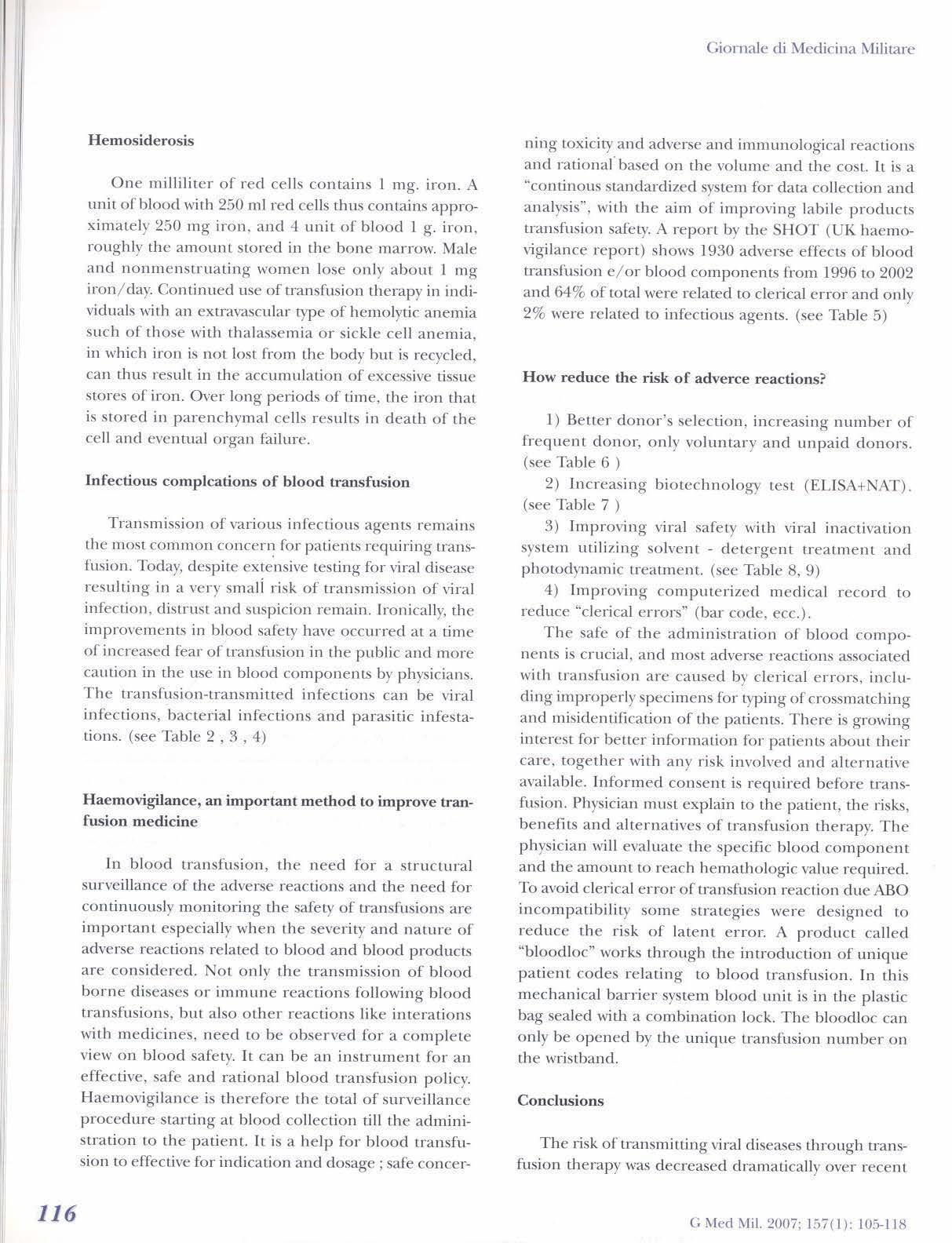
Hemosid e rosis
One millilitcr of red cel ls contains J mg. iron. A unit ofblood with 250 ml red ce!Ls thus contains approx i mately 250 mg iron, ancl 4 unit of blood 1 g. iron , roughly tbc amount storcd in the bone marrow Male and nonrnenstruating wornen lose only about I mg i ron/ day. Continued use of transfusion ù1crapy in individuals \\il h an extravascular rype of hcmolytic anemia such of those with th a lassemia or sicklc cell anemia, in which iron is not lost from the body but is recyclcd, ca11 tJ1us resulL in the accumulation of excessive tissue stores of iron. Over lo n g periods of time, the iron tJ1at is srored in p,u-enchymal cclls results in death of the celi and evcutual organ failurc.
lnfectious complcations of blood transfusion
Transmission of various infectious agents remains tbc most common concerr~ for patients rcquiring transfusion. Today, despite extensive testing for virai discase rcsulring in a very sma li risk of transmission of virai infecrion , distrust and suspicion rcmain. lronicall y, the improvemcnts in blood safety have occurred at a time of increascd fear or transfusion in the public and more caution in the use in blood componenLS by physicians. The transfus ion-transmitted infections can be virai infections, bacteria.l infecLions and parasitic infestations. (see Tablc 2 , 3 , 4)
Haemovigilance, an important method to improve tranfusion medicine
In blood transfus ion, t h e need for a struct ur a l survci ll a n ce of the adverse reacùons aud th e need for contin u ously monitoring ch e safety of u-ansfusions are important especia ll y wh en the sever ity and nature of adverse reac ù ons r e lateci LO b lood and b loocl product~ a r e considcrcd. Not on l y the transmission of b lo od borne diseases or immun e rcactions fo ll owing bloocl transfusions, but also où1cr reactions li ke interations with med ic in es, need to be observed for a comp lete view on blood safety 1t can h e an ins t rurne n t for an effective, safe and rationa l blood transfusion policy. H aernovigilance is therefore the tota! of surveillance procedure starting at blood co llectio n till th e administsati on to th e p atient. It is a help for blood transfusion to effec tive for indi cation and dosage; safe concer-
n in g toxicity and advcrse ancl immunologica! reactions ancl rationa!" based on th e volume ancl the cosL. lL is a ··continous standardized system for data colleclion and ana lysis '', with the aim of improving labile proclucts u·a11Sfusion safety. A report by ù1e S HOT (UK haemovigi lance report) shows 1930 adverse effects of blood transfusion e / or b loocl components from 1996 ro 2002 and 64% of LOta l were rclated to clerical crror and only 2 % werc r clated to infectious agents. (see Tab le 5)
How reduce the risk of adverce reactions?
1) Better donor's se lection. i ncreasing number of freqnenl do11or, only voluntary ancl unpaid clonors. (see Table 6 )
2) Jn creasing biotechno lo gy test (ELISA+NAT). (see 1àble 7 )
3) Im proving vira i safe Ly with ,i ra! inactivation system utilizing solvent - detergent treatment and photodynamic u·catment. (sec Table 8, 9)
4) lm proving computerizcct medicai record to r·cduce ' cJe1ical errors" (bar code, ecc.).
The safc of tJ1e adm i n istration of blood compon ent5 is crucia l, and most adverse reactions associateci wilh transfusion are caused by clerical errors, inclucling improperi)' spccimens for typing of crossmatching and misidentification of th e paùc11ts There is growing intcrcst for beller information fo r pa ri ents aboul their care , together with any risk invo lvecl ancl alternative avai l ab le. l nformed conscnr is r equired before transfusion. Physician must explain lo the paticnt, the ,·isks , benefìts and a l terna ti ves of transfusion therapy. The ph ys ician will evaluate the specific blood component and the a m ount to rcach h emaù1o logic val ue required To avoid clerical erro r oftransfusion reaction d u e ABO incompat i bility some strategies were designcd ro reduce che risk of latem crror. A product call e d "blood loc" works through th e inrroduction of uniqu e patient codes relating to b lood transfus ion. Jn rh is mechanical barrier system b lood unit is in tJ1e p lastic bag sea led with a combination lock. The bloodloc can only be opcned hy the uniqne transfus ion number on the wristband.
The risk of Lrnn smi tùng vira i diseases through transfusion cherapy was d ecrcased dramatically over recent

years due w irnprovernents in both procedures for se lcctiu g blood donors ancl microbiological screening meù1ocls. In particular, Lhe residuai risk of infections by hepatitis C and B and HIV virus have fallen forrher thanks to inu·oduction of nuckic acid tcchnology (NAT) for molecular biology dctcction of viruses, whi ch has considerably rednced thc risk of transmission in the so ca Iled window period. A recent repon by Velali on a mulLicenu·ecl prospective smcly from 2002 to 2006 shows a residuai risk of infections in Italy a~ 1 refcrrccl to 5 rnillions of units for H CV; 1. 8 rcferred to 1 million of units for HIV and 8.3 referred to I million of 11nits for HBV. In conclusion the adverse events in blood cornponent.s transfu:sious are very low ancl the blood transfusion seniccs make cvery effort Lo mini mise the risk. Repon clemonstrare
that most of these events are caused or favoured b y managemenL-related factor: eirher directly or through the negative influence that these factors can have on individuai health care workers . In our opinion, ancl base on the logie of hemovigilance , 1he potcntial scvcrity of the effects of transfusion makes it csscntial that cvery advcrse is fully investigateci in order to determine its dynarnic , causes and predisposing factors. The primary aim of this procedure is to prevent r.he event from bcing rcpcatcd, uy eliminating the causes or inrrodncing corrective mcasurcs or defence systems. Thus. although rhe blood supply is safer than ever, transfusion is nor risk free and should be undcrtaken only afler careful consideratiou of thc paticnt"s clinica! situation and specifìc blood compone11t neecls.
Scu o la
Ital i ana di Se nologia
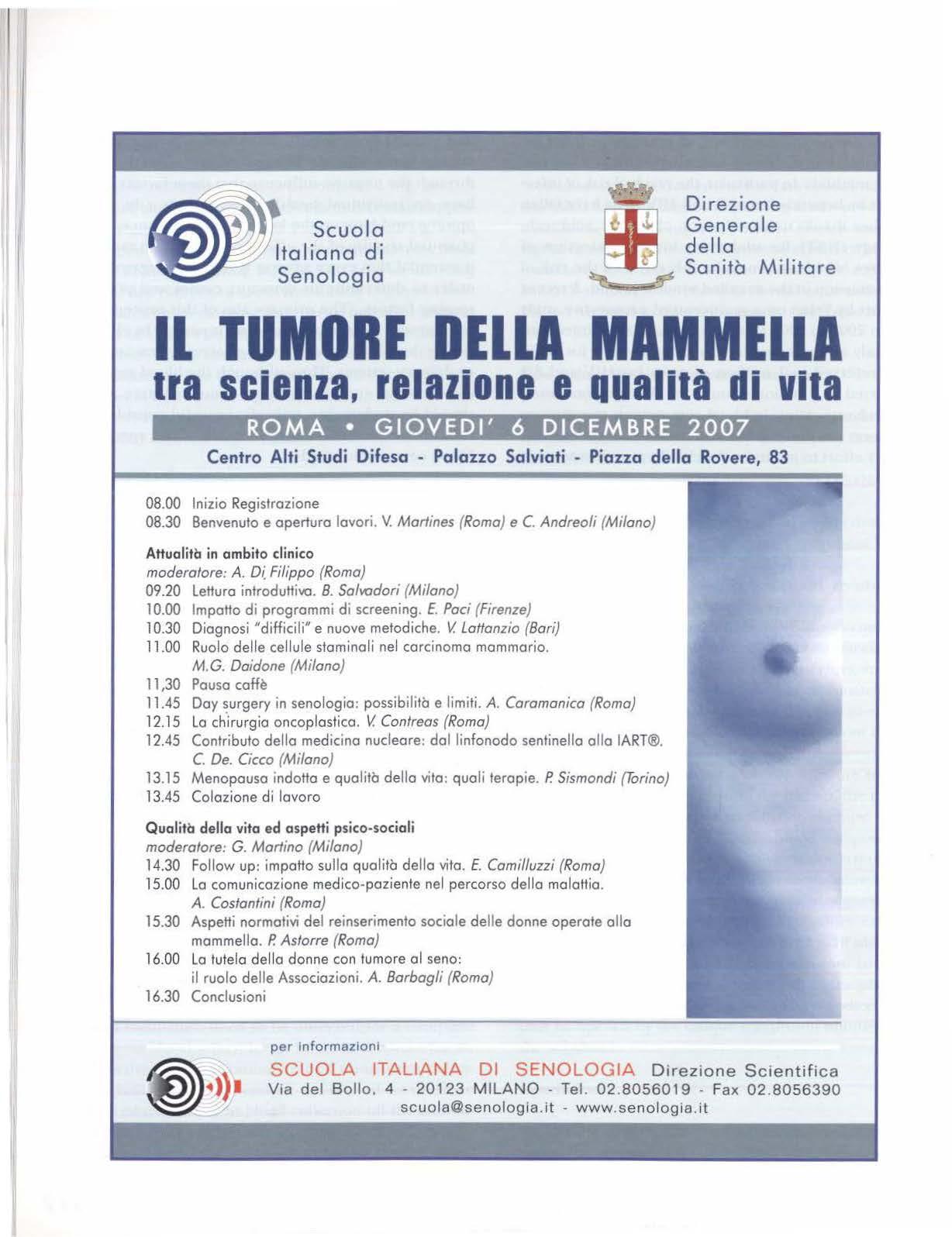
D i re zione
Ge n e r a l e d e lla
Sa n ità M i litare
Centro Alti Studi Dife sa - Pa lazzo Salviati - Piazza della Rovere, 83
08.00 Inizio Registrazione
08.30 Benvenuta e apertura lavori. V Mortines (Roma) e C. Andreoli (Milano)
Attual i tà in ambito cl inico moderofore: A. Dl Filippo (Roma)
09.20 Lettura introduttivo. B. Solvadori (Milano)
10.00 Impatto di programmi di screening. f. Poci (Firenze)
10.30 Diagnosi "difficilt e nuove metodiche. V. Loffonzio (B o ri)
11.00 Ruolo delle ce ll u le st am i nali ne l carcinoma mammario.
M.G. Doidone (Milano)
11,30 Pauso caffè
11.45 Day surgery in seno logia: possibilità e limiti. A Coromonico (Roma)
12 15 La ch i rurg ia oncop laslica. V. Conlreos (Roma)
12.45 Contributo dell a medicina nucleare: dal linfonodo sentinella alla IART®. C. De. Cieco {Milano)
13.15 Menopausa indotta e qualità della vita: quali terapie. P. Sismondi (Torino)
13 .45 Co laz ione di lavoro
Qualità d ella vita ed a spetti psico- sociali modero/ore: G. Martino (Milano)
14.30 Fol low up: impallo sulla qualità della vita. f. Comilluzzi {Roma)
15.00 La comunicazio ne medico-pazi ente nel perc o rso de ll a malattia. A. Cosfonfini (Roma)
15.30 Aspetti normativi del reinserimento sociale delle donne operale alla mammella. P. Aslorre (Roma}
16 00 La t ute la d e ll a donne con tu more a l seno: il ruolo del le Associazioni. A. Borbogli (Roma)
16.30 Conclusioni
per Informazioni
SCUOLA ITALIANA DI SENOLOGIA D irezione Scienti f ica Via del Bollo, 4 - 20123 MILA N O - Tel. 02.8056019 - Fax 02.8056390 sc uo l a@senologia.lt - w w w.s e no l ogia. i t
Emo components for topic use: platelets ge l and fibrin glou
Adri ano Pe tre lJ a *
* Cap. mP. Rt>pr1rlo Ematologia - Dipartimmto hm111t110f.'lnntologia - Polidinia, Mi/ilare ·C,,liu" - Rnma.
Riassunto - Se a tt iva l e, le p iast r ine producono sia numerosi fattori di crescita capaci d i stimolare la replicazione cli cel lul e m esench i mal i , qua li osteob lasti, lìbrob lasli e ce Uule endot e lia li , sia fattori chem io1anici per macrofagi, monoc i ti e p ol imo r fo n ucleati Quando ciò avv iene a liY ello locale si ass iste ad un processo loca l e di riparazione tessutale Il gel piast rinico, p revalememenle a utologo, è util izzato p er uso topico. E' coslitui to da criop 1·eci p i tato e piastrine' concentrate. Gl i effetti riparativi e rigenerati\·i si basano su ll 'alùvaz ione piastri nica e co n segue n te r i lascio a livello loca l e, di fattori di c r e,ci ra. L'app l icazione di colla di fibrina si basa sull'alùva1ione di u n concentraw di lìbrinogeno (con t iene anche a l tri !"attori come la fibronectina ed il fat rore Xlii ) u nitamen te ad una so l uzione d i tromb i na. Al momento de ll ' i mpiego le due componenti sono m iscelate i n presenza d i calcio riproduce n d o l'ulti ma fase de ll a coagu lazione: l'atrivaz i one deJ fi b rogeno i n dotta da ll a trombi n a con conseguente fo rm az io n e del coagu lo d i lìbrina che aderisce nel sito di a ppl icazione.
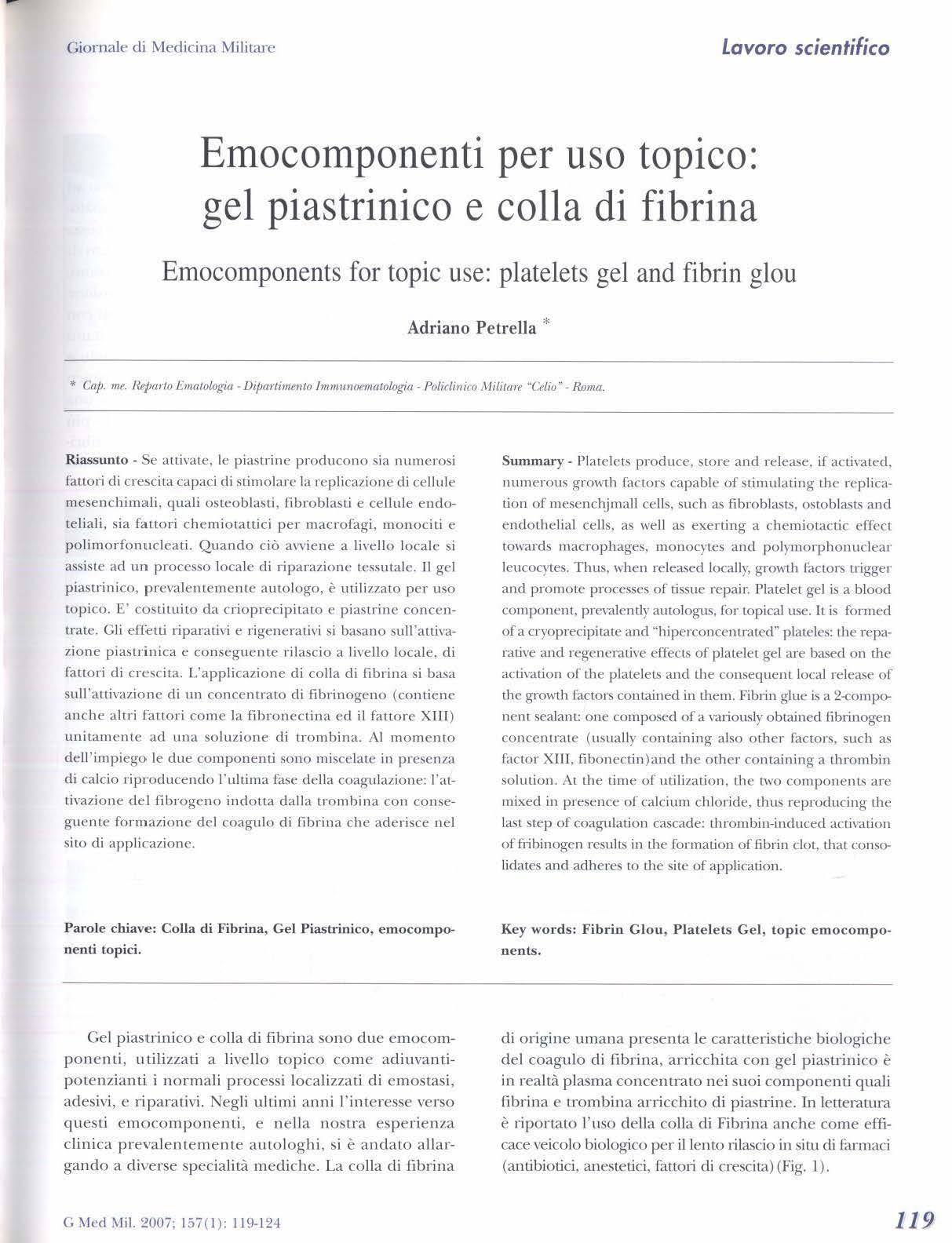
Paro le c hiave : Colla di Fibrina , Gel Pi as trini co, e m ocompone nli lopici . Ge l p iasu-in ico e co ll a d i fibri n a sou o du e crnoc ompo n e nti , utilizzati a li ve ll o top ico co m e adiu va n tip o tenz ian t i i n o rma li process i local izzati di e m ostas i , a d esivi , e riparati vi. Neg li u l t i mi anni l ' inte resse ve r so qu es ti e m oco mpo n e nti , e ne ll a n ostra es p e ri e n za clin ic a preva le n temenLe a ut o log hi , si è anda to a ll arg and o a d i verse s p eciali tà m e di ch e . L a c oll a di fi bri n a
G ~kd Mii.
Summary - Pl a1clcts produce, swre and release. if activated, 11 ume r ous g r owt h facwrs capabte of sti m u lating ù1e n·pl ication of mesenchjmall cells, such a.s fibroblas ts, ostobla,ts and e n doth e l ial cell s. as well as exerting a chemiotactic effect towards macrophages, mo n ocyles and polyrnorphonuclear leucocytes. Thus, when released locally, growth factors u;gger and prnmole processes of tissuc rcpair. P lace let gel is a blood component. preq1Jcntly autologus, for LOpical use. lL is formed ofa cryop r ecipitate and "hiperconcen u <1led" plaleles: ù1e reparative and rcgcnerati\'e effects of plalelet gel are ba.sed on the actimrion of the plalelets and the consequem locai rc lr'a,c of t h e growth facLOrs comained in thern. Fi b ri n g lue is a 2-componen t sealam: one composed of a , ,arious ly ob tained Cibrinogen concentrale (usually conlain in g also other factors, such as factor X III , fibonectin)and thc other con taining a thrombin soluùou At the 1inw of ut ilil arion, the two components are m ixed in p r esence of c.-1lc iu m chlorìde, 1htts reprod u cing the las t ~tep of coagul ation cascade: thrombi n -in duced activa ti on of [i;binogen resu ]t:!, i11 the fonnation of fi b rin clot, tJ1at co n solidatcs an d adheres LO the s ile of appli cation.
Ke y word s: Fibr i n Cl o u , Plate l ets Gel , lo p ic e m oco m pon e n ts.
d i origi ne u mana p resen ta le cara tle ris ti che biologich e de l coagu lo d i fi b ri na, arri cc hita con ge l p i as t1i ni co è in rea ltà p lasma conce m ra to n e i suoi co m ponen t i qual i fi bri n a e Lrom bina arr icchi to d i p iastr ine. Tn letteratura è r ip orta to l' u so d e ll a colla cti F i brina a n ch e come efficace veicolo b io logico per il le 11 to r ilascio in si t u d i furmaci (antib io ti ci, a n estetic i, fa tto1 i d i c rescita) (Fig. 1).

Le piasuine elaborano e rilasciano, se atli\'ate, numerosi fattmi di crescita capaci di s timo lare la rcpliGILione delle cellule me~enrhimali, come fibroblaMi, o~teoblasti e cellule endotelia li ese rcitando anche un ·aLione chemiotanica Yerso le cellule dC'l sistema monoci to-macrofagico.
D,\lla degra11ula1ionc delle pia!>lrine atti\ate \ engono rilasciati localmente i fattori cli crescita di cui ne i.• ~tata documentata l'attività:
• PDGF: alione rntogena cd angiugcnctica , up-rcg11lat ion di altri fattori di crescita (,timolaLione dei fì broblasti e degli osteoblasti).
• TGF-b: ~timo laLione di fibrobla~ti e preosteoblasti, inibiLione degli osteocla~ti e dt·I riassorbime11to 0~\e0.
• I G F I e II: alli\'ità sui precursori degli osteobla~ti, inrremenw dt'g li osteob lasti.
• EGF: stimola7ione delle cellule epidermiche e mesenchimali ( Fig. 2).
La documentata capacità delle pia~trine ad intervenire nei meccanismi di r'i parazion<' ti~sutak ha costituito il presupposto teor'ico all'utili,,o del gel piastrinico in circo~tanzc dher\e acconrnnalc dall'e,igenza di auivare un processo di ripara7ione ti~~11tale, tenendo prc:,enri quc:,li presuppo:,li gli abiti cli applica,ione sono ~tali din, r~i: in chirurgia maxillo-facciak. in ortopedia, in chirurgia rnscola,e. in nilno1erapia.
Ne lla chirurgia o ral e 1\uilizzo del gel piastrinico è st;ito proposto negli intcr\'cnti ablati\'i della regione ma:-..illo- facciale; in questi pa1.ienti il gel piastrinico è stato ,uturato come una sonile membrana al te,snto sottostanrc, nelle fasi di ricostruzionc>, ottenendo un mig l ioramento sia dell'emostasi che della chiusura dei piani ~o\'rappo~ti per l'effeno collante C:'cl un p i ù rapido effetto cicatri11a11te conseguente al rila~cio dei fattori di crescita i\na logarnentc il gel piastrinico si è dimostralo effìcace nel traltamcnto delle fistole orona~ali in combinazione con O\\O da impianto e nella chirurgia impiantare dO\'C:' il rilascio dei fattori di cresci ta con t enuti ne i granu l i de ll e piastrine :,limo la la fo1 maLione cli osso nel ~ito determinando un più eflìcacc posi,ionamento dell'impianto. Tn atnbiw odontoiatrico<.' stato peraltro descritto l'uso del gel piastrinico anche nella chirurgia parodontale e nel l a chirurgia orale in pazienti c.he. per patologie concomitanti , 1isultano maggiormente espo~ti al 1i;.chio di sanguinamento o ai d i feui di cicatri11,vione.
La te rapia lo cale dell e ulcere ha, fondamentalmcnle nella pratica clinica, lo ~copo di creare le condi,ioni
ideali per la formuione del tessuto di granula,ione e la riepila l iziazionc. che non possono awenire se le cause, che hanno proyocato la le~ionc, conlinuano ad e~ercitare la loro influenza. L'inquadramento ctipatogcnetico rlel)e Lùcerc è dunque di estrema importan1a per poter ouenere la guarigione. Mentre il tessuto cli granula1ionc si e, iden1.ia già dalle prime applica1ioni. la completa riepit.aliLLa?ione è fu117ione dell'estensione e della pawlogia soll<>Stantc. Nei pazie111j gio\'ani con ulcere post-traumatiche se11La patologie concomitanti il proces~o di guarigione sembra essere più rapido e completo. l\clla preparazione del gel pia~trinico variando i l contenuto cli crioprecipitalO si ottiene una consi!,ten,a superiore del preparato rendl·ndolo più malleabile. TI ffiprecipitalO è fonte oltre che cli fibrinogeno anche di fibro n ectina importante glicoproteina che media l'adesiont' fra le cellule (Figg. 3, 4).
La chirurgia toracica. la chirurgia addominale rappresentano le indic:11ioni principali all ' lllili,zo della co ll a di fi b rin a, la sua azione emostatica <' adesirn (collante) diminuiscono il rischio di sanguinamento pmtoperaw1 io con consegucntt' riduLione della possihilirà cli don' r reintenenire chirurgicamente. ;'\'ell'analisi costi / benefici, la dimin\1/ionc del fabbisogno trasfusionale post operatorio ouiene un significati\'o ri~parmio economico ,ia in termini di t'O\to degli emocomponemi sia in termini di risparmio complc~sivo nella gestione del paziente.
Meccanis mo di ri gene razi one d e l t essu to osseo: durante la (e<;ionc ciel tessuto osseo si è ipotiuato un rilascio in,iale di PDGF, TGF-beta, lGF I e Il per effetto della degranu lazione delle piastrine in loco. Il P DGf' ~timola la mitosi delle cellule staminali midolla1 i presenti nell'osso e la formazione dei nuo\ i capillari nella sede cli lesione. Il TGF-beta induce il differenziamento de i proostcoblasti verso l e forme più mature. l.'auiùtà del TGF-bt>ta ~i espl ica anche sugli osteobla<;ti che \·engono stimolati a produrre matrice o,~ca, e sui fibroblasti che depo~itano la matrice cli collagene destirnna a sostenere la Cl'l'SCita vasale. La presenrn nel sito delle piasu~ine \eicolate dal torrt>nte ematico rifornisce cli continuo l'area di rigencra,ionc del tessuto osseo dei growtft fortors nccessa1i al suo completo sviluppo. Me ccan is mo di rige n e razi o n e d e l tess uto c utan eo: ,i S\iluppa in ffe fasi. infiammato1ia, formazione del tessmo cli granul;vione, f-ase cli 1imodellamrnto (Figg. 5, 6).
Fase infiammatoria : una lesione tissutale comporta una lesione vasale con fuoriw,cita dc!Je componenti ematiche. Le piastrine presenti eia un lato formano un
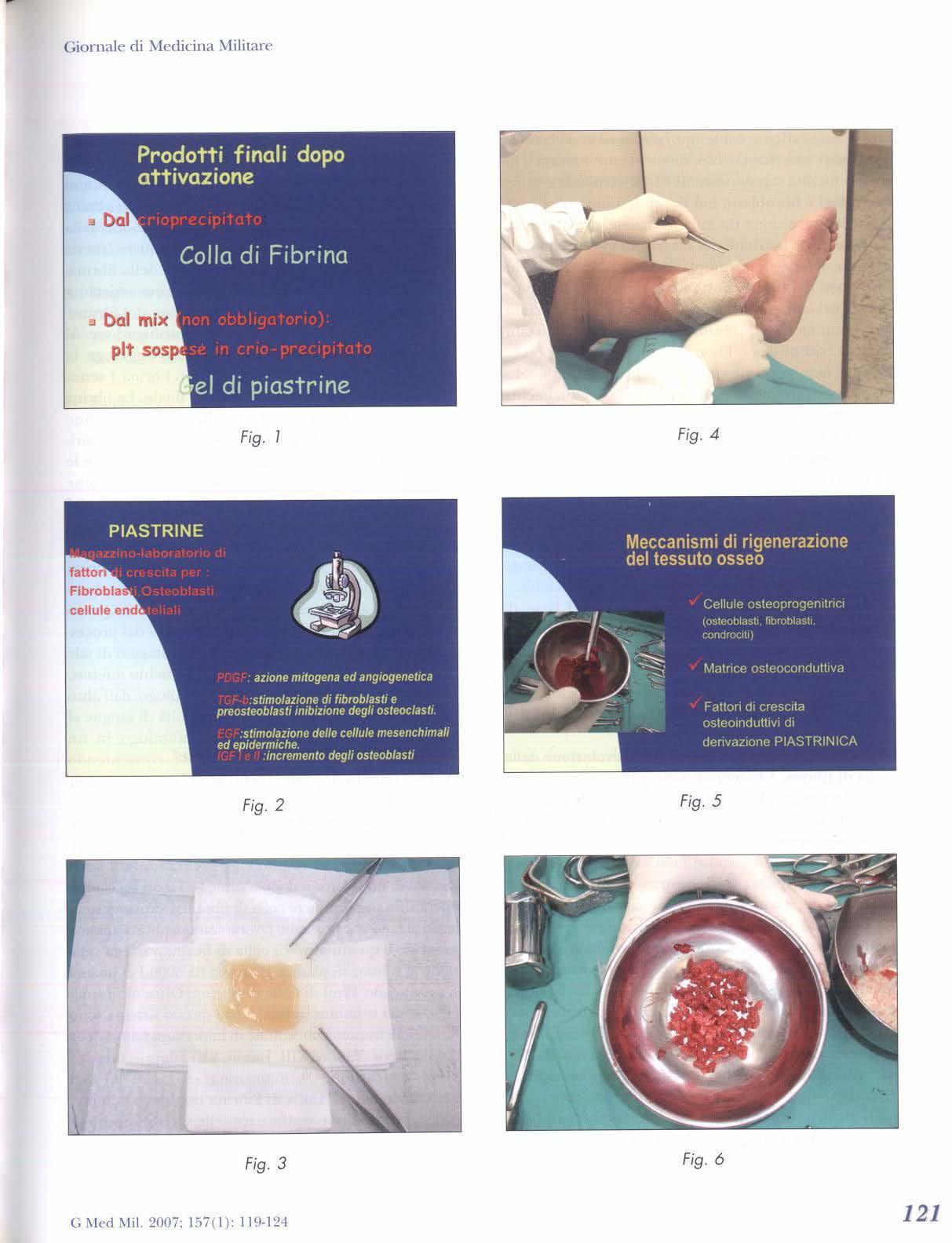
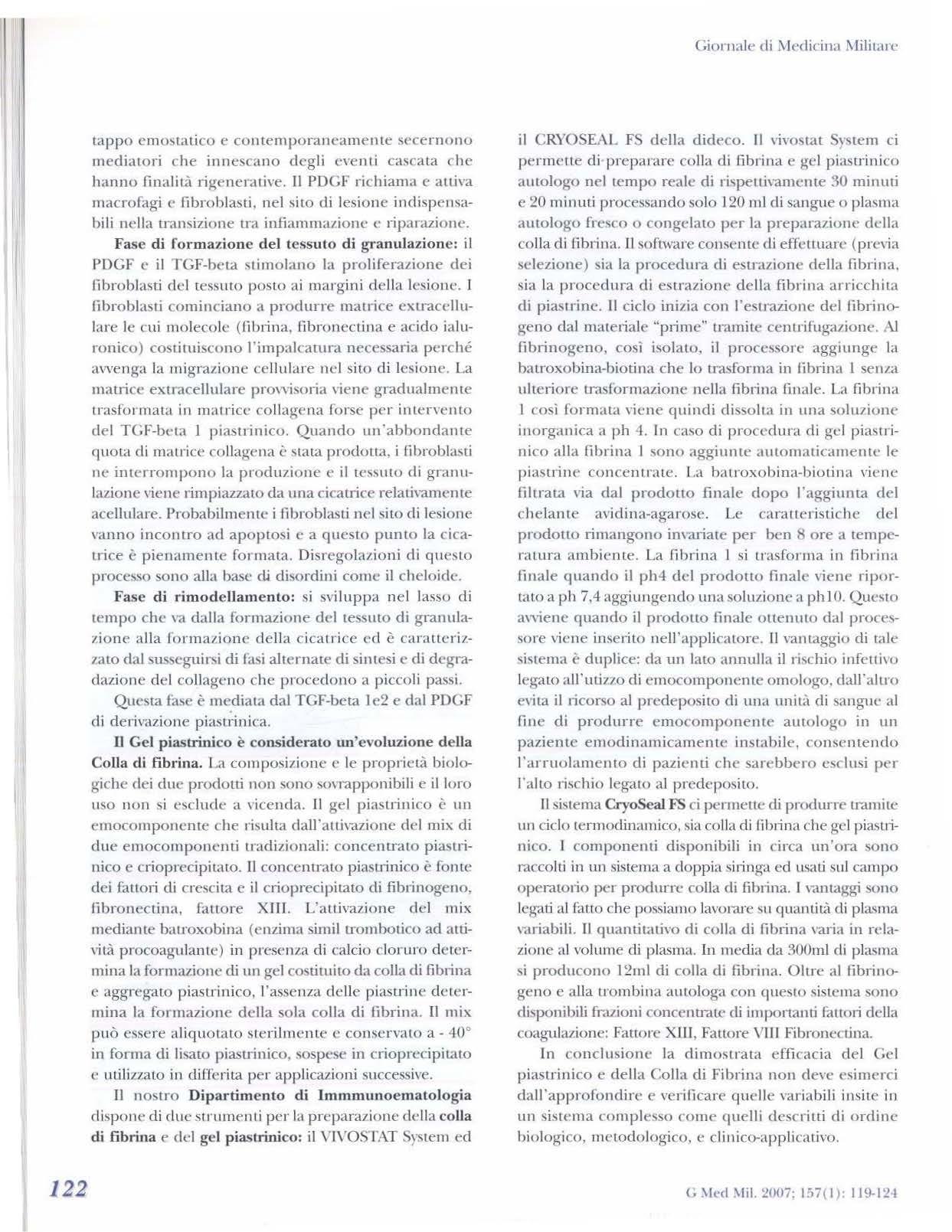
tappo cmo~tatico e contemporaneamente S('Cernono mediatori c he innescano degli C\'enti cascata che hanno finalità rigenerati,·e. li PDGF ri c hiama e atti"a macrofagi e fibroblasti, nel sito di lesione indispensabili 1wlla u·ansizione tra infiamma,ione e riparazione.
Fase di formazione del tess ut o di granulazio n e: il PDGF e il TGF-beta stimolano la proliferaLione dei fibroblasti del tessuto posto ai margini de ll a lesione. I fibroblasti cominciano a produrre matrice extracellulare le cu i molecole (fibrina, fibronectina e acido ialuronico) costirui!.cono l'impalcarurn necessaria perché avvenga la rnigralione ce ll ulare nel sito di lesione. La matrict' extracellulare prowismia ,iene 1,rradualmente trasformata in matrice collagena forse per interYento del TGF-beta l piastrinico. Quancio u11 'abbondante quota di matrice collagcna è stata proclotla, i fibroblasti ne interrompono la produ,ionc e il tessuto cli gram1lazionc viene: rimpiazzato da una cicatrice relativamente acellulare. Probabilmente i lìbroblasti nel sito cii lesione vanno incontro ad apoptosi e a questo punto la cicatrice è pienamente formata. Disregola1.ioni di questo processo sono alla base di disordini come il chcloidc.
Fase d i rimode llam e nto: si sviluppa nel lasso di tempo che ,-a dalla formazione del Lessuto di granula1ione alla forma,ione della cicatrice ec:I è carallcri11ato dal susseguirsi di fasi alternate di sintesi e di dcgradalione del collageno che procedono a picco li passi. Questa fase è me diata dal TGF-bcta I e2 e dal PDGF di derivazione piastrinica.
Il G e l pi as trini c o è cons ide rato un'evo luz io n e d ella Co lla di fibri n a. La composi,ione e le proprietà biologiche òei due prodotti non sono sm rapponibili e il loro u~o non si escl11dc a l'iccnda. Il gel piastrinico è un emocomponente che risulta clall'atLiva1ione del mili. di due emocornpouenti tradi1ionali: concemrato piastrinico e crioprccipitato. Il concentrato piastrinico è fonte dei fattori di crescita e il crioprecipitato di fibrinogeno. fìbronectina, fattore Xlii. L'a u ivazione del mix mediante bau·oxobina (e nLima si.mi i trombotico ad attività procoagutan te) in prcse 111a di calcio cloruro determina la formazione di un gel cos tituito da colla cli fibrina e aggregato piastrin ico, l'asse nza de ll e piastrine determina la formazione della sola colla di librina li mix può essere a li quotato sterilmente e conservato a - 40° in forma cli lisato piastrinico , sospese in criop1ecipitato (' u til inato i n differita per applicazio1ù successil'e. li nostro Dipartim e n to di Immmuno e matol ogia d ispone di due strumenti per la preparaLione della co ll a di fibrina e del g e l pi as trinico: il \ ' l \ 'OSTAT System ed
il C RYOSEJ\ L FS della d ideco. li ,·ivo~tat Sy~tem ci permette di prepa1are colla di fibrina e gel piastrinico autologo nel tempo reale di rispetti,t1mente 30 minuri e 20 minuti processando solo 120 ml di sangue o plac;ma autologo fre~co o congelato per la preparazione della colla cli fibtina. Il software consente di effeltuare ( previa !>elezione) !>ia la procedura di esmt7ione della lì brina. sia la proccclnra cli estra1.ione della fibrina arricchita cli piastrine. 11 ciclo ini1ia con l 'estrazione del fibrinogeno dal mate1iale "prime" tramite ccntrifuga,ione .-\I lìbrinogeno, così isolato, il processore aggiunge la batroxobina-biotina che lo trasforma in fibrina I se11La ulteriore tral,forma1.ione nella fib1ina finale. La fibrina l così formata , ·iene quindi dissolta in una soltl7ione inorganica a ph 4. In caso di procedura di gel piastri11ico ,ù la fibrina I c;ono aggiunte automaticament(· le piast1inc- concentrate. La batroxobina-biotina viene filtrala vi.a dal prodotto finale dopo l'aggiunta del rhelante avidin.t-agarosc Le carattc1istiche del prodotto rimangono im·ariate per ben 8 ore a temperatura ambic n te. La fibr i na l si trasforma in fibrina finale quando il ph4 del prodotto final<' viem· riportato a ph 7,4 aggiuugendo una solu,ionc a ph 10 Questo anienc quaudo il prodotto finale ottenmo dal procec;sore viene inserì.Lo nell'applicatore. Il vantaggio di tale !>i<;tema è duplice: eia un lato annulla il rischio infcttirn legato all'uti7!o di emocornponente omologo, dall"altro e,ita il ricorso al predeposito di una unità di sa ngue al fine di produrre emocomponente autologo in un paziente: emodinamicamente instabile, consentendo l'arruolamento di p,uicmi che sarebbero esclusi per l'alto rischio legato al predeposito. Il sistema CryoSeal FS ci pennette di produrre tramite 1111 ciclo termodinamico, sia colla di fibrina che gel piastrinico. I componenti disponibili in circa un'ora sono raccolti in nn sistema a doppia ~iringa ed usati su l campo operato1io pc:r prodnrn: colla cli fib1ina. I ,-anwggi sono legati al fatto che possiamo larnrare su quantità di plasma variabili. Il quantitati,o cii colla di fibrina \'aria in r<.'lazione a l volume di p lasma. In media da 300ml di pla<;ma si producono 12ml di colla di fib1ina Oltre al fibrinogeno e alla trombina autologa con questo sistema sono di\ponibili fuvioni conrena-ate cli importanò fattmi della coagu la:,ione: Fattore XHI, Fattore Vlfl fibronecrina. l n co nclw,ionc la dimostrata efficacia del Gel piasuinico e della Colla di Fibrina non deve esimerci dall'approfondire e , crilìcare quelle variabili insite in un sistema complesso rome quelli descritti di ordine biologico, metodologico, e clinico-applicativo.
l. Borzini P. e coll.: P/,at('{et gel: clinica[ use and urwnswered questions
Blood T r ansfus 2004; 2 :10-4.
2. Rughetti A. e c oli . : Cosed surgery. Autologus plalekt gel the treatmenl of pseudoarlhrosis.
Blood Transfusion 2004; 2:37-43.
3 . Rughetti A. e coll.: Platelet gel: assays of three growlh Jactor.
Blood T ransfusion 2006; 4:92-101.
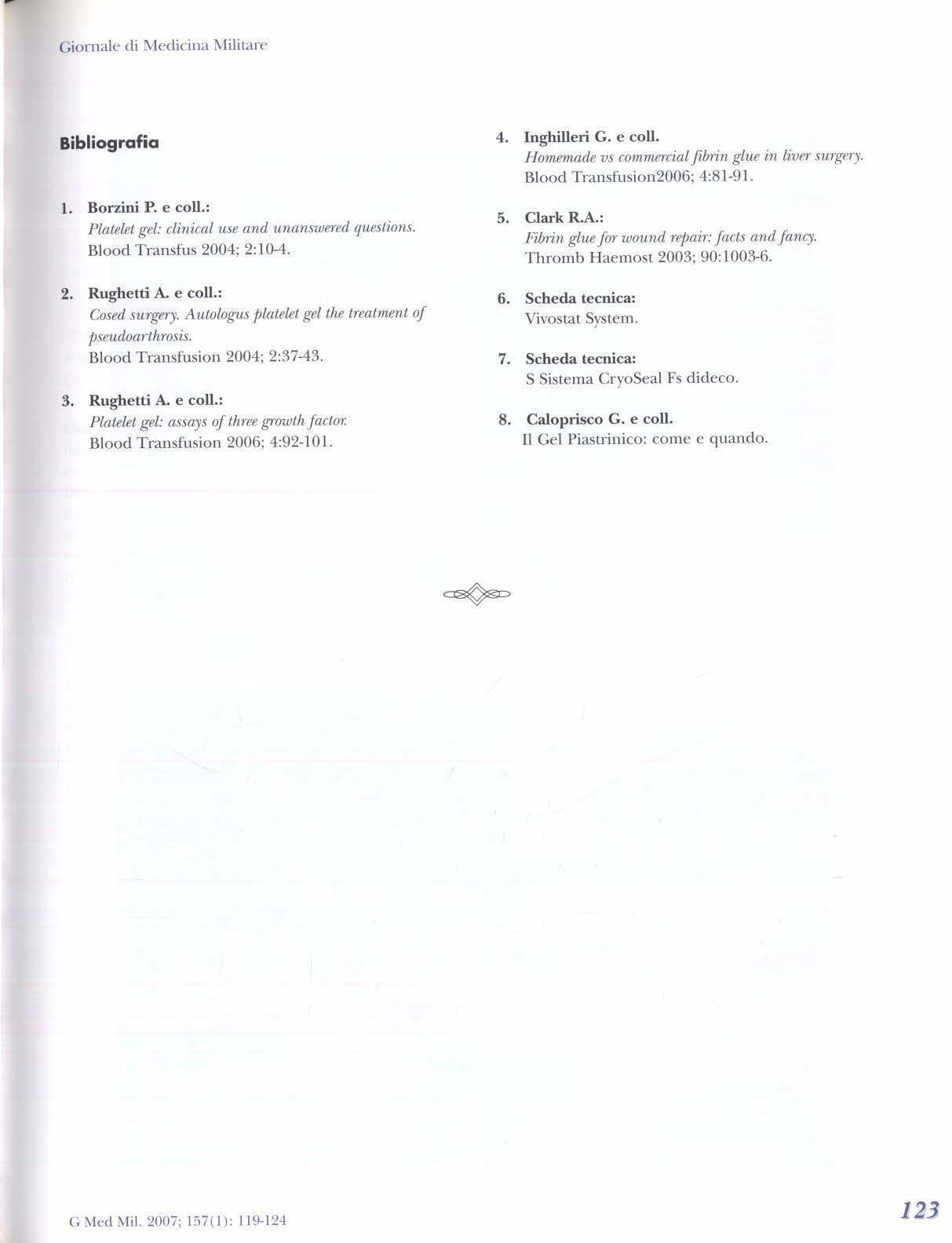
4 . lnghilleri G. e coll. Homemade vs rommeràal jibrin glue in liver s11rgerJ, Bl ood Transfusion2006: 4:8 1-91.
5 . Clark R.A. : Fibrin glue Jor wmmd repair: facts and Jancy. Thro m b H aemost 2003; 90:1003-6
6 . Scheda tecnica: Vivostat System.
7. Scheda tecnica: S Sistema CryoSeal Fs dideco.
8 . Caloprisco G. e coll . n Gel Pi a~ui nico: come e quando.
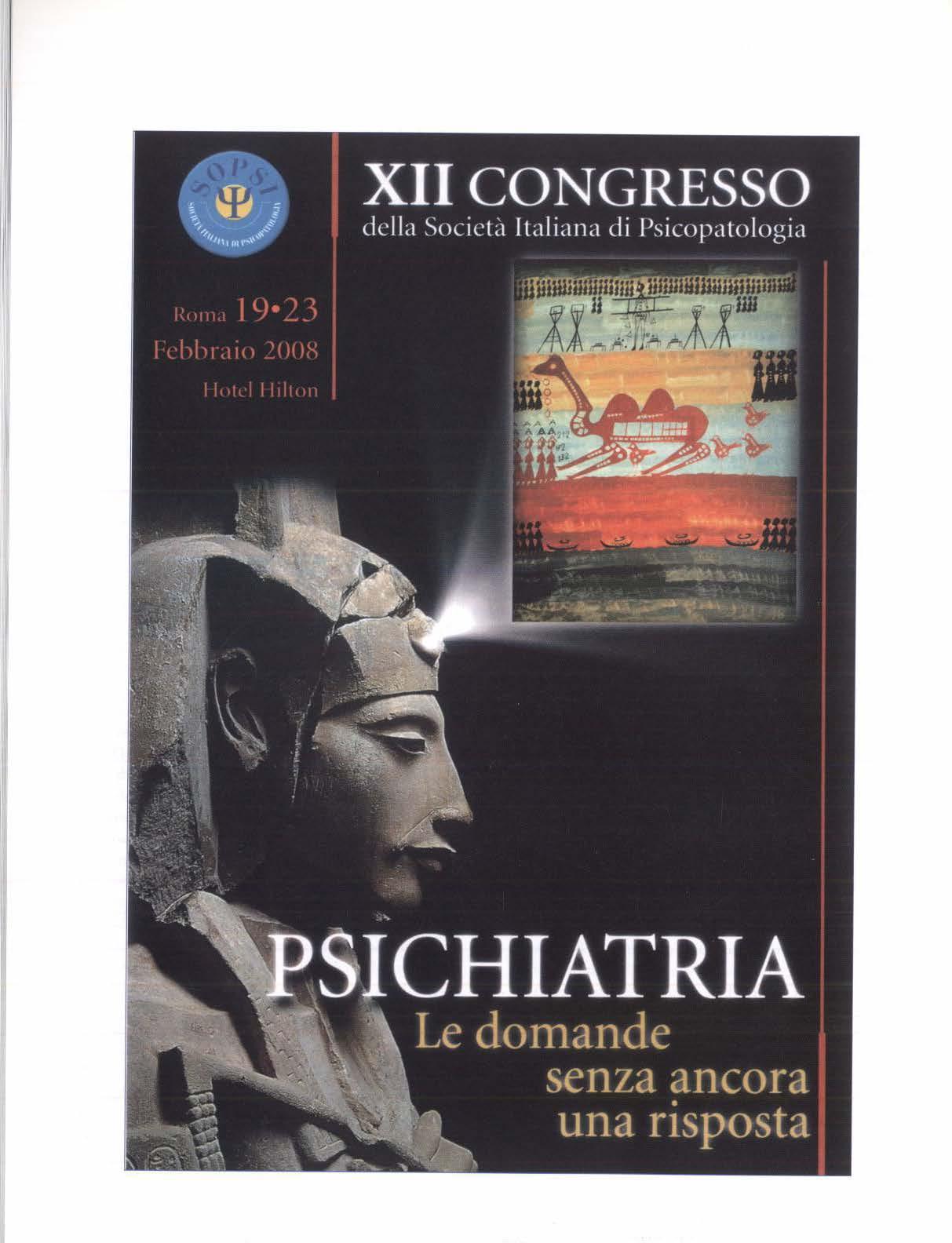
Magg. me. Ca/JO :,,•ruizio C,-inrmnnva:;ùme P gestionr Pmom111po11e11ti - Cr11/m 'Jì-asji11ir,nn/P- Polirlinim ;\fi/itm·,, '"Celio" - Unn,11.
Riassun to - Nel 19!'>0 il dr. ,1 udrey Smilh dimos11·ò che il glicerolo è in grado cli prnteggerc i g lobuli rossi dai da1111i prm·o-cati dal loro congelamento. Da .11lora centi1nia di migliaia di unità di emazie concentrale sono s t ate conge la l e iu varie parti del mondo 11s,mdo diverse procedure. Nella pratica clinica le ema1/ie concentrate vengono congelar<' utilizzando sia il metodo a basso che il mcto <l o ad alto g l icernlo. La nuova apparecchiatura della Hacmoneti cs ACP2 15 ed altri sistemi equh·alenri consenmno, con procedurn sterile, la gliccrolizzazione e la degliceruli11,11ione pm,bcongclamemo del le un it,ì di globuli rnssi co11centrati e la possibi l ità di conserva?ione dopo il lavaggio oltn: le 24 ore fino ad un massimo cli 2 settimane uti l izzando idonea soluzione conservante. Que.,to è: un pa.,so importame per render<' le emazie congelate in grado di costitu ire una riserva strat<'gica in s i tua1 i oni di emergenza o anche di ges1io11c combinata con le scorte d i e1nazie f'rcsche. Il conge lamento delle emazie concen t rate è- inoltre un prezioso ,isiema pe r creare una banca cli globu li rossi cli fenotipo raro e p11ù anche consenLire in cas i selezionati la conscn-azione cli globu li ross i autologhi.
Paro le chiave: Emaz ie c once ntrate, crio c onse rvazione, tempe ratura d i conser vaz ione , g li ce ro lo , glicer o li zz az io n e, deglice rol izzazione , s istema a c ircuito ch iuso
S ummary - l n 19:°\0, Dr. Audrcy Smith show<'d I haL glycerol protects rcd blood cells (RBC) from i1~jury from freezing. Since thal time, hundreds of rh ousands of units of RBC bave been frozen in more ù1an a hundred facilitics around rhc worlcl using a Yarictv of procedurcs. In clinica] practice, units or RBC are froz.en us i ng either low- or h igh-glycerol mcthods. Thc ne11· Haernonctics ACP2 lfl and other equivalent systcms will provide ihe abilir y 10 slerilely dcglycerolize and posttlrnw s 1orc such units fi-.r 2 weeks once processes are licensed and chis way can be considered an importam step in making pre, iously frozen red blood cells available for· e111erge11cy a11d invcntory s i tuations. F11nher111orc RRC freezing is a valuable blood hanking tec h no loi-,ry for prcscrvinR units of ra r e phenotypc ancl il can also suppon medically indicate<l autologous RBC scorage
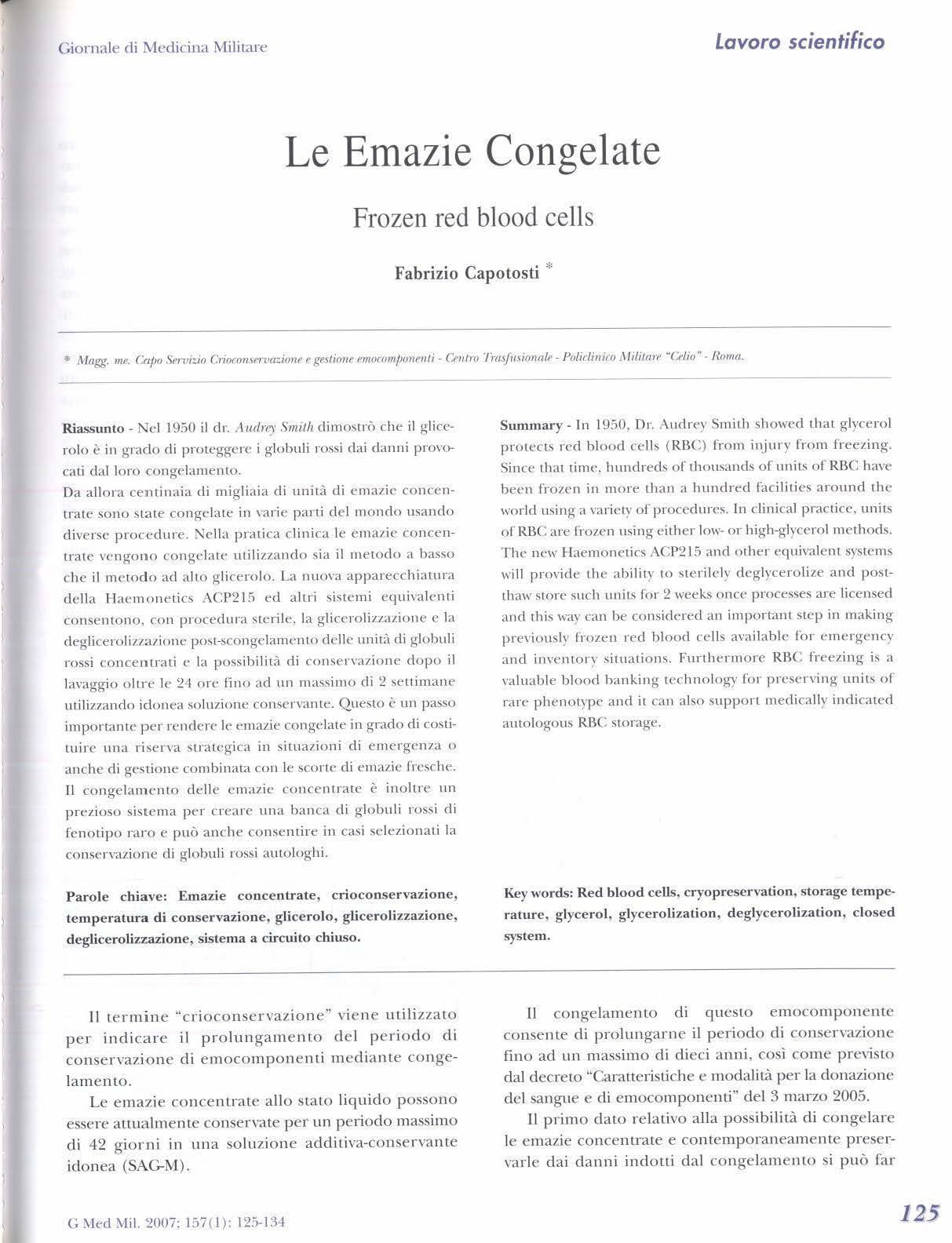
li termine "crioconservazione" viene uti lizzato per i n d ica r e il pro l ungamento del peri odo di conservazione d i emocornponenL i media n te congela m ento.
L e emaz ie concentrate a ll o s t alo l iquido possono essere attual mente conserYate per un perio d o mass i mo di 42 giun1 i i n un a so l uz ione additi\'a-conse r va n te idonea (SAG-M).
C ~kd Mii. 1007: 157(1
Key words : Re d b loo d ce lls , c ry opre ser vation , s to rage temperature , g lyce rol , g lyce rolizati o n , d eglyceroli zation , clo s ed sys tem.
Il conge lameuto di questo emocomponente conseme d i pro l ungarne il periodo di conservazione fino ad un m assimo di dieci anni, così come previsto dal decreto "Caratteristiche e modali tà per la don azio n e del sangue e di emocomponenti" de l 3 m arzo 2005.
Il primo daro r e l ativo a ll a possibilità di conge lare le emazie co n centrate e co n temporaneamente preser,·arle dai danni i ndo u i dal congelamento si può far
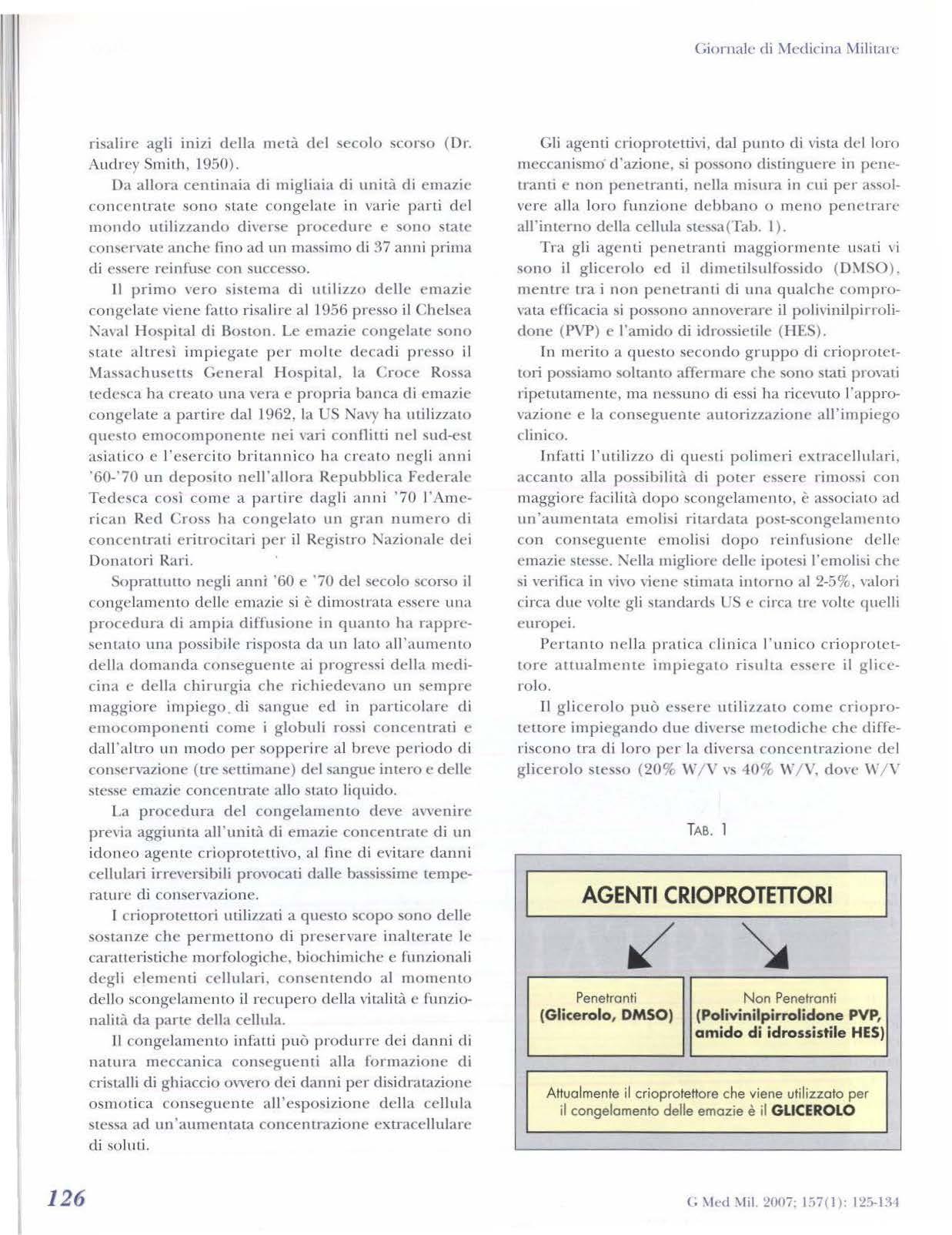
risalire agli inizi della metà del secolo scorso (Dr. Audrey Smith , 1950).
Da allora centinaia di migliaia di unità di cma1ie conccnLratc· sono state congelate in varie parti elc i mondo utilillanclo diver~e procedure e souo state comervaw anche fino ad 1111 rna.~simo cli 37 anui p1ima di essere reinfusc con successo.
li primo ,·ero sistema di utiliao delle emazie congt'late viene fatto risa I i re al 1956 presso il Chelsea 1'\a,·al Hospital di Boston. Le emaLie congelate sono state altresì impiegate per molte decadi presso il Mas,;achusetts Generai Hospital. la Croce Rossa tedei.ca ha creato una vera e propria banca di emazie congelate a partire dal 1962, la US NaYy ha utilizzato questo emocomponente nei rnri conflitti nel sud-est asia1ico e l'esercito britannico ha creato negli anni '60-'70 un deposito nell'allora Repubblica Federale Tedesca co~ì come a partire dagli anni '70 l'Amcrican Red Cross ha congelato un gran numero cli concenn-ati eritrocitari per il Registro Nazionale dei Donatori Rari.
Soprauuno negli anni '60 e ·70 del \ecolo scorso il congelamento delle emaLie si è dimostrata essere una procedura di ampia diffmione in quanto ha rappn:senta10 una possibile risposta da un lato all'aumento della domanda consegu('nte ai progressi della medicina e della chirurgia che richiedevano un sempre maggiore impiego di st1ngue ed in particolare di emocomponenti come i globuli ro..,;.i concentrati e dall'altro u11 modo per sopperire a l breve periodo di coni.en-azione (tre settimane) del sangue intero e delle stesse emaLie concentrate allo stato liquido.
La procedura del congelamento deve awenirc pre,ia aggiunta all'unità cli ema1ie concentrate di un idoneo agente crioprotettivo, al fine di evitare danni cellula,i irre,crsibili prmocati dalle bassissime temperawn: di conserva1ione.
I crioprotcttori utili71ati a quc~to scopo sono delle sostanze che permettono cli preser\'are inalterate le cara11eristiche morfologiche, bioc h imiche e fu111ionali degli elementi cellulari, consentendo al momenw de ll o scongelamento il recupero della vitalità e funlionalità da pane della cellula.
li congelamento infatti può produrre dei danni di nawra meccanica conseguenti alla forma,ionc di cristalli di ghiaccio o,·wro dei danni per disidrataLione osmotica conseguente all'esposizione della cellula stessa ad un 'aumentata concentrnzione extracellulare di soluti.
Gli agenri c,ioprotcttivi, dal punto di vista del loro meccanismo d'azione, si possono distinguere in penetranti e non pcnecr.mri, nella mbura in cui per assolvere alla lor<> funzione debbano o meno penetrare aJl'interno della cellula stc:-.sa(Tab. I ).
Tra gli agenti penetranti maggiormente us,1ti vi sono il glicerolo ed il dimetihulfossiclo ( DMSO ). mentre tra i non penetrami di una qualche comprovata efficacia si posso110 annoverare il poli,inilpirrolidone ( P\'P) e l'amido di iclrossietilc (JIES).
Jn merito a questo secondo gruppo di crioprotcrtori posi.iamo ~oltanto affermare che sono stati prn,-a.ti ripetutamente, ma nessuno di essi ha ricevuto l'appro, ·azionc e la conseguente autoriua1ionc all'impiego clinico.
I nfatti l'utiliuo di qucs1i polimeri extracellulari, accanto alla possibilità di poter essere rimossi con maggiore faci lità dopo scongelamento, è associa10 ad un'aumentata emoli-,i ritardata post-scongelamento con conseguente emolisi dopo reinfusione delle cma1ie stesse. Nella migliore delle ipotesi l'emoli'>i che si verifica in \'i\'o \iene stimata intorno al 2-5%. valori circa due volte gli stanclards US e circa li"<' volte quelli europei.
Pertanto nella pratica cl i nica l'unico crioprntetcore auualmente impiegato risulta es\crc il glicerolo.
Il glicero lo può essere utiliuato come crioprotcttore impiegando due dhcrse metodiche che differiscono tra di loro per la diversa concentrazione del glicerolo stes~o (20% W/ V ,s -10% \\·; v, don- \\' / \ '
TAB. 1
Pene tranti (Glicerolo, DMSO) Non Penetranti (Polivinilpirrolidone PVP, amido di idrossistile HES)
Att ua lmente i l c rioprote ttore che viene uti lizza to per i l congelamento delle emazie è il GLICEROLO
esprime il rapporto peso / volume), per le diverse temperature di conge lamento e conserva7.ione (in azoto liqui do a -L 97 ° C e conservazione a -150 °C con rapida velocità d i conge lamento , ·s in conge l atore meccanico a -80 °C e lenta velocità cli congelamento) m en t re en t rambe le metodiche prevedono un lavaggio post-scongelamento p er ridurre La concentrazione del g li cerolo al di sotto cieli' L% wt/ vol.
In o ltr e il conge l amento in ent r ambe le metodiche deve avven i re il più rapidamente possib il e dopo la g li cero li zzazione delle unità così come la degliceroli:zzazione deve essere effeuuata a brevissi ma dist.anza di tempo chùlo sconge l amento e questo perché il glicerolo interferisce con il metabolismo delle emazie conservate a ll o stato li q uid o (Tab. 2).
Il congelamento del le unità di emaz i e concentrate deve avvenire al massimo entro sette g iorni dalla r acco lta per evitare che la funzionalità di queste ce llul e possa risentire de ll a aumentata conservazione allo stato liquid o. In fatti le emazie concentrate conservate allo stato liqu ido, che possono essere attualmente conservate in SAC-M fino ad u11 massimo di 42 giorn i, vanno incontro durante questo periodo act alcu n e modificaLioni ce llulari , biochimiche e metaboliche. so l o in parte reversib ili. InnanzitutLO la vitalità della maggior parte degli er it rociti, con gli atlllali metodi di conserva7ione, viene mantenuta per le prime due settimane e a l limite della scadenza (se i settimane) una note-
TAB. 2
Velocità di congelamento
Troppo alta (Cr istallizzazione)
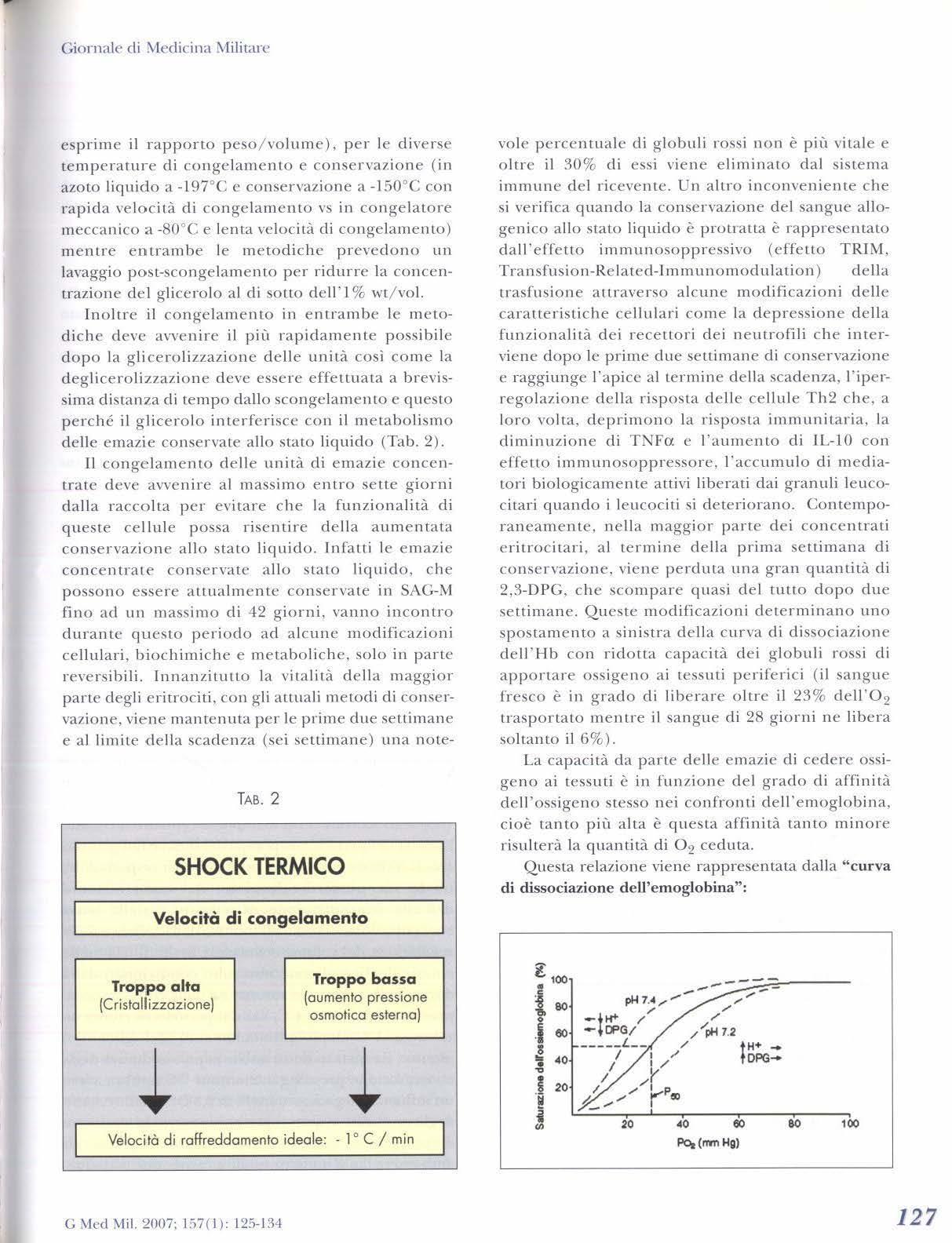
Troppo bassa (aumento pressione osmotica esterna)
Velocità di ra ffreddamento ideale: - I ° C / min
vo l e percentuale cli globuli rossi non è più vitale e oltre il 30% di essi viene e l iminato dal sistema immune del ricevente. Un altro inconveniente che si verifica quando la conscrvaLione del sangue allogenico allo stato liquid o è protratta è rappreseutaLO dall'effetto immunosoppressivo (effello TRIM, Transfusion-Related-lmmunomodulation) della trasfusione attraverso alcune modificazioni delle caratteris ti che cellu lar i come la depressione della fuuzionalità dei recettori dei neur.rofili che interviene dopo le prime due settimane di conservazione e raggiunge l' apice a l termine della scadenza, l'iperregolazione della risposta delle cellule Th2 che, a loro volta, deprimono la risposta immunitaria, la diminuzione di TNFa e l'aurnenlo di LL-10 con effellO immunosoppressore, l'accumulo di mediaLori biologicamente attivi liberati dai granuli leucocitari quando i leucociti si deteriorano. Contemporaneamente, nella maggior parte dei concentrati critrocitari, al termine della prima settimana di conscrvaziouc, viene perduta una gran quantità di 2,3-DPG , che scompare quasi del tutro dopo due settimane. Queste modificazioni determinano uno spostamento a sin istra della curva di dissociazione dell ' Hb con r id otta capacità dei globuli rossi cli apportare ossigeno ai tessuti periferici ( il sangue fresco è in grado di liberare oltre il 23% dell'O 2 trasportato mentre il sangue di 28 giorni ne libera soltanto il 6%).
La capacità da parte delle emazie cli cedere ossigeno ai tessuti è in funzione del grado di affinità dell ' ossigeno stesso nei confronti dell'emoglobina. cioè tanto più alta è questa affinità tanto minore risu lt erà la quantità di 0 2 ceduta.
Questa relazione viene rappresentata dalla "cur va di dissociazion e de ll'emoglo bina":
Come è pmsibile vedere- dalla figura sono ~oprattuuo lt1 conn·ntruium: degli ioni idrogeno (1-1+ ossia il p i I) e la concemraLionc del 2,3-difosfoglicerato (2,3DPC ) ad inf1uen1a1·c tale cur\'a e quindi la capacità di ce~sio11e dell'o<;sigcno ai 1e~~uti da pane del sangue (Tab. 3).
Il 2.3-DPG lega in maniera specilica l'emoglobina riducendone l'affinità per l'ossigeno.
Da ciò ne deriva che l'affinità delle emazie per l'ossigeno dimi11uiKe quando aumenta il loro contcn11to in 2,3-DPG e vice,ersa aumenta se la concentra1ione di 2,3-DPG diminuisce. All'a11menta1e del periodo di conservazione delle emazie concen1ra1e allo stato liquido vi è un decremento del 2.3-DPG che pro\'oca la progrcssi\'a diminuzione nella capacità di cedere ossigeno da pane dei globuli rossi.
li decremento della co11ce11tra1.ione di 2,3-DPG è direttamente propor1ionalc alla durarn della conser\·a1io11e allo stato liquido, <.: da ciò deri,·a la necc~~ità cli congelare le cma1ie nel più bre,e tempo pmsibile dalla loro raccolta e prep~trazionc al line di avere al momento dello scongélamento la reinfusiouc di ema,ie con la maggiore concentrnLione possibile di 2,3-DPG, pur tenendo conto che doro reinfusione il 2,3-DPG tende ad aumentare di nuovo per ritornare ai Yaloii inii'iali dopo più di una seuimana. A tale propo~ito è possibile calcolare la capacità delle emazie di cedere ossigeno mediante la segueme equa1ionc:
y = 0.34x + 3.5
dove y è la caµacità di cessione dell'ossigeno espressa com(:' ml di 0 2 per 100 ml di sangue ex la concentrazione del 2,3-DPG all'interno delle ('111aLie espressa in µmol/gllb.
TAB. 3
Il 2, 3 • DPG (2,3 di fosfoglicerato) lega in mani era speci fica l' HB ri ducendone l'affini tà per 1'0 2
ft [ 2, 3 - DPG ] ....-. - i affinità per 1 ' 0 2 dei
GR
i [ 2,3 · DPG] emu1e - ft affinità per 1 ' 0 2 dei
GR

Da quanto sopra si può dedurre che. indipendente-mente dalla durata della loro conservaLiouc. è possibile ottenere globuli rossi con una maggiore capacità cli cessione dell'ossigeno modificando il loro contenuto in 2.'.~DPG.
Oltre alla capacità di cedere ossigeno, un altro imponante fattore da prendere in considera,ione per Yalutare l'efficacia trasfusionale l· rappresentato dalla sopravvive11La posl-lrnsf11sionaJe del sangue consen·ato cd in particolare, come indice pratico. la sopravvive111a post-trasfusionale a 24 ore. Questo indice è pari al 90%. o superiore in seh11.1ito a trnsfmioni di sangue fresco, dove co11 ciò si intende che dopo ~4 ore dallt1 trasfusione sono ancora in circo lo il 90% o più delle emazie fresche inruse. ma il ,alore di tale indice tende a diminuire con l'aumentare della durata della consen·a1.io11e, ma deve comunque essete> 70% per tutta la durara del periodo di 1empo in cui le ema,ie stesse possono C'>SCre conscn·ate. inoltre la soprawi\·enLa post-trasfu,;ionale i.· eia mellcrc in relaLionc con il co ntenuto cli ATP elci globuli rossi, anche se questa correluiont' non è cmì importante quamo quella u·a la capacità di cedere ossigeno e il contenuto in 2.3DPG, con la consegucnLa che la sopravviwnLa posttrasfusionale non pu<> essere aumentata !,emplicerncnte aumentando l'ATP cellulare. L'e,cncuale carenza di ATP si ripercuote con c·ffetti negativi sulla funzionalità delle emazie poiché determina un'aumentata rigidità della membrana cellulare e diminuita deformabilità, en~nti questi che pro\'ocano una diminuita vitalità delle emazie. lnfaui l'ATP fornisce l'e nergia per il trasporto attivo cli cationi monovalenti (Na+ e K+) attraverso la membrana cellulare mediante l'aLione della cosiddetta pompa del sodio e del potassio (Na,K-ATPa,i), un e111ima di membrana responsabile, tra le sue numero!>c fnnzioni, del mantenimemo dell'alta conrenu·azione di potassio e della ba!>sa concentr.vione di sodio all' i nterno della cellula e della regolaLio1w del volume cellulare. I livelli di ATP nelle emazie deglicerolizzate non sono condizionati dalla durata della crioconser\'azione né dalla conscr\'azione pre-congt>lamento a 4 C, ma dal periodo di conservalione a 4 C dopo allontanamc11to del glicerolo, rncmre , da quanto dello anche sopra, la durata della conserYuione pre-congelamento a 4 ° C sembra aYerc un'innuen,a negativa ~ui li\elli cli 2,3-DPG delle emuie dcgliceroliizate e quindi per poter avere un optimum di recupero del 2,3-DPC, l'imer\'allo pre-congelamemo de\'e essere il più bre,e possibile e co munque mai supe-
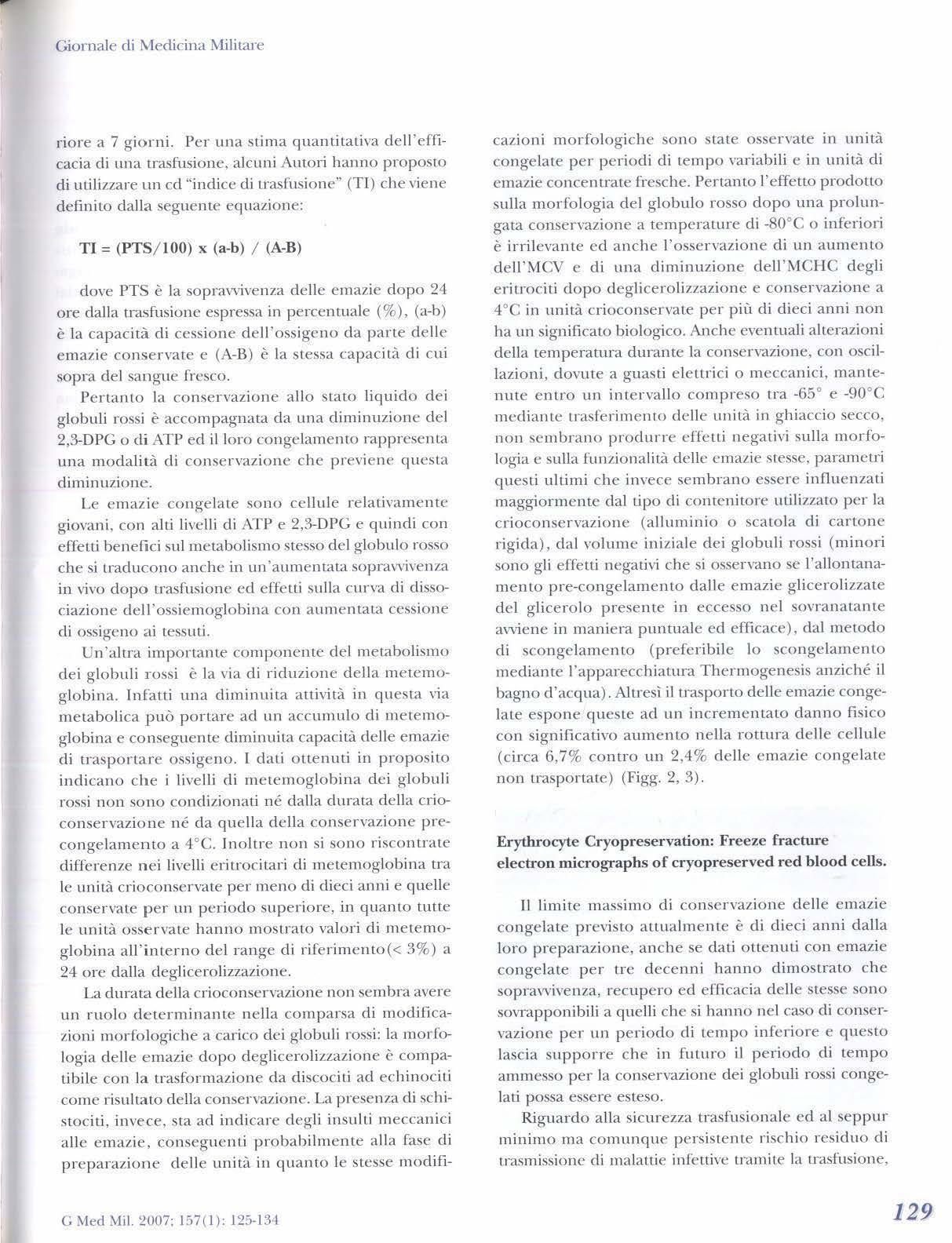
riore a 7 giorni. Per una stima quantitativa dell ' eflicacia di una trasfusione, alcuni Amori hanno proposto di milizzare un cd "indice di trasfusione" (TI ) che viene definito dalla seguente equazione:
TI= (PTS / 100) x (a-b) / (A-B)
dove PTS è la soprav,;ivenza delle emazie dopo 24 ore dalla trasfusione espressa in percentuale (%), (a-b) è la capacità di cessione dell'ossigeno da parte delle emazie conservate e (A-B) è la stessa capacità cli cui sopra del sangue fresco.
P ertan to l a conservazione a ll o stato liquido dei g l obuli rossi è accompagnata da una diminuzione del 2,3-DPG o di ATP ed il loro congelamento rappresenta una modalità di conservazione che previene questa diminuzione.
L e emazie congelate sono ce llul e relativamente giova ni , con alti li velli di ATP e 2,~-D PG e quindi con effetti bene(ìci sul metabolismo stesso del globulo rosso che si traducono anche in un 'aunwntata sopravvivenza i n vivo dopo trasfusione ed effetti su ll a curva di dissociazione dell'ossiemoglobina con aumentata cessione di ossigeno ai tessuti.
Un ' altra importante componente del metabolismo dei g l olm li rossi è la via cli riduzioue della metemoglobina. Infatti una diminuita a t tività in quesra , fa metabolica può portare ad un accumulo di metemog l ob ina e conseguente diminuita capacità delle emazie di trasportare ossigeno. I daLi ottenuti in proposito indicano che i livelli di metemoglobina dei globu li rossi non sono condiz ionati né dalla durata della crioconservazion e né da quella della conservazione preconge l ament0 a 4 ° C Jn o l tre non si sono riscontrate differenze nei live lli eritrocitari di metemoglobina tra le uni tà crioco n servate per meno di dieci ann i e quelle conservate per un peri odo super iore , in quanw tutte le unità osservate hanno mostrato va l ori di metemog l ob in a a ll'in terno del range di riferimento(< 3%) a 24 ore dalla deglicerolizzazione.
La durata della cr ioconsenaLione n on sembra avere un ruolo determinante n e lla comparsa di rnodilicaz ioni morfologiche a car ico dei globu li ross i: la morfologia delle emazie dopo deglicerolizzazione è com p atibile co n la trasformazione da d iscoci ti ad ec hin ociti come risultato della conservaz ione L a presem a dischistoci li , invece, s ra ad indicare degli insulti m ecca ni ci alle emazie, conseguenti probabilmente al l a fase cli preparazione delle unità in quanto l e stesse modifi-
cazioni morfologiche sono stare osservate in unita congelate per periodi di tempo rnr i abili e in unità di emazie concentrate fresche. Pertanto l'effetto prodotto sulla morfologia del g l obulo rosso dopo una prolungata conservazione a tempcralllre di -SOOC o inferiori è irrile vante ed anche l'osservazione di un aumento dell'MCV e cli una diminuzione dell'MCIIC degli eriLrociti dopo deglicerolizzazione e conservazione a 4 ° C in unità criocon.servate per più di dieci anni non ha un sign ificato biologico. Anche eventuali alLerazioni della temperatura durante la conservazione, con oscilla zioni, dovute a guasLi elettrici o meccanici, ma n tenute entro un in tervallo compreso tra -65 ° e -90 ° C mec.lia11te trasferimento delle unità in ghiaccio secco. non sembrano produrre effetti negatiYi sulla morfologia e su lla funzionalità d elle emaz i e stesse, parametri questi ultimi che invece sembrano essere inC111enzati maggiormente dal tipo di contenitore utilizzato per la crioconservazione (allumin io o scawla di cartone rigida), dal vo lume iniziale dei g l obuli rossi (minori sono gli effetti negativi che si osservano se l'allontanamenw pre-congelarnenLO dalle emaz i e g li cero li zzate dd g li cerolo preseme in eccesso nel sovrana.tante avviene in maniera puntuale ed efficace), dal metodo di scongelamento (preferibi l e lo scongelamento med i ante l'apparecchiatura Thermogenesis anzi ché il bag n o d'acqua). Altresì il trasporto delle ema?.ie congelate espone queste ad un incrementato danno fisico con significativo aumenLo n e ll a rottura delle cellul e (circa 6,7 % contro un 2,4 % delle emaz ie congelate non trasportate) (Figg . 2, 3).
Erythrocyte Cryopreservation: Freezc fracture e lectron micrographs of cryopreserved re d b lood cells.
Il limite m assimo di conservaz ione delle ematie conge late previsto attua l mente è di dieci an ni dalla loro preparazione, anche se dati ottenuti con emazi e conge late per tre decenni h anno dimo strato ch e sopravvivenza, recupero ed efficac ia delle stesse sono sovrapponibili a quelli che si hanno nel caso di conservazione per un periodo di Lempo inferiore e qnesto lascia s upporre c h e in futuro il periodo di tempo ammesso per l a conse r vazion e dei globuli ross i congelati possa essere esteso.
Ri guardo alla s icurezza trasfusio n a le ed a l seppur minimo ma comunq u <" pers istente rischio residuo di tra~missionc di malattie infettive tramite la Lrasfusione ,
Fìg 2
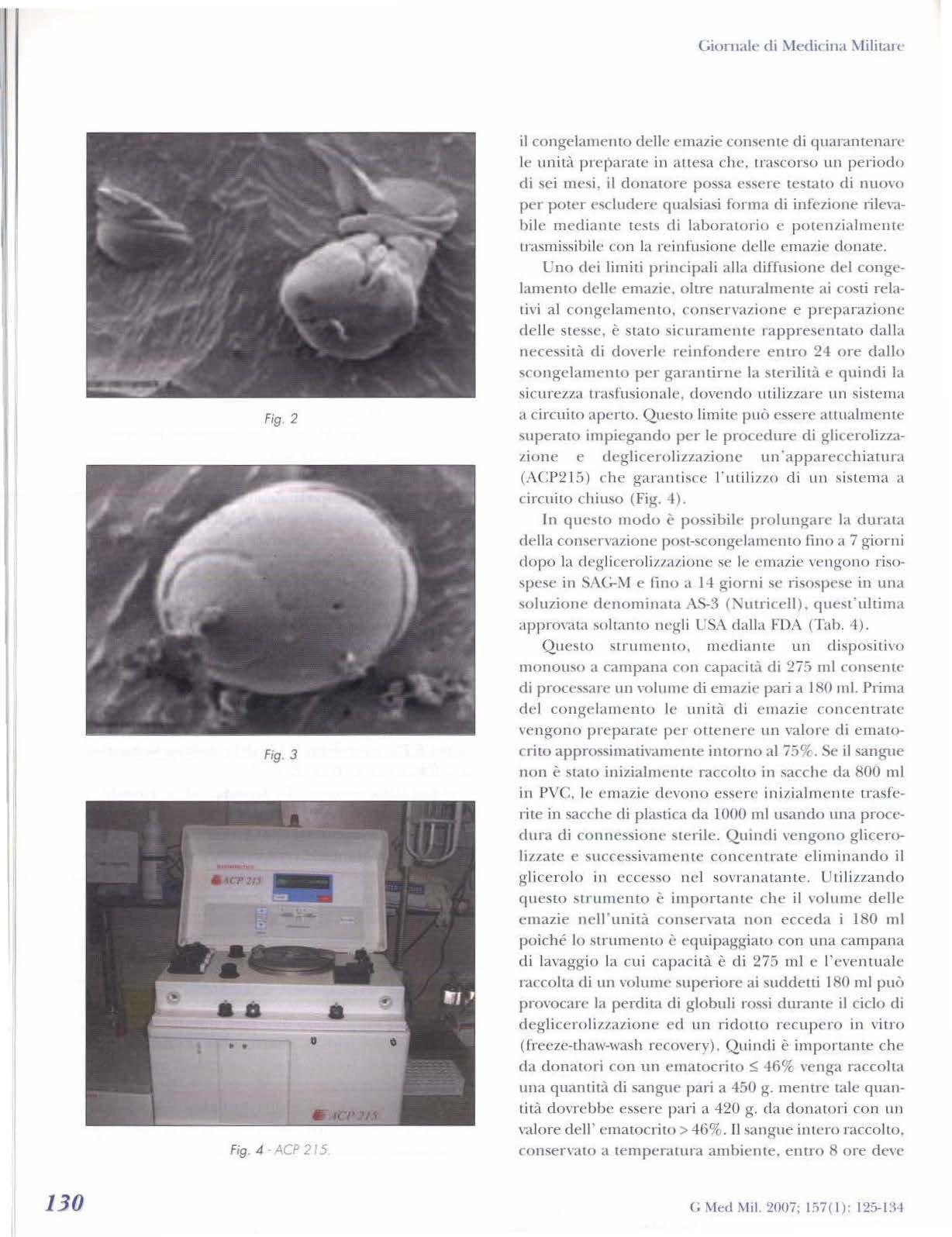
Fìg 3
il congelamento delle emazie comente di quarantenarc le unità pr<'f>arate in attesa cli('. tr.:i~ corso un periodo di se i mc,i, il donatore pos.sa t->~,C're testato di nuovo pe1· poter e~cluden' qua lsiasi forma di infc,ione 1ik,,1bilc mediante tcsts di laboratorio e pcnen1ialmclltt' trasmi ssibile co n la rei11fusione d elle cma,ie donate. Uno dei limiti principali alla diffusione ciel congelamento delle ema,ie. oltre naturnlmente ai cmti rt"lativi al co n ge lamento, ,onserva,.ione e prcparazìonl' delle stesse, è stato sicuramente rappresentato dalla necessità di doverle reinfoudne entro 21 ore dallo <;congelamento per g,uantinw la sterilità e quindi la sicurezza tra<;fusio11ale, dovendo utilizzare 1111 sistema a circuito aperto. Questo limi te può essere auualmcntt' ,uperaro impiegando per le procedure di gliccroJiu.aLione e deglicerolin.a1ionc un 'appa i ccchiatura (ACP2I 5) che garantis,e l'utiliao di u11 siste m a a circuito chiuso (fig. I).
In que,10 modo è possibile prolungan· la durata rlella conservazione pmt-scong-elamento fino a 7 giorni dopo la dc-gliccroli1.1a1ionc se le emazie vengono riso!>pcsc in SAG-;\[ e finù a 14 giorni se riso~pese in una soluzione denominata ..\S-3 (~urricell). quest'ultima apprm-ata so ltanto negli L:SA dalla FDA (Tab. 4). Questo s1rumc11to, mediante un di~positi\u monou,o a campana con cap<tcità di 275 ml çonsente cli proccs"1re un rn l11m e di cmatit' pari a 180 ml. P,ima del congelamento le unità di emazie roncen tratc> vengono preparare µ<:r ottenere un rnlore di cmatociito appros:,,imati,amente incorno al 75%. Se il ~angue non è s tato inizialmente raccolto in sacche da 800 ml in PVC, le emazie devono essnc inizialmente I rasferite in sacche di plastirn da 1000 ml usando una procedura di connessione sterile. Qu111di , engono glicerol11nte e successivamente concentrate e limin ando il g licerolo in eccesso nel sovranatante. Uti liaando questo ~trumento è i111ponantc che il volume delle emazie nell'unità co11serYa ta non ecceda i 180 ml poiché lo strumento è c-quipaggiato con una ca mpan a cli laYaggio la cui capac ità è di 275 ml e l'ev entuale raccolta di un \'Olumt• superiore ai ~uddctti 180 ml può prorncare la perdita di globuli rossi duranH· il ciclo di degliccrolit.1.aLiune ecl un ridouo recupero in vitro (freezc-thaw-wash recovery). Quindi è importante che da donatori con un ematocrito:;; 16~ \'enga raccolta 1111a qnantità di sangue pari a 450 g. mentre tale quantità dovrebbe essere pari a 420 g. da donatori con un valore del!' cmatoc1ito > 46%. Il ~angue intero raccolto. consen·ato a temperatura ambiente, entro 8 ore deYc
essere uùliuaLo per preparare il concentrato eriLTocitario. [I concentrato eritrocitario \'iene quindi trasferito sterilmente nella sacca di plastica da 1000 ml e a sua vo lta connesso sterilmente al kit monouso per la gliccrolizzazioue, dopodiché l'apparecchialura. provvista di un software dedicato provvede ad aggiungere i l glicerolo alle emazie concentrate. Dopo la glicerolizzazi.one, le emazie vengono co11cenLrare per ottenere un cmalocrit.o elci 60 ± 5 V% mediante centrifugazione. Se si impiega una sacca da 1000 ml occorre connettere ste1ilmen te ad essa una sacca di rrasferimento da 600 ml dove far defluire il glicerolo in eccesso presente ne l sovranaLante dopo l'ultima centrifugazione. Quindi le emazie vengono immediatamente congelale e trattandosi di 11n sistema che utilizza una concentrazione di glicerolo al 40 % (W/ V) ciò avviene in un congelatore meccanico a -80 ° C (Figg. 5, 6).
Al momenlo dell'eventuale impiego le unità devono essere dapprima scongelate in un ' apparecchiarura idonea per lo scongelameuLo del plasma (36 ° C per 35 ' ) e verilìcando al termine dello scongelamento che la tempera tuta. di superficie sia compresa tra 30 e 34°C. A questo punto, sempre urilizzando l'ACP215 ed un relativo kil monouso, l ' unilà viene deglicerolizzala e risospesa in idonea soluzione additiva-conservante.
Tutte le unità degliccrolizzare devono essere attcnlamente ispezionate per valutare l'eventuale grado di emolisi. Per ,-.1Iut.are il grado di emolisi si utilizza un'apposita card che consente cli comparare il colore della soluzione efflnente con una scala colorimetrica e di valutare l'accertabi lità del grado di emo lisi . Un ' cmolis i eccessiva si può verificare per lesioni avvenute durante la g licerolizzazione, rlurame il congelamento-sconge lamento (shock termico) o durante la procedura di lavaggio. fn alcuni. casi, allorché il laYaggio , iene effettuato con centrifugazione a flusso continuo , si può osservare il passaggio di emazie intatte nella linea effluente dei rifiuti (spi l lage) ed il co lore ciel liquido emuente è francamente rosso mentre in caso di. emo lisi è di una tinta più rosea. Lo spillage è un evento dovuto principalmenle alla presenza di troppi g lobuli rossi nell ' unità al momento della glicerolizzazione. Tutte l e unità deglic:erolizzate devono avere una concentrazione fina le di glicernlo inferiore all'l % in quanto se le emazie scongelate venissero rcinfuse in presenza di una concentrazione di glicerolo superiore al suddeuo valore (osmo l alità di c i rca 500 mOsm) po trebbero andare incontro ad una lisi osmotica in vivo una volt.a a contatto con il plasma in quanto la velocità di passaggio trans-
TAB. 4
Comparison of Manual Deglyceroli:z:ation to ACP 21 5 with Additive Solutions
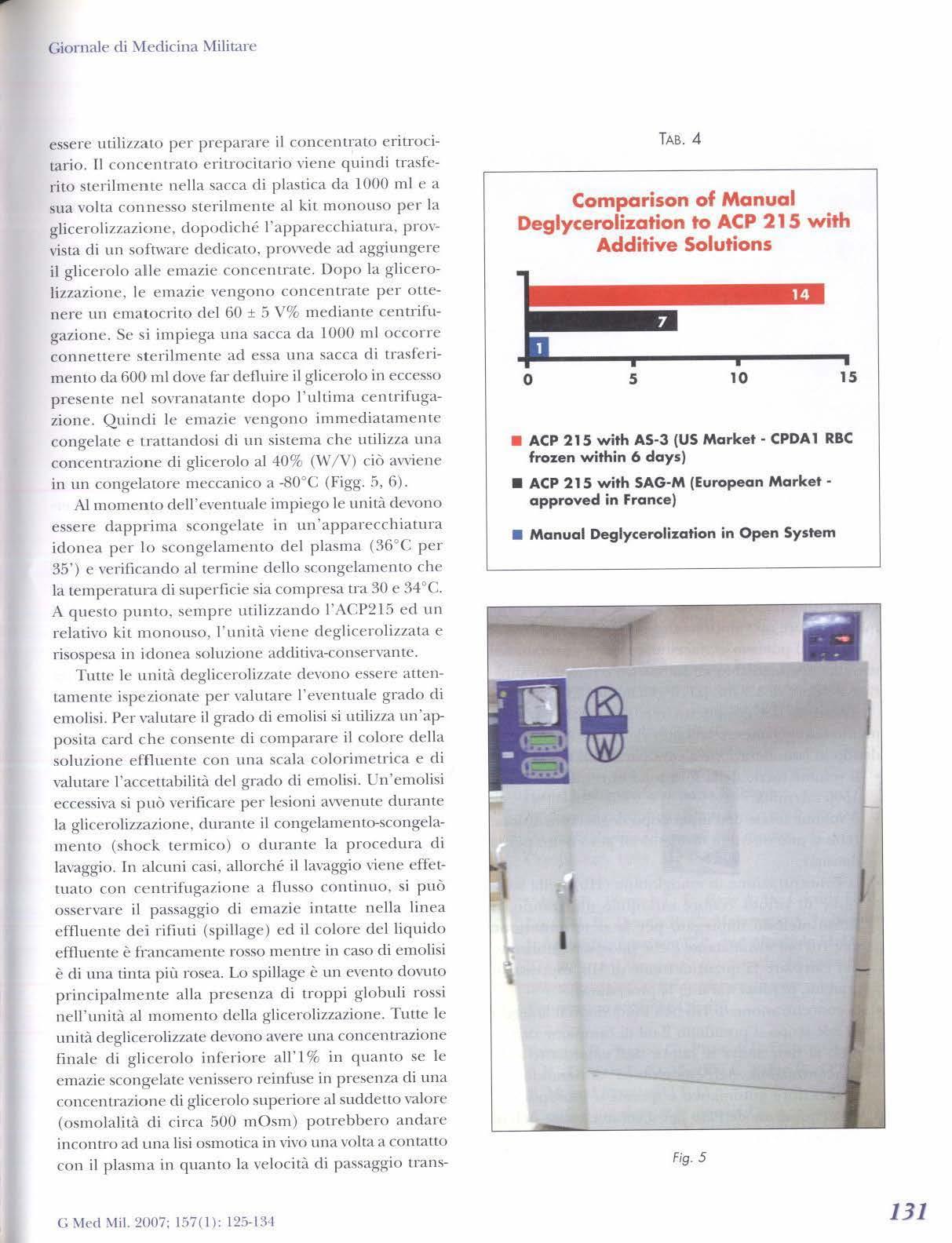
o 5 10 15
ACP 215 with AS-3 (US Market - CPDA 1 RBC frozen within 6 days)
ACP 21 S with SAG-M (European Marke tapproved in France)
Manual Deglyc e rolization in Open System
fig. 5
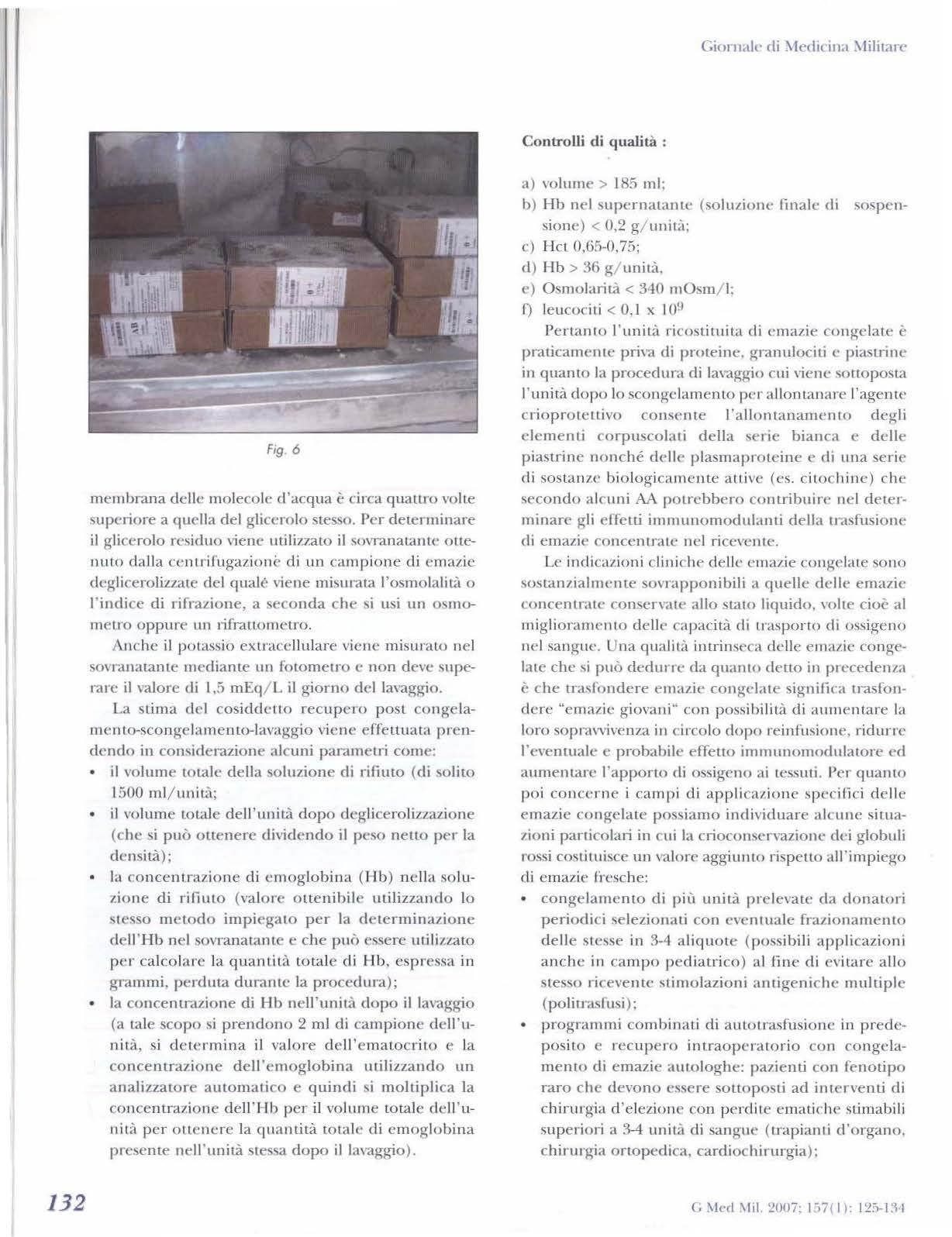
Fig 6
membrana delle molecole d'acqua è circa quattro volte superiore a quella del glicerolo stesso. Per determinare il glicerolo residuo viene utilizzaLO il sovranataJJt<' ouenuto dalla centrifugazione> di un campione di (•mazic dcglicerolizzate ciel qual(' viene misurata l'osmolalità o l'indice di rifratione, a seconda che si usi un osmometro oppure un 1;f,,1ttometro.
Anche il pota ~sio extrace llul are viene misurato nel smranatame mediante un fmomeu-o e non deve superare il valore cli 1,5 mEq / L il giorno del la\'aggio.
La stima ciel cosidde110 recupero post congclamc11to-scongelameuto-lavaggio viene effeuuata prendendo in considerazione alcuni parametri come:
• il volumt' totale della soluzione cli rifiuto (di solito 1500 ml/unità;
• il vo lume toutle dell'unità dopo degliceroliua1ione (che si può ottenere dividendo il peso nello per la densità);
• la conccntratione di emoglobina (flb) nella sol utione di rifiuLO (Yalore ottenibile utilizzando lo stesso metodo imp iega to per la determina,ione dell'Hb nel sovranatame e che può essere 11tili1Lato per calco lare la quantità totale di Hb. esp r essa in grammi, perduta durante la procedura);
• la concentnuione di Hb nell'unità dopo il lavaggio (a La.le scopo si prendono 2 ml di campione dell'unirà, si determina il va lore dcll'C'matocrito e la concentrazione dell'emoglobina utilizzando un analizzatore automatico e quindi si moltiplica la concentrazione dell'Hb per il volume LOtale dell'unità per ottenere la quantità totale di emoglobina pre~cnte nell'unità ~tessa dopo il la,-agE,,io).
Controlli di qualità :
a) volume> 185 ml; b) Hb nel ~upernatante (soluLione finale di sospensione)< 0,2 g/unità: e) I lct 0,65-0, 75; cl) Hb > :{6 g / unità, e) Osmolaricà < 340 mOsm / 1; I) leucociti < O.I x I()!I
Pertanto l'unità ricostituita di ema7ie co ngelate è praticameme priva di proteine, granulociti e piastrine in quanto la proceclurn di lavaggio cui ,iene -;ottoposta l'unità dopo lo scongelamento p<'r a llonta11 arC' l'agente crioproteuivo co11scnce l'allontanamc11ro degli clementi corpuscolati della serie bianca e dcllt> piastrine nonché d('lle plasmaprotcine e di una serie cii sostanze biologicamente attive (es. citochine) d1e ~econdo alcuni AA potrebbero cont ribuire nel determinare gli effetti immunomodulanti della trasfusione cli emaLie co ncentrate nel ricevc!llc.
Le indic azioni cliniche delle emazie co11gcla1e s0110 ~mtan7ialmente sovrapponibili a quelle delle emaLie co ncentrnte consen·ate allo stato liquido, , olle cioè al miglioramento delle capacità di trasporto di ossigeno nel sangue. Una qualità intrinseca delle ema,,:ic congelate che '>i può dedurre da quanto eletto in prcceden,a è che trasfondere emazie congelate significa trasfondere "errn\lie giovani con possibilità di aumentare la loro sopravvivenza i11 circolo dopo reinfusione. ridu r re l'c\'entualc e probabile effetto immunomod11latore ed aumema1e l'apporto di ossigeno ai tessuti Per quanto poi concerne i campi di applicazione specifici delle emazie congelate possiamo individuare alcune si 1ua1ioni particolari in cui la crioconscn·azione dei globuli rossi costituisce un valore aggiunw rispetto all'impiego di emazie fresche:
• congelamento di più unità prelevate eia donatori periodici selezionati con eventuale fr.uionamento delle stesse in 3-4 aliquote (possibili applicazioni anche in campo pediatrico) al fine di evit.are allo stesso ricevente stimolazioni antigeniche multiple ( politrasfusi);
• programmi combinati di autolrasfusione in predcposito e recupero inrraopcratorio con congelamento di emazie auto loghe: pa1ienti con fenotipo raro che de\'ono essere sottoposti ad interventi di chirurgia d 'e lezione con perdite ematiche stimabili superiori a 3-4 unità di sangue (trapiant i d'organo. chirurgia onopedica, cardiochirurgia):

• conge lam ento di glob11 li rossi di gruppo e fp110tipo raro per i vari s is t e mi antigenici ( Kl'll , si~tcma Rh, .Jka e .Jkh, ~\" e f yb. <;istema '.\1nS\, ema,ie O Rh null-O-, U-, Yt-. Vcl-,. ) con p os\ibi li tà di crear<' 1111 registro di ema,ic rare congela r<' al quale i vari Centr i Trasfusionali possano acrt>clC'rc in 01!.0 di necessità;
• cfo,ponibilità di unità pt>r pazienti poliimmuniznti e/o cli fenotipo raro con cons('guence abbrevia1. ion e della iicet"Ca di unità compaLi bili;
• tipi11aLione "isrematica di llllli i donaco,i pe1iodici, ini1ialmeme di gruppo O, pt•r rutti gli antigeni per i cpia l i esistano a ntisie1i tipinami sia di tipo commt·rciale che "wiltf' (banca di \angue congelato);
• di~ponibilità di ,,anguP di gruppo raro (es. O negativo) in situazioni di enwrgen1.a in cui '>i verifichi la necessilà cli nrilinare ciel sangue a front<' <li richiC'st.c che L'cceclano la disponibilità di ~angue frC'~co (t>n1.11.ic concentrate) (cata'>U-ofi 11at11rali. periodi cli carenza fisiologica delle unità donate, ecc ). Qu('Sta mate, ia è regolala dalla lcggt' 2 1 ottobre 200:1 n. 219 (C.U. del 27 ottobre 200!)) ";\uo,,1. di~ciplina delle ani,ità tra!,fmio11,1li e della produzione nazio11all' degli cmoderirnti"' che al capo II. art. 5, comma I così recita: 'fra i servù.i f IP pre11<nio11i eiogn/1 dalle stru/111/f' del Sen,hio s·anilario .\"a::.iona/P in rappo,to allP spm/id1e rnmpPten:P disriplma11 vi;, anclw la gestio111' di una brinw di srm[.;lll' rongelalo l nohre gli aru. J I e 24 della suddeLta lq.me preYedono il primo l'in<;taimvionc di rapporti a livello regionale tra il SS~ t' la Sanità t\ l ilitare mc-diante conwn1.ioni t>d il secondo la coopcr.v. ione del S<>1 \'izio Tra~rusionale Militare con lt' struuure stesse del SSN. ciel '.\tinistero dell' Interno e dt>I D ipartimento della Prote1io11e Ci,i lP, con lo scopo cli a-.sicurare, in rappono a lle preYisioni dellt> 11<:CC!r sità tr,tsf"usionali pc, le si tuaz ioni cli e mergc·111.a, il mantenimcrno di adeguate scorte di prodotti del s,mgue.
Conclusioni:
A.Ilo '>Lato amia le il sangue umano non i· ,mcora '>O!ltituibile con prodo11i artificiali ~uflicienl{•mcrne validi e pertanto la terapia trasfusionale con sangue omo l ogo, ne ll a magi,rior pane dei casi, non ha alternati,·e. li ricorso all"ainotrasfusione è po!,sihill' soltanto in un num C'ro limi tato e se lezionato di situ.vioni e quindi non può essere corn,ideraro un'alrernatirn valida a ll a u-a.sfmione omolog,1.
1\i giorni no\tri la po,sibilità di conservare unità di ema1.ie concentrate fresche lino acl un massimo di 42 Kiorni meclia11te l'aggiunta cli idonee soluzioni addiliYe e conservami (SACr'.\1 ) ha permesso cli avere a disposi1io11e scorte di cma7ie concentrate in grado di ,oprirc qua~i l'intero fabbisogno, resuing<"ndo i possibili campi di applicaLio,w del congelamento arl csigen,e particolari che rappre~entano ,omunque ambiti non seconclati della moderna mccll('ina trnstusionale.
I noltre la disponibi lità di sisrenii a circuito chiuso per la glicerolinazionc e degliccrolina1ionc <ldle cniaLie concentrate con la possibilità cli esLenclere la conse r vazione post-scongelamento delle unità ben oltre le 24 ore, permelH' cli poter gestire le ~,nne di q11<•,to emocomponent<' con maggiore razionalità e rendere in alcuni casi il congelamento critrocitario un prc,ioso beneficio per il paziente.
I. John H css R. : RPd celi jrl'P'Z.1111( ami i/1 1mpacl 011 lhl' .mpp{, cllflill. I ransfusion Medicint> 2004,H.1-8.
2. Rittmeyer I C., Nyd egger U. E.: fnjluenr, of the rr_)oprotu-tit•e agenti K(,cerol rmd hydro;,.yethyl .1tarci on red blood rrll ,UP and 2, 'Jdi/1lw:.phog/_)·re1ic acid !l•veL1. \·ox Sanguinis 1992,62:141-H5.
3. HiJ"Oshi I s hi guro and Boris Rubinsky: ,\Iechrmiral intrracli1111.1 b1,1ween ice nyltals and l('d blood cel1' dunng dirertumal solidifirnl/011. Cryobioloh': 1994, :~I: '183-500.
4 . ValeriC.R. , Pivac e k L. E., Gray A . O. , Cassidy G. P., Leavy M . E. , Dennis R. C. , Me l aragno A. J., Niehoff J. , YestonN. , Emerso n C.P., and Altschule M . D .: The sajPIJ a11d lhf'mfmtlic efferliven!'!!>\ of lwmm1 red celi:. storrd al -80°(:_for rH long m 21 _)'l'(ffS. Transf11sio11 1989.29: 1~9-437.
5. Valcri C.R., Ragno G., Piva ce k L. E., Srey R. , H ess J. R. , Lipp e rt L. E., Mettille F. , Fahic R. , O'Neill E. M. and Szymanski I. O.: A 111ultiren/e1 studJ oj in vitro a1Ul in vivo vah1P1 111 lwman RBC1 Jì·oun wilh •10-percen/ (wt/vol) glyrnvl and storl'(/ after deg~}remli:.ation Jm 15 da)S al 4 C in
AS-3 : assf!srnuml of lU3C processing in lhf' A(P 215. T ransfusion 2001, 41:933-939.
6. Valeri C. R , Ragno G., Pivacek L. and O 'N e ill E. M .:
In vivo survinal o( nphnesis RBCs Jrozm wilh 40percenl (wt/vol) glyrf'T'ol. dPglyceroliud Ì1l the ACP 215 and stomi al 4°C i11 AS-3 Jor up lo 21 days.
Transfusion 200 L, li :928-932.
7. Vale ri C . R. , Lan e ]. P. , Srey R. and Ragno G.:
Incidrnre of hffalwgf' oj human RBCffrozen wtlh 40perrml wt/vol glyrm1l using lwo differenl mf!lltods /or st.orage at -80 "C.
T rnmfusion 2003.43:41 1-414.
8. Lecak J. , Sc ott K. , Youn g C., H annon J. and Ac k e r J. P.:
Evnluation of red blood celi~ stort'd nl -80°C in fXCW o( 10 yearf.
Transfusion 200,J,44:1306-1313.
9. Vale ri C. R. , G. Ragno , Pivac c k L. E . , Cass idy G . P. , Srey R. , H ansson-Wi c her M. , Leavy M . E. : A11 e:,,·pnimmt with glycnol{roun red blood cl'll~ ~lored nl -80°C jo, 11p lo J 7 )'ftm.
Vox Sani-,ruinis 2000,79: L68-J 7,1,
10. Nao taka Ham~aki , Masaaki Yamam o lo: Red blood celi funrtion ami blood storagl'. \'o>,. Sangui11is 2000,79:191-197.

1 1. Mark Popovsky A. :
Frozn1 and wash~d r('(/ bwod cell\ : nrw aJ1prom h,·\ a11ri apj,liral ions.
Tran~fiL-;ion and Aphere.i.., Science 25 (2001) 19~l ~H
I 2. S tand ard Operating Procedure:
Clycerolizalion and rlfglyrnolizalio11 o( ml hlo11d rell, 111 a do11·d S_)Wl1•111 using thf' Haemonf'lln AC1'21 5 Rroiewf'rl and r1J>prm11,d: R o b e rt Valeri, M.D . Director Na\'al Bloocl Research Lahorato1, Bostou Univcrsity School of medicine
13. Spieles G ., Kre sinM. , L oges K. , S putlck A., Hescb e l I. and Rau G.:
The ej(l'rl of storagf' lnnpnal ure 011 lite ~tabili/ ) oj (mu,1 fl)1throrytes.
Cryobiologt' 1995.:12:366-:ns.
14 . D e Palma L., Palm e r R. , Leitm an S. F., Dol m W. D., Kl e in H. G. : L'liliz.ation Jwllern1 offro::.r,1 aululogom rnl blr d rr/1,. Arch Pathol Lab M<'d Vòl. I H, /\1ay IY90.
15 . De L oeck c r R., Go o sse n s W. , Van Du ppen \., Ve r wil g h e n R and D e Locck er W.:
Osmoli< elfi!( ts of di/ulion 011 rrytltrocyt,,s "/tn/11-n.1111; mzd thawing m g(rrerol-co11tain111g b11f/n Cryobiology 30.279-285 ( 1993).
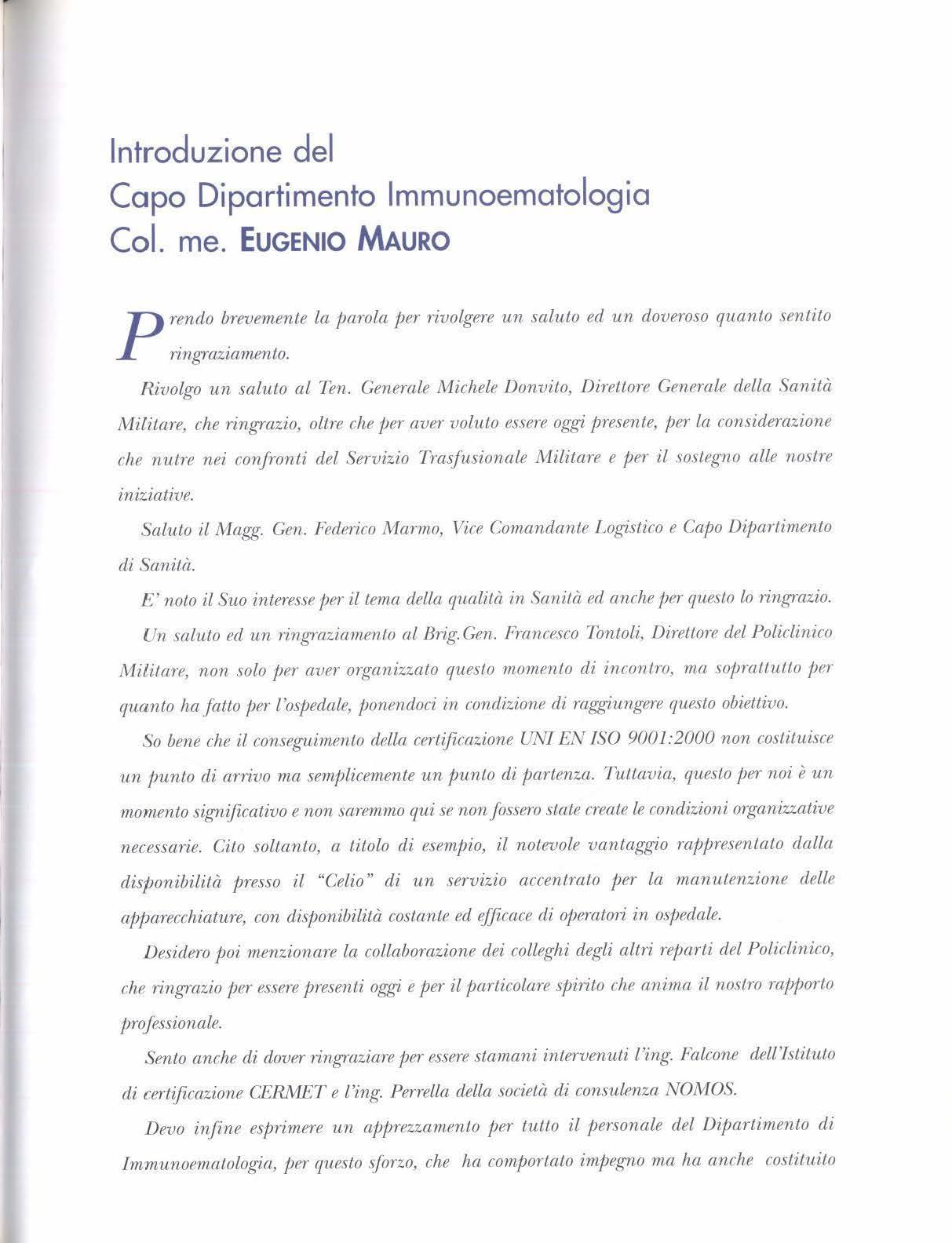
Pr~ndo b_revemenle la parola per rivolgere un saluto ed un doveroso quanto smtìto nngraziamento.
R.ivolgo un saluto al Ten. Gfnerai,e Michele Donvilo, Direttore Generale dPlla Sanità MilitarP, che ringrazio, oltre che jJer aver voluto essere oggi presente, fJl>r la ronsiderazione che nutre nei confronti del Servizio Trasfusionale ivlilitare e per il sostegno alle nostre iniziative.
Saluto il Magg. Gen. FPderico Marmo, Vice Comandante J,ogistiro e Capo Dipart,imento di Sanità.
E' noto il Suo interesse per il tema dello qualità ;n Sanità ed anche per questo lo ringrazio.
Un saluto ed un ringmziamenlo al Brig.Gen. Franasro Ton.tali, Diretton' dp[ Policlinico Miti/are, non solo per ava organizzato questo momento di incontro, rna soprattutto /Jer quanto ha fatto /Jn l'ospedale, /Jo11endoci in condizione di raggiungere qw~sto obiettivo.
So bene che il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 non costituisce un punto di arrivo ma semplicemente un punto di partenza. Tuttavia, questo per noi è un momento signifitativo e non saremmo qui se non fossero state rreale le condizioni organizzative necessarie . Cito soltanto, a titolo di esempio, il notevole vantaggio rafJpresenlato dalla disponibil'ità presso il "Celio" di 1,m servizio accen lrnto per la man ulenzione delle apparecchiature, con disponibilità costante ed ~fficace di ojJeratori in ospedale
Desidero poi menzionare la collaborazione dei colleghi degli cdtri re/Jarti del Policlinico, f"he ringrazio fJer essere presenti oggi e per il particolare spirito che anima il nostro rapporto fJrojessionale.
Sento anche di dover ringraziare per ess11re stamani intervenuti l'ing. Falcone dell'Istituto di certificazione CER.lvl.ET e l'ing. Perrella della società di consulenza NOMOS.
Devo infine esprimere un ap/JrPzzarnento jJer tutto il personale del Oiparlirnento di Immunoematologia, per questo .~(orzo, che lw comfJortalo impegno ma ha anche rostituito
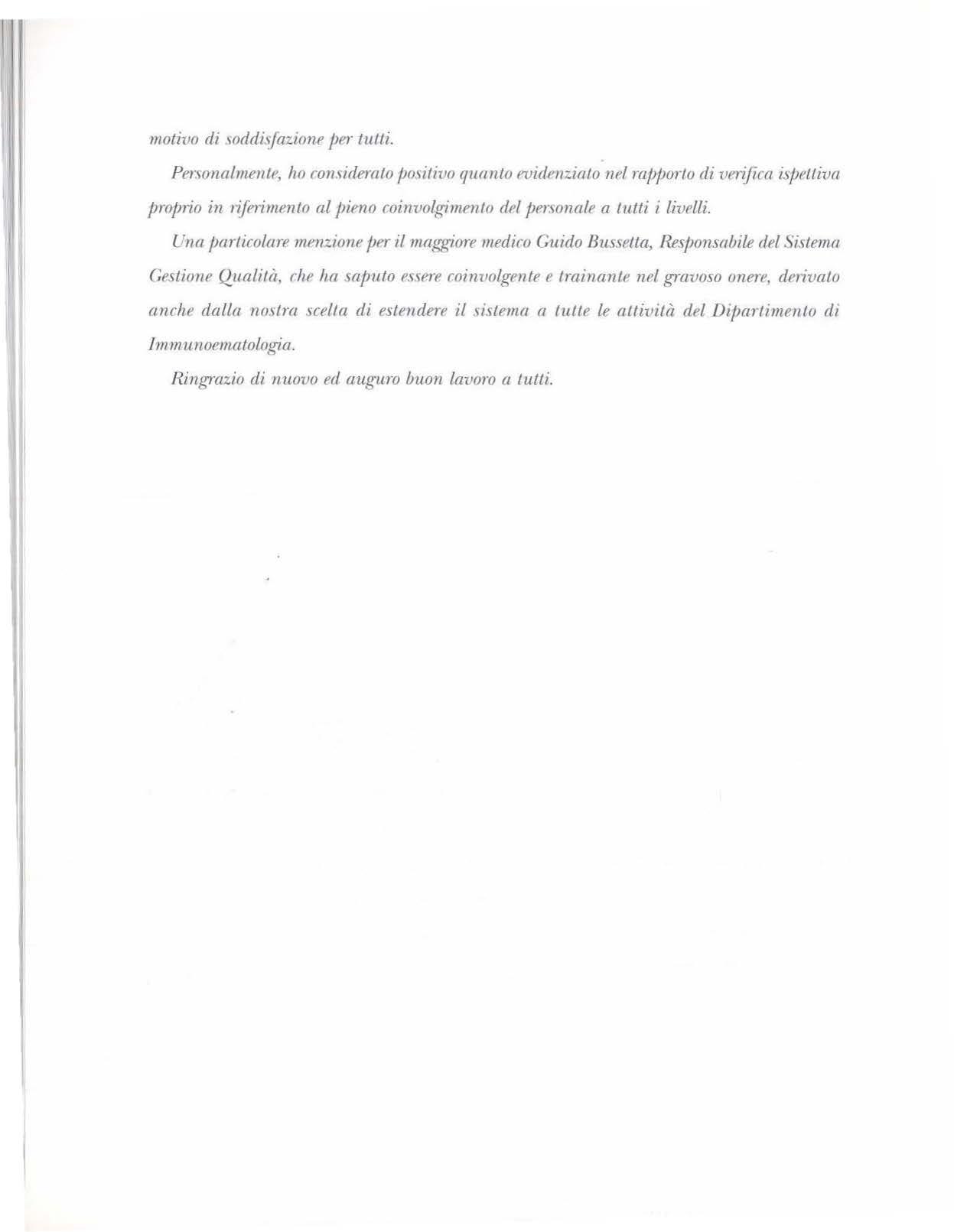
motivo di Ioddisfa:.ione J>n- tulli.
Penonalmenle, ho comideralo positivo quanto roidf'nzialo nPl rap/;orto di vPrijira is/Jelliva
pro/1rio in ri.JerimPnto al J>ieno coùroolgimenlo dPI penonale a tulli i livelli .
Una particolarP mmzione per il maggfore medico Guido Busstlla, Responsabile del Sistema
Gestione Qualità, che ha saputo essere coinvolgente e trainrmlP nel gravoso onere, derivalo anchP dalla nostra scelta di estende,·p il sistnna a tulle le attività del Dif1artimenlo di 1m munoematologia.
R ingrazio di nuovo ed auguro buon lavoro a tutti.
SCHEDA TECNICA ALLEGATA AL CERTIFICATO DATA SHEET ATTACHED TO THE CERTIFICATE
°'llanlzzazlon&l()genj,am
POLICLINICO MILITARE 01 ROMA DIPARTIMENTO DI IMMUNOEMATOLOGIA
Re;lslrlZlonl noiR,g/sfrlm no.
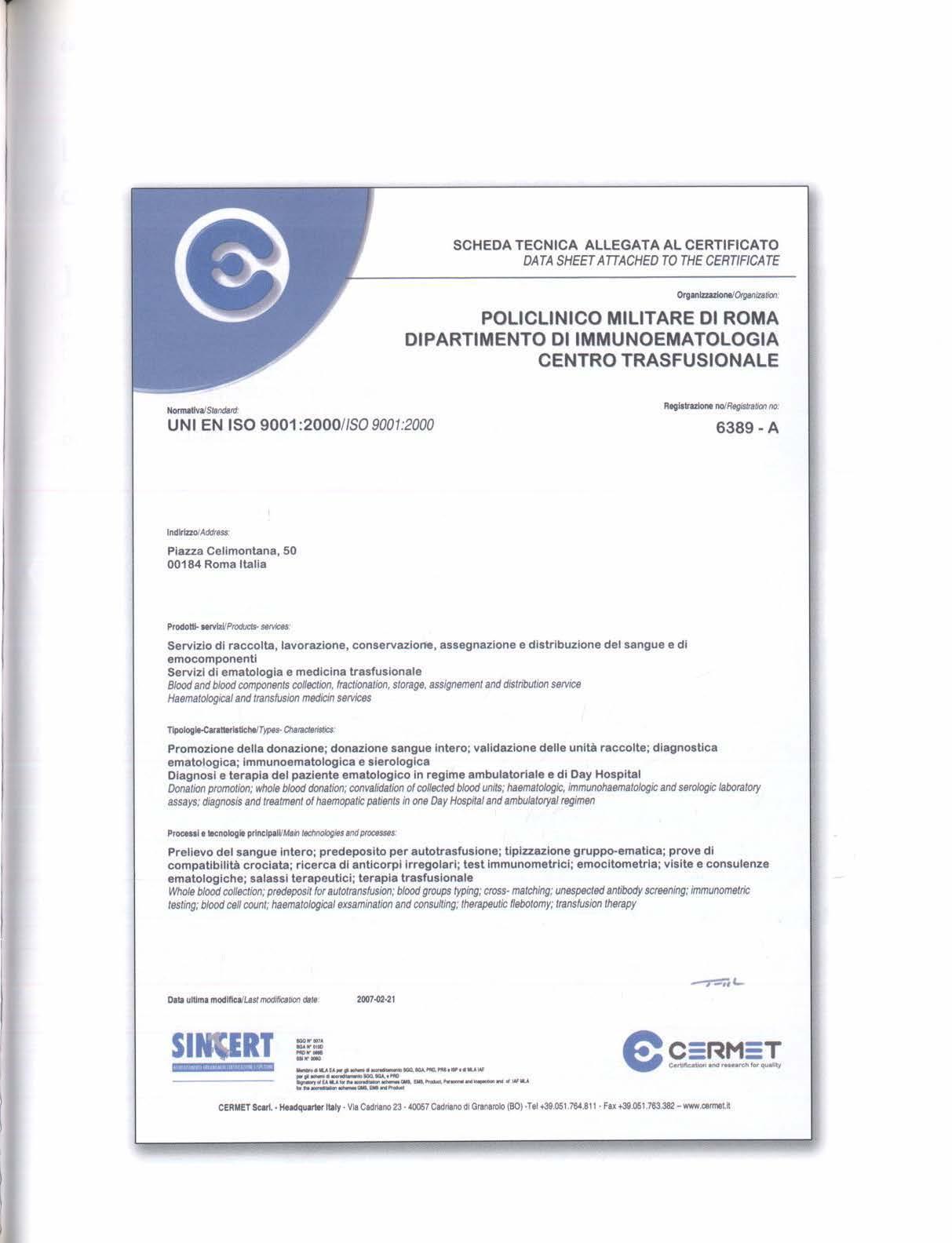
NonnallYa'Slandailt
UNI EN ISO 9001 :2000//SO 9001:2000
lnd11zzo1Addrus
Piazza Cellmontana, 50 00184 Roma Italia
Prodolll-~Pr<WC!t--
Servizlo di raccolta, lavorazione, conservazione, assegnazione e d istribuzione del s a ngue e di emocomponentl
Servizi di ematologia e medicina trasfusionale
Blood and blood components eolfectlon. lractlonation, storaga, ssstgnemenl and dlstnout,on servioo
Haemato/ogg/ and transtvslon medicm services
~i.tar1111<111lcholT-O!alldtrisla 6389 -A
Promozione della donazione; donazione sangue Intero; validazione delle unità raccolte; diagnostica em atol ogica; lmmunoem atolog ica e sierologica
Di agnos i e terapia del paziente ematologico in regime ambulatoriale e di Day Hospital
Donation promotion: wtiote blood donation; conval1dation ol conected blood unns; haematologic, lmmunohaematologic and sarologic laboratory assays: dìagnosis and treatmfll!I of haemopatlc pa&onts in one Day Hospital and ambutato,yat regimflll
Proceul t IICnologla prlnclpalVMal! """'11o/og,_. ,nelp(....,.&
Prelievo del sangue Intero; predeposlto per autotrasfuslone; tipizzazione gruppo-ematica; prove di compatibilità c rociata; ricerca di anticorpi Irregolari ; test lmmunometrlcl; emocltometrla; visite e consulenze ematolog iche; salassi terapeutici ; terapia trasfusionale
Whole blood colf11Ction; predeposit for autotransfusion; blood groops typlng; cross- matchlng: unaspected antibody screening: lmmunometric test1ng; b/ood ~ll count; haematological exsammatlon and consun/ng; therapeutlc Habotomy; transfusion therapy
CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ OUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
SI dicllln CM 1 di,..._ por 11-..-Cl,p,lmzlono: W.carfllyfletllwQ.elly""-"""'s,.ndtlle~ POLICLINICO MILITARE DI ROMA - DIPARTIMENTO DI IMMUNOEMATOLOGIA NTRO TRASFUSIONALE
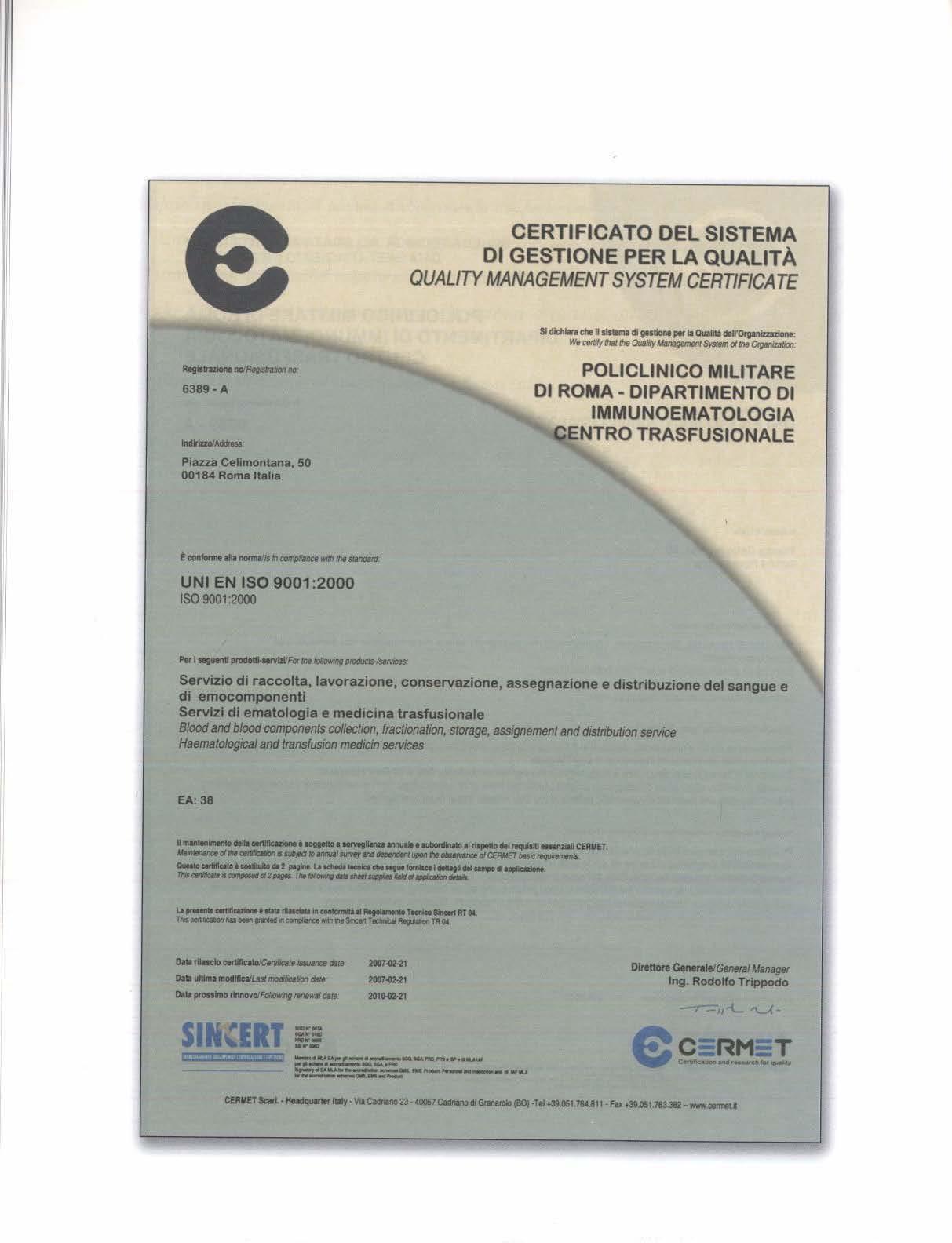
Plezzil c.a.,a Dliii LI, IO 00114Remalllìlla
UNI EN ISO 9001 :2000
ISO 90013DI
ilt ,,.
Senlizlodl raccolta. lavorazione, COftNMIZione, asaegnuione edi8tribuzlonedel ungue e
hrwttdl ....blloglaemetllclnablfullonate
II giorno 7 marzo 2007, presso il Policlinico Militare di Roma si è svo l ta una cerimon ia in occasione della consegna del cen ifì cato del sistema di Gestione per la Qualit~t ISO 9001 :2000 al Dipart imemo di I mmunoemato logia - Ce ntro Trasfusiona le Sono in tervenu t i il Ten .Gen. Mirhefr, Donvilo. Di rettore Generale della Sanità Militare. il Magg. Gen. frderito 1'vlar1110 Vice Comandame Logistico e Capo Di partimcnLo Sanità dell'Esercito, il 13rig.Gen. Frrmffsco Tonto/i Direttore de l nosocomio ed in pres<"nza di unti i Capi Dipartimento del Policlinico Militare di R oma , del C:o l. me. },'ugenio Mauro, Capo Dipartimento di Immun oematologia e del Magg. me. Guido Bussetta. responsab il e del sistema Gestione Qualità del Dipartimento.
Hanno panecipato inoltre, l'lng. Rodolfo Trippodo Direttore Genera le della Società di Ce1·tifìrazione Cermet e I' l ng. Giusi'f1pP Perrella Direttore della società di consulenza per la qualità Nomos. ll lavoro che ha avuto una durata complessiva di c irca 1m anno e eh<" ha visto impegnato in primo piano il Magg. me. Guido Busselta con i l supporto de ll a società di ronsulema :--JOMOS, ha portato alla delìn iz ionc in maniera <locument._ùe di:
1. Un Manuale per la Qualità;
2. 15 Procedure operative standard:
• Gestione documentazione
• A udit
• Gestione Non Conform i tà
• Gestione Azioni Correttive
• Attrezza ture
• Privacy
• Acquis6
• Recla mi
• Politica e 1i esame
• Piani di qualità
• Carta servizio
• Ri sorse umane
• Gest ione donatori
• Misurazione sodd isfazione dell'nreme
• Info rm az ione e co n senso informato.
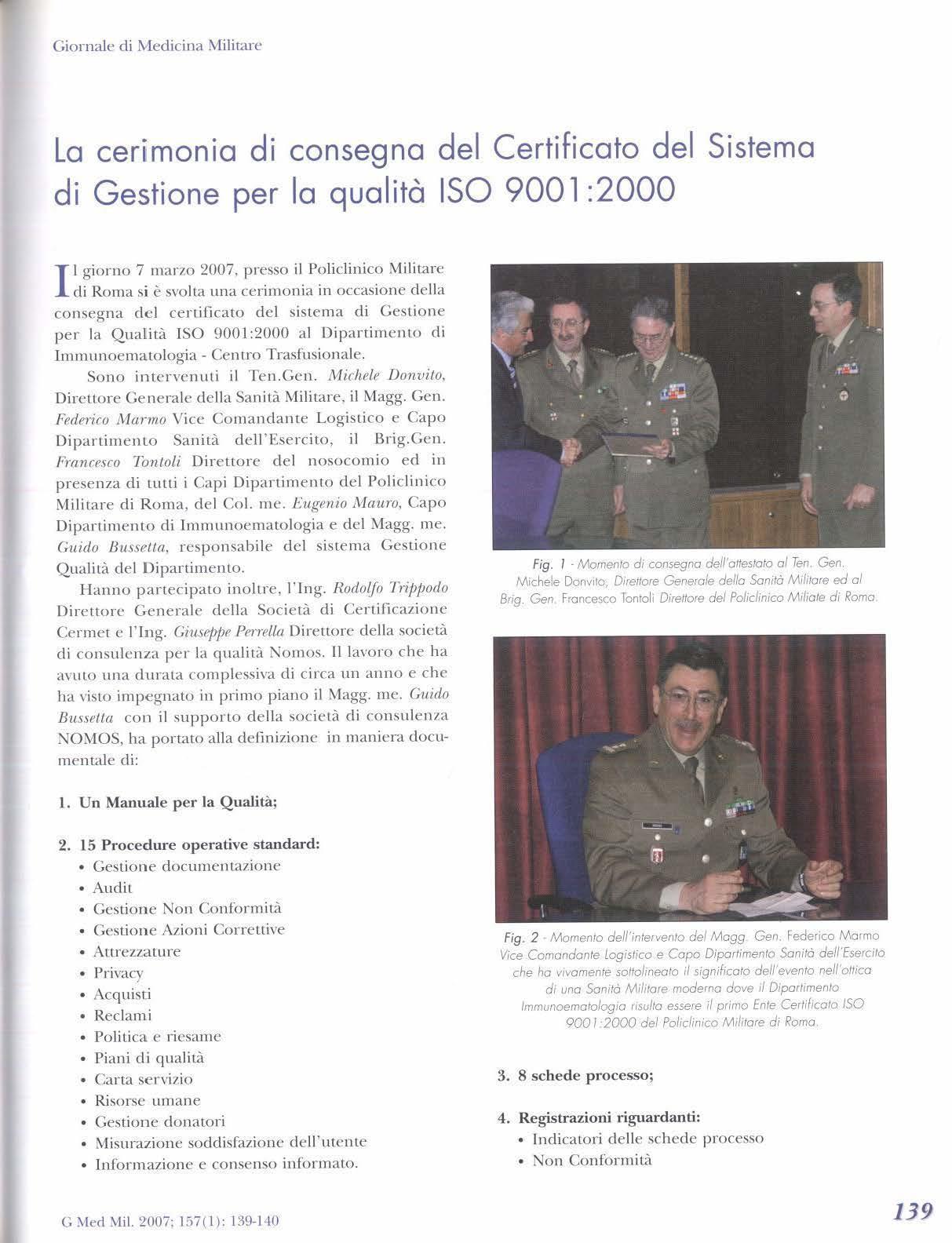
I · N\omen10 d1 consegna deil'oNesto lo
Fig 2 · Momen 10 del/'in lerve11 to de.I Magg Gen. Federico Mo1mo Vice Com a ndan te logistico e Capo Dipartime nto Sanità dell 'Esercito che ho v1vomenre sollolìneo to il significa to del/ evento ne/l'ott1co dì una Sanità Militare mod erno dove 1/ D1port1menlo lmmunoematologio 11sulro essere il primo Ente C e rlilicoto ISO 900 / ·2000 del Policlinico Militare di Roma
3. 8 schede processo;
4. Registrazioni riguardanti:
• Indi catori de lle schede processo
• Non Conform ità
• :\!on Conformità Classilìcate
• Riesame
• Azioni Correttive
• Fornitori
• Personale
• Audit
• AurezzaLttre.
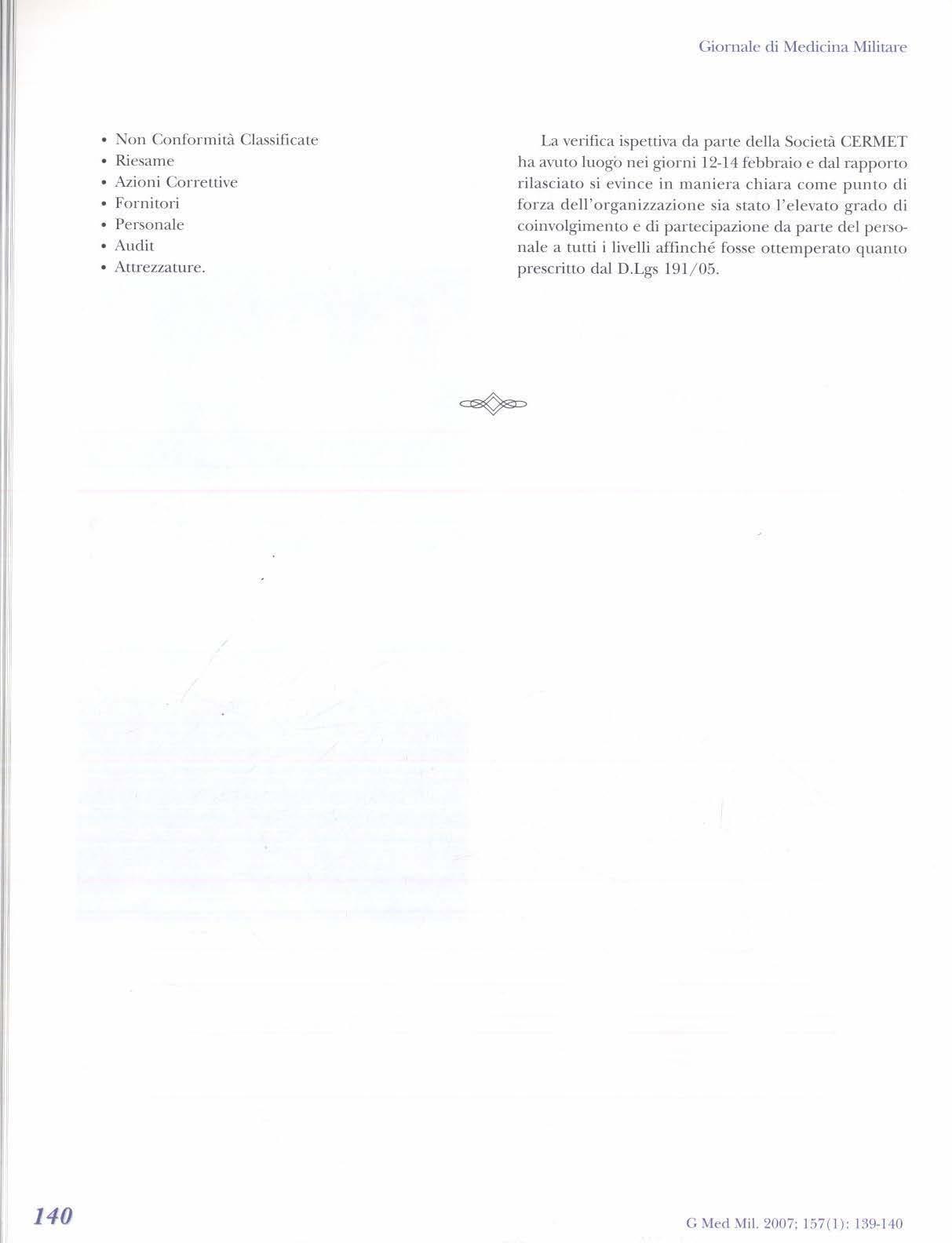
La verifica isperciva da parte della Società CERMET ha avuto luogi:> nei giorni 12-14frbbraio e dal rapporto rilasciato si evince in maniera chiara come punto di forza dell'organizza z ione sia stato l' el e varo grado di coinvolgimento e di partecipazione da parte ciel personale a tutti i livelli affinché fosse ottemperaLO quarno prescritto dal D.Lgs 191 / 05
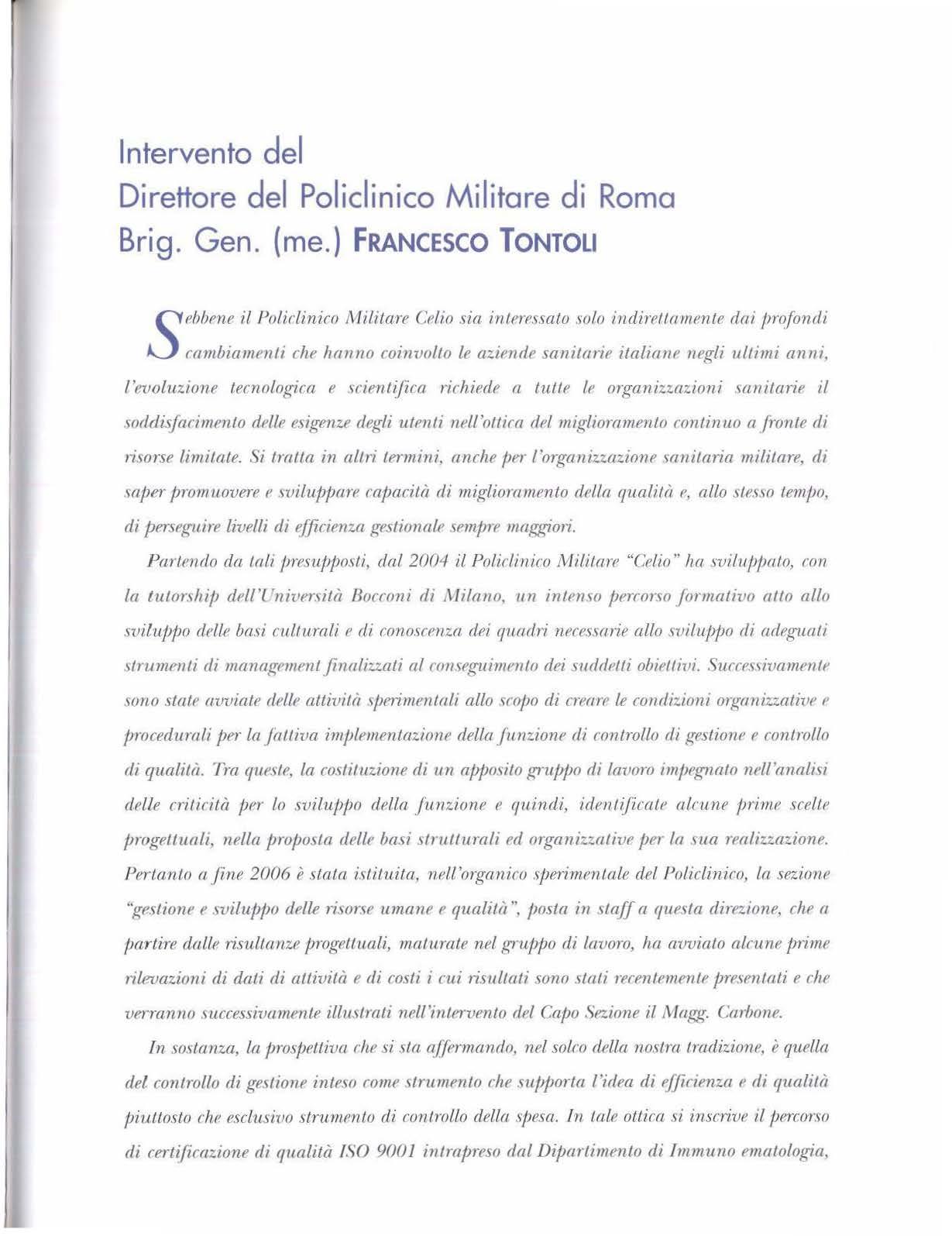
SPbhme il Polirlinico Militare Cplio sia inlNPssato solo indirellmnmle dai /m>fondi rmnbiammti che hanno coinvolto le m:.in1de sanitariP italùtw' negli ultimi anni, l'evoluzione tecnolo[(ica P scienti/ira richiedP n lultP IP 01ganizznzioni srrnitariP il wddisfarimenlo dPlle esignne degli ulmli 11pll'ottica riel miglioramento continuo a fronte di 1isorse limitale. Si tratta in altri termini, anche per l'mganizzazione rnnilaria militare, di .wper promuovere P svilupparf capacità di rnigliormnento della qualità r 1 allo sfpsso tem/Jo, di persr,guire livelli di efficienza gestionale semprP maggiori.
Partendo da tali /Jresu/J/Josti, dal 2004 il Politlinico Militare "Celio" ha sviluppato, con la tulm:\hip dt>ll'l'nivn:ùtà Bocroni di A / ila no, un intenrn /1errorso formativo allo allo sviluppo dellP basi cullurali e di ronosrmza dei quadri nerPssarù allo sviluppo di adeguati \frumenti di managt•menl finalizzali al romPguimmto dei suddPlti obiellivi. Sucre nivam{'11/f sono state avviate r/(,flp attività 5perimenlali allo sro/JO di crearP Le condizioni 01K(1rtizzativP r> f1rocedurali per la falliva i111pln11entazionf della Jìmzione di tontrollo di gestio11e P controllo di qualità. Tra queslf>. la costituzione di un apposito gruppo di lavoro imJ;egnalo nell 'analis1 delle crititità per lo svilu/JjJo della funzionP e quindi, identi}lcalf alcune prime scelte progettuali, nella proposta deflp basi strul/urali ed organizzative per la sua rmlizzazionP. Pertanto a j,ne 2006 è slala istiluila, nell'organiro sperimmtale del Policliuito, la sezio11P ''gpslione e rnilup/10 del/,e rùone umam>f qualità", jJOsta in staff a quPsla dirnione, che a partire dalle risultanze progelt uali, mal urale nel gru/1po di lavoro, ha avvialo alcune prime rilevazioni di dati di allività e di costi i cui risultati sono stati recentemente presentali e cl1f verranno successivamente illu\lrali nell'inlrrvento del Capo Sn.ione il Al agg. Carbone.
l n sostanza, la prospt>ttiva rhe si sta affermando, nel solt0 della nostra tradìziorif, ;, quella del controllo rii geslionP inteso romP slrummto che su/;porla L'idea di ejfirienza "di qualità piuttosto che Psclusirio strummto di controllo della sjJesa. hl t ale otlirn si inscrive il percorso di rertificazione di qualità I SO 9001 intrapreso dal Dipartimento di hnmuno nnatologia.
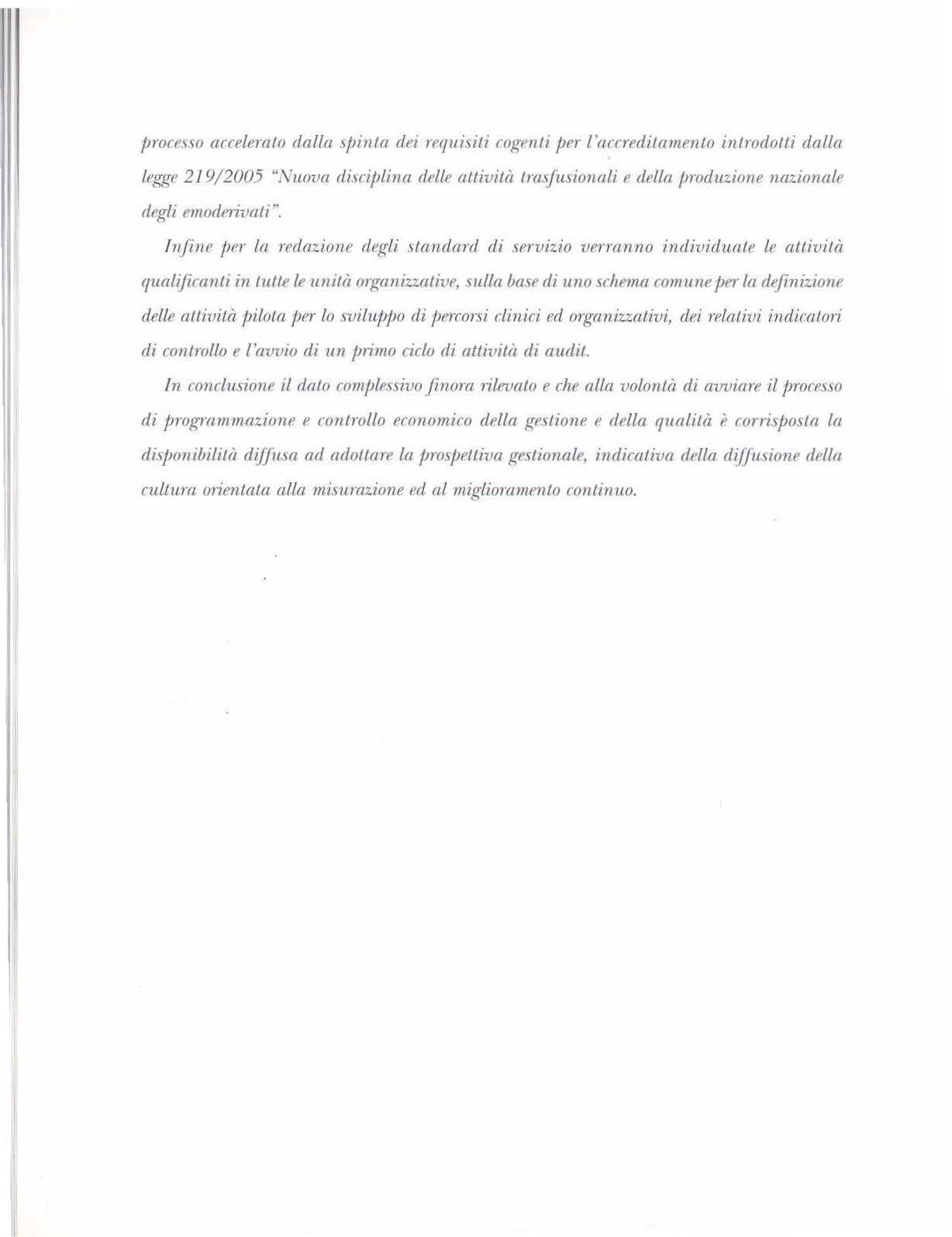
/HoCfsso acceleralo dalla spinta dei rNJuisiti rogf'nli per l'accredilammlo introdotti dalla legge 219/2005 "Nuova disri/Jlina clfl/p rttlività trasfusionali e della produzione nazionalf degli emodnivali ".
Infine per la redazio11f rle14li standard di snvizio verranno individualf le attività qualificanti in tulle le unità organizzative, sulla base di uno srhnna comunf per la rlefìnizione dellP allività pilota /Jfr lo svilupj;o di /H11-corsi diniri ed organizzativi, dei rPlati-oi indicatori di controllo e l'avvio di un /Jrimo ciclo di attività di audit.
In rondusione il dato romp!Pssivo .finora rilroato I' che alla volontà di avviare il processo di jJrowrnmnazione " rontrollo Pconomico della wstione e della qualità è rorrisposla la disponibilità diffusa ad adottare la J;rosj)Plliva f{estionale, indicativa dPlla diffusione della cultura odentata alla misurazione ed al miglioramento continuo.
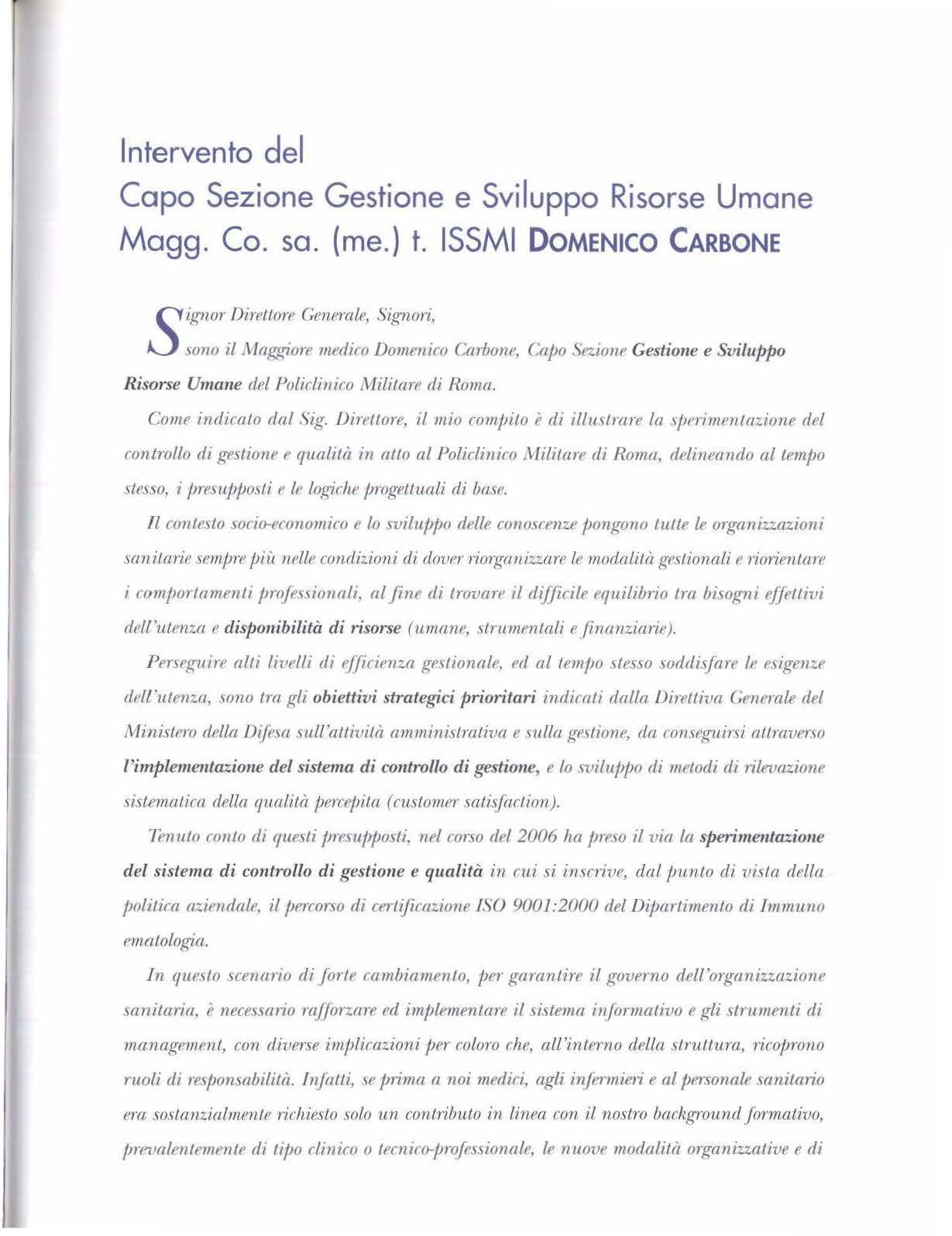
Signor /Jirplfore Genera!t1 Signori, sono il Ma.~iore mediro Domeniro Carbone, Capo Sezione Gestione e Sviluppo Risorse Umane del Policliniro Militar<' di Rnma.
Come indicato dal Sig. Direttore, il mio rom/Jilo è di illu Hrare la \'fJPrimentazione dr! rontrollo di gestione e qualità in atto al Polidiniro A1ilitare di Roma, delineando al tempo stesso, i prrsupposti e le logiche /Jrogelluali di base.
Il ronlPsto sorio-eronomiro f lo sviluppo rfplfp conosrenu pongono tutte le organizzazioni sanitarir sempre più nelle condizioni di dorwr riorganizzare le modalilrì gPstionali P riorienlarP i comportamenti professionali. al finP di trovare il difficile l'(fllilibrio tra bisogni effettivi <frll'utenza P disponibilità di risorse (umanP, strnmmtali e jinrwziarie).
Perseguiff alti livelli di Pfficiem a gestionale, ni al tem/H> stesso wddisfare ft, fsigenze drll'utem:.rt, sono tra gli obiettivi strategici prioritari indimti dalla Direttiva Genrrale del Ministero rlPlla Difl1sa sull'aflività amministrativa e s1dla gestione, da ronsegu ù;5i attraverso l 'implementaz ione del sistema di controllo di gestione, e lo sviluppo di metodi di rilevazionr si.sterna/ira della qualità perre/Jila (rustonwr sati.sjàttion).
Tenuto conto di questi j>rfwjJposti. nel corso <M 2006 ha prrso il via la sperimentazione del sistema di controllo di gestione e qualità in rui si instrivr, dal /Junto di vista della /Jolitica aziendale. il perrorso di cntijìrazione ISO 9001:2000 del Dipartimento rii lmmuno mzatologia.
In questo scenario di fortf rambiamf1llo, per garantire il governo dell'organizzazione sanitaria, j, necessario rafforzare ed imj)lemenlm'f' il sistema informativo f gli strumenti di managnnenl, con diverse implirnzioni per coloro the, all'interno della slru.llura, ricoprono ruoli di l'Psponsabilitrì. i nfatti, M ' prima a noi mediri, agli infPrmieri e al personalP sanitario era sostanzialmenfP richiesto solo un contributo in lin ea con. il nostro barkgroun.d formativo, /m>valentemente di tipo clinico o lecniro-j,rofessionale, I.e nuove modalità organizzative e di
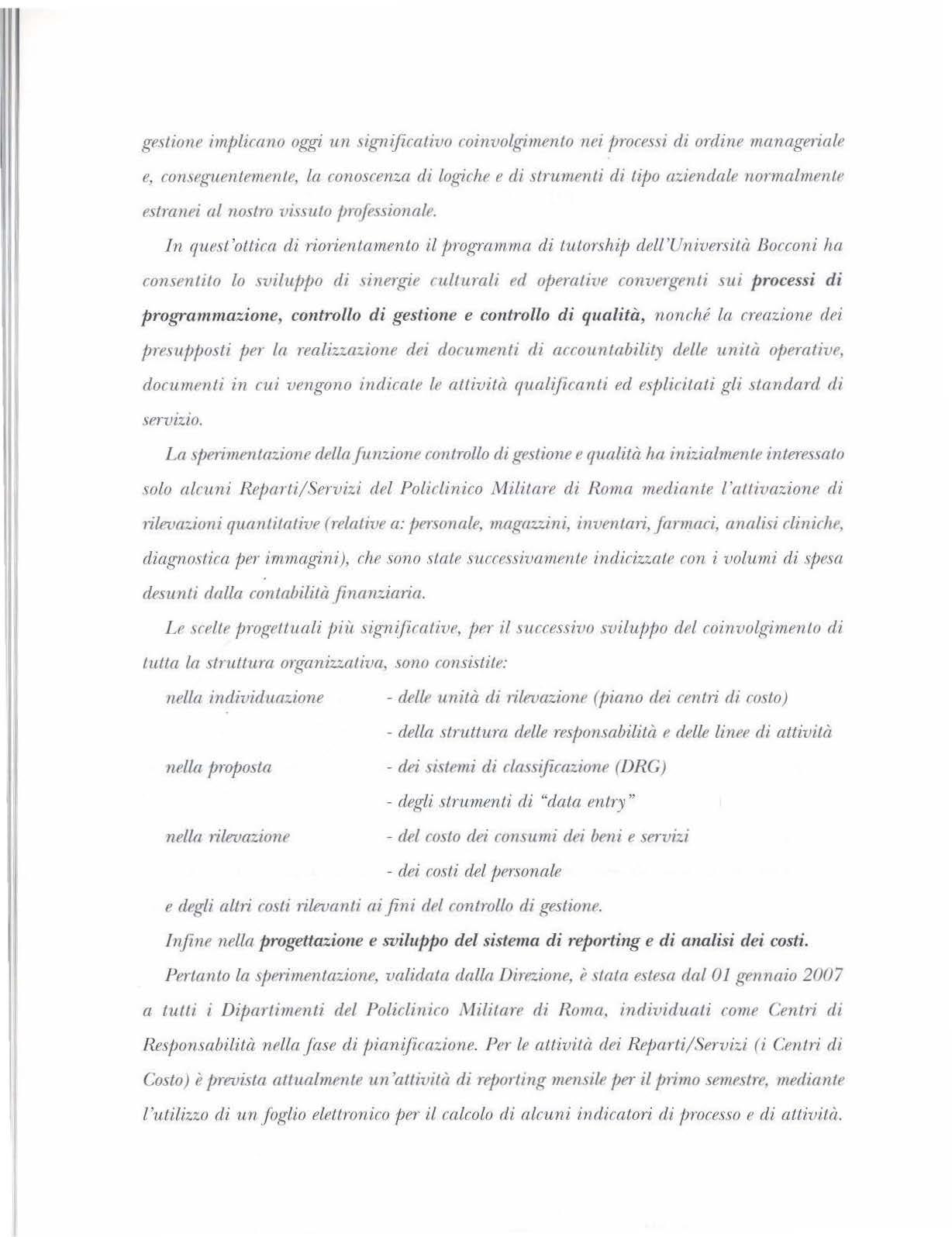
gestione implirano oggi. un significativo roinvolgimenlo nei /nocessi di ordine manageriale e, con.\t'g,tentemmlf, la conoscenza di logiche e di strumenti di tipo aziendale normalmenlf estra11Pi al nostro vissuto professionaft,.
I n qupst'ottira di riorientamento il jJrogramma di tutorship dell'Università Bocconi ha ronsenlito lo sviluppo di \Ìnergie rnllurali ed operative convngmti sui processi di programmazion e, controllo di gestion e e controllo di qualità, nonrhf la creazione dei pre:wpposti per la realizza::.imu dei documenti di acrounlabilit)' ril'lle unità operative, dornme11ti in mi vengono indirnte {1, attività qualificanti Pd esjJliritati gli slandard di servizio.
La spr>rimenlazione dPllaf11nzio11P rontrollo di l(Pstione P qualità ha i11izialrnn1/e interessa/o solo alcuni RP/Hll'li/Servizi del Policlinico Militare di Roma mf<lirmte l'alli1Jazione di rilevazioni quantitative (relativP a: penonale, magazzini, invmtari, farmaci, analisi cliniche, diagnostica jJer immagini), rhe sono slatf sucressivmnrnfe indirizzalP ron i volumi di spesa desunti dalla contabilità finanziaria.
Le srPlfr proiettuali jJiù signifirntive, j)Pr il successivo svilujJ/Jo dPL roinvo!gimPnlo di Lu/la la slrullura organizzativa. sono ronsistilP:
nella individuazione - d.(dfl' unità di rilroaziont' (/Jiano dei centri di costo) - della çtruttura rMle responsabilità P delle linn, di attività nr>lla proposta - dei s1stnni di dassijìrazionP ( DRG ) - degli strumenti di "data l'nlry"
nella ri!roazionP - del costo dei consumi dl'i beni e servi::.i - dei costi del /Jersonale e degli altri costi rilevanti ai.fini tifl rontrollo rii gestionf'.
l nfinf nella progettazione e sviluppo del sistema di repm·ting e di analisi dei costi.
F'f'rlrmlo la çpf>rimentazionP, validala dalla Dirnione, è ç/ala estesa dal 01 gn1naio 2007 a tutti i Dipartimmti del Policlini co Militare di Roma, individuati romf' Centri di Responrnbilità nf'lla fase di pianifirazione . P er le attività dei Reparti/Servizi (i Centri di Costo) è prroista attualmente un 'attività di reporling mensilP per il /Jrimo semPstre, mediante l'utilizzo di un foglio elellronico pPr il calcolo di alcuni iurlicatori di processo f' di attività.
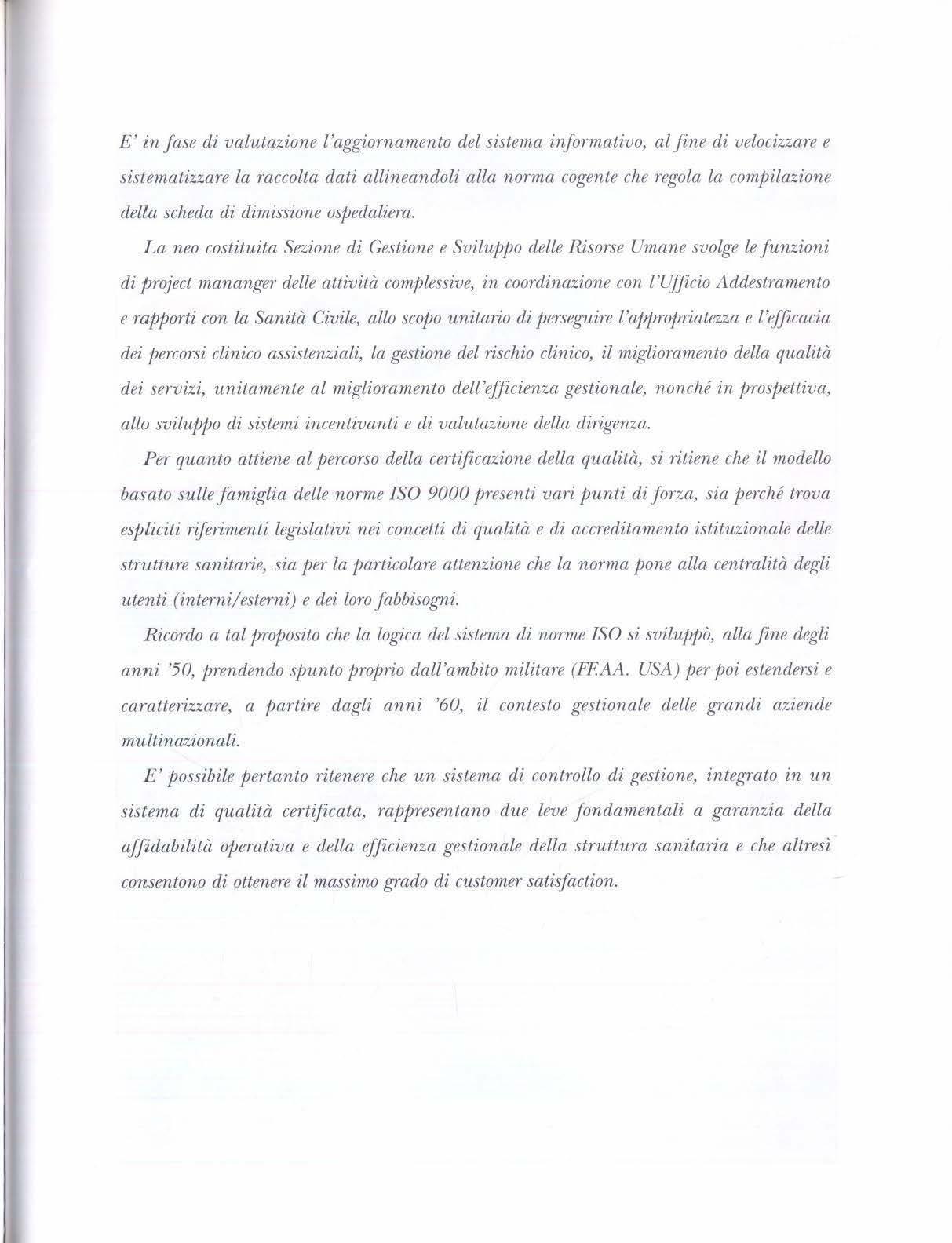
I!,'' in fase di valutazione l'aggiornamento del sistema informativo, al fine di velocizzare e sistematizzare la raccolta dati allineandoli alla norma cogente che rr>gola la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera.
La neo costituita Sezione di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane svolgf le funzioni di project mananger delle attività complessive, in roordinazione con l'Ufficio Addestramento e rapporti con la Sanità Civile, allo scopo unitario di perseguire l'approprialezza e l'efficacia dei percorsi clinico assistenziali, la gestione del rischio clinico, il miglioramento della qualità dei servizi, unitamente al miglioramento dell'~fficienza gestionale, nonché in /Jruspettiva, allo svilu,jJjJo di sistemi incentivanti e di valutazione della dirigenza.
Per quanto attiene al jJercorso della certificazione della qualità, si ritiene che il modello basato sulle famiglia delle norme ISO 9000 presenti vari punti di forza, sia perché trova espliciti riferimenti legislativi nei concetti di qualità e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, sia per la fJarticolare attenzione rhe la norma pone alla centralità degli utenti (interni/esterni) e dei loro fabbisogni
Ricordo a ta l proposito rhe La logira del sisterna di norme ISO si sviluppò, alla fine degli anni '50, prendendo spunto proprio dall'ambito militare (FF.AA. USA) per poi estendersi e caratterizzare, a jJartire dagli anni '60, il contesto gestionale delle grandi aziende multinazionali .
E' J;ossibi le pertanto ritenere che un sistema di ronlrollo di gestione, integrato in un sistema di qualità certUzcata, rafJpresenlano due leve fondamentali a garanzia della affidabilità operativa e della ejfitienza gestionale della struttura sanitaria e che altresì consentono di ottenere i l massimo grado di rustorner satisfaction .
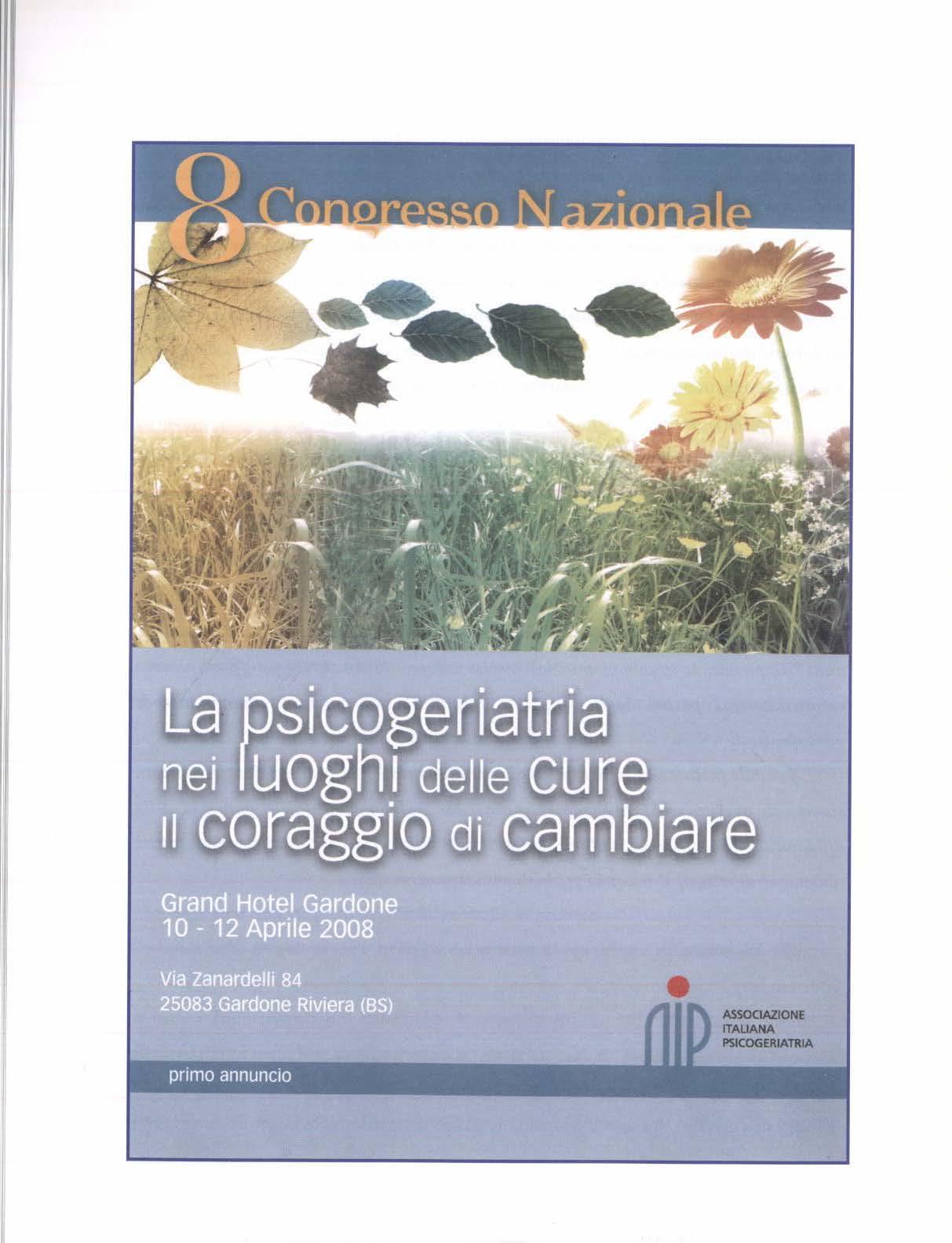
Giusepp e P erre lla *
* Foutiatore e ruppresenlrmtr legnlf' della 1or-il'tà ti, w11;u/enia NO,\1OS.
Riassunto - La società di consulenza :--Jumos con esperienza guindicennale nel settore sanitario, ha anno modo di poter lavorai-e per la prima volta, con una struttura sanitaria mi l itare.
L'espericnn maturnLa. in questo campo con l'assis tenza a su·uuure san i carie sia pubbliche che private su rntto il territorio nazionale ha avuto modo di essere applicala anche al Celio attraverso il principio di quello che è definito il servi1io san i ra,;o snello basato su servizi oriemati principalmente verso i bi~ogni <lei cittadino utente, i l mig liornrnemo dell'effìcienza nell'impiego delle risorse e. app l icando principi operativi già affermati la caccia e la lotta agli sprechi Tuua,~a in questo vasto e delicato settore il lavoro svo lw con la Sanità M i litare ha messo in luce per gli opnatori di NOMOS, elementi inattesi qui focalizzali
Parol e c hiave: Se rvizi o Sanitario s n ello, E ffi cie n za, N OMOS .
Summary - Fo1- thc tìrsL Lime Nomo~, a consnltancy society in health care has had thc oppurtunity to work whit a Milìtar y organization.
The experience in this ficld, rcached in public and private structure~ in ltaly has had the opport.unity lO be applied ac to Lhc Dcpanment of lmmunoematology through the theory of Slim Sanitary Service based on che c licnt ancl his neecl , ù1e irnprovernent of the efficienq, and applying just affirmed operative procedure~, the hunting of the waste. Howner. in this delicate and vast sector this job whit Military S,rnitary Service has s hown for the persona! or :--Jomos unexpected elemenLS here rcprcscmed.
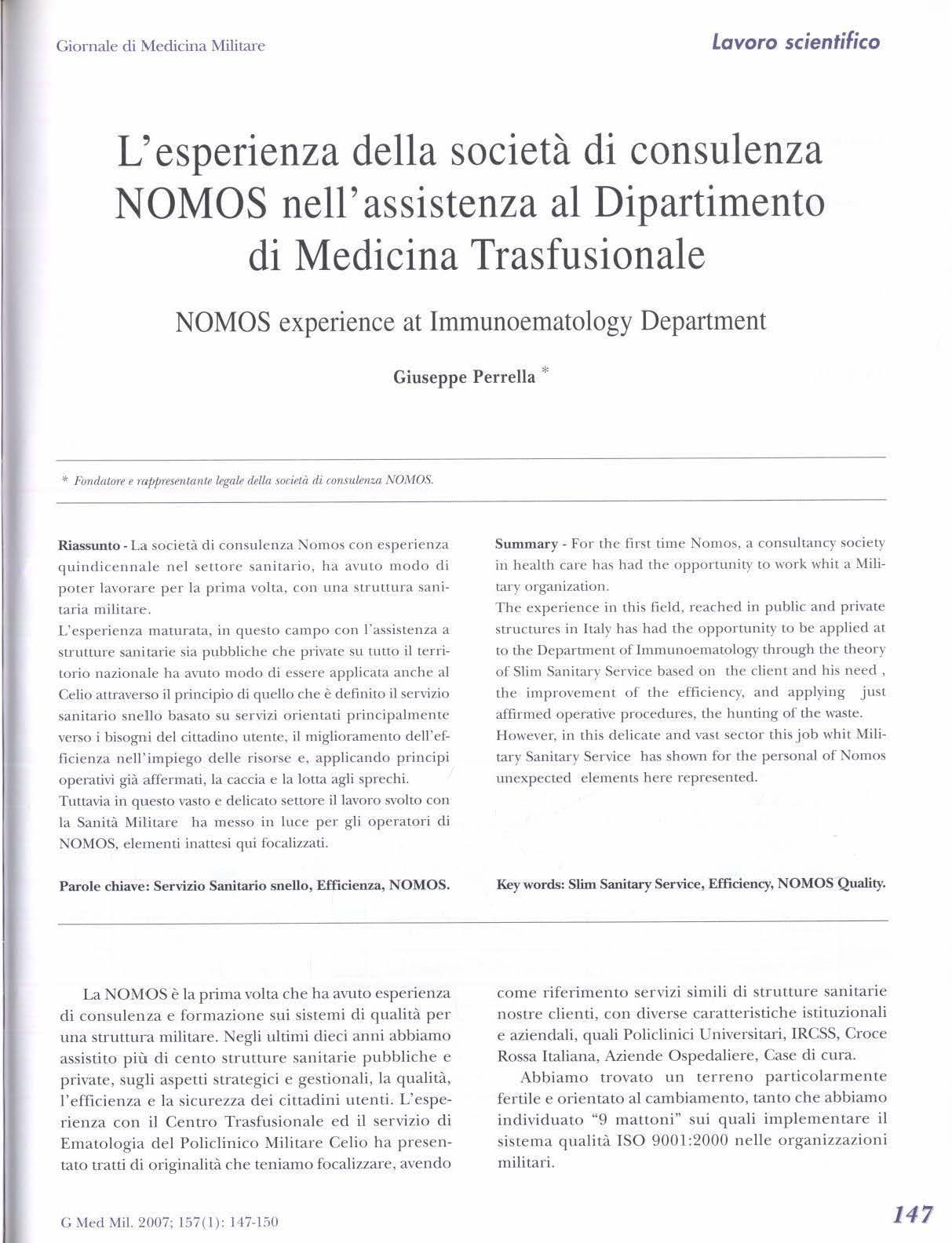
La NOMOS è la prima vo l ta che ha avuto esperienza di consulenza e formazione sui sistemi di qualità per una struttura militare. Negli u l timi dieci anni abbiamo ass istito più di cemo strutture sanitarie pubbliche e pr ivate, sugli aspetti strategici e gesti onali, la qualità, l'efficienza e la sicurezza dei cittadini utenti. L'esperienza con i l Centro Trasfusiona le ed il servizio d i Ematologia del Policl i nico .Militare Ce l io ha presentato tratti di origina li tà che teniamo focalizzare, avendo
Key word!;: Slim S ani tary Se rvice, Efficiency, N O MO S Qualiry.
come riferimento servizi simil i di strutture sanitarie nostre clienti, con diverse caratteristiche isùtuziona l i e azienda l i, guaii Policlinici Un iversitari, IRCSS , Croce Rossa f ta l iana, Az iende Ospeda l iere , Case di cura.
Abbiamo trovato un terreno part icolarmente fertile e orientato al cambiamento, tanto che abbiamo individuato "9 mattoni" sui quali implementare il sistema qua l ità ISO 9001:2000 nel le organizzazioni militari.
Centrali tà d e lle pe rson e:
o p erare seco nd o princ ipi fond a nti e m o Liva zio ni p rofond e, piuttos to c h e in h ase a d a tteggi ame nti e compo rta m e n t i;
• co involg im e nto d e l p e rsona l e a lutti i li velli d e ll'o rganizzaz io n e;
• ce ntra lilà d e lle person e si a a ll ' inte rno d e ll 'o r gani zza zi o n e che co m e ute nti.
L'organizzazione :
• c hia1-ez za e t ras p are n za d e ll' asse u o o r g an i zza tivo, co n d esc ri z io n e d e i com piti e d e ll e r es pon sa bilità d e ll e di verse p os izioni;
• a bitudin e ad o p e r a r e second o proc e dure fo rma lizza te co n solidate e dis p o nibil i tà a d e finirn e di nuove;
• cultura d e lla g es ti o n e p e r obi e t Livi c h e s iano ve rificabili e misurabil i.
Il cambi amento:
• o ri e nt a m en to all ' efficienza o lu·e c h e all 'e ffì cac i a ;
• p rocesso di s upe ramento d e ll 'o rga ni zzaz i o n e buro-
cra ti c a attrave rso l' a d oz i o n e di pro ce dur e e s trum e nti s n e ll i;
• o rie nta m e n to a l ca mbi a m e nto ed a l mi g li o ra m ento co ntinuo ( Fig 1 ).
Col fine cli r einves tire qu es te co ndizi o ni favo r evoli , con la dire z ion e sono s ta ti defi niti t r e principi g ui da fo nda m e nta l i pe r la pro ge tta z i o n e e l ' impl e m e n tazi o n e d e l siste m a qu a lità:
• svil upp a r e proce dure e s trum e n t i di ges ti o n e e c ontrollo s n e lli e s u mi s ura d e ll 'organ iaaz i o n e e d e lle p erson e con a tre n z io n e a lla cacci a e a lla l o t ta ag l i s prechi ;
• c hi a r eZla n eg li i mpe g ni , a uraver so un a c omun ica1ione a gile e d e ffì cace in m od o da faci l ita r e il co involg imento e la pie n a c ondivis io n e, n o n so l o d e ll e p os izioni d i l avoro e el c i c o mporta m e nti es te ri o r i , ma d e i prin cipi fo nd a nti dell e pe rso n e;
• punt a r e s ull a formazi o n e, p r eva l e ntem e nt e in affi a n ca m e nto , o p e r a nd o n e l v ivo d e i p rocess i , in m o d o da fa c i litar e l a ve rifi ca co ntinu a d e ll ' aµpre nd i memo e l a s tessa e ffi caci a e d e ffici e n za deg li s trnm e mi del sis t e ma di g es tio n e p e r l a qual i tà
Parte nd o d a qu es ti prin c ipi, è s t_a to fac il e r e in ves tire l e esp e ri e n ze c h e a bbi a mo a n1t o c on il m o nd o T oyota , i l p e n sare s n e llo, l a qu a l ità viss m a. non c h é valoriz za re e mig li o r a r e il know how NOMOS. La m e tod o log ia e g li s trum e nti d e i Mas ter Proccss si so n o 1ivela ti m o lto pro du ttivi, in qu anto h a nn o ris p os to a ll 'es ige n ta di e vir a r e, quando p oss ibil e, pro ce dure na rrn-
Le person e l ' organizzazione Il cambiamento
Operare secondo principi fondonti e motivozioni profonde
Coinvo lgi mento del personole a tutti i livel li dell'organizzazione
Centrali tà delle persone dell'organizzazione e deg li utenti
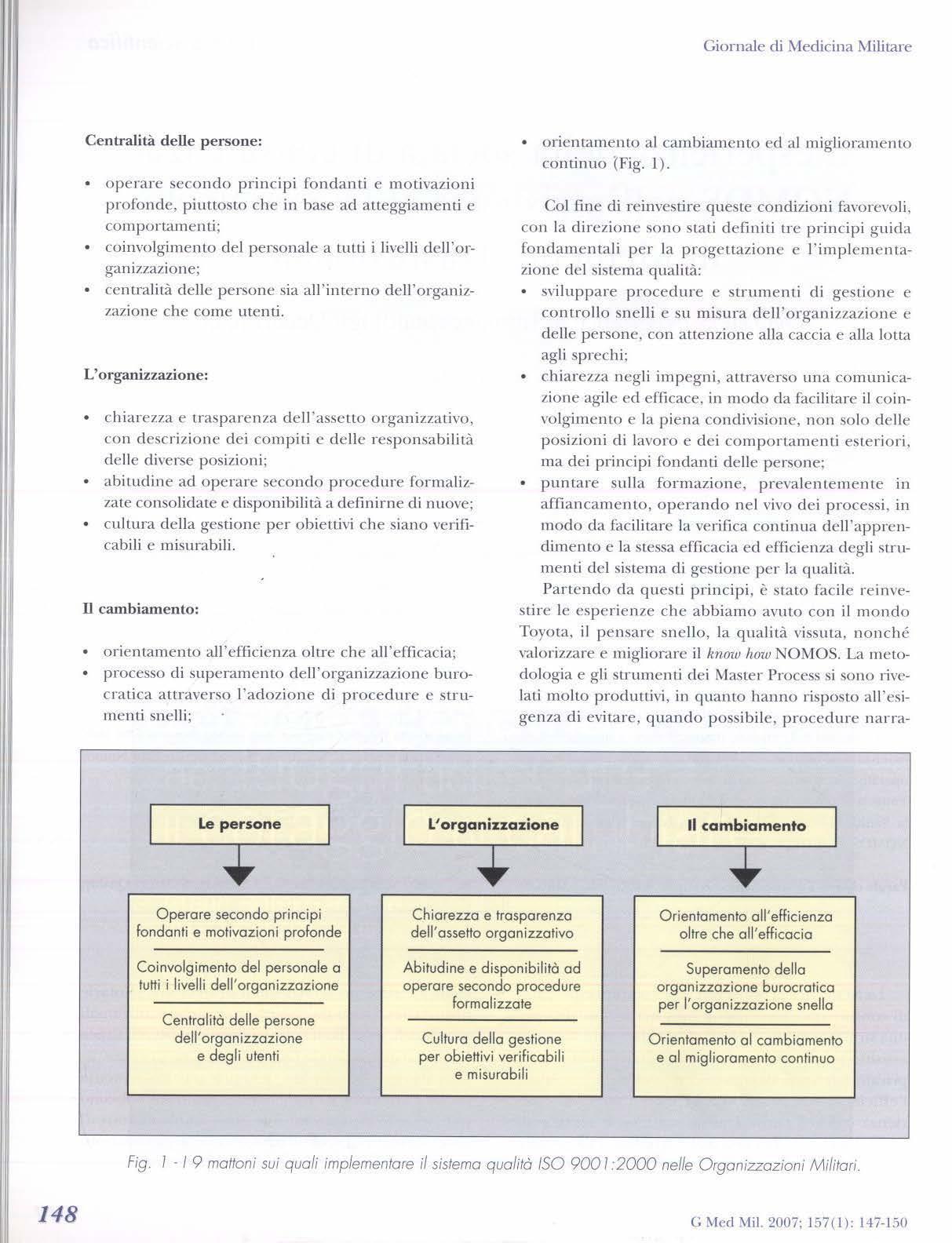
Chiarezza e trasparenza dell'assetto organizza tivo
Abitudine e disponibilità ad operare secondo procedure formal i zzate
Cul tura della ges tione per obiettivi verificabili e misurabili
Orientamento all'efficienza o ltre che a ll'efficacia
Superamento dello organizzazione burocratica per l'organizzazione snello
Orientamento a l cambiamen to e al miglioramento continuo
Fig I - I 9 mattoni sui quali implementare il sistema qualità ISO 900 I :2000 nelle Organizzazioni Militari
Le persone

Operare secondo principi fondanti e motivazioni profonde
Coinvolgimento del personale a tutti i livelli dell'organizzazione
Centralità delle persone del!'organizzazione e degli utenti
l 'organiu:azione
Chiarezza e trasparenza dell'assetto organizzativo
Abitudine e disponibilità od operore secondo procedure formo Ii zzate
Cultura dello gestione per obiettivi verificabili e misurabili
Il cambiamento
Orientamento all'efficienza oltre che all'efficacia
Superamento dello organizzazione burocratica per l' organizzazione snello
Orientamento ol cambiamento e ol mig lioramento continuo
Fi9 . 2 - Gli strumenti della gestione snello e a visto.
Monitoraggio e gestione della soddisfazione degli utenti
Requisiti
Conformità olle normative
Informazione chiaro e comp leto Impegni misurabili e verificabi l i dagli utenti
Carla dei servizi
Requ i siti
Chiarezza delle procedure di fruizione dei servizi Impegni reciproci
Standard de i servizi misurabili
Guida oi servizi interni al Policlinico
fig. 3 - Gli strumenti di gestione della Cusromer Salisfoction del servizio trasfusionale.
Live , per focalizzare sulla c atena clieme-fornitore, altra verso:
• la qualificazione delle risorse impegnale, degli inpm e degli output di processo;
• l'individuazione e il controllo dei punti critici;
• i cruscotti e gli obiettivi misurabili di processo e di direzione per la conduzione dei processi stessi.
Per declinare la strategia della direzione ai diversi livelli dell ' organizzazione sono state implementate le Bal,anced Scorecard, così come ognj reparto e unità operativa è stata dotata di obiellivi, iuclicatori , target, di diverso tipo, gestionali, clinici, operativi. <li direzione.
Per facilitare la comunicazione ed il coinvolgimento, abbiamo fatto prevalere decisamente la rappresentazione grafica sulla scrittura, operando nell'ottica della gestione a vista. Si è trattato di rendere il più possibile visibili e u·acciabili i processi, i rischi di anomalie ed errori , gli obiettivi / target e i relati,~ scostamenti.

Allo scopo il sistema qualità ha utilizzato mappe dei processi ai diversi livelli dell ' organizzazione, flow charl, balanced scorecard, cruscotti gestionali (Fig. 2).
Le condizioni favorevoli, i principi guida e gli strumenti di gestione per la qualità implementati hanno permesso di mirare oltre l'obiettivo della conformità alla normatiYa vigente e oltre un sislema di assicurazione qualità. L'attuale sistema qualità del Centro è prima di tllltO fortemente orientato alla soddisfazione degli ULent:i, agli obiettivi dell'efficacia clinica e dell'efficie11La, al miglioramento cominuo.
Per la soddisfazione degli utenti, si è voluto tener conto della diversità degli utenti del servizio implementando i seguenti principali strumenti di conoscenza e gestione:
• la carta dei servizi;
• la guida ai servizi interni al Policlinico;
• le indagini di Custorner satisfaction (Fig. 3).
Massimario della
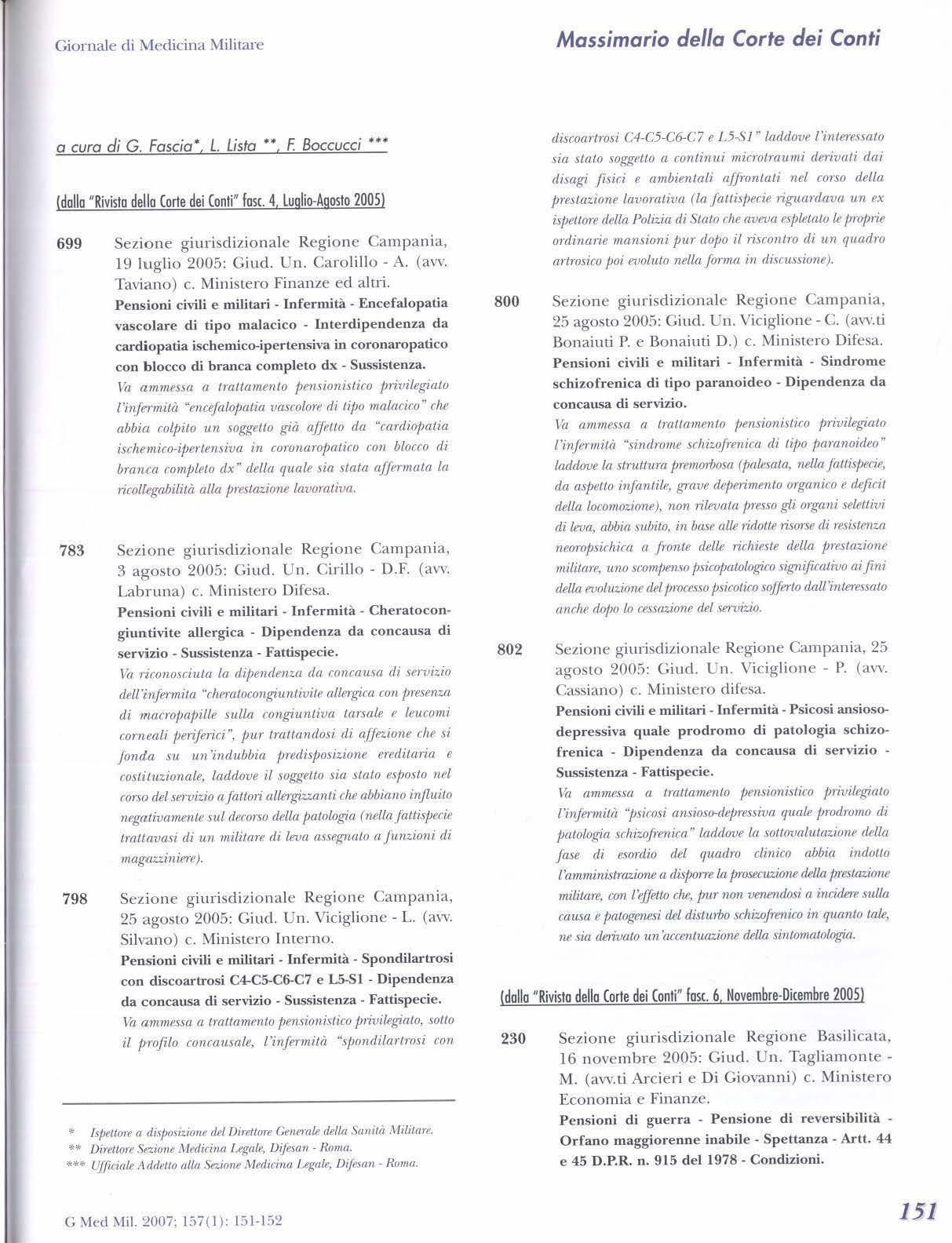
a cura di G. Fascia*, L. Listo ** F. Boccucci •**
(dalla "Rivista della Corte dei Conti" fase. 4, luglio-Agosto 2005)
699
783 798
Sezione giurisdizionale Regione Campania, 19 l ug li o 2005: Giud. Un. Carolillo - A. (avv. Taviano) c. MinisLero Finan ze ed altri. Pensiooj civili e militari - Infernùtà - Encefalopatia vascolare cli tipo malacico - Interdipendenza da cardiopatia ischenùco-iperlensiva in coronaropatico con blocco cli branca completo dx - Sussistenza. \0 ammessa o trattamento /1rnsiomstico pri1!ilegiato l'infennilà "encefal.opatia vascolorf' di tipo malarico·· che abbia rol/1ito un soggPllo già afjPtlo da '"cardiopatia ischemiro-ipertensiva in coronaropatiro rn11 blocco di branco completo dx'" della quale sia stata affermata la ricollegabilità ali.a prestazione lavoratÌ!ia.
Sezione giurisdizionale R egione Campania, 3 agosto 2005: Giud. Un Cirillo - D.F. (avv. La.bruna) c. Ministero Di fesa . Pensioni civili e militari - Infermità - CheratocongiUJlltivite allergica - Dipendenza da concausa cli servizio - Sussistenza - Fattispecie. Va riconosciuta la di/Jendenz.a da ronrnusa di iervizio dell'injn;nitn •·cheratoconghmt1vite allergirn cou presenui di macropnpille mila congiuntiva tarsale e leucomi corneali jJeri/nici ", pur trattandosi di affezione che si Jo11da su 1111 "indubbia jJredisposizione l'reditaria e rostitu:zionale, laddove il soggetto sia staio esfmsto nel rorso del servizio afa/lori aUergizza11ti d1.P abbiano influito negativamenle sul derorso dello patoù1gia (nella fattispetie /mUavasi di un militare di leva assegnalo a f1imio11i di 11Wgl!ZZÌ11ÌP1"e).
Sezione giurisdizionale Regione Campan ia, 25 agosto 2005: Giud. U n. Vìciglione - L. (aw. Silvano) c. Ministero lnterno Pensioni civili e militari - lnfernùtà - Spondilartrosi con cliscoartrosi C4-C5-C6-C7 e L5-Sl - Dipendenza da concausa cli servizio - Sussistenza - Fattispecie. Va ammessa a /rol/amrnto pensi011i,,tic0 privilRgiato, sotto il profilo conrtmsale, l'infermità "sp011dilartrosi l'Oli
* lspetton• a disf/()1izione del Dire/Iure Geni'1"a/e della Sa1tità Militare.
* * Dire/Wre SeziQne ,\ll'dirina /,egale, 1Jifesa11 - Rq11w.
*** Ufficia/P Adrlel/0 alla Sezione .'vlnlicina /;PgalP, Difrsan - Roma.
disroartrosi C4-C5-C6-C:7 e 1.5-SJ" laddove l'inlereualo ,ia stato soggPltO a corltinui microlrawni derivo/i dai disagi fi1iri e ambientali affrontati nel rorso della prestazioni' lavomti11t1 (In fa11isperie nguanlava un ex ispettore della Polizia di Sia/o rhe nvPVa rspletalo le J1roprie ordinarie mansioni pur dopo il risrontro di w1 quadro artrosico poi evo/ilio nella forma in di,cw;Jione).
Sezione giurisdizionale Regione Campania , 25 agosto 2005: Giud. Un. Viciglione - C. (avv.Li Bonaiuti P. e Bonaiuti D.) c. Ministero Difesa. Pensioni civili e militari - Infermità - Sindrome schizofrenica di tipo paranoideo - Dipendenza da concausa di servizio. \,a ammessa a tra/lomento pensionistiro Jirivilegiatn l'infermità ·'sindrome schizofrmiw di tipo pamnoideo ., laddove fa st1111/11ra premorbnsa (fmlesata, nella jàttis/1Prie, da aspetto infm1lile. grave deperimento organico e defiril d.Plla lowmozinnr), non rilevata presso gli organi Sl'ÙJ/tivi di lroa, abbia subito, i11 basi' alle ridotte risorse di resistmzo neoropsichiw a fronte ddle ri.rhie.5te della prestazione mifilarP, mw scompmso psicopatologico signifì.cativo ai fini della euofuzio11e tlRl processo psicotu-o soffPrto da/L'interessato anche dopo Ù! ressazione del .1ervizio.
Sezione giurisdizionale Regione Campania. 25 agosto 2005: Giud. Un. Viciglione - P. (avv. Cassiano) c Ministero dife~a.
Pensioni civili e militari - Infernùtà - Psicosi ansiosodepressiva quale prodromo di patologia schizofrenica - Dipendenza da concausa di servi zioSussistenza - Fattispecie.
Va mn1nessa a trattamento pensionistico priuiftgiato /"infl'nnità "psicosi ansioso-depressivn qnalf' J1rodromo di pa!ologia sthizojrenica , laddllfle la sottovalutazioni' della fase di esordio del quadro clinico abbia imlotto l'mnministra.z.ùme a dispon-e In prosecuzione della preslnzione militare, con l'effetto che, p1tr 1111n venendosi a inridere sulla causa e patognusi del disturbo srhizofrrmiro in quanto tale, ne sia de1ivalo un 'accentuazione delu.1 ,intornato{ogia.
(dalla "Rivisto della Corte dei Conti" fase. 6, Novembre-Dicembre 2005}
230 Sezione giurisd izionale Regione Basi.licata. 16 novembre 2005 : Ciud. Un Taglia.monteM. (aw.ti Arc ie 1i e Di Giovanni) c. Ministero Economia e Finanze.
Pensioni di guerra - Pensione di reve rsibilitàOdano maggiorenne inabile - Spettanza - Artt. 44 e 45 D.P.R. n. 915 del 1978 - Conwzioni.
G \led Mii. 2007; l:'>7 ( I ) : 15 1-15~
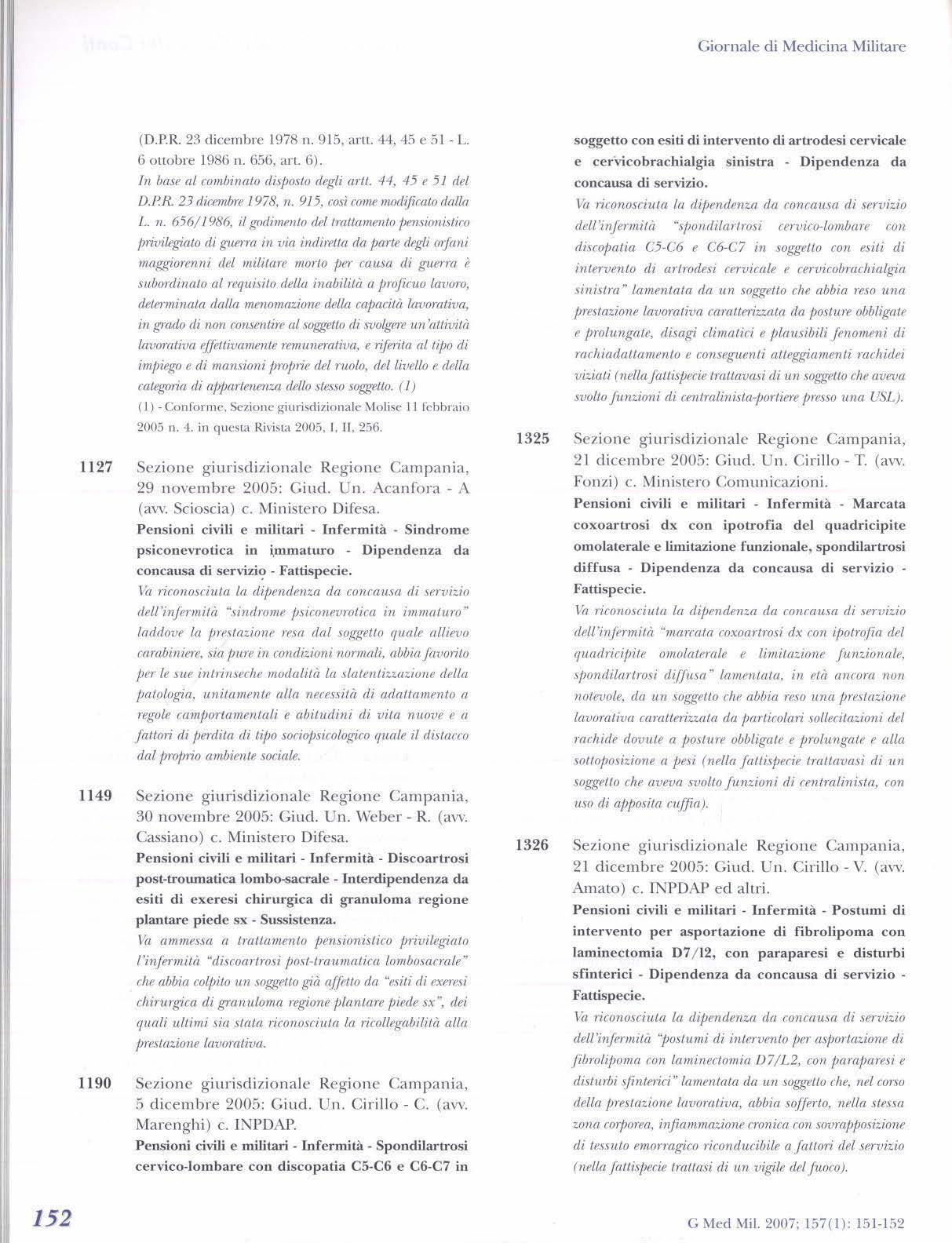
(D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915. am. 44, 45 e 51 - L. 6 ouobre 1986 n. 656, arL 6).
In bas,, al rom.binata disposta degli ari/. 44, 45 r 51 del DYR. 23 dimnbre 1978, n. 915, rosì ro111P 11wdijìrato riaf/a L 11. 656/ I 986, il godimm In del tmttamn11n pemùrnistiro p1i1rilegialo di guerra in via indiretta da jJ(lr/e drgli orfani maggiarenni del mili/are morto fNr rausa di guerra ì> subordina/o al requisilo della inabilità a /1roficua la11oro. determina/a dalla 1rn>1wmaziu11e d1,/la capacità lavorativa, in grado di non romenlire al soggetto di svolgere un 'attività lavamtiva e[frllivammte rP11w11Pmliva, e nP,rita al li/JO di imfiiego e di mansioni jmJJnie del ruolo. del lù 1ello e ddla mtep,mia di appartenen:n. dPllo st,:sso soggpllo. (I) ( J) - Conforme. Sezione giu,-isdizionalc- ;\folisc 11 febbraio 2005 11. -!. i n qucsra Rì\'ista 2()05. I , 11 , 236.
Sez ione giur isdiziona le R egione Campania, 29 n ovembre 2005 : Gind. Un Acanfora - A (aw Sc ioscia) c. Ministero Difesa.
Pen s ioni civili e militari - Infermità - Sindrome psiconevrotica in i,uunaturo - Dipend e n za da concaus a di servizi'? - Fattispecie. \,·1 riconosrinla la dij1e11de11za da conrrm.rn rii sPn1i:::.io rfp[/'i11Jnmìtà "sinrlrmnP /Jsirn111mrolira in immnt11ro" /(lddovP 111 /Jrfs/azione reso dal Joggetln quale allievo taT((biniel'I', sia pure in condizioni 11or111ali, abbia favorito pn le Jue irilriru,edu, modalità la slatenlii.wziu11e dPlla J1atalogi.a. unitaml'nte alla neresJitrì di adaltmnmto a regolP rnmportammta/i P abill1di11i di vi/a. 11 1w11P p a /allori di /ierdi ta di ti/m soriopsicologiro quale il rli5la/'ro dal /1ro/J1io ambienll' sociale.
Sctione g iu risdiz ionale Regione Campania, 30 novembre 2005 : Giud. Un. \<\-'eber - R. (avv. Cassiano) c. Ministero Difesa
Pen s ioni civili e militari - Infermità - Discoa rtrosi pos t-troumatica lombo-sacrale - Interdipendenza da esiti di exere si chirurgica di granuloma regione plantare piede sx - Sussistenza. \i1 ammPssa a tral/amen/o pensùmislirn priviiRgialo I 'infpn11itrì "di fforfflro.5i Jio.1t-lra11maticci /ombosarralf" rlw abbia rolpitn II n soggPllO già r1ffrllo rin "eçiti rii P'<Presi rhfrurgica di granuloma regione plan tare piedi' sx·; dei quali ultimi sia :,/ttla rirouosciuu, la ricollegabi/ità alla firestazione lavoraliva.
Sez ione giurisdizionale Regi one Ca mp a ni a, 5 dicembre 2005: Giud. Un. C irill o - C. (avv. M arenghi ) c. INPDAP.
Pensioni civili e militari - Infermit.à - Spondilartrosi cervico-lombare con discopatia C5-C6 e C6-C7 in
s oggetto con esiti di intervento di artrodesi cervicale e cervicobracbialgia sinistra - Dipendenza da concausa di servizi o. \lii rfronosriuta la dipmdnna dn rnnra11sa di srr11izio d.ell'injérmità '·sponrlilartrosi cervìto-lombarl' r011 discopatia C5-C6 e C6-C7 in soggello con esili di inlervet1lo di arlrode,i cervicalP P rervicubrachialgia :,iui:,tm" Lamrnlala da un soggPllo che abbia reso una /1restazionl' lavorati11a ramttrrìz.zata do postwP obbligati' P J1ro /11 ngale, disagi climatici e plausibili Je11omeni di mchiodallamen/a e conseguenti alleggiamenli rachidei t iiziati (uellafallispffiP lmttava.çi di un sagg,'fllO rlw a11n1a svolta f1.1nzia11i di rentralinista-/1ortiere presso una USL).
Sezione giurisdiLi oualc R egion e Campan ia, 21 dicembre 2005: Giud. Un. Ciri ll o - T. (avv. Fonzi) c. Ministero Co municazioni.
P e nsioni civili e militari - Infermità - Marcata coxoartrosi dx con ipotrofia del quadricipite omolaterale e limitazione funzionale, s pondilartrosi diffusa - Dip e nd e nza da co ncausa di se rv izioFattispecie.
Va riconosciuta la dipendenza da ranra ,ua di ,çervizio rlel/'injènnitcì "manata rnxoartrosi dx ron ipotrofia drl quadriri/iite omolaternfe e limitazione funzionali:'. sj1ondilortrosi diffu~a" lamentata, in età ancora 11011 110/evole, da l/TI soggello chP ahbia reso 1111a /ne,tazione lavl.Yraliva rarnlterizzala da partir:olari sol/Pritazinni r/p/ rnchùlP dovute a posture obbligate e prolungatr ,, alla sottoposizione a pesi ( nella fallisperir lrnllavasi di un soggel/o che aveva svolto funzioni rii reutrnlinista, ran uso di aj;posi/(1 rujfia ).
Sezione gi u risdiL ional c R egio ne Campania, 21 dicembre 200rj: G i ud Un. Cirillo - V. (avv Amar.o) c. INPDAP ed a ltri
P e n s ioni civili e militari - Infermità - P ostumi di intervento per asportazione di fibrolipoma con lam.ioe c tomia D7 / 12 , con parapares i e disturbi s finte rici - Dip e ndenza da co ncausa di servi zioFattispecie.
'1kt 1icono:,ciula la dipendenza da rallmu.sa di servizio dell'in}l>rmila ·postumi di inlrrvenlo /ier as/1ar/azionP di Jibrolijioma ron lmnincrtomia I) 7/L2, con poraparPsi e disturbi s(inleriri" lamentata da 1111 :,oggello e/te. nel cursu della preslazione lavorativa, abbia soffrrto, nelf.ri stessa wna c01/1arm, illjìr11mna:àone rronica ron so11raj;posizione di tr uu.lo emormgico rironduribile a f(lt/ori rld servizio (nr/la Jallis/JeCie lrattasi di un vigile del jW)l'O).
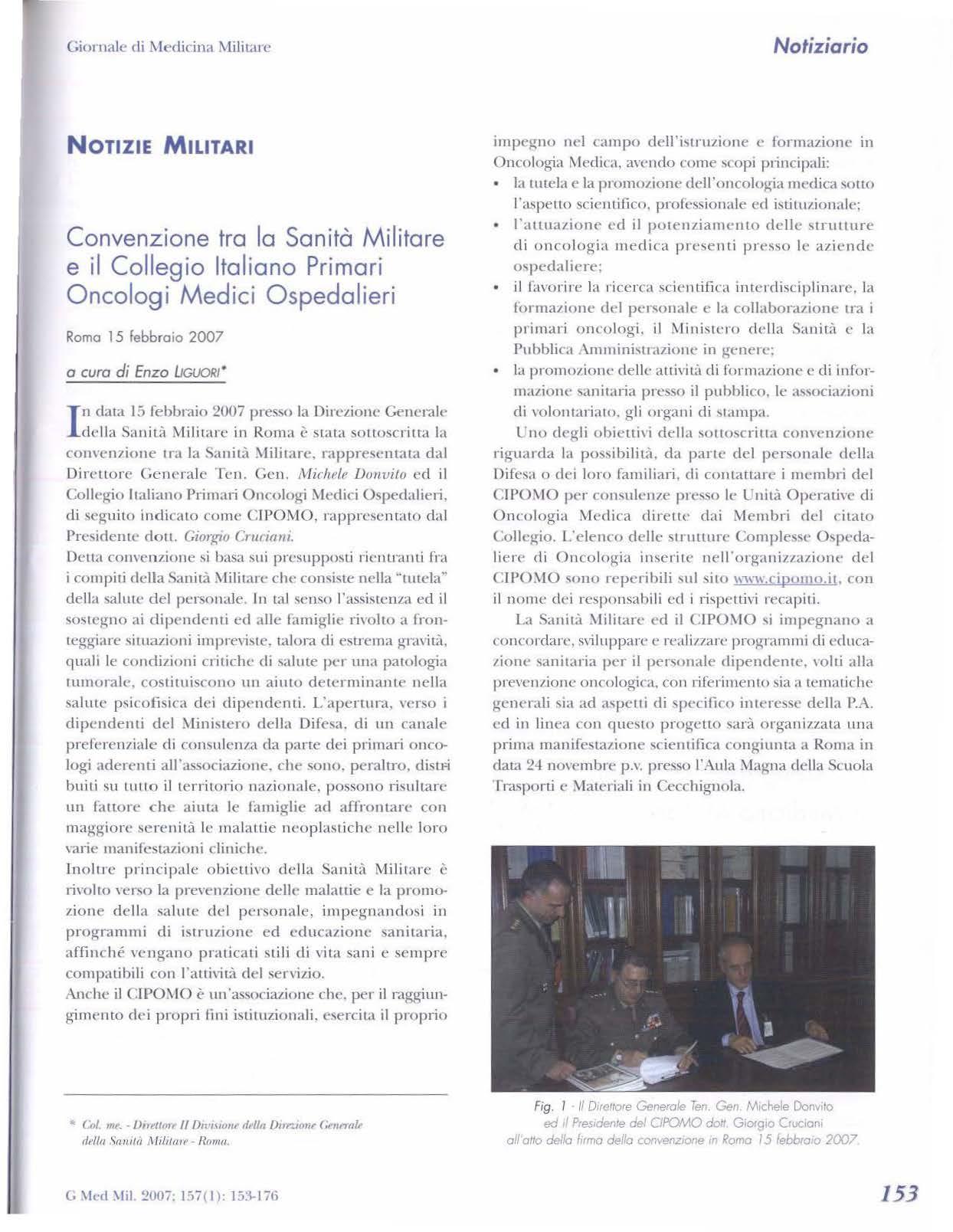
Convenzione tra la Sanità Militare e il Collegio Italiano Primari
Oncologi Medici Ospedalieri
Roma 15 febbraio 2007
a cura di Enzo I.JGUORI •
In data 15 fe-bbraio W07 presso la Din:Lione Generale de ll a Sanità Militare in Roma è stata s01toscrirta la conn'n1io11e ira la Sanità :\Iilitare, rappresentata dal Direttore Generale Ten. Gcn. Michl'IP Do11vilo ed il Collewo I1ali~1no P1irnari Oncologi :\kclici O~pedalieri. di seguito indicato come CIPOMO. rappresentato dal Pre~1denu: don. Giorl(IO r:rurìanì.
Detta con\'enzione si basa sui presupposLi rie11Lrami fra i compiti clella Sanicà i\Ii licare che consi,te m•lla ~llltda·· della salute del personale. In tal scmo l'assisten;rn ed il soswgno ai dipendenri ed alle famiglie 1ivolto a fronteggiare ~iwa1ioni impre,~sle. talora di estrema gravitù, qual, le cond.i7ioni critiche cli salme pt'r una patologia tumorale. costituiscono un aiuw determinante nella salute psicofisica dei dip<'ndenti. L 'a perlllra, wrso i dipendenti del Ministero della Difesa, cli 1111 canale pref('remialc di consulcn,i:a da parte dei primari oncologi adert'nti all'associazione. che ~ono. peraltro, dist.Fi buiti su Lut t o il terrico1io 11azio11ale, possono risultare un fanorc che aiuta le famiglie ad affrontar<.· con maggiore serenità le ma lattie 1wop lasticlw nelle loro rn1ie manifest.a1ioni cliniche•. Inoltre principale obieuivo della Sanità Militare è ri,·olto ver~o la prevenzione delle malattie e la promozio1w della salute del personale, impegnandmi in programmi di istru,ionc ed cduca1iom· sanitaria, affinché vengano praticati stili cli , ita sani e S<'mpr<' compatibili con rauhità ciel seniLio.
Anche il Cil?0~10 è un'associaLionc che. per il raggiLu1gimt·11to dei prop1i tini istilllzionali, c~ercita il proprio
impegno nel campo dell'i~truzione e formazion<' in Oncologi;i Medica, avendo come ~copi p1incipali:
• la tutela e la prom<l/ione dell'oncolo).{ia medica ,orto l'aspeuo sric11ti1ìco, professionale ed islitu,i:ionale;
• l'.1ttlla11one cd il potenLiamento delle ,rrutturc cli oncologia meclica presenti presso le aziende o~pcdalicre:
• il favorire la ricerca scientifica interdisciplinare. la forma,ione del per,onale e la collabora1ionc tra i primari oncologi. il Ministero della Sanità e la Pubblica ,\mminis11,11iont" in genere:
• la promo,ione delle auivitù cli formazione e di informaòorw sanita1ia presso il pubblico. le associa,ioni di rnlon1a1ia1<>. gli organi di ,1ampa. l.1 no degli obieui,i della souoscrina come111ione riguarda la po~sibilità, da parte del per~onale della Difesa o de, loro familiari, di contattare i mt.·mbi-i del CIPO\fO per consuk111e pre<;So le Cnità Operati\'c di Oncologia Medica clirettt· dai Membri del citato Collegio. L'elenco delle struuure Comple5st.· Ospedaliert> di Oncolo).{ia inserite nelrorganiaazione del C I P0:\10 ~ono reperibili sul sito ww,\.çip01110.it. con il nome dei responsabili ccl i rispe1tivi recapiti.
La Sanità ~1ilitarc ed il CtP0\10 ,i impegnano a concordare, sd l upparc e realil7aic programmi cli ecl1tca1ionc.· sanitaria per il per~o11ale dipendente.-. rnlti alla prewn1ion<: oncolugira. con riferimen to sia a tematiche generali sra ad a<;peui di specifico int<'resse della P.A. cd in linea con questo prog-ctto ~arà organizzata una prima manifcsta1iorw ,cicntifìca co ngiunta a Roma in data 24 nmembre p.v. presso l'Au la Magna della Scuola Trasporti e ~lateriali i11 Cecchignola.
• (.ì>/. me. - l>trel/mr Il D11•111m1, dr//11 011r.w11e (;1·111"lnlr rJ,,//11 çm,i/11 Mili1r111• - f-/oma.
Tali programmi potranno essere costituiti da:
• conferenze al personale;
• seminari o approfondimenti tecnico-scientifici per il personale sanitario miliLare;
• inserimento di lezioni o altri eventi di didattica frontale nell'iter formativo del personale sanitario militare;
• pubblicazione di articoli di natura scientifico-divulgativa su riviste militati;
• conuibuti specific i ai contenmi dei sili sanitari nella rete Difesa.
Per adempiere i compiti della convenzione è staro costituito un apposito ComitaLO Tecnico-Scientifico, i cui membri sono:
• Brig. Gen. Vito Contreas
Vkerlirettore Generale della scrivente Direzi,me Generale:
• C.A. Angelo Uva
Capo 2 Ufficio lspeuorato <li Sanità rle lla \farina;
• Col. Paow Astorre
Capo Repano oncologia presso il Policlinico Militai e cti Roma con funzioni di ~egreteria ;
• Dott. Giorgio Cruiiani
Pn:·-~idente Clf'OMO (tcl. 0545214081) ;
• Don. Ugo Folco
Primario OncoloKo Pietra Li g ure ( tel. O196232679) :
• Dou. Modesto D'Af1rile
Primario Oncologo Latina ( tel. 07736553840)
A Gammorth, in Tunisia, dal 20 al 25 maggio 2007
37° Congresso Mondiale
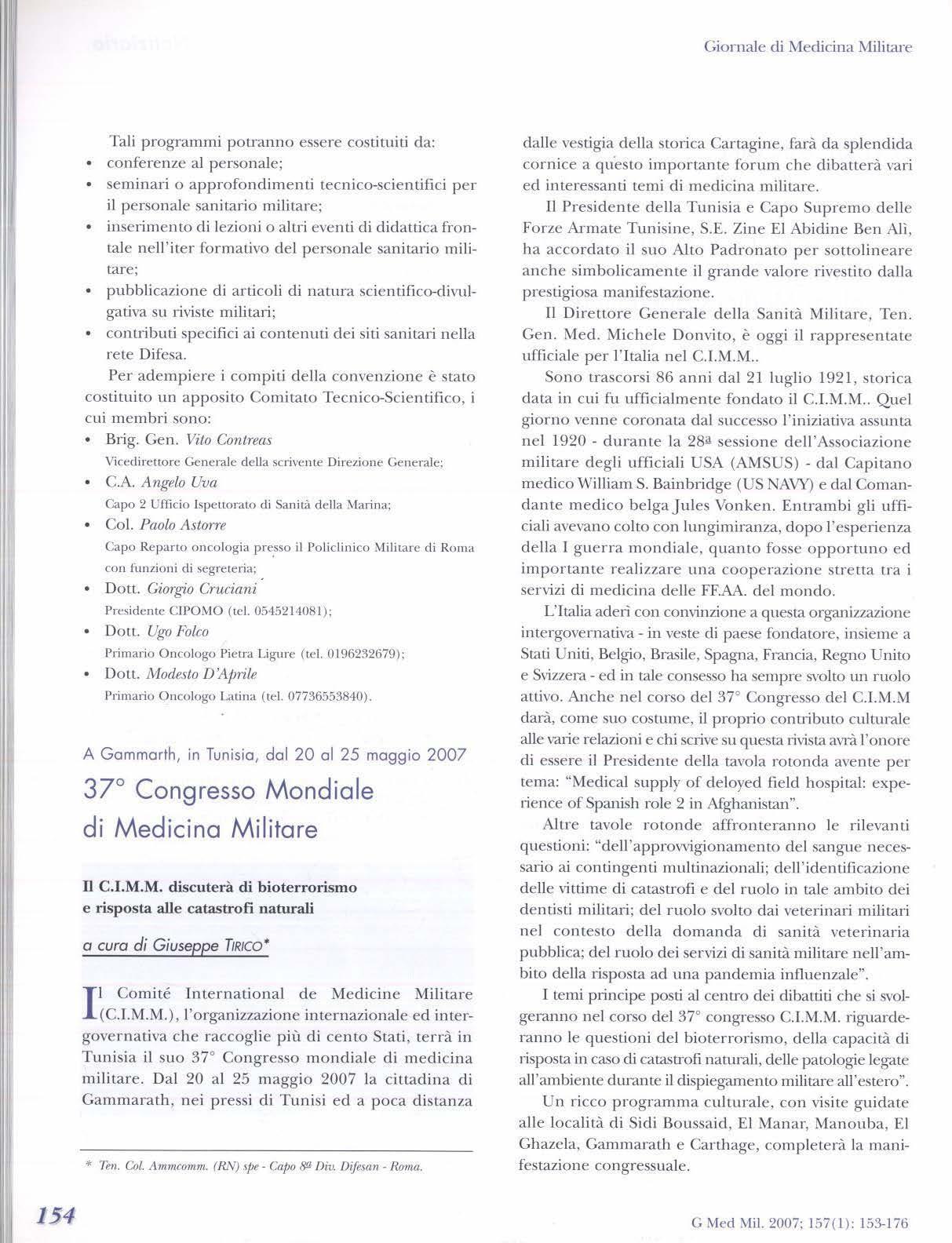
Il C.I.M.M. disc uterà di bioterrorismo e rispos ta alle c atastro fi naturali
o cura di Giuseeee TiRICO *
IlComité International de Medicine Militare (C.I. M.M.), l ' organizzazione internazionale ed intergovernativa che raccoglie più di cento Stati, terrà in Tunisia il suo 37 ° Congresso mondiale di medicina militare. Dal 20 al 25 maggio 2007 la ciuadina di Gammarath, nei pressi di Tunisi ed a poca distanza
Giornale di Medicina Milit.are
* Tn1. Col. 1lmmcmTLm. ( RN) ,pe- Capo 8'J Div. Difescm - Roma.
dalle vestigia della storica Cartagine, farà da splendida cornice a qu esto importante rorum che clibanerà vari ed interessami temi di medicina militare.
li Presidente della Tunisia e Capo Supremo delle Forze Annate Tunisine, S.E. Zine El Abidine Ben Alì, ha accordato il suo Alto Paclr onato per sottolineare anche simbolicamente il grande valore 1·ivestito dalla prestigiosa manifestazione.
Il Direttore Generale della Sanità Militare. Ten. Gen. Med. Michele Donvito, è oggi il rappresentate ufficiale per l'Italia nel C.LM.M
Sono trascorsi 86 anni dal 21 luglio 1921, storica data in cui fu unicialrnente fondato il C.I.M.M.. Quel giorno venne coronata dal successo l'iniziativa assunta nel 1920 - durame la 28a sessione dell'Associazione militare degli ufficiali USA (AMSUS) - dal Capitano medico William S. Bainbridge (US NAVY) e dal Comandante medico belgajules Vonken. Entrambi gli ufficiali avevano colto con lnngimiranza, dopo l'esperienza della I guerra mondiale, quanto fosse opportuno ed importante realizzare una cooperazione stretta tra i servizi di medicina delle FF.AA. del mondo.
L'Italia aderì con convinzione a questa organizzazione inte1·governaLiva - in veste di paese fondatore , insieme a Stati Uniti, Belgio, Bra5ile, Spagna, Francia, Regno Unito e Svizzera - ed in tale r.onsesso ha sempre svolto un ruolo attivo. Anche nel corso ciel 37° Congresso del C.l.M.M darà, come suo cosLUme, il prop1io conoibuco cu lturale alle v.:uie relazioni e chi scrive su questa rivista avrà l'onore di essere il Presidente della tavola rotonda avenLe per tema: "Medical supply o[ cleloyed field hospital: experience of Spanish rote 2 in Afghanistan".
Altre tavole rotonde affronteranno le rilevanti questioni: "dell'approvvigionamento del sangue necessario ai contingenti multinazionali; dell'identifìcazione delle vittime di catastrofi e del ruo lo in tale ambito dei dentisti militari; del ruolo svolto dai veterinari militari nf'I contesto della domanda di sanità veterinaria pubblica; del ruolo dei servizi di sanità militare nell'ambito della risposta ad una pandemia influenzale".
1 temi principe posti al centro dei dibattiti che si svolgeranno ne l corso del 37° congresso C I.M.M. riguarderanno le questioni del bioterrorismo, della capacità di risposta in caso di catastrofi naturali, delle patologie legate all'ambiente durante il dispiegamento militare all ' estero".
Un ricco programma culturale, con visite guidate alle località di Sidi Boussaid, El Manar, Manouba , El Ghazcla, Gammaraù1 e Carthage, completerà la manifestazione congressuale.
a cura di Alessandra .lAMPm1 •
I - Pre m essa
Il d.l gs 3 0 giugno 2003 , n . 196 in 1roduce nel nostro sistema legislatirn il t.u. in materia di pr i\ acy. intitola10 "Codi ce in ma ted a di pro tezione d i d ati p erso n ali".
A lungo all',picaco. tale ~trum<· ruo, non già meramente compilativo bensì innovativo, ha tradotto in norma positiva l'esistenza del di ritto della persona alla propria autodeterminazione informativa. enucleando al contempo un ulteriore diriuo ddla persona di rile\·a111a costituzionale. li diritto alla protezionf' dei dati personali viene così riconosciuto come diritto fondamentale ed autonomo. ed in seguito espressamente qualificato come uno dei diritti e delle libertà fondamemali cui si estende la garanzia coMitll7ionale di cui all'an. 2.
li nucleo fondamentale della 110\ i1à legislati\·a ,he LUtela i dati personali ronsistc nella pumuale e tassativa individuazione e nella maggiore rrote,.ione accordata ad una particolare categoria di dati, dt·finiti "se11sihili", cioè quelle informa1ioni riguardanti la sfera più intima dell'indi,iduo (he maggiormente incidono sullo S\ ilupµo e 1,ul libero esplicarsi della personalità, che possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scrilto dell'imeressato r previa autori1.Zazione del Garan1e. J dati sen~ibili <,i caratterizzano per la particolare capacità di incidere sulla riscrvate.ua dell"individuo cui si riferiscono e di determinare rischi di discrirnina1io11e sociale.
L'ar1. 4. primo comma , letL.d) del Codice drfinisce ~ensibili "i dati personali idonei a ri\'ela1e l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose lilosoliche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati. associazioni od organilza, ioni a carattere religioso, lilosofico, politico o sindacale. nonché i daci personali idonei a ri\'clare lo stato di ,alme e la vita sessuale".
Per ciò che invece auiene ai rapporti economici la legge non considera se11sibi li né meritevoli di dscrvate11a i dati idonei a n\·clare la siwa1ione patrimoniale o finanziaria dell'interessato.
Tutto ciò prt·messo va operata 1111a breve descrizione sistematica del Codice, che risulta suddiviso in tre pani di cui la p1ima contiene disposizioni generali, la seconda disposiLioni relati\-e a specifici seuori, mentre la terza riguarda la tutda dell'interessato e le san1io11i.
2 - Parte I - D isp os izioni ge nerali
Le disposizioni generali costitlliscono uu insieme di norme visle dal profilo passivo, iu quanto delìniscono gli strumenti di difesa dell'interessato a prescinder<· dal tito lare, e sono applicabili a tutti i soggetti, pri\'aci e pubblici.
In panicolare, gli ar1icoli eia 1 a 17 contengono le pre\'isioni generali e programmatiche, le definizioni. la disciplina dei diritti, delle loro modalità di eserci1io. nonché della loro tutela e risconrro, la rcdaLion(' dei codici di deontologia e cli buona condotta, l'obbligo di informativa, l'inversione dell'oocn' della prova (nel senso che la responsabilità è ei,clnsa ~e il soggetto pro,·a di a\er posLO in essere tutte le misure atte ad evitarlo). gli obblighi derivanti dalla tes:.azione del trattamento, la pote\tà del Gara1ne di individuare particola1 i categorie cli dati ordinari che. pott·ndo presentare rischi per i diritti e le libertà fondamentali, necessitino di spccilìca cautela nel trattanwnto.

• Fi111z \mm. Dot1.11a '2fl Sr.. - 7!! /)it ,i,i<mP-ff l<epar/11
Direc.fon, Gennai,• de/l(I \n111tà ,\f1hl111 e - Rnma.
C ~led \lii. 2007: 157 ( 1 ): 153-lìtì
Prima di passare alla disamina degli artt. 18 - 22. si segnalano t ra le disposizioni generali gli artl. 2830 ~ngli obblighi e le respomabilità del titolare, del responsabi le e de ll 'incaricato del trattamento; gli artt. 31 - 36 che pre\'edono obblighi finalinali alla sicurc11a dei dati e le nornre minime di sicureua; gli artL. 37 e 38 che contemplano l'obbligo di notifica7ionc a l Garame: l'art. 39. sulla comunica1ione dei dati tra soggetti pubblici, che prevede obblighi di comunicazione al Garantt': l'art. IO che sanci,ce la possibilità clell'emana1.ionC' cli au torizza.t.ioni generali relative a categorie di daLi o di ticolari di cui diremo in seguilo, l'art. 41 ciispom· che il titolare si avvalga di tali amori11azioni senza obbligo di richiederle perso11almentc; inlìnc, gli artl. -!2 - 45 che disciplinano il rra.,ferimento ùei dati al l'estero.
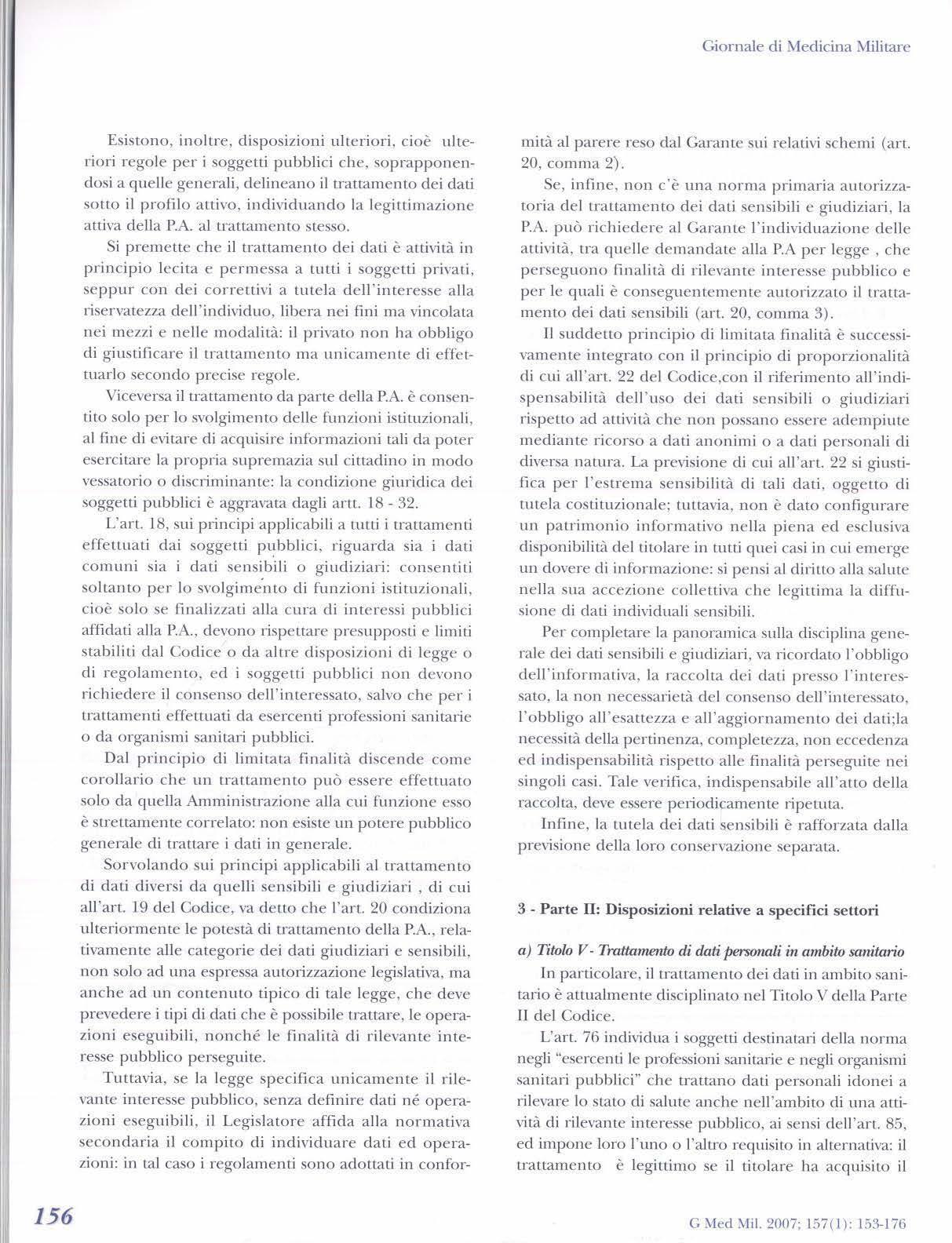
Esistono , in ollre, disposizioni ulteriori, cioè ulteriori regole per i soggetti pubblici che. soprapponendosi a quelle generali, delineano il trattamento dei dati sorto il profilo attivo, individuando la legitlimalionc attiva della P.A. al trattamPnro stesso.
Si premette che il trattamento dei dali è atti,,ità in principio lecita e permessa a tuui i soggetti privali, seppur con dei correui\'i a tutela dell'interesse a ll a riservatezza dell'individuo, libera nei fini ma vincolata nei mezzi e nelle modalità: il privato non ha obbligo di giusrifìcare il trattamento ma unicamente di effettuarlo secondo precise regole.
Viceversa il trattamento da pane della P.A. è consentito solo per lo svo lgimento delle funzioni istituzionali , al 6nc di evitare d i acquisire informazioni tali da poter esercitare la propria supremazia sul cittadino in modo vessatorio o discriminante: la condizione giuridica dei soggetti pubblici è aggravata dagli ant. 18 - 32.
L'a rl. 18, sui p1incipi applicabili a umi i trattamenti effettuati dai soggetri pubblici, riguarda sia i dati comuni sia i dati sensibili o giudiziari: consentiti soltanto per lo svolgime.nto di funzioni istituzionali, cioè solo se finaliZlati alla cura di interessi pubblici affidati alla P.A., dernno rispeuare presupposti e limiti stabiliti dal Codice o da altre disposizioni cli legge o di regolamento. ed i soggecti pubblici 11011 devono richiedere il consenso dell'interessato , salvo che per i trattamenti effeLtuati da esercenti professioni sanitarie o da organismi sanita1i pubblici.
Dal principio di limitata finalità discende come corollario che un trattamento può essere effettuato solo da quella Amministrazione alla cui funzione esso è strettamente correlato: non esiste un potere pubblico generale di trattare i dati in generale.
Sorvo lando sui principi applicabili a l trattamemo di dati diversi da quelli sensibi li e giudiziari , di cui all'art. J 9 del Codice, va detto che l'art. 20 condiziona ulteriormente le potestà di trattamemo della P A., relativameutc alle categorie dei dati gindiliari e sensibili, non solo ad una espressa amorizzazione legislativa, ma anche ad nn contenuto tipico di tale legge , che deve prevedere i tipi cli dati che è possibile trattare, le operazioni eseguibili, nonché le finalità di rilevante interesse pubblico perseguire.
Tuttavia, se la legge specifica unicamente il rilevante interesse pubblico, senza definire dati né operazioni eseguibili, il Legislatore affida a ll a normariva secondar ia il compito di individuare dati ed operazioni: in tal caso i regolamenti sono adottati in confor-
midi al parere reso dal Garante sui relativi schemi (art. 20, comma 2).
Se, inlìne , non c'è una norma primaria autorizzaroria ciel tra uamento dei dati sensibili e giudiziari, la P.A. può richiedere a l Garante l'individuazione dell e auività. tra quelle demandate alla P.A per legge , che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemenre autorizzato il trattamento dei dati sensibili (an. 20, comma 3).
Il sudcle uo p1incipio di limitata finalità è successivamente integrato con il principio di proporzionalità cl i cui all'art. 22 del Codice,con il riferimento all'indispensabilità dell 'uso dei dati sensibili o giudiziari rispetto ad atti,'ità che 11011 possano essere adempiute mediante ricorso a dati anonimi o a dati personali <li diversa narura. La previsione di cui all'art. 22 si giustifica per l'estrema sensibilità di tali dati. oggetto di tutela costituzionale; tuttavia , non è dato configurare un patrimonio informativo nella piena ed esclusiva disponibilità ciel tiLOlare in tutti quei casi in cui emerge Llll dovere di informazione: si pensi al diriuo alla salute nella sna accezione collPttiva che legittima la diffusione di dati individuali sensibili.
Per completare la panoramica sulla disciplina generale dei dati sensibili e giudiziari, va ricordato l'obbligo dell'informa1iva. la raccolta dei dati presso l'interessato. la non necessarietà del consenso dell'interessato. l'obbligo all'esattezza e a ll'aggiornamento dei dati ;la necessità della pertinenza, completezza, non eccedenza ed indi spensabilità rispeuo alle finalità p e rse g11ite nei singoli casi. Tale verifica. indispensabile all'ano della raccolta, deve essere pc1iodicamente ripeLuta.
Infine , la tutela dei dati sensibili è rafforzala dalla previsione della loro conservazione se parata.
3 - Parte Il: Disposizioni relative a spec ifici settori
a) Titolo V- Trattamento di dati personali i11 ambito sanitario
In particolare. il u-attamento dei dati in ambito sanir.a rio è atwalmenre disciplinato n e l Titolo V della Parte 11 del Codice.
L ' art. 76 individua i soggetti destinatati della norma negli "esercenti le professioni ~anitarie e negli organismi san itari pubblici'' che trattano dati personali idonei a rilevare lo stato di salute anche nell'ambito di 11na arLività di rilevante interesse pubblico, ai sensi d e ll'art. 85, ed impone loro 1'1111 0 o l'altro requisito in alternativa: il trattamento è legittimo se il titolare ha acquisito il
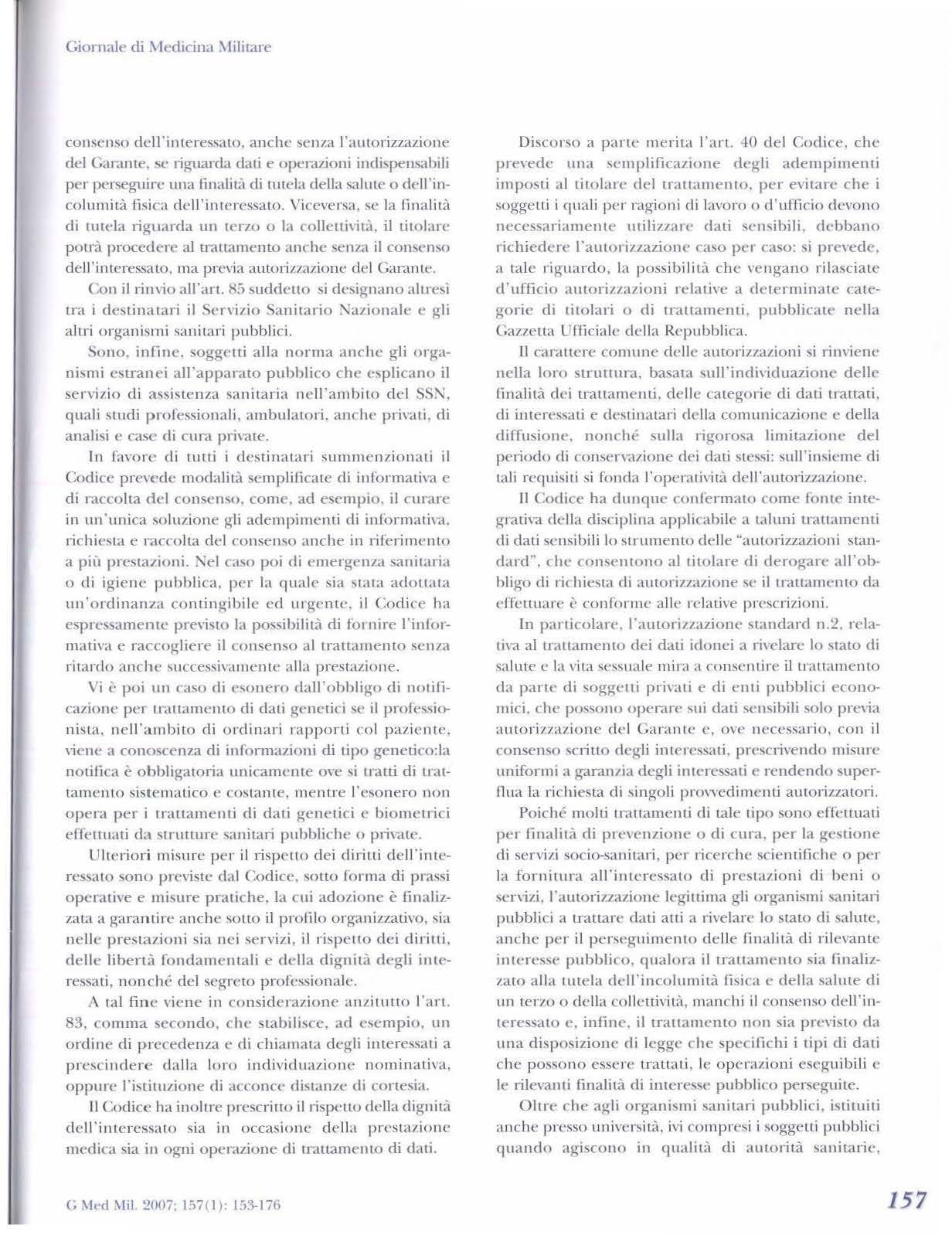
consenso dell'interessato. anche ~enza l'autorizzaLione ctcl Garante, ~e riguarda dati e openvioni indispensabili per perseguire u11a finalità di nncla della salute o ddl'i11columità lìsica clcll'intc-rcssaLO. Vicc\'ersa, M-' la fìnalità di 1uwla rigu,1r<ìa un 1erw o la colleui\ità. il titolarl' potrà procedere al trattamento anc-he sen,a il consenso dell'interessato, ma pre\'ia autmiaa, ione del Garante. Con il rimio atrart. 85 sudcteuo si designano alu esì tra i destina tari il Sen i,io Sanitario ~.11ionale e gli altri organismi ~anìtari pubblici.
';ono, infine, soggetti alla nonna anche gli organismi c~tranei all'apparato pubblico che esplicano il servi,io di assi~tenza s;initaria nell'ambito del SSN, quali studi professionali, ambulatori. anchP pri\'ati, di analisi e ca:.c di cura prirnte.
In favore di umi i dC'stinatari sumnH.• nzionati il Codice pre, <·de modalità semplificate di informatirn e di raccolta dd const-nso. come. ad esempio. il curare in un'unica solulione gli adempimenti di informativa, richi<'sl.a e rnccolta del consenso anche in riferimento a più prcsta.1ioni. Nel ca,o poi di emergt•nu.t ~ani1a,;a o di igiene pubblica, pPr la quale sia ~tata adouata un'ordinann contingibile ed urgrnte, il Codicc ha espn·,~amentc pre, isto la possibilità cti fornire l'informativa e raccogliere il consenso al Lrattamento sc11La ritardo anche successinuucnte alla prestazione.
Vi è poi un caso di <.>sonero chùl'obbligo di notificaLione per trattamento di dati genetici se il prolessi<>nista, nell'ambito di ordinari rapporti col palientc, ,iene a conoscenza di informa1ioni cli tipo genetico:la no1ifica è obbligatoria unicamcme m e si tratti di trattam<·nto sistematico e· co~tan cc, meni re l'esonero non opera per i 1rawrn1en1i di dati genetici e biometrici effe11t1ati da strutture sanitari pubbliche o p1;rnte.
U l ter i or i misnrc per il rispt>lto dei diritti dell'interessato sono previste dal C:odic('. sotto forma di prassi opcrative e tni-,ure pratiche, la cui adozione è finali1za 1a a garan 1irc anche sotto il profìlo org<1nizzativo, sia nelle presta,ioni sia nei sen i1i, il rispetto dei diriui, delle l ibertà fondam<'ntali e della digniLà degli interessati, nonché del segr<'to professionale. ,\ tal fine \'i<'IIC in consiclenuione a11Litutto l'an. 83, comma secondo, che stabili,ce. ad esempio. un ordine di precedenza e di cl1ianrn1a degli interessati a prescindere dal l a loro individuazione nominativa, opput e l'isciu11ione di acconce distanze cli conesia. li Codice ha inoltre prescritto il rispcllo della dignità del l 'i1ttcressal0 sia in occasione della prcsta,ione medira sia in ogni operazione di tn\ltamcnto di dati.
Discorso a partl' merira l'arL 40 del Codice, che pre,·edc una scmplifìca1ione degli adempimenti imposti al titolare del trauamenco, per e,-irare che i soggeui i quali ()C'I ragioni cli lavoro o d'ufficio dcvono necessariamente 11tiliua1C' dati sensibili debbano richieden• J'autorì11alione r,tso per raso: sì prnede , a tale riguardo. la possibilit.ì che H' ngano rilasciate d'ufficio autori11a,ioni relatin: a determinate categorie cli titolari o di u-attamenti, pubblicate nella Gazzetta Uflìciak della Repubblica.
Il carattere comune dl'lle autori11a1ioni si rinviene 11cl1<1 loro struct11ra. basata sull'indi, idua1ione clell(' finalità elci tr.iLtan1<'llli, dC'llc categorie di dati trauati, di iHtercssati e destinatari della comunicazione e della diffu~ione, nonché sulla rigorosa limiLa1ione del 1wriodo cli ronscr\'a.1ione dei <laù stessi: sull'imieme di tali requbiti si fonda l'operatività dell'antorimvione.
Il Codice ha dunque confem1ato come fonte imeg-rativa clclla disciplina applicabile a taluni trauamcnti di dati se11sibili lo strumenlo delle "aulo1·izza1ioni staudard'', chc consenwno al titolare di derogate all'obbligo di richiesta cli au1ori71a1ione se il trattamento da <'ITeuuare Ì? conforme alle relative prescririo11i. ln pa1t icolare l'autori11Mione ~candard n.2, relativa al tn\ltamcn10 dt'i dati idonei a rin lare lo :-tato di salute e la \'ila sc,suale mira a consentire il trallamcnto da pane di '>oggcui priva11 e di enti pubblici economici. che possono operar<' Mli daù '>cmibili wlo pre,ia autorizzaLione dd Garanre e, ove necessario, con il consemo ~critto degli interc.,sati, pre.,crivendo misure uniformi a garan,ia degli interessati e rendendo supernua la richiesta di ~ingoli prowedim<'nti autor-iaatori. Poiché molti trattamenti di tale tipo sono c-ff<'ttuati per finalità di pn: , enzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per rice1·cl1c ~cientifiche o per la fornitura all'interessato di presta1ioni di beni o ,eniLi. legillima gli organismi ~anitari pubblici a u-au.an· dati atti a ,;velar<' lo stato di salute, anche per il persegnimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, qualora il trauamcnto sia linali71ato alla tutela ckll'incolumità foica e della ,alllle di un ter;,o o della collettività, manchi il consenso dell'interessato e, infine, il trauameolO non sia pn·, iMo da una disprn.izionc di legge che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, Il- operuioni eseguibili <' le rilc\'anti fìnalit,ì di intcn:·\~e pubblico perseguite. Oltre che agli organismi ,anitari pubblici, i~ùtuiti anche pre~so uniwr~ità, ivi compresi i soggeui pubblici quando agiscono in qualità di autorità sanita,;c,
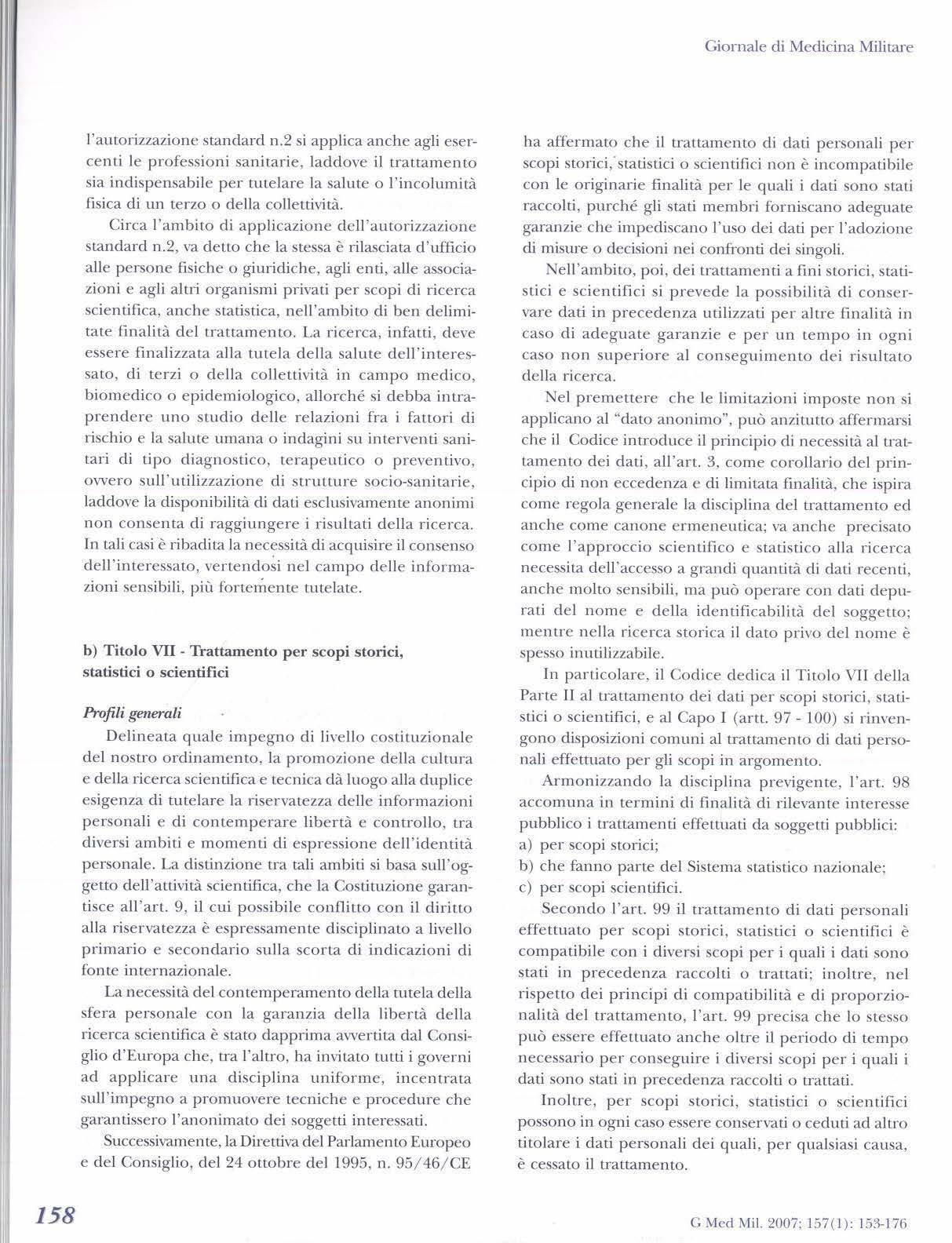
l'autorizzazione standard n.2 si applica anche agli esercenli le professioni sanitarie, laddove il trattamento sia indispensabile per tutelare la salute o l'incolumità fisica di un terzo o della co llettività.
Circa l 'amb ito di app li cazion e dell'autorizzazione standard n.2, va detto che la stessa è rilasciata d'ufficio alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, a ll e associazioni e agli alui organis mi privati per scopi di ricerca scientjfìca, anche statistica, nell'ambito di ben delimitate finalità del trattamento. La ricerca, infatti , deve essere finalizzata alla tutela della salute dell'interessato , di terzi o della co ll ettività in campo medico, biomedico o ep id emiolo gico allorché si debba inu·aprendere uno studio delle relazioni fra i fattori di rischio e la salute umana o indagini su interventi san itari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero su ll'utiliz zazi one di strutture socio-san i tari e. laddove la disponibilità di dati esclusivamente anonimi non conse11ta di raggiungere i risultati della ricerca. ln tali casi è ribadita la necessità di acquisire il consenso dell'interessato, venendosi nel campo delle info rmazioni sens ibili , più forterr1ente tutelate.
b) Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Profili generali
Delineata quale impegno di livello costituzionale del nostro ordinamento, l a promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica dà luogo a ll a duplice esigenza di tutelare la riservatezza d e lle informazioni personali e di contemperare libertà e controllo. tra diversi ambiti e momenti di espression e dell'idemità personale. La distinzione tra tali ambiti s i basa sull ' oggetto dell'attività scientifica, c h e la Cost illJZione garantisce all'art. 9, il cui possibile con ni tto con il diritto a ll a riservatezza è espressa.men te disciplinato a li ve ll o primario e secondario sul la scorta di indicazioni di fonte inte rnazi onale.
La necessità del contemperamento della tutela della sfera personale con la gara n zia della lib ertà della ricerca scientifica è stato dapprima avvertita dal Consiglio d'Europa c he , tra l 'a ltro, h a invitaLO tutti i governi ad applicar e una disciplina uniforme, inc e n trara sull'impegno a promuovere tecniche e procedure che garantissero l'anonimato dei soggetti interessati
Successiva mente, la Direttiva del Parl a.me nto Europeo e d e l Consiglio, del 24 ottobre del 1995, n. 95 / 46 / CE
ha affermato che il trattamento di dati personali per scopi storici; statistici o scientifici non è incompatibile con le originarie finalità per le quali i dati sono stati raccolti, purché gli stati membri forniscano adeguate garanzie che impediscano l'uso dei dati per l'adozione di misure o decisioni nei confronti dei singoli.
Nell'ambito, poi , dei trattamenti a fini storici, statistici e scientifici si prevede la possibilità cli conservare dati in precedenza utilizzati per a ltre finalità in caso di adeguate garanzie e per un tempo in ogni caso non superiore al conseguimento dei risultato della ricerca.
Nel premettere che le limitazioni imposte non si applicano al "dato anonimo·•, può anzitutto affermarsi che il Codice in troduce il principio di necessità al trattamento dei daLi, all'art 3, come corollario del p1incipio di non eccedenza e di limi tata finalità. che ispira come regola generale la disciplina del trattamenr.o ed anc h e come canone ermeneutica; va anche precisato come l'approccio sciemi1ìco e statistko al la 1·icerca necessita dell'accesso a grandi quantità di dati recenti, anche molto sensibi li , ma può ope r are con dati depurati del nome e della identificabilità del soggetto; mentre nella ricerca storica il dato privo del nome è spesso inu tilizzabile.
In particolare , il Codice dedica il Titolo VTT della Parte 11 al trattamento dei dati per scopi storici, statisLici o scientifi ci, e al Capo 1 (artt. 97 - 100) si iinvcngono disposizioni comuni al trattamento cli dati personali effettuato per gli scopi in argomento.
Armonizzando la disciplina previgente, l'art. 98 accom un a in termini cli lìnalità di rilevante interesse pubb li co i trattamemi effettuati da soggetti pubblici: a) per scopi storici; b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale: c) per scop i scienillìci.
Secondo l'art. 99 il trattamento di dati personali effet tuato per scop i storici , statistici o sc ient ifi ci è compat ibil e con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati; inoltre , nel rispetto dei principi di compatibilità e di proporzionalità del trattamento, l'art. 99 precisa che lo stesso può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
Inoltre, per scop i storici, stat istic i o scie ntifi ci possono in ogni caso essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati persona li dei quali. per qualsiasi causa, è cessato iJ trattamento
Alla stregua, infine, dell'art. J00 i soggctù pubblici. ivi compresi le università e g- li cnli di ricerca, possono con autonome dctcrmina1ioni comunicare e diffondere , anche a privati e per \'ia tclematic'a. a laureati, dottori di ricerca, docenli, esperti e swdiosi, dati relativi ad attivi t à di m1dio e di ric'erca ad esclusione di quelli semibili o giudiziari.
Trattame nto per sco pi s tatisti ci o scie ntifi ci
TI Capo III (arcr. I 04- 109) è dedicato al tr.mamento di dari personali effettuato per scopi statistici o, in quanco rompaùbili, per scopi scientifici.
L ' art. 105 semplifica l'obbligo di infonnatfra. stabilendo che se specifiche circostanze. indi,iduatc• dai rispeuivi codici di deonto logia, sono ra li da consentire ad un ,oggetto di I ispondere in nome e· per conto di un familiare o comi, cnte, l'info r mati,-a è ,-alidamente prestata anche per il tramite clt:l soggetto legittimato alla rispo~ta. Tale semplifica1ione può applicarsi, per esempio, in occasione del 1ile\'amento di dati statistici a fini di censimento della popola1ione.
L'inlormatiYa 11011 è don1ta, inoltre, nel caso di trattamento di dati in origine raccolti per allri scopi. quando richiederebbe uno sforzo sproporzionato 1·ispet10 al diritto tutelato, purché \'engano adouate idonee forme di pubb licità alternative, pre"istc nei codici deontologici.
L'an . J 10 riguarda il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato cli salme per scopi di ricerca srienti fìca in campo med ico, biomedico o cpidemiolo-
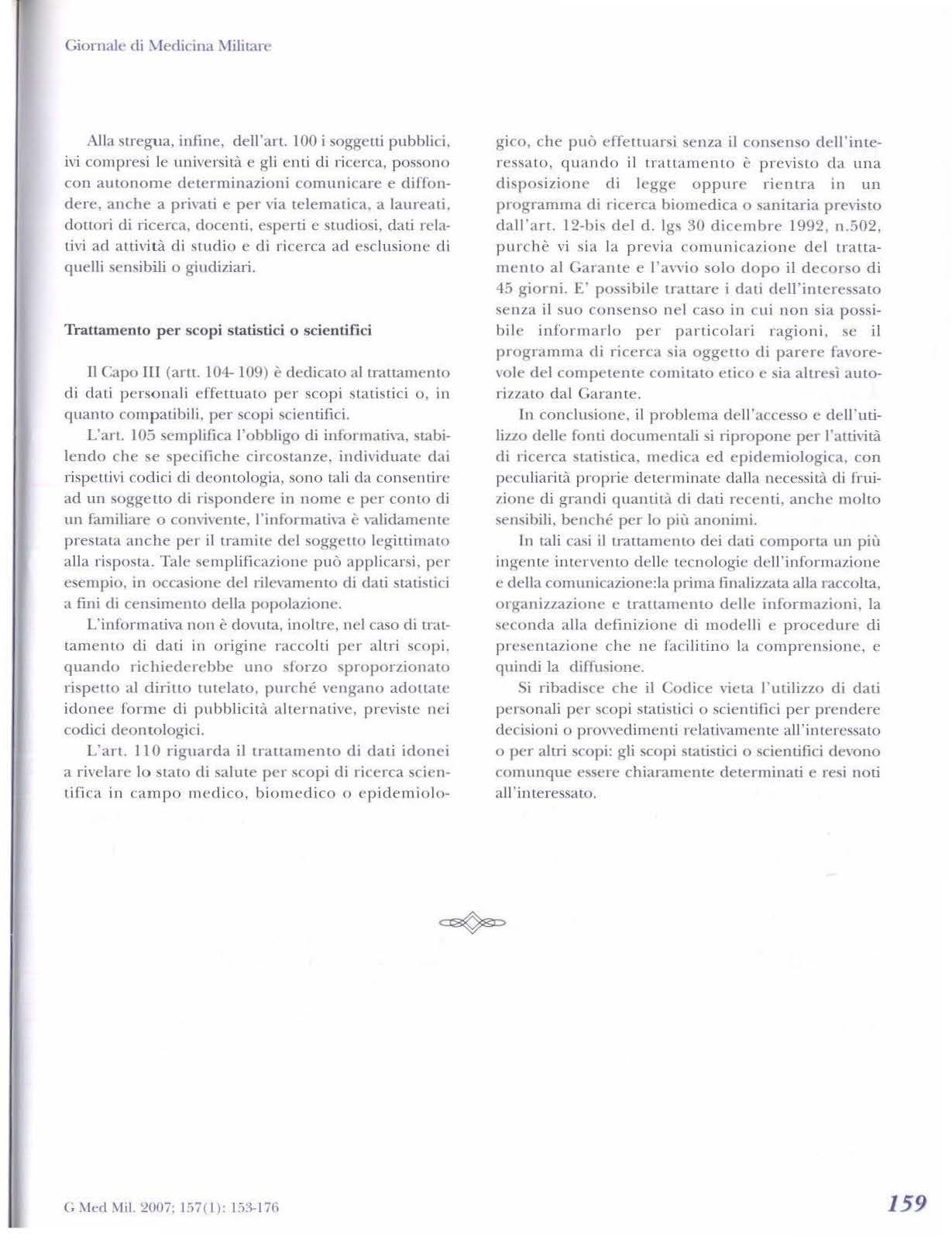
gin>, che può effettuarsi senza il consenso dell'interessato, qu;indo il trattamento è previsto da una disposizione cli legge oppure rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria pre,·isto dall'art. 12-bi'> del d. lgs 30 dicembre 199~. n . 502. pur chè ,·i sia la pre,•ia co111unica1ione del trattamento al Garame e l'awio solo dopo il decorso di 45 giorni . E' possibile trattare i d a ti deirintcressato senza il suo consenso ne l caso in cui non sia possibile informarlo per particolari ragioni, se il programma di ricerca sia oggetto di parere fa, ore,ole de l competente comitato etico e sia al!resì autoriaato dal Garante.
In conclusione, il problema dell'accesso e dcll'utili110 delle fonti documentali si ripropone per l'atti,ità cli ricerca swtisùca. medica ed epidemiologica, con pl'<' uliarità propri.e determinate dall,1 necessiùt di frni1ione cli grandi quamità di dati rc<.:enti, anche molto ,emi bili, benché per lo più anonimi.
In tali ca~i il trattamento dei dati comporta un più ingenle intervento delle tecno logi<' dcll'inforn1a1.ione e della comu11ica1ione:la prima finalizzata alla raccolta, organinazionl' e trauanH.' uto delle informa,ioni. la seconda alla ddìni7ion<• di modelli e procedure di presentazione che ne facilitino la comprensione, e qui11di la diffmione.
Si ribadi, c e che il Codice , ieta l'utilizzo cli dati pcr~onali per scopi statistici o scientifici per prendere decisioni o provvedimenti relatÌ\"amcme all'interessato o per altri ~copi : gli scopi ~latisùci o scientifici devono comunque e!>serc chiaramente determinati e re~i noti all'illleressalO.
a cura di Marco CANNAVICCI•
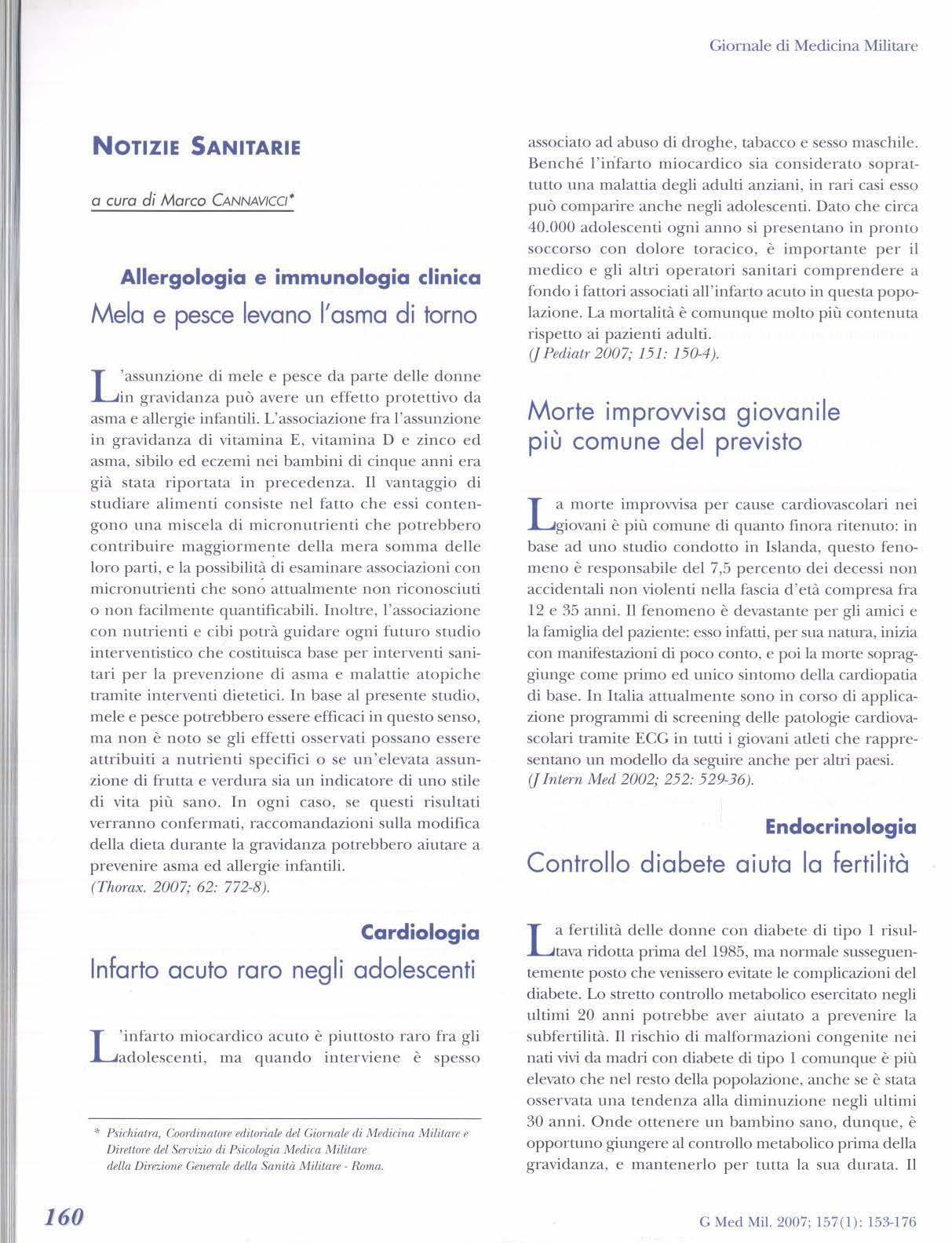
Allergologia e immunologia clinica
Mela e pesce levano l'asma di torno
L' assunzione di mele e pesce da parte delle donne in gravidan,:a può avere un effe no protettivo da asma e allergie infauùli. L'associazione fra rassuuzione in gravidanza di vitamina E. vita min a D e zinco ed asma. sibilo cd eczemi nei bambini di cinque anni era g ià stata riportata in precedenza. Il rnntaggio di studiare a lim enti consiste nel fatto che essi contengono una miscela di micronutrienli che potrebbero contribuire maggiormeme della mera somma delle loro parti, e la possibilit~ di esaminare associazioni con micronutrienti che sono attualmeme non riconosciuti o non facilm ente quantificabili. hioltre, l ' associazione con nutrienti e cibi potrà guidare ogni futuro studio interventistico che costi tuisca base per interventi sanitari per la prevenzione di asma e malattie atopiche tramite interventi dietetici. In base al preseme studio, mele e pesce potrebbero essere efficaci in questo senso, ma non è noto se gli effetti osservali possano esse r e attribu iti a nutrienti spec ifi ci o se un'elevata assunzione cli frutta e verdura sia un indicatore di uno srj le di vita più sano. In ogni raso, se questi risultati verranno confermali, raccomandazioni su ll a modifica della dieta durante la gravidanza potrebbero aiutare a prevenire asma ed alle r gie infanlili. (Tlwrax. 2007; 62: 772-8 )
Infarto acuto raro negli adolescenti
L'infarto miocardico acuto è piuuosto raro fra g li ado lescenti, ma quando interùene è spesso
* Psu hù,tra, Coortli11atnrr ediLmù,IR del GwrnalP di ,\/ed fr i,w MilitarP P Oil'Pllor, del Srrr1izio di Psirolof!:in MPdim Militare del/li Di1nìm1e Genemf,, dfllll Sanità Militare - Ho11111. Giornale
associato ad abuso dì droghe, tabacco e sesso maschile. Benché l' i rifano miocardico sia considerato soprattutto una malatùa degli adulti anziani, in rar·i casi esso può comparire anche negli adolescenli. Dato che circa 40 000 adolescenti ogn i anno si presentano in pronto soccorso con dolore toracico. è impanante per il medico e gli altri operatori sanitari comprendere a fondo i fattori associati all'infarto acmo in questa popolaz ione. La mortalità è comunque molto più contenuta rispeuo ai pazieuti adulti.
U Pediatr 2007; 151: 150-4).
più comune del previsto
La morte unprovvisa per cause cardiovascolari nei giovani è più comune di quanto finora ritenuto: in base ad uno studio condotto in Islanda questo fenomeno è responsabile del 7,5 percenLo dei decessi non accidentali non violenti nella fascia cl'et.1 compresa fra 12 e % anni. Il fenomeno è devastante per gli amici e la famiglia del paziente: esso infa.tli, per sua natura , inizia con manifestazioni di poco conto. e poi la mone sopraggiunge come primo cò unico sintomo della cardiopatia di base. In ltalia attualmente sono in corso cl i applicazione programmi cli screening delle patologie cardiovascola1i tramite ECC in tuLLi i giovani atleti che rappresentano un modello da seguire anche per altri paesi. (f lnlern Med 2002; 252: 529-36).
La fenilità delle donne con diabete cli tipo I ris11ltava ridotta pl'ima del 1985, ma normale susseguentememe posto che venissero evitate le comp licazion i del diabete. L o stretto controllo metabolico esercitato negli ultimi 20 ann i porrebbe aver aiutato a prevenire la subfcrtilità Il rischio di malformaLioni congenite uei nati vi"i da madri con diabete cli tipo 1 comu11que è più elevato che nel resto della popolazione, anche se è stata osservata una tendenza a lla diminuzione negli ultimi 30 anni. Onde ottenere un bambino sano, dunque , è opportuno giungere al contro ll o metabolico prima della gravidanza. e mantenerlo per tutta la sua durata. li

presente studio, comunque, è stato svolto in Svezia, e non è opportuno generalizzarne i risnltati a tulla la popolazione mondiale per via delle differenze nella qualità dell'assistenza medica e nelle strategie di coutrollo del diabete.
(Diabetes Care 2007; 30: 2271 - 6).
Benchè le complicazioni della fase terminale abbiano l'impatto più negativo su ll a qualità della vita dei pazienti diabetici , per molti di essi il trattamento completo, comprensivo del con trollo intensivo dei fauori di rischio multipli, vi s i avvicina molto. Un'impanante minoranza dt>i pazienti pensa infatti che questi trattamenti abbiano un impallo negativo :mila qualità della vita paragonabile a quello delle complicazioni, e questo rappresenta un dato nuovo.
Quasi LUtti i medici praticanti conoscono in prima persona le sfide dell'assistenza ai paz.iemi diahetici, ed il presente stndio in capsula le difficoltà che si incontrano 11cll'educazione del paziente: q~li deve essere informato molto precocemente sulle realtà della terapia d e l diabete. e sopra t tullo sul fatto che nel tempo saranno necessari molti medicinali onde controllare in modo ottimale la glicemia, la pressione ed i livelli di colesrerolo e prevenire le complicazioni che sono talvolta asintomatiche. (Diabetes Care 2007; 30: 7-6).
L' e lastografia ecografica risulta promettente per la previsione d e lla malignità dei noduli tiroidei. Tali noduli sono comu ni , e la grande maggioranza di essi è cli natura benigna: solo meno del cinque percento sono maligni. I noduli più fissi e so lidi sono maggiormente a rischio di malignità, ma ciò è altamente soggettivo e dipendente dalle esperienze dell ' esam inatore. Sono necessari ulteriori s tudi in materia , ma l'elastografia ecografica sembra avere un grande potenziale quale nuovo strumento per la diagnosi dei tumori tiroidei , soprattutto per quanto 1iguarda i noduli citol ogicame nte incerti. UClin Endocrino/ Melab 2007; 92: 2917-22).
Un breve periodo di depriYazione del sonno causa variaLioni nella regolazione ormonale de l glucosio, con un forte effetto sul l a secrezione delle insule pancreaLiche, una diminuzione nei livelli di glucagone e una lieve riduzione nei livelli di peptide C. Il presente studio supporta fortemente la nozione secondo cui il sonno svolge un ruolo chiave nella regolazione delle funLioni metaboliche nell'uomo. La deprivazione del sonno incrementa marcatamente l'appetito durante il riposo basale, determinando un incremento relativo attenuato dnrante l ' ipogUcemia. Nonostante le distinte alterazioni nell'attivit.à secretoria basale, l'ampiezza assoluta della controregolazione ormonale e la risposta dell'appetita all'ipoglicemia non risulta inf1uenzata dalla deprivazione del sonno. L'appetito rappresenta un importante segnale d ' allarme per l 'ipoglicemia emergente , stimolando un'assunLione di cibo che contrasti un ulteriore declino nei livelli di glucosio circolante: una riduzione dell'abilità d percepire adeguatamente incrementi dell'appetito che si aggiungono all 'imp atto oressigeno della mancanza cli sonno di per sé potrebbe incrementare il rischio di grave ipoglicemia nei pazienti in debito cli sonno. La significatività fisiolùgica di questi dati e la loro correlazione con l'interazione fra debito di sonno cronico e disordini metabolici come obesità e diabete di tipo 2 rimangono ancora da stabilirsi.
U Clin Endoc,in Metab 2007; 92: 3044-51).
Ipazienti con encefalopatia epatica minimale (MHE) riportano un maggior numero di incidenti su·adali e violazioni rispetto al resto della popolazione. I medici che assistono i pazienti con cirros i dovrebbero dunque essere consapevo li dell'epidemia nascosta di MHE che met.te in pericolo sia il paziente che gli altri guidatori con cui interagisce, in generale, i pazienti cirrotici che non bevono a t tivamente dovrebbero sempre esse re interrogati sull a propria st0 ri a a lla

guida. Il presente swdio suggerisce che i pazienti con MHE abbiano diverse aree cli clisfonzione cogniLiva che li rende propensi a guidare negligentemente.
Fibre , lattulosio e probiotici sono in grado di beneficiare i pazienti con MHE, e pertanto i rischi alla gu ida dei pazienti che ne sono affetti sono in teoria passibili di trattamento efficace.
(Am]Gastromterol 2007; 102: 1903-9f' 1910-1).
Ipiù recenti. regimi chemioterapici garantiscono ai pazienti con tumori colorettali avanzati chiari benefici addizionali nel ri tardo della progressione della malattia e n e l prolungamenLO della soprawivenn, ma le combinazioni polifarmaccutiche portano a un aumento della tossicità. Sono necessarie ulteriori analisi per valutare il rapporto toss icità/ beneficio per queste terapie: il presente stud io in tal senso s i propone di fornire le basi per g li stud i futuri: i progressi nell'arca sono chiari e ben definiti, ma le incertezze ancora esistemi suggeriscono che i dati non sono ancora suflìcienti. specialmente per le terapie più recenti.
(Lanret Onco{ online 2007, pubbliratf' il 20/9)
La tempistica e l'ordin e di comparsa di cinque anticorpi assoc iati a l morbo ce li aco s u gger iscono c h e potrebbero esservi implicati fauori scatenanti diversi dal g lutin e nella dieta, almeno in parte, per la comparsa della forma clinica d e ll a malattia. Un'ampia minoranza dei pazienti inoltre presenta una transitoria o fluttuante posi Lività ad uno o più dei cinque anticorpi senza alcuna variaz ion e nella dieta: ciò significa c he il sistema immunitario in metà dei casi è in grado di curare la malauia o almeno es tin guere l 'autoimmuni Là correlata a ll e transglutaminasi senza l'e sclus i one del g lutin e dalla dieta. Basare l'esofagogastroduodenoscopia sulla base della positività agli anticorpi AGAIg C o ACA-IgA potrebbe risparmiare molte analisi non necessarie. (Am] Gastromterol 2007: 102: 2026-35).
La terapia cogn iti vo -comportamentale (CBT) ha un effetto diretto sul miglioramento complessivo dei sintomi gastrointestinali nei pa7ienti con colon irritabile, indip endentemente dai suo i effetti sullo stress: il miglioramento di questi sintomi è connesso a miglioramenti della qualità della vita, il che potrebbe diminuire lo stress. Benché molteplici studi cl in ici supportino l'efficacia dei trac1amen ti ps icologici per la ricluLione dei sintomi del colon irritabile, il meccanismo responsabile cli questi micrlioramenti era rimasto finora sconosciuto. Il falli- ,, mento delle semplici var iazion i dello sc.ile di vita non deve dunque rar perdere le speranze al paziente. La limilazione della tecnica consigliata comunque consisle nel fauo che essa richiede visite mediche settimana li per IO settimane: la vera sfida è sviluppare u11 sistema che possa essere sfruttato al di fuori dell'ambito clinico.
(Gastroenterology 2007; l33: 433-44).
Secondo un rnodell~ _a~imale. lo stre~s acuto incr_cmenta la permeabil1ta esofagea e dilata lo spazio intercellulare. La fisiopatologia e la generazione dei sintomi nel reflusso gas tro esofageo sono multifauoriali, e lo stress può rappresentare un componente importante dell ' a lgor itm o. La permeabilità mucosa.le indo tta dallo stress, che consente l'incremento dell'espos i zione delle lerminalioni nervose sensoria li a i contenuù gastrici rcfluiti, potrebbe contribuire all'esacerbazione dei sintomi sia in presenza che in assenza cli e r os ion i in pazienti con esposizion e all'acido nel lum e esofageo altrimenti normale. Gli autori sperano di comprendere meglio i meccanismi fisiopatologici che sp ie gano i sinwmi nei pazienti con rcilusso non erosivo cd in quelli con reflusso refrattario agli inibitori della pompa prot0nica. Se lo stress incrementa la permeabilità della mucosa e pertanto influenza la percezione dei simomi del reflusso, ciò potrebbe cosùtuire un target terapcuùco nei pazienti con rellusso difficile da u·attare.
(Gut 2007; 56: 1191-7).
Vaccino poco influente sugli anziani
Glianziani potrebbt>ro u-arre un beneficio scarso o nullo dalla vaccinazione annuale contro l'influenza. l programmi di vaccinazione tenlano di diminuire la mort,ùità connessa all'inll11enza mirando ai soggetti dai 65 anni in sù per la v<1.ccina1.ione, ma l'efficacia di questa strategia è oggetto di dibattito: benchè diversi sntdi climosui no l'efficacia del vaccino negli adulti più giovani , pochi di essi hanno incluso soggetti più anziani, e speciétlmente quelli al di sopra dei 70 anni. In auesa di prove più certe, i soggetti anziani dovrebbero comunque continuare a 1·icevere iJ vaccino: l'influenza causa ogni anno molti decessi. ed anche un vaccino parzialmente efficace è comunque meglio di nessun vaccino. La rivalutazione delle probabili conseguenze della senescenza immune richiederebbe in ogni caso il vigoroso perseguimento di altre opzioni. (LanCPI Inferi Dis. 2007; 7: 658-66).
I PUFA n-6 contro l' HIV
IPUFA n-6 a catena lunga nel latte mammario possono diminuire il sischio di trasmissione clell'IIIV tramire l"aJlattarnento. Anclw i livelli di acido arachiclonico e linoleico presentano una correlazione inversa con la d iffusione del virus nel latte materno, mentre l'acido ]aurico e pent.adecanoico non è associato alla trasmissione madre-lìglio. e gli acidi gras.5i u--an<; sono correlati ad una maggiore diffusione del virus associato a cellule e non. L ' efTetw dell'integrazione cli alcuni alimenti in questo ambito va prima Lestaro in studi clinici randomizz.aù, ma è possibile effettuare l"inLegrazione tramite PUFA n-6 a care na lunga preformaù o con olii vegetali a basso costo 1icchi in quesù composti. (A111} Clin Nu!:r 2007; 86: 682-9).
Hiv infantile:
comune l'epatite cronica
L'epatite Be C è comune nei bambini con infezione da I-liv, che dovrebbero ricevere uno screening cli
routine per queste infezioni. Benchè bambini ed adolescenri co11 Hiv stiano vivendo vite più lunghe e sane, vi è una certa caren7a di ricerca sulla gestione dell'epatite cronica nei bambini. TI basso numero di casi documentati di infe7ione cronica da Hcv nei gruppi di bambini più piccoli espos1 i all'Hiv riflette !"effetto dello screening universale dei donatori di sangue e l'espansione dell'uso della terapia HAART in gravidanza. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito ad una rimarchevole diminu7,ione del tasso di acquisizione pt>rinatale delle infezioni da Hbv ed I kv, ma ciò nonostante, dara l'elevata prevalenza della coinfezione documentata nel preseute studio, sarebbe prudente effettuare LlllO screening di tutti gli adolescenti con I-liv per !"epatite virale. Tali coinfezioni sono comunque probabilmente molto più comuni in Africa ed in Asia , a causa dell'impossibilità di controllare i prodotti ematici e della mancanza cli accesso alla vaccinazione anti-Hbv.
(Clin lnft'rl Dis 2007; 45: 795-8).
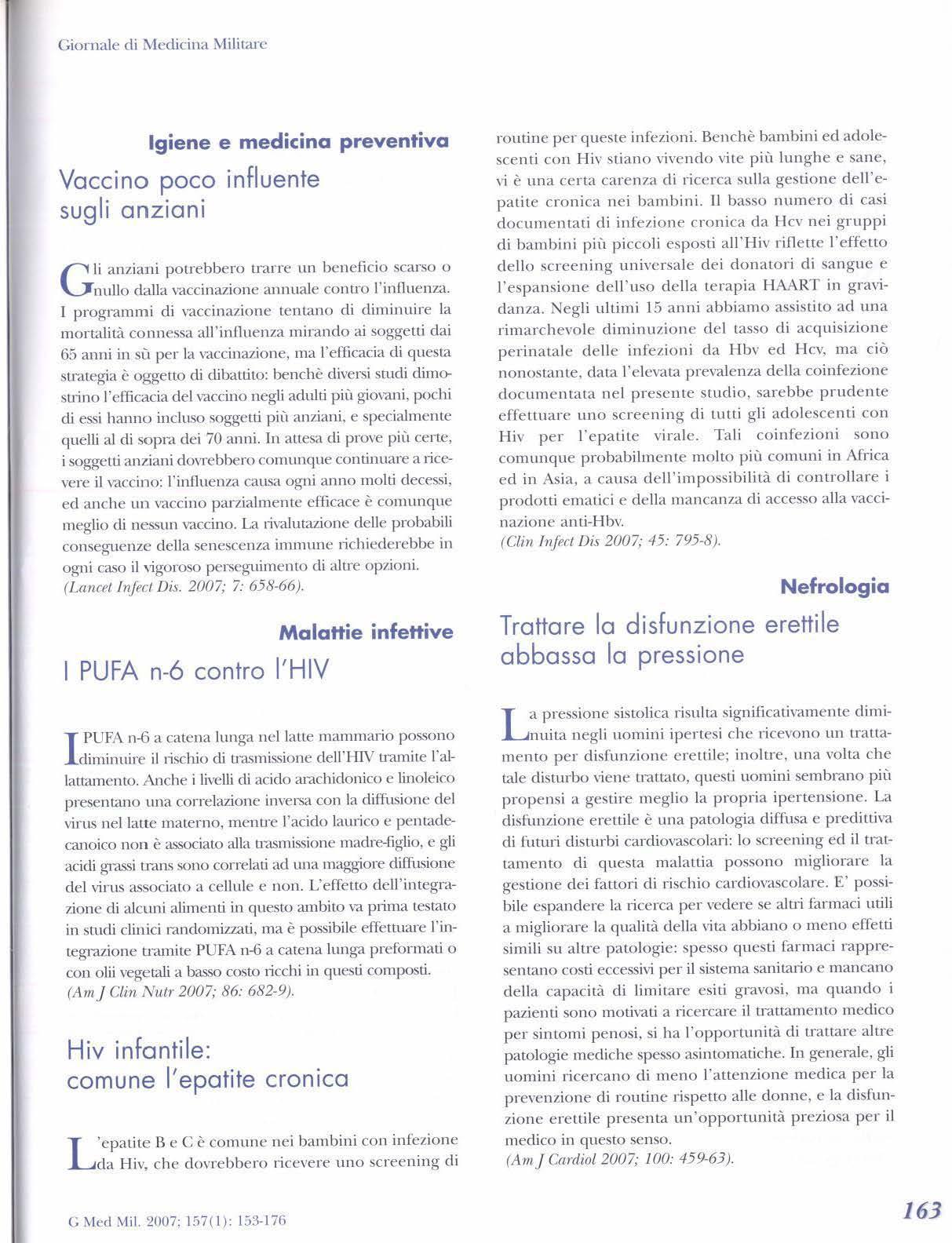
Trattare la disfunzione erettile abbassa la pressione
Lapressione sistolica risulr.a significati\"amente diminuita negli nomini ipertesi che ricevono un trattamento per disfunzione erettile; inoltre, una volta che tale clistnrbo viene trattato, questi uomini sembrano più propensi a gestire meglio la propria ipertensione. La disfunzione erettile è una patologia diffusa e predittiva cli futuri disturbi cardiovascolari: lo screening ed il trattamento di questa malauia possono migliorare la gestione dei fattori cl i rischio cardiovascolare. E' possibile espandere la 1icerca per \"edere se altri farmaci utili a migliorare la qualità della ,~ta abbiano o meno effetti simili su alu-e patologie: spesso questi farmaci rappresentano costi eccessivi per il sistema sanita1io e mancano della capacità di limitar<' esiti gravosi. ma quando i pazienti sono motivati a i-icercare il trattamento medico per sinLomi penosi. si ha l'opportunità di Lrartarc alU"e patologie mediche spesso asintomaùche. In generale, gli uomini ricercano di meno l ' attenzione medica per la prevenzione di routine 1ispetto alle donne , e la disfunzione erettile presenta un ' opportunità preziosa per il medico in questo senso.
(Am J Cardiol 2007; ZOO: 459-63).
BMI e declino cognitivo in età avanzata
Non ostante l'associazione fra obesità ed incremento del rischio di ipertensione, diabete e malattie cardiovascolari. un elevato BMT in età anziana non è preditùvo di declino cognitivo. l risultati del presente studio infatù dimostrano l'assenza di variazioni signilìcative nella memoria o nella funzionalità cognitiva nell'arco di sei anni nei soggetti in sovrappeso o obesi: anzi, i soggetti con minor BMI presentano un maggior declino cognitivo nell'arco dello stesso pc1iodo: i motivi di questo fenomeno non sono noti, ma essere sottopeso può essere correlato ai primi stadi del morbo di Alzheimer.
(Neurology online 2007. pub{llicato il 19/9)
Il gene GBA è un gene di suscettibilità al morbo di Parkinson, e le mutazioni a suo carico incrementano il rischio di forme ad esordio precoce della ma lattia. li 14 percento dei palienti parkinsoniani è portatore di mutazioni GBA, rispetto al cinque percento dei soggeuj senza la malattia. Ino l tre la mlllazione è stata riscontrata nel 22 percento dei pazienti che hanno sviluppato la malattia prima dei 50 anni e ne l I O percento di quelli in cui si è presentata dopo tale soglia. li presente studio apre una nuova direzione per la r icerca, e potrebbe in ultima analisi portare allo sviluppo di nuove terapie. Sono necessari ulteriori studi su popolazioni più ampie e su famiglie per determinare con precisione rischi e penetranza prima che vi possa essere una qualche applicabilità clinica, ma ciò nonostante il gene GBA potrebbe unirsi ai geni parkin e LRRK2 quale agente principale nell'eziologia de l morbo di Parkinson. (Neurolog;y. 2007; 69: 1270-7).
Un 'attenta selezione dei pazienti migliora ampiamente le probabilità che una rizotomia dorsale selettiva (SDR) possa risultare di beneficio nei bambini con paralisi cerebrale. Tre diversi studi precedenti avevano già dimostrato che la SDR riduce la spasticità degli ani, ma i miglioramenti funzionali a lungo termine erano risultati \'ariabili: tale va1iabilità nei risultati potrebbe essere dovutil a dirferenze nella selezione dei pazienti e nella valutazione degli esiti. L' intervento di fatto non è una panacea per la diplegia da paralisi cerebrale, e non va visto in quest0 modo In base al presente studio, molti dei bambini operati tendono ad aumentare di peso dopo l' intervento in misura proporzionale alla spasticità iniziale: ciò potrebbe essere dovuto al fiuto che la spasticità di per sé porta al consumo di calorie , e le famiglie dunque devono essere pronte a effettuare una restrizione calorica dopo l'intervento. (Arrh Dis Child 2007; 92: 781 - 5).
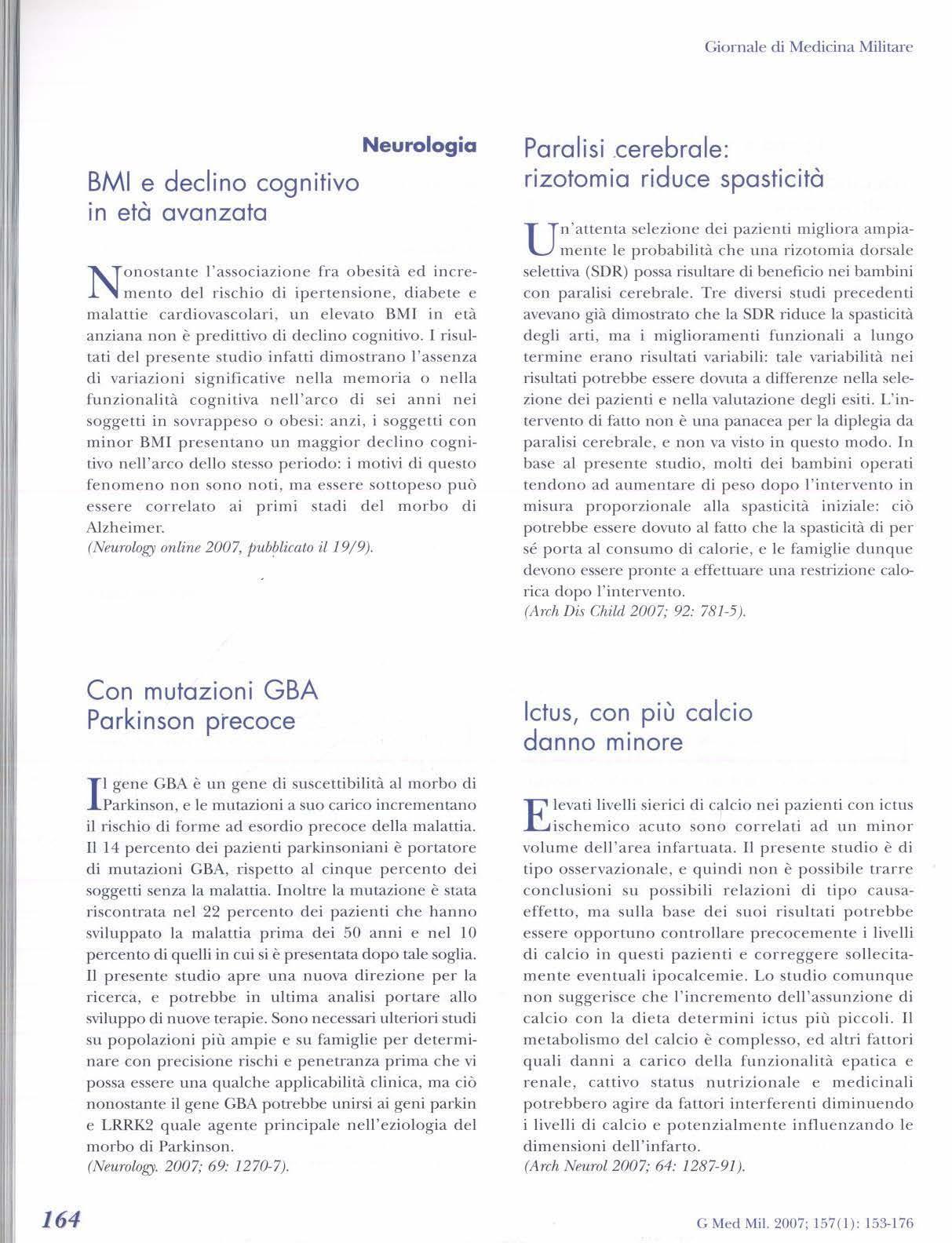
Ictus , con più calcio danno minore
Elevati livelli sierici di calcio nei pazienti con ictus ischemico acuto sono correlati ad un minor volume dell'a1-ea infanuala. Il presente srudio è di tipo osservazionale, e quindi non è possibile trarre conclusioni su possibili relazioni cli tipo causaeffetto, ma sulla base dei suoi risultati potrebbe essere opportuno controllare precocemente i livelli di calcio in questi pazienti e correggere sollecitamente eventuali ipocalcemie. Lo studio comunque non suggerisce che l' incremento dell'assunzione di calcio con la dieta determini ictus più piccoli. li metabolismo del calcio è complesso , ed altri fattori quali danni a carico della funzionalità epatic-a e renale, cattivo status nutrizionale e medicinali potrebbero agire da [atto1i interferenti diminuendo i livelli di calcio e potenzialmente influenzando le dimensioni delrinfarto.
(Arch Nrurol 2007; 64: 1287-91 ).
Intcnenti componamencali personaliuati p ossono migliorare lo screening rlei tumori colorellali in m edicina cli base. 1 ta:>si cli scrren in g di ciuesò tumori sono in a11mc11to. ma no11 quanto sarebbe auspicabile. e il declino nella mo1 talità da cs~i deri\"ante potrebbe essere almeno in parte auribuito all'increm en to elci tassi di ~treening. Nonostante te clifft1~e raccomandazioni delle org,rninazioni ~reria li stiche. comunque, i tas~i cli screen i ng rimangono al di sollo di quelli o t limali. Un esempio delle caw,e alla ba:-e del f'cnorneno potrebbe essere la m oltep li cità delle op7ioni disponibili: la semplificaLionC' dello screening sarebbe di grande aiuto anch<· per quanto rigua1 da la preparazione degli esami che, sia nel caso clcll'esamc delle feci che in que ll o de ll a rn lonscopia. comporta complira1io11i per il paLienLe. I n medicina di base, inoltre. non \ i :-ono meccanismi di controllo pe1 ver i ficare che gli e~ami prescritti siano ~Lati effeuuati. (Cm1r1•1 011li11e 2007. /mbblirnlo ti 24 / 9).
predice i I successo
Igeni corre lati alla sem,ibilità agli agent i chemioterapici possono g uid are la sce lta della terapia nei singoli p,uienti 011cologici. 1 geni esaminati, correlali alla '>ensibil i tà a due delle te r apie antitumorali più diffuse, implicano auc h e l'azione dei geni di ripara1ione del DNA ed il metabo li ~mo ce llul a r e, ma <;cmbra che , i :-iano anche mecca11bmi sco110sciuti che non consentono l'efficacia di cnlrambi i farmaci nella stessa ce llul a. Una che mi oterapia scquc111iale basata <;ui prof'ili cli espn·s~ione genica potreb b e p ortare a miglioramenti degli e:,iti cl i nici: i regimi basati 1,ulle firme genomiche appaiono promettenti, 111a ri c hi e don o una conva l id a in st 11di c lini ci prospettici. (f Cli11 011ml. 2007; 25: 4350-7 )
Le pazienti più anziane con mmorc mamma1~io che ricevono d1emiotcrapia adinvamc presentano un lie\'c ma signifìcaòvamente aumentato rischio di "iluppare leucemia mieloidt' acuta. E' inoltre pm-;ibile che il presente ~llldio abbia ~ottostimato questo ri'>chio. in quanto non è stato po!,sibile deter111inare la frequenza della sindrome micloclisplastica tramite le note mediche esaminate. Coutrariamcntc a quanto riportaLO precedentemente. comunq11e, il traLtame11to con G-CSF entro il p1imo anno dalla diagnosi non aumenta '>ignificati,anwntc il ri-.chio. Le ùeci-,ioni sulla chemioter.1pia adiuvante nelle donne an,iane do\Tebbe incorporare considerazioni sia su i benefici che sui rischio ~ia a bre\'e che a lungo termine, onde consentire a ll e patienti di effettuare scelte consapc\Oli. (/ C:li11 Onrol 2007; 25: 3871 -6).
Ipuien t i che smeuono di bere alcool possono diminuire signilìcativamcnte il proprio 1ischio di tumori e,ofagei e cli testa e collo, ed il rischio continua a diminuire con il prolungai '>i del periodo di a'>tensione dall'alcool. Gli studi epidem iologici hanno c0Manterne111e dim rn, Lr a t o un 'as~oc iazione fra con-,umo cli alcoo l e tumori di cavità orale, faringe, laringe ed e,ofago. con una chiara correla1io11c dose-risposta. J risultati ciel prcseme ~tudio pre:,entano u na ~ituaLione s imi le a quell a cie l fumo co n i tum o ri po lmonari: s m ettere diminuisce il rischio. ma impiega anni a farlo, e comun q ue 11011 si rorna mai ai lhclli di coloro che 110n hanno mai be, uco. Nel complesso, i ri~thi ciel consumo di alcool su l cari co patologico. c h e sono globalmente della ste~.,a portata di quelli del fumo, ~ono tratta t i in modo molto cli\cr,o dai media e dal pubblico: pc1 qualche ragione gli effetti cardioprotcttivi dell'alcool sembra 11 0 domina 1e l 'atteni ione dei media. Sarebbe importante esaminare gli effetti de!Ja 'i<hpensionc clell'alcool ~li a l tri tipi di tumori correlati ca u sa lm cnte a l s u o co n s um o, come le n eop lasie maligne di fegato e 111arnmella, ma non \'i è mo lta ricerca in gucMe aree. E' inoltre necessario i n\'esti-
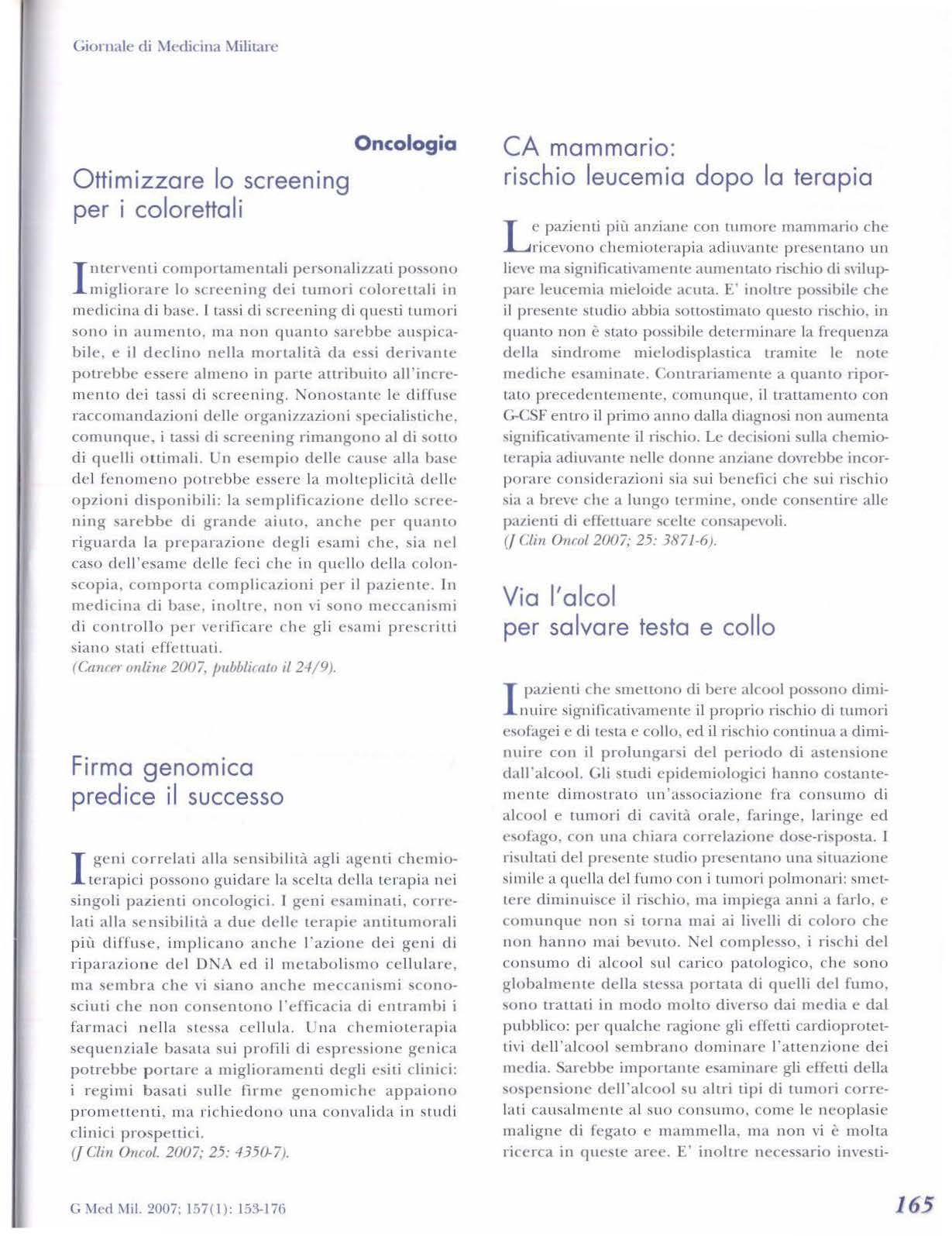
\led 7\lil. 200i: 1.'li( I ) : 153-1
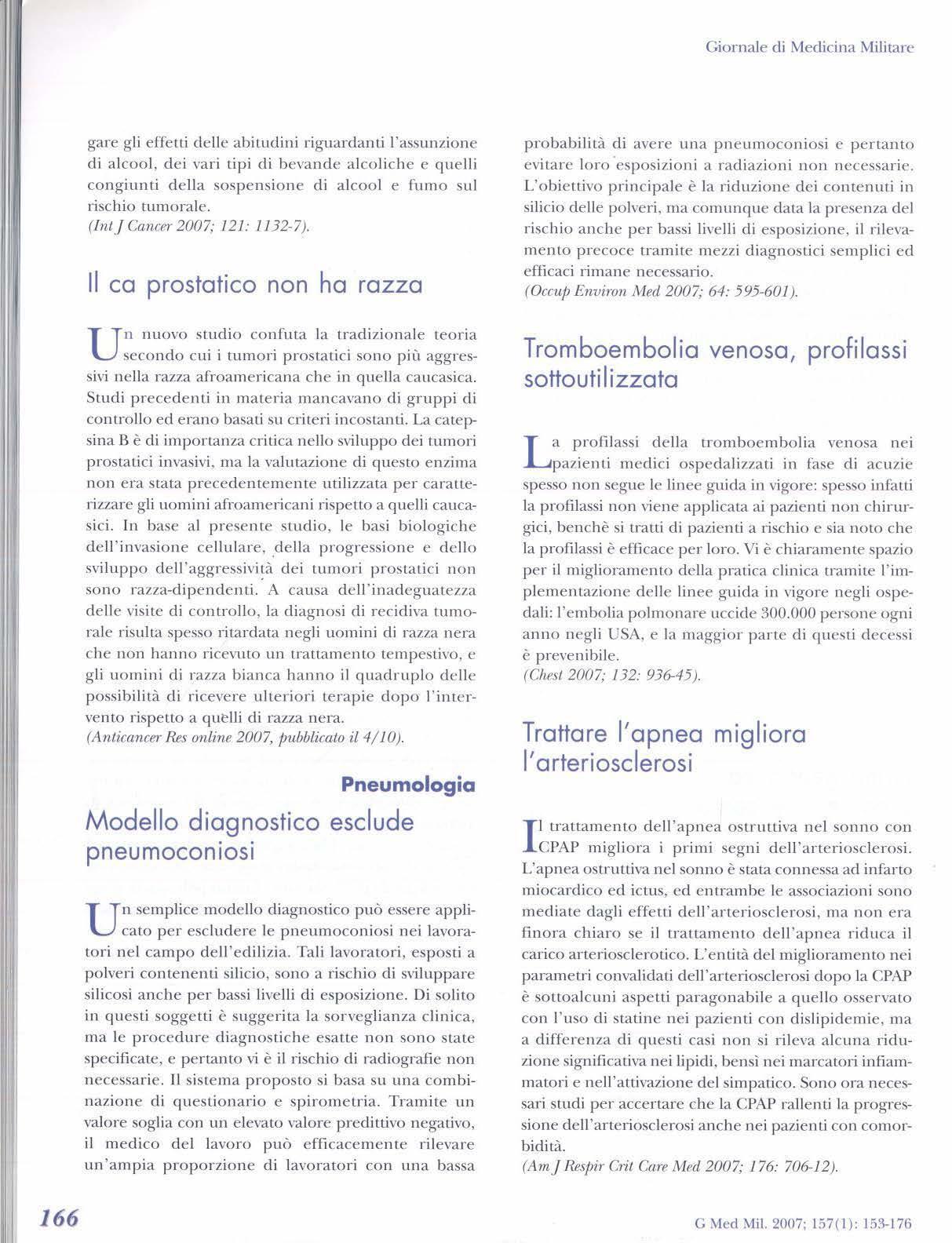
gare gli effetti delle abitudini riguardanti l'assunzione di alcool. dei vari tipi di bevande alcoliche e quelli congiunti d ella sospensione di alcool e fumo sul rischio tumorale. (Int] Cancer 2007: 121: 1132-7).
Un nuovo studio confuta la tradizionale teoria secondo cui i tumori prostatici sono più aggressivi n e lla razza afroamericana che in quella caucasica Studi precedenti in materia mancavano di grupp i di controllo ed erano basati su criteri incostanti. La cateps in a B è di imponanza critica nello sviluppo dei tumori prostatici invasivi, ma la valutazione di questo el17.ima non era stata precedentemente utilizzata per carallerizzare gli uomini afroamericani rispetto a quelli caucasici. In base a l presenre stud io, le basi biologiche dell'invasione ce llul are, _della progressione e dello sv ilu ppo dell'aggressivi~à dei tumori prostatici non sono razza-dipendenti. A causa dell'inadeguatezza delle visite di controllo, la diagnosi di recidiva tumorale risulta spesso ritardata negli uomini cli razza nera che non hanno ricevuto un trattamento tempestivo, e gli uomini di razza bianca hanno il quadruplo delle possibilità di ricevere ulteriori lerapie dopo l'intervento rispetto a quelli di razza nera. (Anlicancer Res online 2007, /1ubblicalo il 4/10).
Modello diagnostico esclude pneumoconiosi
Un sempli ce modello diagnostico può essere applicato per esc ludere le pneumoconiosi nei lavoratori nel campo dell'edilizia. Tali lavoratori, esposti a polved contenenti si li cio, sono a rischio di S\iluppare si li cosi anche per bassi livelli cli esposizione. Di solito in questi soggetti è sugge rita la sorvegli anza clinica, ma le procedure diag nostic h e esatte non sono state specificate, e pertanto vi è il rischio di radiografie non necessarie. Il s isrema proposto si basa su una comb inazione di questionario e spirometr ia. Tramite un valore soglia con un elevato \"alore predittivo negativo, il medico ciel l avoro può efficace m ente rilevare un 'amp ia proporzione di lavoratori co n una bassa
probabilità di avere una pneumoconiosi e pertanto evitare loro ·esposizioni a radiazioni 11011 necessarie. L'obiettivo principale è la 1iduzio11e dei contenuti in silicio delle polveri, ma comunque data la presenza del rischio anche per bassi li vell i di esposizione, il rilevamento precoce tram it e mezzi diagnostici semplici cd efficaci 1;rnane necessario .
(Occup Environ Med 2007; 64: 595-601 ).
Tromboembolia venosa, profilassi sottoutilizzata
La prolìlassi della tromboembolia \'Cnosa nei pazienti medici ospeclalizwti in fase di acuzie spesso 11011 segue le lin ee guida in vigore: spesso infatti la profilassi non \riene applicata ai pazienti non chirurgici, benchè si tratti di pazienti a rischio e sia noto che la profìlassi è efficace per loro. Vi è chiaramente spa1io per il miglioramento della pratica clinica cramite l"implementazio11c delle linee guida in vigore negli ospedali: l'embolia polmonare uccide 300 000 persone ogni anno nt"gli USA, e la maggior parte di questi decessi è prevenibile.
( Chl'sl 2007; 132: 936-45)
Tra ttare l'apnea migliora
Il trattamento dell ' apnea ostruLLiva nel sonno COll C PAP migliora i primi segni dell'arteriosclerosi. L 'apnea ostruttiva nel sonno è stata connessa ad in farto miocardico ed ictus, ed entrambe le associazioni sono mediate dagli effetti dell'arteriosclerosi , ma non era finora chiaro se il trattamento dell'apnea 1;duca il carico arteriosclerotico. L ' entità del miglior.:uncuto nei parametr i convalidati dell'aneriosclerosi dopo la CPAP è sottoalcuni aspetti paragonabile a q11ello osservato con l'uso cli statine nei pazienti con dislipidemie, ma a differenza di questi casi non si rileva alcuna riduzione si1,,TT1ificativa nei lipidi, bensì nei marcatm; infiammatori e nell'attivazione del simpatico. Sono ora necessari studi per accertare che la CPA P rallenti la progressione dell'arteriosclerosi anche nei pazienti con comorbidità.
(Amj Respir Crit Care Med 2007; 176: 706-12).
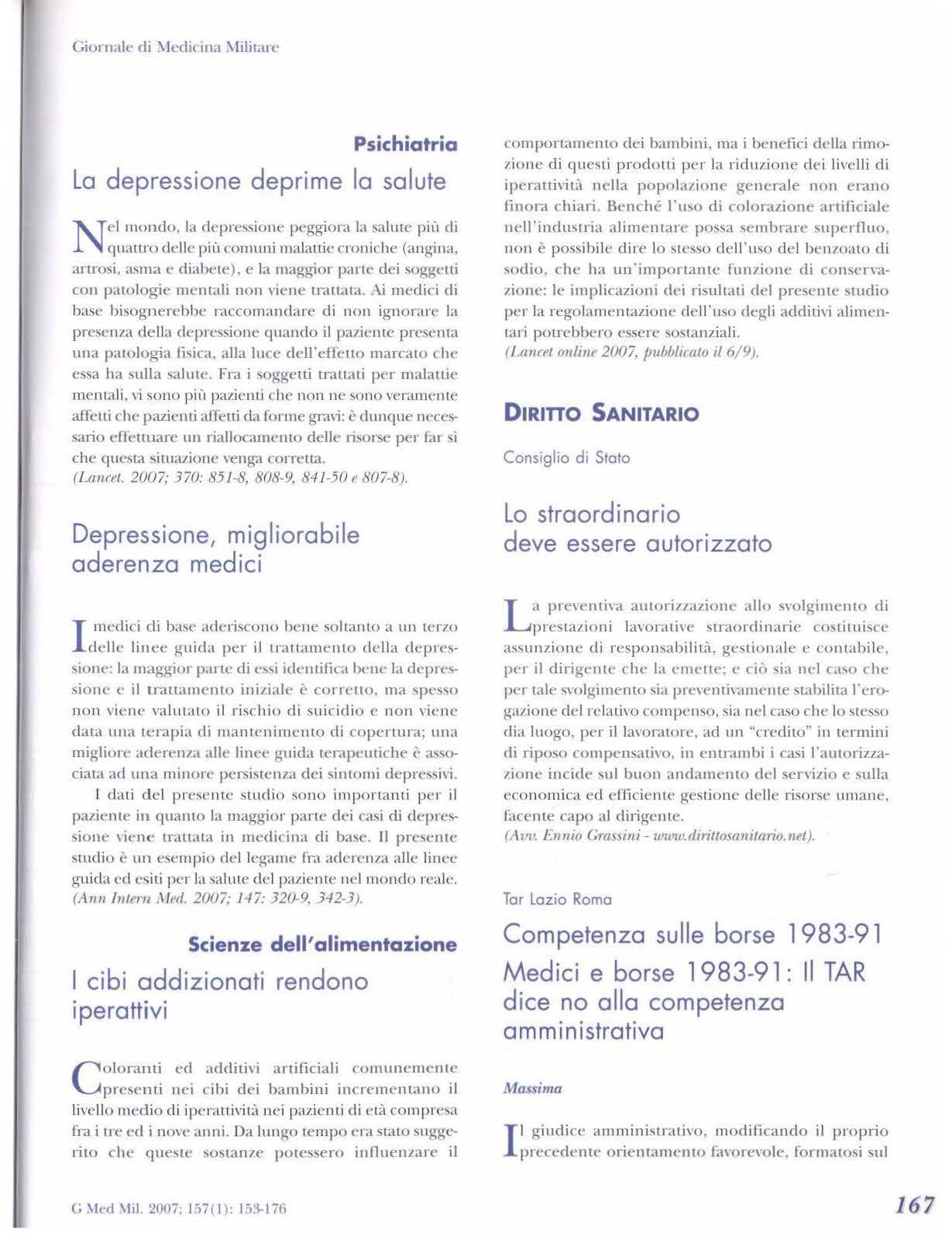
Nf'I moudo, l a depressione peggiora la sa lute più di quattro ddl<: più comuni malattie croniche (angina, artrosi, asma e diabete), e la maggior parte dei soggetti con patologie mentali non , ,iene tratt.11.1. Ai medici di base bi:,ognert>bbe raccomandare di 11011 ii:,rnorare la pres!'111a della depressione quando il patit'ntc pre~cnta una patologia fisica, alla lucC' dell'cffeuo marcato che essa ha ,ulla sa lme. Fra i :,oggetti trattati per malauie memali, vi so110 più pazienti che non ne sono veramente affetti che pazienti affetti da forme gravi: è dunque necessario effettuare un 1iallocamento delle risorse per fai ,ì che quc:,ta sirua,ione venga correua. (Lanrt'I. 2007; 370: 851-8, 808-9, 841-50 t' 807-8).
Imedici cli base aderiscono bene so lt anto a un H'rw clelll- linee guida per il trattamento della depres:,ione: la maggio, parte di essi 1dt>ntifica bt'ne la depre;,sione e il trattamento ini,iale è corretto, ma spc,,o non viene valutato il rischio cli suicidio e non \'iene data una terapia di mantenimento di copertura; uua migliore aderenza alle linee guida terap<•utiche è a~sociata ad una minore persisten1.a dei sintomi depre,-,i,i. f dati del prc~Pnte studio sono importanti per il pa1iente in quanw la maggior parte dei casi di depressione , iene trattata in medicina di ba.,e. Il presente studio è un esempio ciel legame fra acl eren1a alle lince guida cd esiti per la salute del pazienre nel mondo reale. (Ann lutem Mt'rl. 2007: 147: 320-9, 3-1-2-3).
I c ibi addizionati rendono iperattivi
Coloranti ed additi,i artificiali comunemente pre~enti nei cibi dei bambini incrl'menrano il livello medio cli ip<'ratti\'ità nei pazienti di età compresa fra i tre ed i nm e anni. Da lungo tempo era stato 'inggcrito che queste sostan7e potessero i11011e1uare il
comportamento dei bambini, ma i benefici della rimo1.ione di questi prodotti per la riduzione dei livelli di iperattiYità nella popola,ione gencrale non erano finora chiari. Benché l'uso di colora1.ione artificiale rwlt'indnstria alimentare possa ~embrare superfluo, 110n è po~sihilc dire lo stesso dell'uso del ben,oato di sodio. che ha un'importante fun,ionc di con<;en·a1ionc: le implicazioni dei risultali ciel presente ,tudio per la regolamentazione dell'uso dq~li additiYi alimentari potrcbbt·ro essere ~O~lanziali. (f anrf't onlinl' 2007, pubblìwto il 6/9).
Consiglio di Stato
Lo straordinari o deve essere autorizzato
La pre\t n1i,·a auton11azione allo wolgimento di prestationi la\'Oralil'e straordinarie co ,tilllisce as~unzione cli responsabilità, gestionale t· contabile. pl·r il dirigente che la emette; e dò ,ia nel ca,o che per tale wolgimento sia pre,entiYamente stabi li ta rerogalione del I dativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo. pc-r il lal'oratore, ad un "credito" in 1crmini di riposo compensatirn, in enmunbi i casi l'au1orizza1io1w incide \Ul buon andamento del sen;,io e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.
(, h•n Ennio Crassini - www.d11ittosa11itario. nel )
Tor Lazio Roma
Competenza sulle borse
Medici e borse 1983 -91 dice no alla competenza amministrativa
Massima 1983-91 11 TAR
Il giudice amminislrati\O, modilicando il proprio precedente orientamento fa,or<•,olc, formawsi sul
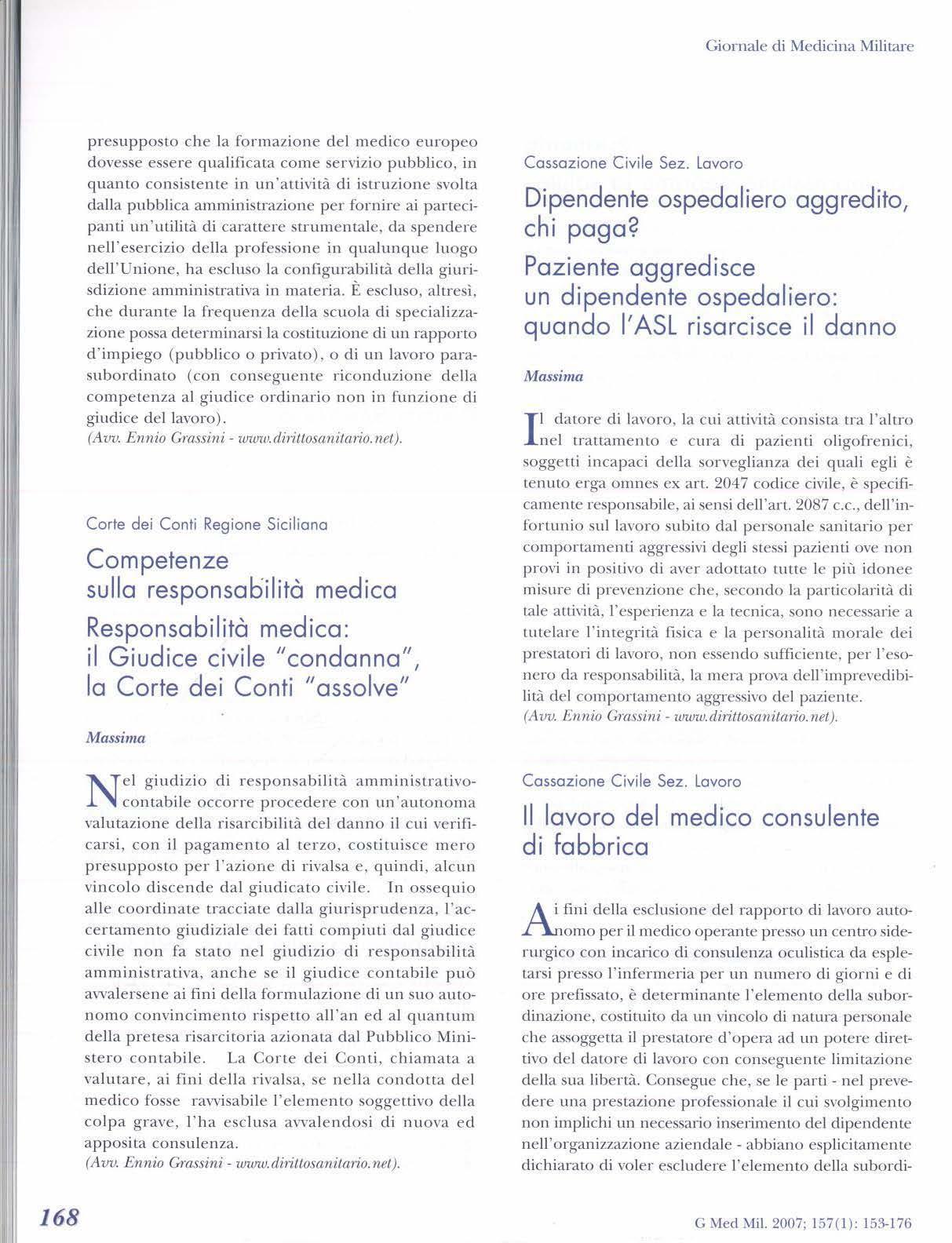
Ipresupposto che la formazione del medico europeo dovesse essere qualificata come servizio pubblico, in quanto consis t ente in un'aujvità di istruzione svo lta dalla pubblica amministrazione per fornire ai partecipanti un 'u tilit à di carattere strumentale. da spendere nell'esercizio della profess ion e in qualunque luogo dell'Unione, ha escluso la configurabilità della giurisdizione amministrativa in materia. È escluso, a ltresì, che durante la frequenza della scuola cli specializzazione possa determinarsi la costituzione di un rapporto d'impiego (pubblico o privato), o di un lavoro parasubordi n ato (con conseguente riconduzione della competenza al giudice ordinario non in funzione cli giudice del lavo r o)
(Avv. Ennio Cmssini - www.diriUosanitario.n('t).
Responsabilità medica:
il Giudice civile "condanna", la Corte dei Conti "assolve "
Mass ima
Nel giudizio cli responsabilità amministrativocontabile occorre procedere con un 'autonoma va lutaz ione della risarcibilità del danno il cui ver ificarsi, con il pagamento al terzo, costituisce me1·0 presupposto per l'azione di rivalsa e, quindi, alcun vincol o discende dal giudicato civile. ln ossequio alle coord inate tracciate dalla giurisprudenza, l'accertamento giudiziale dei falli compiuti dal giudice civi le non fa stato nel giudizio di responsabil ità amministrativa, anche se il giudice contabi le può avvalersene ai fini della formulazione di un suo autonomo convin cimento rispetto a ll 'a n ed a l quantum della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministe r o contabile. La Corte dei Conti, chiarnata a valutare, ai fini della riva lsa, se nella condotta del medico .fosse ravvisabile l'elemento soggettivo della co lp a grave, l'ha escl us a avvalendosi di nuova ed apposita consu lenza. (Avv. J:,"nnio Gmssini - www.dirittosanilario net).
Cassazione Civil e Sez. Lavoro
Dipendente ospedaliero aggredito, chi paga?
Paziente aggredisce un dipendente ospedaliero : quando l'ASL risarcisce il danno
Ma ssima
Ildatore di lavoro, la cui at~ività ~on~ista_ tra !'al~~> nel trattamento e cura d1 paz1ent1 ohgofre111c1, soggeni incapaci della sorveglianza dei quali egli è tenuto erga ornnes cx art. 2047 codice civil e, è specificamente responsabile, ai sensi dell'art. 2087 e.e., dell'infortunio sul lavoro subito dal personale sanitario per comportamenti aggressivi degli stessi pazienti ove non provi in positivo cli aver adottato tntte le più idonee misure di prevenzione che, secondo la particolarità di tale atti,·ità, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori <li lavoro. non essendo suflicie11te. per l'esonero da responsabilità, la mera prova dell ' imprevedibilità del comportamento aggress ivo <lei paziente. (Airo. Ennio Grassini - www.diriltosanilaiio.net )
Cassazione Civile Sez. Lavoro
A i fini della esclusione ciel rapporto di lamro autonn omo per il medico opercmte presso un centro siderurgico con incarico cli consu lenza ocul istica da espletarsi presso l'infermeria per un numero cli giorni e di ore prefissat0, è det erminante l'eiemenlo della subordinazioue, costirnito da un vincolo di nawra personale che assoggerta il prt>statore d'opera ad un potere diretti vo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà. Consegue che. se le parti - nel prevedere una prestazione professionale il cui svolgime nt o non implichi un necessario inserimento ciel dipendente nel)' o r gan izzaz ione az iendale - abbiano esplicitamente dichiaraw di vo le r escludere l'elemento della subordi -
nazione, non è possibile pervenire ad una div<>rsa qualificazione ciel rapporto sulla base del semplice 1iscontro degli elementi sussidia1i. ma è necessario che sia provala la sussistenza di fatto del vincolo della subordina:,ione. (Avv. Ennio Grassini - www.dirillosnnitario.net)
Cassazione Penale
Misur~ c~ella cust0dia in carcere s~1cccssiv_ament~ sosulu1ta con qt1ella meno afn1tt1va degli arresti domiciliaii - nei confronti del medico responsabile del Ser.T. per violazione continuata della legge sugli stupefacenti e per il del irto continuato di peculato di cui all'arL 314 codice penale. li P.M. aveva mosso l'accusa al medico, di aver ceduto. a titolo oneroso, a numerosi tossicodipendenti , ed a più riprese, compresse di farmaco composto da un principio alt.ivo ad azione stupefacente [buprenorfinal, di cui lo stesso era in possesso in relazione a detra sua qt1alifìca, e destinato ad essere somministrato gratuitamente ai soggetti iscritti al Ser.T. per contrastare la dipenclen7..a da eroina ed inserito nella tabella 2 Sezione A allegata al novellato D.P.R. n. 309 del 1990, - al cli fuoii dei casi contemplati dalla legge e senza l'osservanza della rigorosa procedura preYiSta per la somministrazione del farmaco in parola. (Avv. Ennio Gmssini - www.dirittosanitari.o.ne/).
Tor Sici lia - PalermoAssegnazione delle cariche nei farmacisti
Diniego alla richiesta di sostituzione del farmacista eletto Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti
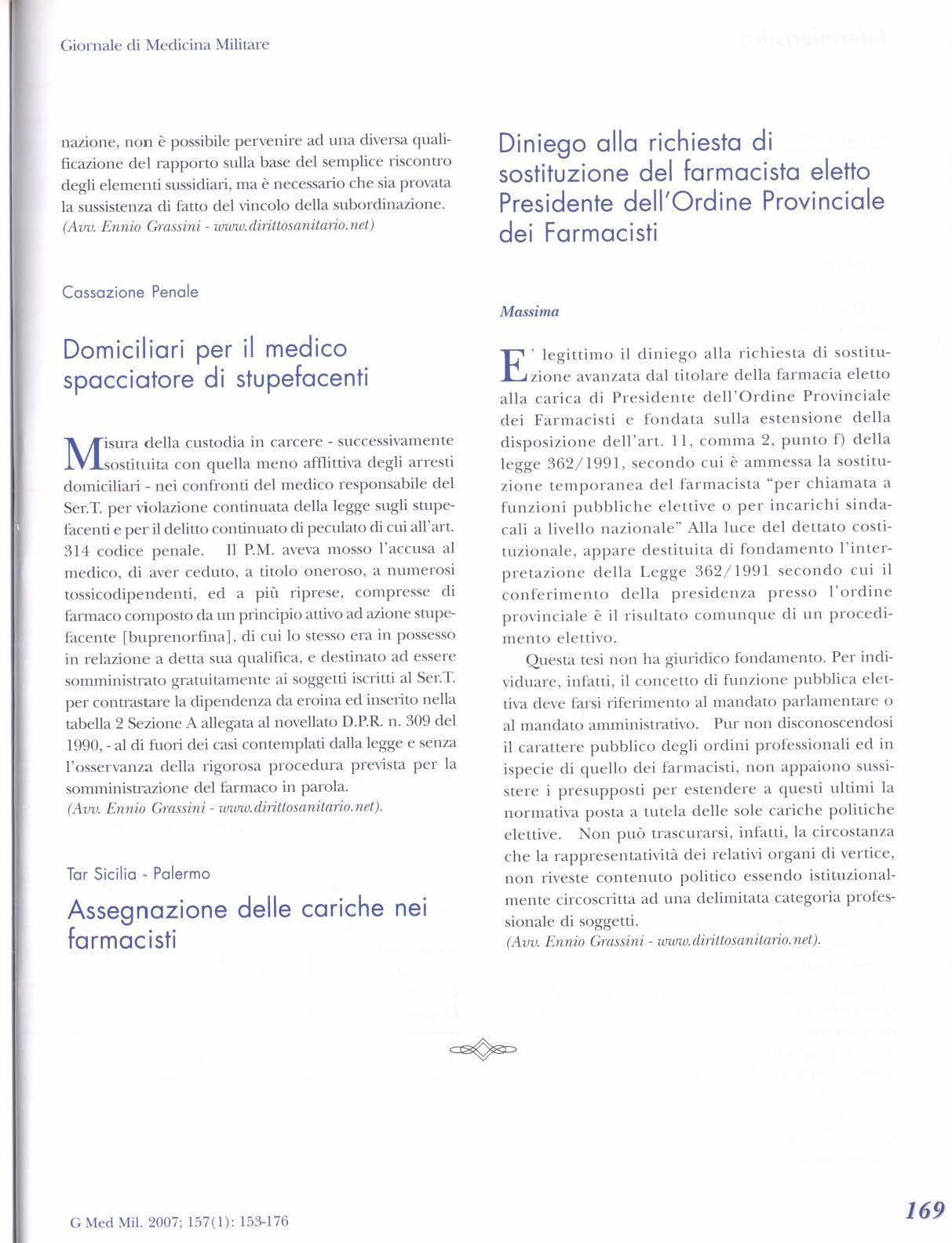
Mass im a
E, legit1i1110 il diniego alla richiesta cli sostituzione avanzata dal titolare della farmacia eletto alla carica di Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti e fondata sulla estensione della disposizione dell'ari. 11, comma 2, punto f) della legge 362 / 199] , secondo cui è- ammessa la sostiluzione temporanea del farmacista "per chiamata a funzioni pubbliche elettiYC o per incarichi sindacali a livello nazionale" Alla luce ciel dettato coslituzionale, appare destituita di fondamento l'interprelazionc della Legge 362 / 1991 secondo cui il conferimento della pr<>sidenza presso l'ordine provinciale è il risultato comunque di un procedimento elettivo.
Questa tesi non ha giu1idico fondamento. Per individuare, infatti , il concetto di funzione pubblica elettiva deve farsi riferimento al mandato parlamentare o al mandato mnministrativo. Pur non disconoscendosi il carattere pubblico degli ordini professionali ed in ispecie di quello elci farmacisti, non appaiono sussistert: i presupposti per estendere a questi ultimi la normaliva posta a tutela delle sole cariche politiche clellive. Non può trascurarsi, infatti, la circoslanza che la rappresentatività dei relativi organi di vertice, non riveste contenuto politico essendo istirnzionalmentc circosc.ritta ad una <lclirnitata categoria professionale di soggetti.
(Avv. Ennio Grassini - www.dirillosanitario.net).
a cura di Walter DE CARO,.
Significato e funzione del codice deontologico
Quando agiamo enlro l'ambilo tracciato dalla legge, il nostro comportamento è legale. ~fa non tntro ciò che è legale è legittimo. E' possibile immaginare situa7ioni in cui un certo intervento (diagnostico, terapeutico o di ricerca) sia in accordo con le leggi esistenti, ma conu-asti con il giudizio morale del professionista sanitario: e che quindi quesri lo giudichi legale, ma non legittimo.
Un esempio molto chiaro della dissociazione tra lega lit à (== conformità alla legge) e legi ttimità (= accettabile dal punto di vista della professione o della propria coscienza morale) è offrrto dal conflitto in cui si sono trovati molti medici e infermieri durante il periodo in cui è stata in vigore in Germania , sotw il rc1:,rime nazista, la legge che imponeva l' eutanasia per i cosiddetti "pesi morti"' della naz.ione ( lun godegenti negli ospedali psichiatrici, schiz.ofrenici. epilettici, alcolizzati, maiali in fase terminale e neonati con malformazioni genetiche).
Dalla 1icostrnziòne di tutta la triste \~cenda - che si calcola sia costata la vita a 70.000 persone, la metà dei lun godegenti negli ospedali psichiatrici - risulta che le uniche forme cli resistenza all'esecuzione del programma dì eutanasia, volut0 personalmente da Hitler, furono quelle di istituzioni psichiatriche gestite dalla Chiesa, sia evangelica che cattolica, il numero dei medici che si oppose attivamente al programma non fu e levato. così come furono relativamente pochi i convinti sosLeniLOri del programma. La grande massa, sia dei medici sia della popolazione che ne venne a conoscenza, si Lasciò guidare con inerzia.
Può il va lor e dell'ohbedienza a una legge essere prioritario risplé'tto a quello del rispetto alla vita? Questo è stato il conDitto in cui si sono Lrovati molti in ferm ieri e medici (oltre alla paura per le co11Seguenze personali della disubbidienza. Alla fine del corso, g li infermieri giuravano fedeltà e ubbidienza a
Giornale di Medicina Militare
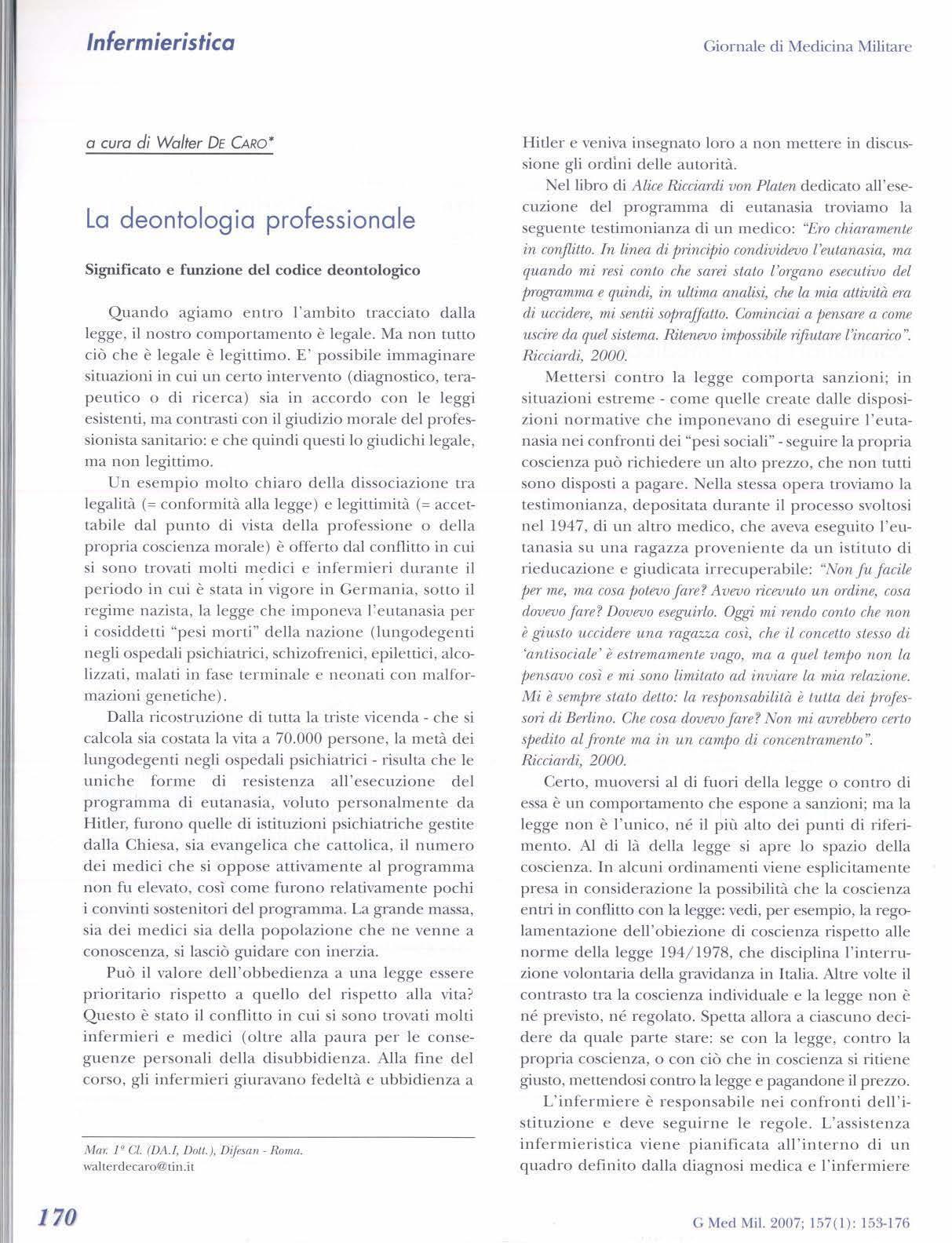
,\lrlf. 1 " Cl. (DI\.!, Doli.), Di(Pm11 - Rmrw. wal terdecaro@tin.it
Hitler e veniva insegnato loro a non mettere in discussione g li ordini delle auLOrità.
Ne l li bro di Ali.ce Ricciardi van Platen dedicato a ll 'esecuzione del programma di enr.anasia troviamo la seguente testimonianza di nn medico: "Ero chiaramente in conflitto. fn linea di principio condividevo l'eutanasia, 11w quando mi resi conio che sarei stato l'o1gano esecutivo del programma e qu i 11di, in ultima analisi, rhe la mia allivilrì f'T'a di urcidere, mi ~entii sopraffallo. Cominciai a pensrffe a come uscire da quel sistema. Ritenevo imfJOssibife -rifiutare l'inrarico ". Riccia rdi, 2000
Mettersi contro la legge comporta sanzioni; in situazioni estremt' - come quelle create dalle disposizioni normative che imponevano di eseguire l'eutanasia nei confron 1i dei ·'pesi sociali" -seguire la propria coscie n za può richiedere un alw prezzo. che non tutti sono disposti a pagare. Nella stessa opera troviamo b testimonianza , depositata durante il processo svoltosi nel 1947, di un a ltro medico, che aveva eseguito l'eutanasia su una ragazza proveniente da un istituto cli rieducazione e giud icata irrecuperabile: "l'lon .fu facile per me, ma cosa j,otevo fare? Ar,evo ricevuto un ordine. rosa douevo jarf? Dovevo eseguirlo Oggi. mi nmdo conio dze non Ì' giuslo uccidere una ragazza così, rhP il ronrPtlo slesso di 'antisociale' è estremamente var;o, ma a qurl tm,J10 non la pmsavo così P mi sono limitato ad inviar!' la mia relazion e Mi è sempre stato detto: la responsabilità è luUa dei professori di Berlino. r-h e cosa dovevo }are? 1Von mi avrebbero certo sj1edito al fronte u1c1 in un cam/10 di rnncentramenfo ·•. Rirciardi, 2000.
Certo, muoversi ,ù di fuori della legge o contro di essa è un comportamento ch e espone a san:òoni: ma la legge non è l'unico, nf il più alto dei punti cli riferimento. Al cli là della legge si apre lo ~pazio della cosc ienza. In a lcuni ordinamenti viene esp licitamente presa in considerazione la possibilità che la coscienza enui in conflitto con la legge: ved i, per esempio, la regolamentazione dell'obiezione cli coscienza rispetto alle norme della legge 194/ 1978, che disciplina l 'interruzione vo lontaria della gravidanza in Italia. Altre volte il comrasto tra la coscienza individuale e la legge non è né preYisto, né regolato. Spelta a llora a ciascuno decidere da quale par1e stare: se con la legge , contro la propria coscienza, o con ciò che in coscienza si ritiene giusto, metcenclosi contro la legge e pagandone il prezzo. L 'infermiere è responsabile nei confronti dell'isti tuzi one e deve seguirne le regole. L ' assistenza infermieristica viene pianificata all'interno di un quadro defìnito dalla diagnosi medica e l'in fermie r e
è legalnH.:nte respousabile dell'csecu1ione degli orrlini medici. A livello lt·galc pesa di più il potere delle decisioni istitnLionali e del medico L'infermiere è anc lw respon~abile nei confronti del paziente. Cosa si dC\t' fare quando il lllcdico prende nna decisione non condi\'io;ibile e chiede all'inl'crmiere di eseguirla? Si deq• ini,iare l'ali111enta1ione per gastrostomia ad un pazient<.' in sima,ione non n·\ersibile che non i.· in grado cli dare il consenso e le cui condi,ioni cominuano a peggiora,e?
Prima di ri\·olgcrci all'etica, \'ogliarno considerare un 'altra fonte di norme per le pratiche biomediche: le regole deontologiche. Ili linea di principio, queste sono indipendenti sia dall'etica che dalla legge. Sono formulate dai profc~~ionisti. al fine di gar.intire il huon funzionamento ~ociale della profession<'. La sanzione delle infrazioni alla dconwlogia non è- né di natura morale (colpa), né giuridica (crimine); ha piuuo~10 carauere dio;ciplinare (a seconda dei dl\ersi gradi di gravità dell'infrc11ione, si prevede l'ammonizione, la sospensione temporanea dall'esercizio della prol<.:~~ione o addirittura la radiai ione dall'albo professionale. co11 la conscgucn.ta di 11011 poter più praticar<' la profes~ionc nel contesto sociale che l'autoriZLa).
:-Jell'ambito delle prof'es~ioni sanitarie sono stati i medici i primi a dotan,i cli 1111 codict' di deontologia. I l primo codice medico ufficiale è. in ordine cronologico, quello emanato clall'J\merirrrn Mfdirnl A5.rnciatio11 nel 1817, i medici italiani dovettero attendere la mt'là ciel XX ~ecolo per il loro rndice di dconLOlogia: il primo• il cosiddetto "codice Frugoni" • fu elaborato nel l 9:'l4; poi fu rinnovaw con una frequcn,a cresce me: nel 1978. nel 198\l, nel l 995 e il più recente nel 1998.
La preoccupa;,ione principale che traspare nel corpo delle norme di deon1ologia medica, in quanto modelli di comportamento faticosamente consolidati nel tempo mediante la ripetiti\ità e autorc\'olnwntc proposti dagli organismi piìt rappre~etllativi della profes~ione, è quella di co~truire una relazione di fiducia con il pa1iente. La deontologia tende a cor-.-eggere l'intrin,eca asimmetria del rapporto sanit<1rio-paLien te, esplicitando le normC' di comportamento a cui i sanitari. in quanto professionisti, si impegnano ad attenersi. 'son si limita, perciò, a difender(' gli interessi della categoria. concepita come una corpora:rione, ma tutela ancht' i paLicn1i da eve,nuali co1nportamc11ti illeciti eia parte dei membri della professione.
Un codice ckontologiro esplicita i niteri di comportanwnto degli operatori sanitari, e (Wrtanto quc-llo che il cittadino dC\'e auender-;i dal profes~ionista. Va esplicitato il comportamento minimo considerato cmretto o il comportamt"nto ottimale: Ri.,poudere ai bbogni dcll'uten1e, cioè assisten-, 11011 è 1111 comportamento par ticolarme!lle meritevole. E' pan<.' intrin<;eca di una profe<;,ione ,celta proprio per rispondere ai hi,ogni di chi sta male. Tenere le proprie conosccnLe aggiornate e fare ricerca 11011 è un "di più", ma il minimo dovuto nei confromi delle pe1 ,one per le quali si la,ora. Ribadire che que,te sono le scelte cli una professione significa riaffermare il dovuto. Sorcoli11carlo ecces:-i\'amente significa. come lettura estrema, portare un determinato compm tamento nell'area, più o meno prl·caria, della benevolcnLa di una prolessione.
Le regole ckomologichc sono, perciò, pitì rhe un semplice regolamento interno alla professione. Le si potrebbe chiamare uno "spirito" con cui si esercita la professione, che dcriYa d;:i una pt'r('ezionc colletti\·a clcll'a11.ività svol1a, del semo di CJlll'Sta atLivit.ù e ciel suo a, ticolarsi con l'organi11,11ione sociale. che autorina l'e,crcizio dell'arte terapt.·lnica. Se i cittadini mcssero l'impressione che le rq~ole deontologiche tulelano solo !,{li interessi dei professionisti, sarebbe cornprnnwssa la rela11onc fiducialC'. che per la medicina i.· iHdi~pc•nsabilc.
Rapporto tra legge, deontologia, etica
Elica, deomologia, legge: diversi sono i 1110di di correlare queste tre ist;1111L' normati\'<..', di da.re loro 1ile\'a1ua sociale. Si può immaginare tra loro un'aLione si1wrgica. Pe, e1,emplifica1t', possiamo riferirci alla regolamentazione dell'inlcrru;,ionc della graviclan1.a in \Ìg-ore in Italia dal 1976. La deo11Lologia professionale d<'l medico ,i ,iwa a cerniera tra le istan1c normati\·e della legge e quelle della coscienza morale indi\iduale. li rndice deontologico proclama la 1100 disponibi l ità del medico p<'r le intern11ioni \'olo11tarie della gravidarlla al di fuori dei ca,i pre\isti dalle legge, memre lo lascia libero cli seguire la roscicn;a negli alui casi (cfr. codice di deontologia del 1978. nn. 1 16-47).
La deon1ologia \'iene cosi a collocarsi su un piano rliH"rso dalla k-gge e non in rotta cli collisione con essa. La legge. a sua \'Olla, prevedendo la clausola clcll'obie1ione di coscienLa per l'operatore sanitaiio, lascia sia all'nica cht· agli orientamenti deontologici il loro
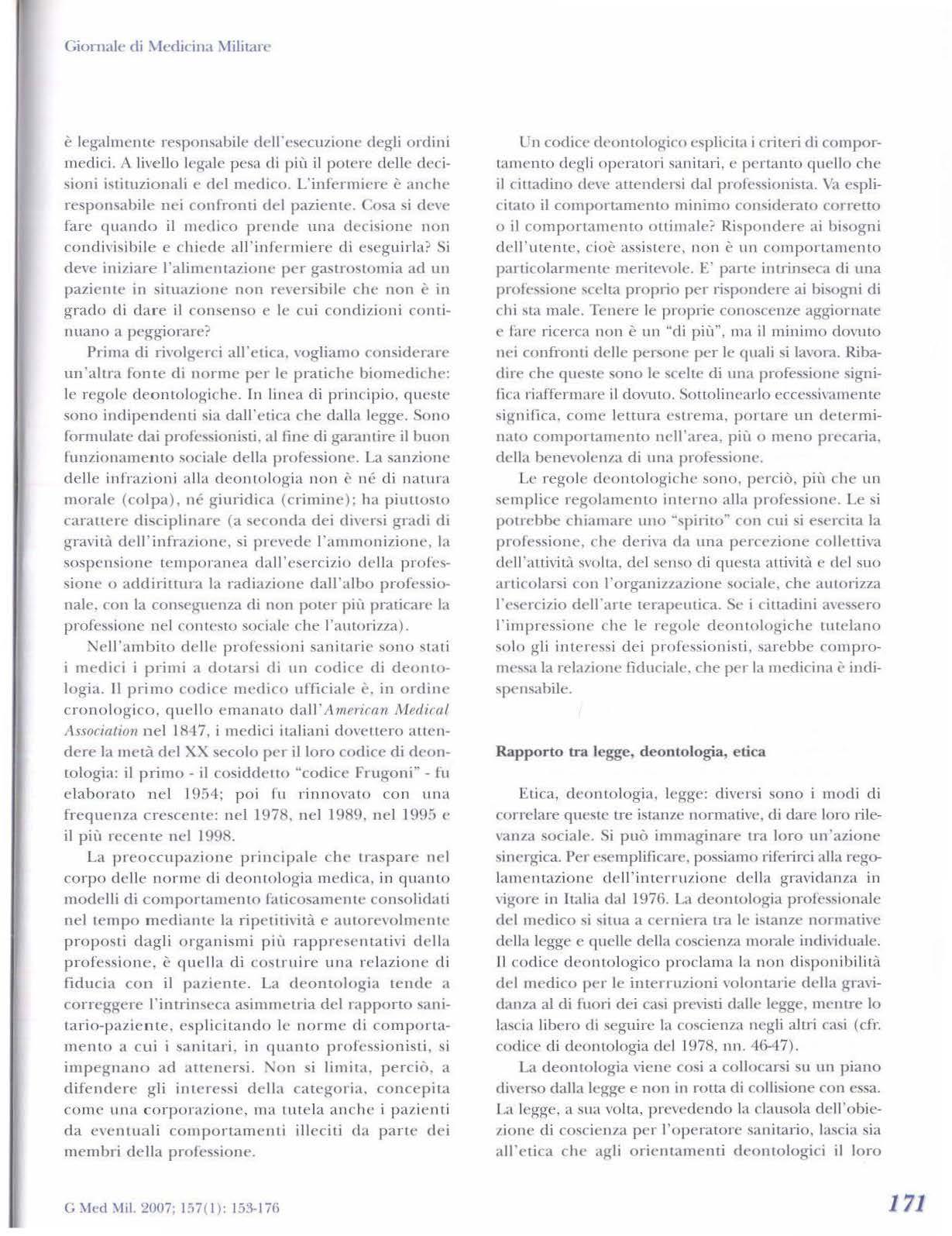
c.: ~fui \1il.
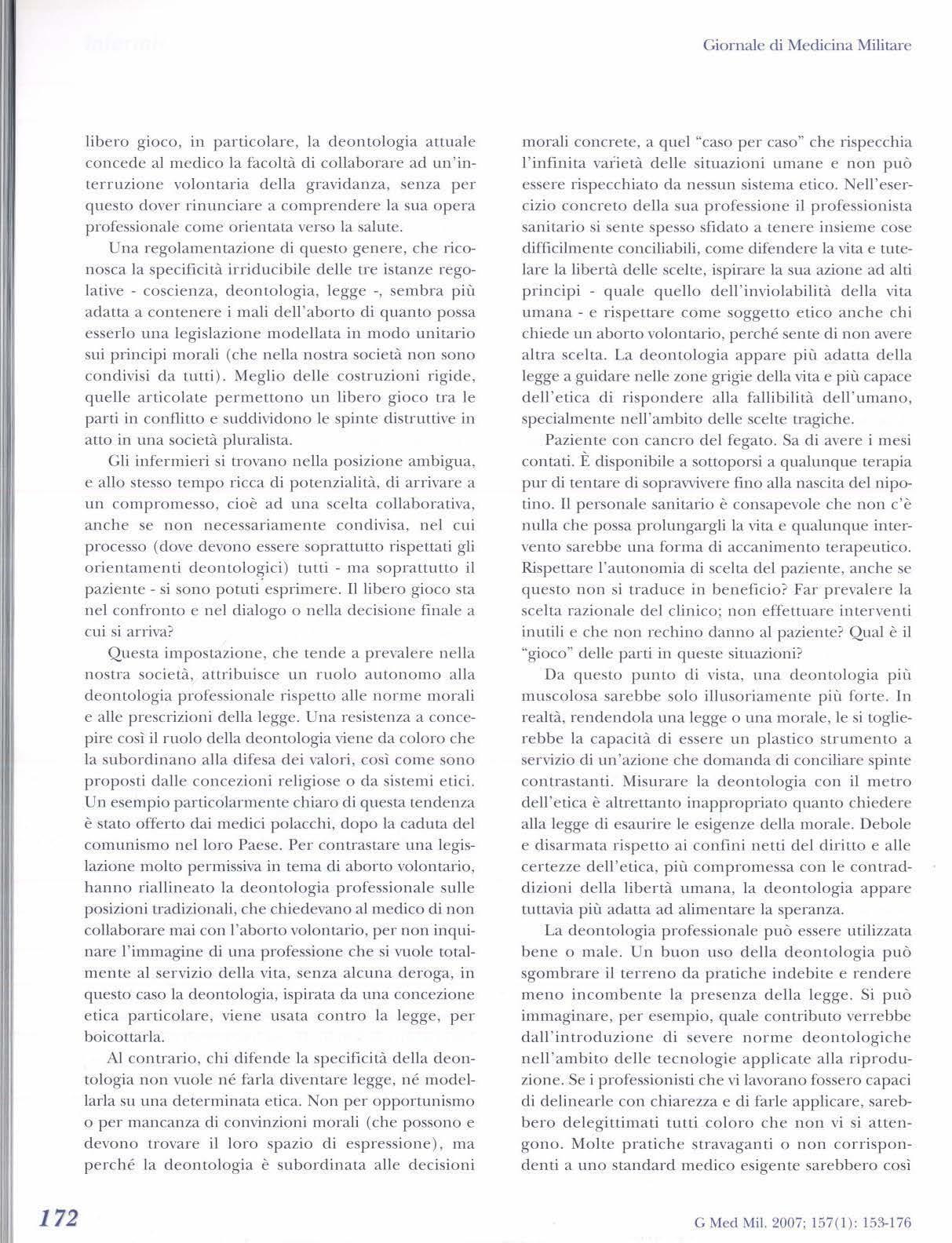
libero gioco, in particolare , la deontologia atlllale concede al medico la facoltà di collaborare ad un'interruzione \'olo11taria della gravidarl.la, senza per questo dover rinunciare a comprendere la sua opera professionale come orientata verso la salme.
Una regolamentazione di quesro genere, che riconosca la specificità irriducibile delle tre istan7e regolative - coscienza, deontologia, legge -, sembra più adatta a contenere i mali dell ' aborto cli quanto possa esserlo u11a legislazione modellata in modo unitario sui piincipi morali (che nella nostra società non sono condivisi da tutti). Meglio delle cosu·uzioni rigide, C]Ue lle articolate permeuono un l ibero gioco tra le parti in conflillo e suddividono le spinte distruuive in atto in una società pluralista.
Gli infermic1·i si l.rovano nella posizione ambigua, e allo stesso tempo ricca di potenzialità, di arrivare a un compromesso, cioè ad una scelta collaborativa, anche se non necessariamente condivisa, nel cui processo (dove devono essere soprattutto rispellali gli orientamenli deomolo~ici) tutti - ma soprattutto il pazieme - si sono potuti esprimere. li l ibero gioco sta nel confronto e nel dialogo o nella decisione finale a cui si a1Tiva?
Questa impostazione, che Lende a prevalere nella nostra società, attribuisce un ruolo autonomo alla deonwlogia professionale rispetto alle norme morali e alle presc1;zioni della legge. Una resisten1.a a concepire così il ruolo della deontologia viene da coloro che la subordinano alla difesa dei valori, così come sono proposri dalle concezioni religiose o da sistemi etici. Un esempio particolarmente chiaro di questa tendenza è stato offerto dai medici polacchi, dopo la caduta del comunismo nel loro Paese. Per contrastare una legislazione molto permissiva in tema di aborto volontario, hanno riallineac.o la deontologia professionale sulle posizioni tradizionali, che chiedevano al medico cli non collaborare mai con l'aborto volontario, per non inquinare l'immagine di una professione che sì vuole totalmente al ser\'i7io della vita, senza alcuna deroga, in questo caso la deontologia, ispirata da una concezione etica particolare , viene usata contro la legge, per boicottarla.
Al contrario, chi difende la specificità della deontologia non vuo le né farla diventare legge, né modellarla su una determinata etica. Non pe,- opportunismo o per mancanza di convinzioni morali (che possono e devono trovare il loro spazio di espressione). ma perché la deontologia è subordinata alle decisioni
morali coucrete, a quel "caso per caso'' che rispecchia l' infinita varietà delle situazioni umane e non può essere rispecchiato da nessun sistema etico. Nell'esercizio concreto della sua professione il professionista sanitario si seme spesso sfidato a tenere insieme cose cliflìcilmente conciliabili, come difendere la vita e tutelare la libertà delle scelte, ispirare la sua azione ad alti principi - quale quello dell'inviolabilità della vita umana • e rispeLtare come soggetto etico anche chi chiede un aborto volontario. perché seme di non aYere altra scelta. La deontologia appare più aclaLLa della legge a guidare nelle zone grigie della vita e più capace dell'elica di rispo11dere alla fallibilità dell'umano, specialmente nclrambito delle scelte tragiche.
Paziente con cancro del fegato. Sa di avere i mesi contati. È disponibile a sottoporsi a qualunque terapia pm cli tentare di soprawivere fino alla nascita del nipotino. Il personale sanilario è consapevole che non c'è nulla che possa prolungargli la ,~ta e qualunque intervento sarebbe una forma di accanimento terapeutico. Rispettare rautonomia di scelta del paziente, anche se questo non si traduce in beneficio? far prevalere la scelta razionale del clinico; non effeuuare interventi inutili e che noJJ rechino danno al paziente? Qual è i] "gioco" delle parti in queste situazioni?
Da questo punto di , ista, nna cleont.o logia p1u muscolosa sarebbe solo illusoriamente più forte. In realtà, rendendola una legge o una morale, le si toglierebbe la capacità cli essere un plastico strumento a servizio di un 'azio ne che doma11da di conciliare spime contrastanti. Misurare la deontologia con il metro dell'elica è altrettanto inappropriato qtiamo chiedere alla legge dì esaudre le esigenze della morale. Debole e disarmata rispetto ai confini netti del diritto e alle certe7,ze dell 'e tica. più compromessa con le contraddizioni della libenà umana, la deontologia appare tuttavia più adatta ad a limentare la speranza.
La deontologia professionale può essere mi lizzata bene o ma le . Un buon uso della deomologia può sgombrare il terreno eia praLicbe indebite e rendere meno incombeme la presenza della legge. Si può immaginare, per esempio, quale contributo verrebbe dall ' introduzione di severe norme deontologiche nell'amb i to delle tecnologie appl icate alla riproduzione. Se i profession isti che vi lavorano fossero capaci di delinearle con chiarezza e di farle applicare, sarebbero delegittimati tutti coloro che non vi si aLLengono. Molte pratiche stravaganti o non corrispondenti a uno standard medico esigente sarebbero così
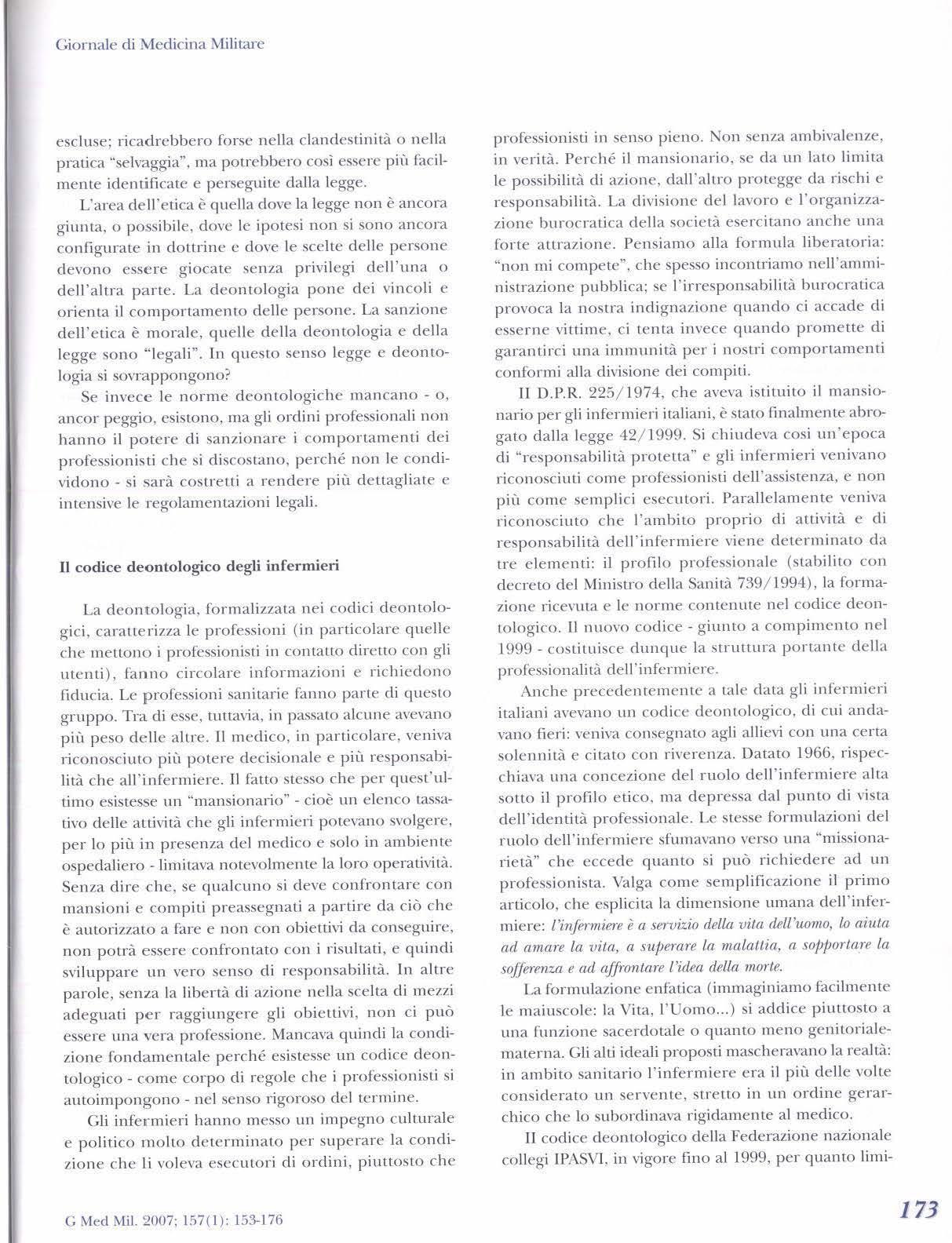
escluse; ricadrebbero forse netla clandestinità o nella pratica "selvaggia'', ma potrebbero così essere più facilincnte identifìcatc e perseguite dalla legge.
L'area dell'etica è quella dove la legge non è ancora giunta. o possibilP, dove le ipotesi non si sono ancora configurate in dottrine e dove le scelte delle persone devono essere giocate senza privilegi dell'una o dell'altra parte. La deontologia pone elci vincoli e orienta il comportamenro delle persone. La sam,ionP dell'etica è morale, quelle della deontologia e della legge sono "legali". In questo senso legge e deontologia si so,Tappongono?
Se invece le norme deontologiche mancano - o, ancor peggio, esistono, ma gli ordini professionali non hanno il potere cli sanzionare i comportamenti dei professionisti che si discostano, perché non le condividono - si sarà costretti a rendere più dcuagliate e intensive le regolamentazioni legali.
Il codice deontologico degli infermieri
La deont.ologia, formalizzata nei codici deontologici, caratterizza le professioni (in particolare quelle che meuono i professionisti in contatto diretto con gli menti), fanno circolare informazioni e richiedono fìdncia. Le proressioni sanitarie fanno parte rli questo gruppo. Tra di esse, tuttavia, in passato alcune avevano più peso delle altre. Il medico, in particolare. veniva Iiconosciuto più potere decisionale e più responsabil ità che all'infermiere. Il fatto stesso che per quest"ultimo esistesse nn "mansionario" - cioè 1111 elenco tassativo delle allività che gli infermieri potevano svolgere, per lo più in presenza del medico e solo in ambientt> ospedaliero - limitava notevolmente la loro operatività, Senza dire che, se qualcuno si deve confrontare con mansioni e compiti preassegnati a partire da ciò che è autorizzato a fare e non con obietti~; da consegnire, non potrà essere confrontato con i risu l tati, e quindi sviluppare un vero senso di responsabilità. In altre parole, senza la libertà di azione nella scelta di mezzi adeguati per raggiungere gli obiettivi, non ci può essere una vera professione. Mancava quindi la condizione fondamentale perché esistesse un codice deontologico - come corpo di regole che i professionisti si autoirnpongono - nel senso rigoroso del termine.
Cli infermieri hanno messo un impegno culturale e politico molto determinato per superare la condizione che li voleva esecutori cli ordini. pi11ttosto che
professionisti in senso pieno, Non senza ambivalenze. in verità. Perché il mansionario. se da un lato limita le possibilità di a7ione, dall'altro protegge da rischi e responsabilità. La divisione ciel lavoro e l'organizzazione burocratica della società esercitano anche una forte attrazione. Pensiamo alla formula liberatoria: "non mi compete", che spesso incontriamo nell'amministrazione pubblica; se l'irresponsabilità burocratica provoca la nostra indignalione guando ci accade di esserne vittime, ci tenta invece quando promette di garantirci una imrnnnità per i nostri comportamenti conformi alla di\'isione dei compiti,
[I D.P,R. 225 / 1974, che aveva istituito il mansionario per gli infermie1i italiani, è stato finalmente abrogato dalla legge 42 / 1999. Si chiudeva cosi un'epoca di "responsabilita protetta" e gli infermie1i \'Cnivano riconosciuti come professionisti clcll'assistenza, e oon più come semplici esecutori. Parallelamente veniva riconosciuto che l'ambito proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere viene determinato da rre elementi: il profilo professionale (stabilito co11 decreto del Ministro della Sanità 739 / l 994), la formazione ricevuta e le norme contenute nel codice deonlOlogico. Il nuovo codice - giunto a compimento nel 199!) - costituisce dunque la struttura portante della professionalità del! 'infermiere.
Anche precedentemente a tale data gli infer!llicri italiani avevano un codice deontologico, di cui andavano fieri: \'eniva consegnato agli allie\~ con una certa solennità e c:itaro con riverenza. Datato 1966, rispecchiava una concezione de l ruolo dell'infermiere alta sotto il profilo etico, ma depressa dal punto cli vista dell'identità professionale, Le stesse formulazio11i del ruolo dell'infermiere sfumavano verso una "missionarietà" che eccede quanto si può richiedere ad un professionista. Valga come semplificazione i l primo articolo. che esplicita la dimensione umana dell'infermiere: l'inf,mnif're è a :servizio dell,a vita df'll'uomo, lo aiula ad arnare la vita, a superare la malattia, a sopportare la soffermza e ad affrontare l 'idea df'lla morie.
La formulazione enfatica (immaginiamo facilmente le maiuscole: la Vita, l'Uomo ) si addice piuttosto a una funzione sacerdotale o quanto meno genitorialematerna. Gli alti ide,ùi proposti mascheravano la realtà: in ambito sanitario l'infermiere era il più delle volte considerato un servente, srrt>tro in un ordine gerarchico che lo subordinava rigidamente al medico.
Il codice deontologico della Federazione nazionale collegi lPASVI. in vigore lino al l 999, per quanro lirni-
rato nel riconoscimento della professionalità dell'inrermiere, era sicurameme anni luce lonlano dai regolamenti in uso un secolo prima. L'elenco dei Doveri dell'infermiera che riportiamo - di fome sconosciuta, ma identificabile come proveniente dagli Stati Unitici µermette di cap ire il cammino sociale che hanno dovuto compiere gli infermieri per gi11ngere ad essere riconosciuti come professionisti in senso pieno.
Con l' acquisi zione di un vero statuto professionale, gli infe rmieri italiani hanno potuto formulare un codice deontologico vero e proprio li nuovo codice. nell 'esplicitare i valori condivisi dalla comunità inferm i eristica. rinuncia ad ogni formu l azione sovrapponibile al linguaggio religioso. Assume perciò una posizione di rispetro nei confronti di ogni visione filosofica , ideologica e religiosa, senza per questo rinunciare ad espl i ciwre i principi etici irrinunciabili che, secondo la rinessione bioetica, devono ispirare I' eserciLi o della medicina.
La modernità - nel senso di sintonia con i valori che ca ratte rizzano la stagione dell 'e tica in medicina che si colloca sotto il segno della rivoluzione liberaledel codice deomologico degli infermieri italiani si annuncia già dal Lesto posto a inlroduzione del docu-
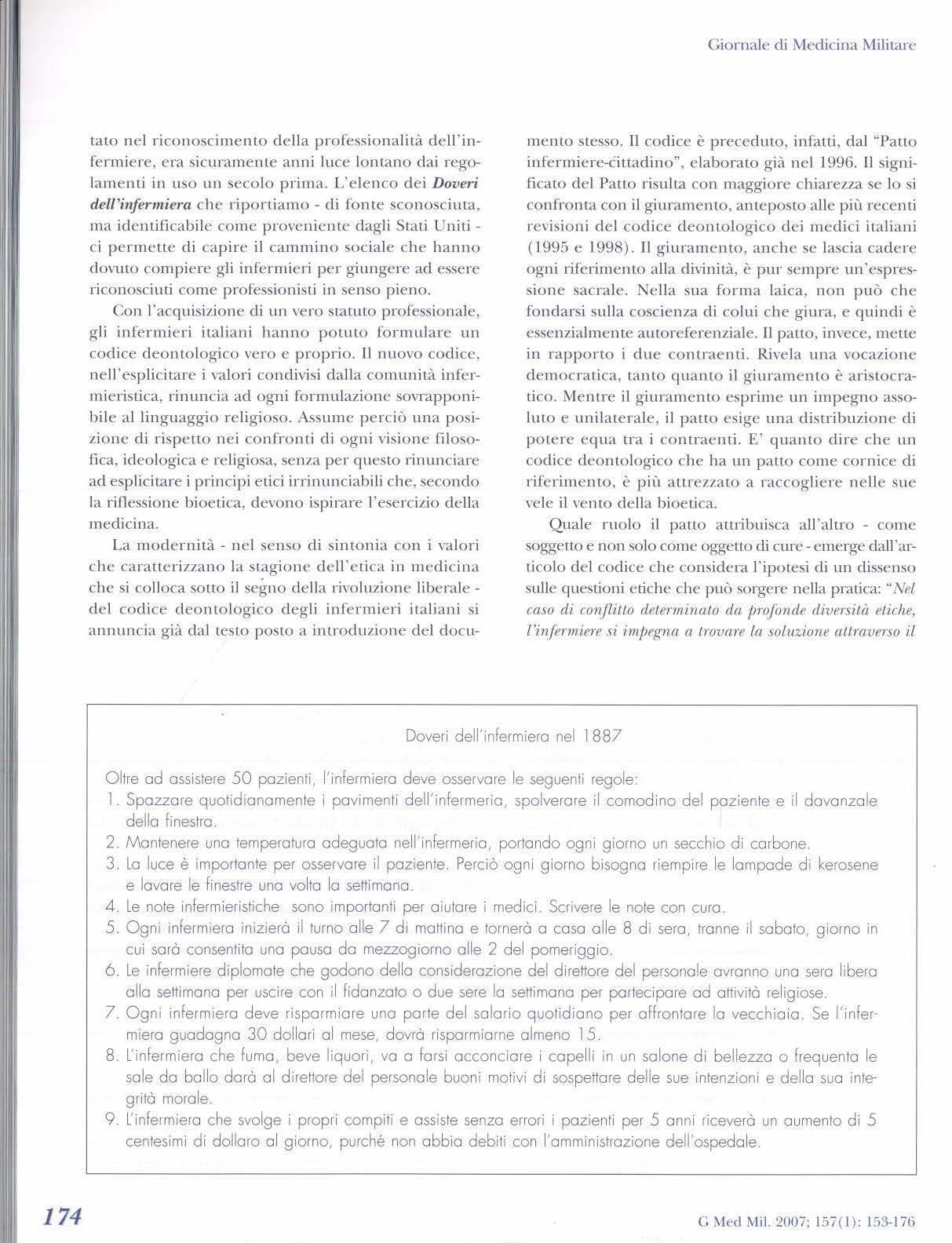
mento sLesso. Il codice è prece duto, infatti, dal '' Pa(to infcnniere-éittadino", elaborato gi:'i nel 1996. Il significato del Patto risulta con maggiore ch_iarezza se lo si confronta con il giurarnenlo, anteposto alle più recenti revi sioni ci el codice deonwlog i co dei medici italiani ( 1995 e 1998). li giuramento, anche se lascia cadere ogni riferimento alla divinità, è pur sempre un espressione sacrale. Nella sua forma laica, non può che fondarsi sulla cosciem..a di colui che giura, e quindi è essenzi almente autoreferenziale. Il patto, invece, melte in rapporto i due contraenti. Rivela una vo cazione democratica, tanlo quanto il giuramento è aristocratico . Mentre il giuramento esprime un impegno assolULo e unilaterale, il patto esige una distribuzione di potere equa tra i contraenti. E' quanto dire che un codice deontologico che ha un patto come cornice cli riferimento, è più attrezzato a raccogtiere nelle sue , ·cl e il vento d ella bioe tica.
Quale ruolo il pano au1ibuisca all 'aJu·o - come soggetto e non sol o come oggetto di cure- emcr14e dall'arti,olo del codice che considera l'ipotesi di un dissenso sulle ques tioni etiche che può so r gere nella pratica: "Nel caso di con.jlitlo rlP/ermi11a/o da profonde diversità el iche, l'infennierP si im/1Pgna a trovare la soluzione allraverso il
Doveri dell'infermiera nel 1887
Oltre od assistere 50 pazienti, l' inferm iera deve osservare le seguenti regole:
1. Spazzare quotidionomen le i povimenli del l'infermeria, spolverare i l comod i no del paziente e il davanzale dello finestra.
2. Man tenere uno temperatura adegualo nell' i nfermeria, portando ogni giorno un secchio di carbone.
3. lo luce è importante per osserva re i l paziente. Perciò ogn i giorno b isogno ri empire le lampade di kerosene e la vare le fines tre una volto la settiman a
4. le noie inferm ieristiche sono importanti per aiu tare i medici. Scrivere le note con cu ro
5. Ogni inferm iera i nizierà il tu rno a lle 7 di mattino e tornerà a casa ol le 8 d i sera, tra nne il saboto, g iorno in cui sarò consent ito una pauso da mezzogiorno olle 2 del pomerigg io.
6. Le i nfermiere diplomate che godono dello conside razione del d irettore del personale avranno una sera li bera al la settimana per uscire con i l fidanzato o due sere lo settimana per partecipare od attività re lig iose.
7. Ogni infermiera deve risparmiare uno porte del salario quotidiano per affrontare lo vecchia ia. Se l'infermiera guadagno 30 dollari a l mese, dovrà risparmiarne almeno 15.
8. L'infermiera che fumo, beve liquori, va o fars i acconciare i capelli in un solone di bellezza o frequenta le sole da bol lo da rò al d ire ttore del personale buoni motivi di sospettare delle sue intenzioni e della sua i ntegrità mora le.
9. L'infermi era che svolge i prop ri compi l i e assiste senza e rrori i pazienti per 5 anni riceve rò un aumento di 5 centesimi d i dollaro al giorno, purché non abbia debiti con l'amministrazione dell'ospeda le
dialogo. In J>resenza di volontà profondamente in contrasto con i principi P/ici della jJrojèssionP P con I.a coscienza personale, sì avvale del diritto all'obiezione di coscienza".
Gli infermieri si collocano d'emhlée sulla frontiera dei nuovi di.riui-dowri tra curanti e cittadini tracciata dalla bioetica formulando in questi termini il rapporlo con la persona assistita: ·•!.'infermiere asrolta, informa, coinvolge la /m-sona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garanlito e consPntirl' all'assistilo di esprimere le f1roprie salte".
La semplicità con cui viene indicato il fatto che l'ascolto è il punto di partenza per l'intero processo che conduce al consenso informato è più che una formulazione felice: è la spia che nel nuovo codice deontologico degli infermieri si esprime una percezione dei bisogni diversa eia quella che vediamo rispecclùata dalla pratica medica abituale.
Il bambino ha la febbre e il medico fa diagnosi di polmonite. La madre crede nella medicina complementare e non fa somministrare all"inferrniere l'antibiotico presrritto. La scelta non è condivisibile, perché al bambino viene negato un intervento di documcmata efficacia. Un trattamento
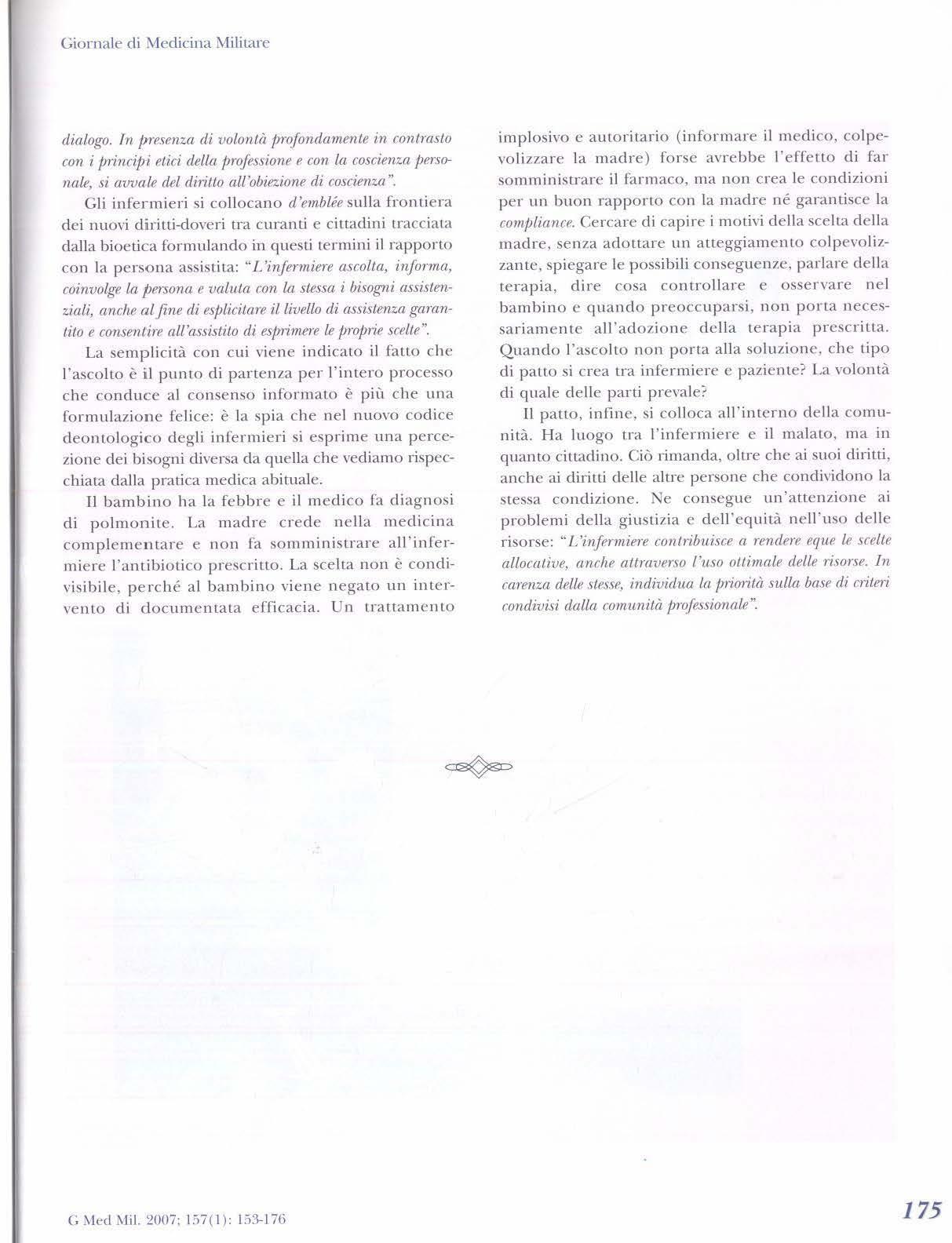
implosivo e autoritario (informare il medico, colpcvoliZ?are la madre) forse avrebbe l'effetto di far somministrare il farmaco, ma non crea le condizio11i per un buon rapporto con la madre né garantisce la complianCP. Cercare di capire i moLivi della scelta della madre, senza adottare un atteggiamento colpevolizzante. spiegare le possibili conseguenze, parlare della terapia, dire cosa controllare e osservare nel bambino e quando preoccuparsi, non porta necessariamente all'adozione della terapia prescritta. Quando l'ascolto non porta alla soluzione, che tipo di patto si crea tra infermiere e paziente? La volontà di quale delle parti pre\'ale?
Il patto, infine, si colloca all'interno della comunità. Ha luogo tra l'infermiere e il malato, ma in quanto cittadino. Ciò rimanda, o l tre che ai suoi diritti. anche ai diritti delle alu·e persone che condividono la stessa condizione. Ne consegue un'attc1uione ai problemi della giustizia e dell'equità ne l l'uso delle risorse: "J,'infi>rmiere contribuisci' a rendere eque le scelte allocative, anrhP attra1.1erso l'uso o/limale del!R risorse. In carenza delle stessi', individua fa /Jricrrità sulla base di rriteri rondivisi dalla comunità profeJsionale".